Due film che non c'entrano nulla
20-03-2025, 19:42Americana, cinema, governo Meloni, memoria del 900, scuolaPermalinkForse perché non ho mai avuto molte illusioni sulla statura politica e morale di Giorgia Meloni, che mi ritrovo sempre meno in sintonia con chi la rimprovera. È un po' come Berlusconi, ai tempi in cui i suoi detrattori sbagliavano costantemente obiettivo: quello corrompeva la guardia di finanza, e loro gli davano del nano pelato. Aa Meloni invece l'altrieri ha osato non riconoscersi nel Manifesto di Ventotene, il che non può essere una sorpresa per chiunque conosca un po' sia lei sia il Manifesto: ma improvvisamente questo diventa un delitto di lesa maestà, all'improvviso una mattina il Manifesto di Ventotene diventa una specie di carta costituzionale benché nessun parlamento l'abbia approvata, e la maggior parte di noi l'abbia nemmeno letta. Però Repubblica la pubblica in edicola, e Benigni ci farà la sua predica annuale, quindi aa Meloni come si permette. Ora, quand'è successa questa cosa? Quand'è che Spinelli e Rossi, la cui eredità politica sembrava essersi perduta nell'immediato dopoguerra, sono diventati i nostri Padri Fondatori?
Non ne ho idea, è un caso che sinceramente non ho seguito. L'idea che la carta sia l'atto di concezione dell'Unione Europea mi è sempre sembrata una forzatura: Spinelli e Rossi avevano qualche buona idea (ma anche qualche abbaglio, inevitabile vista la situazione in cui scrivevano), ma non credo che senza le loro idee non avremmo avuto i trattati di Roma e poi di Maastricht. Così come è una forzatura affermare che l'europeismo sia nato a Ventotene, quando ne parlava ed esempio Mazzini già un secolo prima. A Ventotene la sinistra italiana arriva tardi, credo a metà degli anni Novanta: non ho argomenti per dimostrarlo, soltanto labili suggestioni (una Festa Nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, più di vent'anni fa, con un padiglione che ricostruiva scala 1:1 la camera di Spinelli).
Ad esempio l'anno scorso è uscito Un altro ferragosto di Virzì, che essendo il sequel di Ferie d'agosto è ambientato a Ventotene. Nel film Sandro, che già in Ferie era l'archetipo dell'intellettuale di sinistra declassato, ha sviluppato un'ossessione per una specie di pollaio che avrebbero costruito i confinati, e se ricordo bene ha chiesto l'intervento della Sovraintendenza ai beni culturali per preservare il monumento antifascista. Nel frattempo sta sempre peggio di salute e ha allucinazioni in cui vede Spinelli, Rossi, le rispettive mogli, e ovviamente Pertini: tutto un Walhalla laico di eroi che lo attende al di là della malattia. Mentre lo guardavo trovavo tutto molto appropriato, e allo stesso tempo cercavo di ricordarmi se nel film di un quarto di secolo prima Sandro avesse mai anche solo accennato agli antifascisti al confino sull'isola.
L'ho voluto riguardare e ho avuto conferma che no del 1996, Sandro dei confinati non parlava mai, e sì che non teneva molto spesso la bocca chiusa. Rivista con gli occhi di oggi, una dimenticanza del genere è inspiegabile: insomma, il primo film che mette in luce la nuova lotta di classe tra ceto riflessivo impoverito e borghesia berlusconiana abbruttita è ambientato nell'isola che fu il simbolo dell'antifascismo: una metafora cotta e servita, eppure gli sceneggiatori non ne approfittano mai, come mai? Forse nel '96 gli sceneggiatori non sentivano la necessità di sottolineare quanto fosse importante Ventotene per l'antifascismo e l'europeismo perché, come tutti noi, al tempo il manifesto lo ignoravano, dei confinati avevano sentito parlare molto vagamente, e Ventotene l'avevano scelta magari perché era più facile girare lì che, poniamo, a Ponza. Tutti questi Grandi Padri che Sandro si crea nel secondo film, circondandosi di figure serie e sorridenti un po' come Fazio quando sceglie gli ospiti di riguardo, sono adozioni molto tardive, di gente che si è ritrovata orfana di Gramsci e Che Guevara a quaranta o cinquant'anni. Può darsi che gli autori del secondo film l'abbiano ammesso, quando a un certo punto ci fanno scoprire (spoiler) che il pollaio è un falso storico, l'ha rimesso assieme il figlio di Sandro da bambino. È un retroterra culturale postumo, non necessariamente posticcio, perché ai manifesti si può aderire a qualsiasi età. Bisogna però leggerli. Aa Meloni un po' lo ha letto – anche solo un paragrafo – e ovviamente non le è piaciuto, il che è abbastanza in linea col personaggio e la sua storia. Chi invece se la prende con lei, lo ha letto davvero? Non necessariamente. È una generazione cresciuta riempiendo gli scaffali dei soggiorni di supplementi editoriali (libri, vhs, cd, dvd, album di figurine) senza sentire l'esigenza di aprirli troppo, a rischio di consumarli.
***
E ora qualcosa che non c'entra davvero nulla, ma siccome si parla di film, segnalo che su Raiplay c'è ancora non so per quanto The Fabelmans in versione originale coi sottotitoli: un altro film in cui a un certo punto ci sono lunghe scene in una scuola dove ragazzi e ragazze interagiscono, si parlano, si innamorano, ma soprattutto si bullizzano come belve e si pestano a sangue. Queste scene, che sono familiari alla mia generazione più dei Promessi Sposi, forse non le avrei mai trovate così strane se poi nella vita mi fossi ritrovato di nuovo nella scuola media, un posto dove ovunque vada il preadolescente devono esserci in media 1-2 adulti a guardarlo, tranne in bagno; e ciononostante colluttazioni se ne verificano ogni giorno, senza gli eccessi delle scuole americane, per il semplice motivo che appunto: adulti ce ne sono dappertutto, e per quanto non sempre siano svelti di riflessi, sono comunque un grosso deterrente che impedisce al cervello del preadolescente di anche solo concepire pestaggi organizzati o assalti alla baionetta nei corridoi.
Insomma se mi chiedete perché la società USA sembra subito più violenta della nostra, senz'altro sono convinto che un certa disponibilità di armi c'entri per qualcosa; ma poi l'idea forse cattolica che i ragazzini van guardati. Senonché.
Senonché in molte scuole adesso va di moda questa DADA, ovvero "Didattiche per Ambienti Di Apprendimento", che significa in soldoni che invece di spostare gli insegnanti dall'aula della classe A all'aula della classe B, sposti le classi dall'aula dell'insegnante A all'aula dell'insegnante B. Come tutte le didattiche, ha una sua funzionalità: ad esempio negli USA diverse materie sono opzionali, per cui è normale che gli studenti cambino non soltanto aula, ma proprio classe, ovvero trovino altri studenti, a seconda della materia. Da noi però succede questa cosa, che molte novità vengono accettate un po' alla svelta perché bisogna semplicemente mostrare ai genitori che stiamo innovando, e a parte questo non è che possiamo permetterci più elasticità di tanto, perché l'organico è quello che è (anzi lo tagliano), quindi le classi rimangono le stesse, però... cambiano aula. Se lo chiedete a me, spostare classi di 25 ragazzi invece che insegnanti singoli è un'autoevidente assurdità logistica, che serve semplicemente per limare altri minuti di intervallo tra una lezione e l'altra: è normale che gli studenti se ne dicano entusiasti, così come molti genitori che appunto, come me sono cresciuti più coi telefilm americani che con Leopardi. Poi in questo modo servono gli armadietti, vi immaginate? Proprio come nelle highschool, ma quanto sarà figo? Quindi qual è il problema?
Mah, ditemi voi. Se l'insegnante A resta fermo nella sua aula A, e l'insegnante B nella sua aula B, cosa succede nei corridoi compresi tra A e B? Esatto, un sacco di ragazzi di tutte le classi liberamente in giro. Capite che ci sono le premesse per cominciare anche noi a scrivere film e serie in cui ci si accoltella sui pianerottoli, è finalmente un gap con la scuola anglosassone che stiamo per colmare, vi immagino entusiasti, e poi tra vent'anni da tutto questo bullismo chissà che geni incompresi verranno fuori, che Spielberg, che Watterson, finalmente.
Il gesuita che doveva sparire
12-03-2025, 02:59Americana, santiPermalink12 marzo: Beato Rutilio Grande Garcia (1928-1977), sacerdote salvadoregno.
(Non c'entra nulla, ma stamattina dovrebbe esserci un pezzo mio sul Manifesto, magari interessa).
 |
| https://www.jesuits.global/it/2019/02/01/tributo-a-rutilio-grande-sj/ |
Affacciato sulla strada che collega il borgo di El Paisnal con la cittadina di Aguilares (El Salvador), c'è ancora un monumento con tre croci metalliche che spuntano dal marmo. Ormai nessuno lo tocca più, ma i primi anni furono complicati. Le croci a volte venivano divelte, persino il marmo si sgretolava o spariva. Non si trattava di miracoli, ma dei trattori degli squadroni della morte. Le croci segnavano il punto in cui il 12 marzo del 1977 le loro pallottole avevano raggiunto l'auto dove viaggiavano padre Rutilio Grande, il catechista settantaduenne Manuel Solórzano e Nelson Rutilio Lemus. Quest'ultimo era un ragazzo di sedici anni, che con Rutilio e Manuel andava a celebrare la novena di San Giuseppe nel villaggio natale di padre Rutilio. Altri tre ragazzi nell'autovettura rimasero indenni, e al processo identificarono gli squadristi, che comunque furono assolti. L'obiettivo era evidentemente padre Rutilio (bersagliato da dodici pallottole), che malgrado avesse rinunciato a un ruolo prestigioso nel seminario di San Salvador per occuparsi di una semplice parrocchia, continuava a dare molto fastidio ai proprietari terrieri. Di Rutilio doveva scomparire anche la memoria: il busto in marmo che lo ritraeva fu fatto saltare in aria pochi giorni dopo l'inaugurazione. L'autore, lo scultore spagnolo Pedro Gross, scampò a un attentato e preferì lasciare il Paese.
 |
| Pedro Gross con il busto dedicato a Padre Rutilio |
Chi ancora ricorda la guerra civile che insanguinò El Salvador negli anni Ottanta, sa che scoppiò in seguito all'assassinio del vescovo Oscar Romero, mentre officiava una messa, nel 1980; uno dei martiri più scenografici della storia della Chiesa, perché il cecchino scelse di colpire il vescovo proprio durante l'elevazione, mentre reggeva ostia e calice (ricordo la didascalia del fumetto pubblicato dal Piccolo Missionario: "il sangue del vescovo si mescola a quello di Cristo"). Si tratta probabilmente del momento più adatto per sparare a un sacerdote officiante: ha le braccia alzate, il petto necessariamente proteso. Ma sembra anche un riconoscimento dell'assassino nei confronti della sua vittima, quasi una confessione: devo ucciderti, ma non posso evitare di fare di te un martire, un eroe. La crudezza con cui fu eliminato può suggerire l'impressione che Romero fosse uno di quei cristiani militanti che in quegli anni avevano spostato il baricentro verso la sinistra dei campesinos – col risultato di attivare la reazione di forze nazionaliste che potevano contare sull'appoggio dell'esercito e il benestare del Pentagono. Ma Romero non era un teologo della liberazione, anzi: quando fu nominato vescovo di San Salvador, all'inizio del 1977, passava per un conservatore, o in ogni caso un uomo di Chiesa che non intendeva immischiarsi nella politica. A trasformarlo nel leader dell'opposizione salvadoregna fu la strage di Aguilares. Rutilio era un suo collaboratore, e probabilmente un suo amico; Romero accorse subito a El Paisnal per celebrare una lunga messa che doveva servire anche a placare gli animi. La domenica, tutte le celebrazioni salvadoregne furono sospese: centocinquanta sacerdoti co-celebrarono con Romero un'unica messa nella cattedrale, per ricordare Rutilio, Solórzano e Lemus. E siccome per il governo si trattava di un semplice e increscioso caso di delinquenza comune, il vescovo annunciò che non avrebbe più preso parte a eventi ufficiali finché il governo salvadoregno non avesse identificato e punito i colpevoli. Il governo non li identificò mai, e nei tre anni che gli rimanevano da vivere Oscar Romero non strinse più la mano a un solo politico salvadoregno, diventando la voce più autorevole dell'opposizione al regime.
 |
| Monumento a Romero e Grande, El Paisnal |
Neanche Rutilio dava l'impressione di essere un rivoluzionario. A leggere un po' di testimonianze sembra di riconoscere quel tipo di prete timido che da adolescente può sentire il richiamo della vita sacerdotale perché sembra venire incontro alle necessità di un temperamento introverso: la promessa di un'esistenza pacifica, l'inserimento in una comunità dove ci si aspetta di svolgere un ruolo utile ma non troppo appariscente. Dopodiché Rutilio ha la trovata di entrare nei gesuiti sudamericani proprio nei terribili anni Settanta, il che lo porterà a diventare il leader di intere comunità di proletari angariati da una classe proprietaria avida e assassina; ruolo che Rutilio accetterà con cristiana rassegnazione e (sembra) non troppo entusiasmo. Mentre era già in macchina, quella sera, e forse aveva capito di essere seguito, i ragazzi gli sentirono dire: "Bisogna fare quel che Dio vuole".
Trump ci è, Trump ci fa
28-02-2025, 01:54Americana, TrumpPermalinkE forse confondiamo anche stavolta effetti e cause: Trump potrebbe essere impazzito perché è troppo potente, ma potrebbe anche essere diventato così potente proprio perché è un povero pazzo; chi altro avrebbe potuto intestarsi con disinvoltura strappi in politica estera e interna inimmaginabili dal 1945. Può darsi che la democrazia ceda alla follia quando non sa più risolvere le sue contraddizioni, o uscire dalle situazioni in cui si è cacciata. Una di queste, al netto dei retroscena che ognuno racconta come più gli garba, è l'Ucraina: una situazione che si è ingarbugliata molto prima del 2022, degli accordi di Minsk e di Euromaiden. Storicamente, i democratici rappresentanti dell'Occidente hanno ritenuto che l'Ucraina fosse scalabile; che messo alle strette, Putin avrebbe dovuto cedere, o che un suo eventuale bluff sarebbe stata la sua fine politica. Possiamo discutere lungamente su chi abbia più di altri abbia commesso questo errore (Obama? Angela Merkel?) Quello che a questo punto dobbiamo accettare è che un errore di valutazione c'è stato. Non solo, ma dobbiamo anche riconoscere che non lo pagherà chi lo ha commesso, bensì gli ucraini e, meno pesantemente, gli europei. La retorica democratica crolla di schianto e ci accorgiamo che oltre a "un invasore e un invaso" c'erano venditori di armi che ci speculavano, venditori di gas che dalla fine dei due Nord Stream hanno tratto un immediato vantaggio, compratori di terre rare che stanno per chiudere un buon affare, ecc. Tutto questo, i cultori della democrazia potrebbero trovarlo osceno, ma possono consolarsi: la democrazia è sospesa, al suo posto c'è un pazzo che fa un po' quel che gli pare.
In Palestina, una situazione molto diversa: ma anche lì, dopo aver coccolato per decenni un regime basato sulla segregazione religiosa (e razziale); dopo averlo visto diventare sempre più violento e meno incline ai compromessi, a un certo punto ti scoppia il bubbone, ti ritrovi un genocidio sulla riva del Mediterraneo e cosa fai? Accetti le tue responsabilità? No, perché nel frattempo tu, democrazia occidentale, hai pensato bene di suicidarti. Non fai neanche le primarie del partito democratico; alle elezioni candidi il nonno in carriola e quando diventa chiaro che la carriola ha delle difficoltà lo sostituisci con una vice la cui impopolarità era abbastanza nota; siccome Trump aveva già vinto contro una donna wasp, ci mandi una donna neanche wasp, perché vuoi proprio essere sicuro di perdere. La responsabilità se la prenderà un povero pazzo, anzi una squadra di pazzi un po' nerd incapaci di notare le differenze tra realtà e simulazioni AI, che magari riusciranno a confondere i sionisti eludendo le loro richieste con proposte ancora più folli. È una teoria.
Rimane sempre sul tavolo l'ipotesi che con Trump e Musk il capitale abbia raggiunto il punto di accumulazione dopo del quale la realtà semplicemente collassa: i cittadini contemplano interdetti ma non possono farci niente perché il capitale ha già da tempo attirato a sé non solo gli strumenti del consenso, ma anche le infrastrutture della comunicazione: nonché esercito e finanza, per cui non si vede proprio come uscire da quello che ormai è un buco nero. Ma probabilmente è un'ipotesi troppo pessimistica: voglio dire, tiranni impazziti ne abbiamo avuti sempre, e in un qualche modo ne siamo sempre usciti; probabilmente anche Svetonio era convinto di vivere negli ultimi giorni dell'umanità, tutti sono convinti di questa cosa, e prima o poi qualcuno ci beccherà. Sarebbe molto buffo che quel qualcuno fossi io.
Trump, l'idiota in marcia?
11-02-2025, 17:07Americana, futurismi, Israele-Palestina, TrumpPermalinkCome vi sentite un mese dopo un mese di Trump 2 la vendetta? A questo punto della storia immaginavo che i commentatori moderati stessero cominciando ad assorbire lo choc e a ingegnarsi per trovare un metodo in tanta pazzia – in fondo anche quella del madman è una tattica di combattimento, no? Se ti mostri completamente inattendibile e inaffidabile, l'avversario sarà in difficoltà perché tutti gli schemi con cui è abituato a combattere non sono più applicabili. A volte ha funzionato – anche se fin qua si trattava, senza eccezione, di leader autoritari e probabilmente psicopatici... però a volte ha funzionato, quindi perché no? In fondo cosa ha fatto Netanyahu dal sette ottobre in poi, se non il matto? e quel Milei con la motosega, anche lui non piace così tanto ai moderati?
Qualche sforzo in tal senso in effetti c'è stato, perché in fondo ci sono motivi seri per occupare la Groenlandia – e anche il Canada alla fine cos'è, se non una curiosità storica. Quanto alla rivierizzazione di Gaza, beh, almeno Trump ha il privilegio di abolire l'ipocrisia: Gaza non è più abitabile, e gli israeliani non hanno le risorse per renderla tale. A essere più precisi non avevano nemmeno le risorse per distruggerla come l'hanno distrutta: tali risorse sono state generosamente fornite dagli americani, per cui a valle di tutta la retorica sionista e biblica, se lì ci sono delle spiagge interessanti (e dei giacimenti interessanti), prima o poi gli americani li reclameranno. A Netanyahu evidentemente la cosa non piace; del resto a nessuno statista piace quando gli americani gli ricordano che è semplicemente un maggiordomo – e non importa quante donne e bambini abbia sepolto negli scantinati, e quanto si sia divertito a macellare gli innocenti: sempre un maggiordomo resta. Da canto loro, gli americani hanno sempre quell'annoso problema con la sindrome di onnipotenza, che li ha condotti a guerre senza fine e senza senso: Trump, meno apparentemente bellicoso di molti altri presidenti, ne sembra comunque la massima incarnazione. Probabilmente l'uomo è davvero convinto che due milioni di persone si possano deportare facilmente in un posto migliore. Altri uomini prima di lui erano altrettanto convinti di cose del genere. Purtroppo ora i loro nomi si trovano in pagine di Storia dedicate ai genocidi, ma davvero, la buona fede c'era e non dubito che anche Trump ne abbia.
Così, un mese dopo il Secondo Avvento di Trump, non ho resistito e sono andato a rileggermi Gli idioti in marcia. Non ne vado fiero. Ma magari è successo anche a voi. O più probabilmente non conoscete Gli idioti in marcia – che viceversa in certe sottoculture è un testo famosissimo, oltre che un modo di dire. Per fortuna si tratta di una lacuna che si può colmare in venti minuti; Gli idioti in marcia (The Marching Morons) è infatti un raccontino di fantascienza di Cyril M. Kornbluth. Se proprio non volete leggerlo on line, potete trovarlo nel tredicesimo volume della splendida raccolta I grandi racconti della fantascienza, che per me ormai è un testo sacro: nello stesso volume ci sono cose anche più belle e rilevanti, come Null-P, che spiegava il berlusconismo nel 1951; Sentinella di Clarke (Kubrik ci fece un filmetto), Un secchio d'aria di Leiber, insomma se dovete leggere un solo libro di fantascienza nella vostra vita, forse è quello giusto. Tutta l'antologia è curata da Isaac Asimov, il quale nella breve introduzione al racconto ci avvisava già negli anni '80 che "marching morons" in inglese stava diventando un termine colloquiale, molto spesso usato per commentare le notizie di cronaca. In effetti "idioti in marcia" si può applicare quasi a tutto quello che si legge negli ultimi giorni: aa Meloni spia i giornalisti ma si dimentica di pagare l'app di spionaggio? Marching morons. Si fa beccare mentre promette letame su uno scrittore famoso internazionalmente per la lotta alla camorra? Marching morons. Gli industriali italiani si fanno abbindolare da un tizio che si presenta come il ministro Crosetto e gli propone di trasferire fondi su un conto all'estero – per motivi umanitari, per carità? Marching morons. Ma insomma chi sono questi marching morons?
Nel lontano 1951 Kornbluth aveva già notato che le persone intelligenti tendono a riprodursi meno dei "morons". Da giovane nerd frustrato, la cosa lo convinceva di vivere in un mondo di idioti; da bravo scrittore di fantascienza riteneva giusto scrivere un romanzo per esplorare un'ipotesi: questa tendenza, nel lungo termine non renderà l'intelligenza un gene recessivo? Chi non ha ancora letto il racconto potrebbe comunque aver familiarizzato col problema grazie al film Idiocracy, che ne riprendeva l'assunto. Gli autori del film però non potevano seguire Kornbluth fino in fondo, perché l'autore non si limitava a immaginare un mondo futuro popolato di idioti, ma proponeva anche una soluzione – decisamente genocidaria. Parliamo del resto di un ventottenne newyorkese di origine askenazita che si era conquistato una medaglia di bronzo sulle Ardenne. I genocidi per lui non erano pagine di Storia studiate a scuola, ma episodi a cui aveva assistito e nei quali si sentiva coinvolto. In effetti l'altro suo racconto memorabile, Two Dooms, nasce dall'esigenza esistenziale di giustificare il progetto Manhattan: per spiegare ai suoi lettori e a sé stesso che gli americani dovevano sviluppare la Bomba, Kornbluth si immagina cosa sarebbe successo se i nazisti, in un rush finale, fossero riusciti a svilupparla prima di loro. È forse la prima ucronia del genere, dieci anni prima della Svastica sul sole e non è affatto indenne da una serie di pregiudizi di stampo coloniale che oggi troviamo più difficile distinguere dal razzismo dei nazisti che Kornbluth aveva combattuto non solo a parole. Ma anche The Marching Morons, a guardarlo da una certa distanza, rivela una concezione eugenetica che era la stessa da cui partivano i nazisti. I genetisti tedeschi temevano che i matrimoni misti disperdessero la "razza ariana"; Kornbluth era convinto che l'"intelligenza" fosse un analogo fattore genetico a rischio dispersione. Sia i nazisti sia Kornbluth non arrivano al genocidio immediatamente, ma a un certo punto è la logica dei loro ragionamenti a tirarsi da sola le conclusioni e condurli lì, dove stanno arrivando Netanyahu e Trump; non c'è niente da fare, se concedi che determinate persone abbiano un fattore genetico più prezioso, dovrai isolarli e trovare per loro un Lebensraum dove possano crescere e moltiplicarsi indisturbati; chi è di intralcio a questa operazione dovrà essere messo da parte, possibilmente in modo indolore, anzi sarebbe fantastico se potessero andarsene volentieri, in un luogo dove fossero felici (per quanto possano essere felici gli individui inferiori; pensiamo a certi acquari con la conchiglia e il castelletto).(Continua)
Dio è con noi (in mancanza di meglio)
23-01-2025, 01:17Americana, TwitterPermalinkQuello di Musk potrebbe essere un gesto infelice che gli è sfuggito in una situazione di stress (o fattanza), ma anche la solita manifestazione di nazismo ironico. Sul nazismo ironico mi ritengo un'autorità perché insegno nella scuola media, dove la gente incide le svastiche sui banchi molto prima di associarle al nazismo; e le incide principalmente per dare fastidio a chi gli dice che è una cosa sbagliata; tutto qua, poi crescendo magari diventano anche razzisti e antisemiti, ma in principio c'è questa necessità di fare incazzare l'autorità, che non cessa nemmeno quando l'autorità diventano loro – anche in questo noi italiani siamo all'avanguardia, no? Con tutti i motivi che c'erano per intitolare un aeroporto a Silvio Berlusconi (è brutto, è lontano, è costato un fottio di soldi al contribuente, ha ingrassato tanta cricca disonesta) a un certo punto pareva che il motivo più importante fosse far arrabbiare la sinistra, ok, immagino che per alcuni sia meglio del sesso. Dopodiché Musk è inquietante per tantissimi altri motivi, e uno di questi motivi è che questa deriva, fino a qualche anno fa, era abbastanza inimmaginabile. Questo trumpismo di Musk (e di Zuckerberg, e di Bezos) ha tutta l'aria di un piano B, o comunque di una situazione in cui questi tycoon digitali si sono infilati perché evidentemente altre opzioni si erano esaurite. Altrimenti lo avrebbero fatto otto anni fa, e in teoria loro sono quelli rapidi e sul pezzo.
Otto anni fa può darsi che il piano A di Musk fosse davvero andare su Marte; dopodiché magari la realtà ha presentato il conto. Così come fino a qualche anno fa Zuckerberg era convinto che ci avrebbe portati tutti nella realtà virtuale: un altro pianeta che alla fine non si è rivelato accessibile. In ogni caso fino a qualche tempo fa questi erano progetti più interessanti che prendere il potere a Washington. Oggi no. Oggi sia Zuck sia Musk forse stanno picchiando la testa contro limiti strutturali: ad esempio la Tesla più di tanto non è competitiva e non lo sarà ancora per un pezzo, il che può portare anche il più turboliberista a lobbizzare Washington e a chiedere un po' di sano protezionismo contro l'elettronica cinese. Nel frattempo Musk si è ritrovato proprietario di Twitter, e non sapremo mai se è stato un capriccio, un tranello o la fase di un diabolico piano; ma a quel punto ha dovuto accettare anche lui la grande verità scomoda che con Twitter non si faranno mai i soldi – e in generale nessun social network è mai riuscito a trovare un modello di business che non conduca a un rapido immerdamento.
Se volete è lo stesso equivoco per cui in Italia qualcuno fino a qualche anno fa era convinto che i giornali potessero stare sul mercato da soli, quando la realtà quotidiana ci dice che la maggior parte ricicla denaro del contribuente per amplificare le opinioni politiche del committente. Musk si è ritrovato subito nella stessa situazione: l'unico modo per cavare qualche utile da Twitter era darsi alla politica. Soldi con X non ne avrebbe mai fatti, laddove un po' di influenza politica sugli elettori poteva ricavarla, e quindi se anche il suo obiettivo iniziale non era diventare un demagogo, Musk lo è diventato. Ha comprato un social, era una sòla, l'unico modo per valorizzarla era trasformarla nella centrale della disinformazione occidentale, Musk è diventato il capo della disinformazione occidentale e ora si ritrova nella Sala Ovale della Casa Bianca a spiegare come si governa a gente che ne sa persino meno di lui. C'è di che emozionarsi e alzare braccia a caso.
Alla fine il capitalismo non è che possa fingersi diverso da quello che è: anche chi accumula con le migliori intenzioni si ritrova molto presto incastrato in meccanismi padronali, e non è neanche detto che Musk fosse partito con le migliori intenzioni. Siccome Marte non è terraformabile, le auto elettriche non salveranno il mondo, il metaverso non funziona e anche le AI cominciano a sembrare una bolla, non resta che darsi alla politica, che in effetti era un po' la Cenerentola, uno spazio che interessava sempre meno gente, popolato da personaggi facilmente rilevabili da chi in questi anni ha fatto i soldi veri. Musk li ha fatti, magari più con le crypto che lanciando razzi, vendendo automobili e inserzioni su X. Ma alla fine quando hai tanta liquidità, hai un problema di liquidità. Trump non è mai sembrato l'investimento più sicuro, ma a un certo punto non devono esserci più state molte alternative a comprarselo, e quindi Washington e il mondo – sempre in mancanza di meglio.
Insomma, e sintetizzando: è come se Musk si fosse messo a giocare a Risiko perché si è accorto che Monopoli è un gioco di merda.
Sotto scroscianti applausi
20-01-2025, 23:55Americana, Berlusconi, fascismo, memoria del 900, tvPermalinkPer me la democrazia finisce con Kamala Harris, che più di altre figure si è prestata a interpretare il ruolo di chi cede il potere perché avrebbe troppa paura di usarlo. Lo cede a un conclamato golpista già condannato per aver falsificato documenti, il che è vergognoso; ma d'altra parte se non lo cedesse dovrebbe richiedere l'uso della forza contro un conclamato golpista già condannato per aver falsificato documenti, e non ne ha evidentemente il coraggio. Una democrazia seria, e preoccupata della sua sopravvivenza, avrebbe identificato in Trump una minaccia almeno dal 6 gennaio 2020; e invece per tutto questo tempo la minaccia è stata lasciata in pace, forse nell'illusione che qualche processo penale avrebbe potuto alienargli la base e i finanziatori: uno dei tanti calcoli sballati dello staff di Biden. Quindi la democrazia finisce così? Perché non ha avuto il coraggio di difendersi?
Noi italiani conosciamo il dilemma meglio di altri. Anni fa, Alberto Asor Rosa fu pubblicamente deriso per aver obiettato a quei politici, veramente poco avveduti, che continuavano a ripetere di voler e poter sconfiggere Berlusconi nelle urne (con che risorse? con che giornali? con che televisioni?): poiché lo stesso Berlusconi aveva già dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio di truccare la competizione elettorale, disponendo dei media ben oltre i termini di legge (che modificava a suo piacimento nei periodi in cui era al governo), poiché era evidente quanto il suo conflitto d'interessi fosse una minaccia alla democrazia, Berlusconi andava arrestato dalla forza pubblica, che anche a questo dovrebbe servire. Asor Rosa era molto ingenuo, ma secondo me aveva ragione, e Trump andrebbe arrestato. Qualcuno da fuori potrebbe considerarlo un colpo di Stato, ebbene esistono situazioni di emergenza in cui lo Stato deve difendersi da minacce concrete. Qualcuno all'interno potrebbe insorgere: è il rischio da correre. Se Trump deve trionfare, che almeno questo succeda perché i suoi sostenitori sono disposti a morire per lui. Se la democrazia deve cedere il passo, che almeno faccia resistenza. Armata. Quella che Kamala Harris non consentirebbe mai: suppongo che tra Trump e una guerra civile, lei veda in Trump il male minore. Neanche esattamente un male. Il suo partito continuerà a interpretare il ruolo dell'opposizione parlamentare, istituzionale, pacata, inutile; e a emarginare il dissenso a sinistra. Inoltre l'amministrazione Biden si era infilata in due gineprai così complicati – l'Ucraina e Gaza – che dev'essere un sollievo per i Democratici lasciare ai trumpiani la responsabilità di uscirne.
In questi giorni sembra obbligatorio lasciare un'opinione sulla fiction di Joe Wright, M il figlio del secolo. A me il Mussolini grottesco di Marinelli tutto sommato sembra che funzioni. L'aspetto più discutibile, fino alla quarta puntata, mi sembra l'assenza degli industriali. In due ore si sono visti in scena per cinque secondi, in un siparietto brechtiano in cui coprono Mussolini e Cesare Rossi di banconote in cambio del loro sostegno contro i socialisti che insistevano a vincere le elezioni. Non sarò io a prendermela se per una volta gli autori televisivi si cimentano coi siparietti brechtiani, anzi ne vorrei più spesso: ma Mussolini era in buoni rapporti con Fiat e Ansaldo già da quando nel 1914 aveva cambiato idea sulla Grande Guerra, trascinando tanti socialisti come lui nella follia suicida dell'interventismo. Capisco che gli autori abbiano preferito scorciare, semplificare (la fiction comincia nel 1919), ma anche durante la marcia su Roma sembra che Mussolini sia un uomo solo tra gli esagitati in camicia nera e le istituzioni, un equilibrista che riesce a bleffare e ingannare un re che avrebbe potuto schiacciarlo con un tratto di penna. Sarà andata davvero così? Il re ne aveva paura, o preferiva davvero il buffone ai socialisti? E gli industriali, nel frattempo, non avevano dato qualche segnale?
Forse qua sopra ho commesso un errore simile, attribuendo ai Democratici di Kamala Harris lo stesso ruolo tremebondo di re Vittorio, che avrebbe ceduto la nazione non perché tutto sommato gli conveniva, ma per paura. Come se non ci fossero interessi ben più potenti delle nostre paure. I democratici si sono arresi perché il Capitale aveva scelto Trump, e contro il Capitale non avevano nessuna intenzione di combattere. Vincere contro Trump avrebbe significato interpretare le necessità di gruppi sociali che vogliono un welfare state come ce l'hanno gli stati normali; che non capiscono la necessità apocalittica di sostenere Israele in un'operazione di pulizia etnica; che sanno di non poter vivere ancora di idrocarburi per un'altra generazione. Non ho idea di quanto queste istanze siano diffuse nel popolo americano (che per lo più non vota); ma di sicuro non erano istanze che i Democratici potevano difendere. Il loro programma era un blando capitalismo dal volto umano, ma per l'umanità c'è sempre meno mercato. La democrazia è una società aperta: si dovrebbe difendere mantenendo il pluralismo, combattendo chi sparge paure e ci specula sopra. Non è mai stato chiarito se sia compatibile col capitalismo: forse no, non a lungo perlomeno. In Italia è stata sconfitta vent'anni fa da Berlusconi; negli Usa forse oggi.
Una cattolica in America
22-12-2024, 02:11Americana, migranti, santiPermalink |
| Lei è Cristiana Dell'Anna. |
Frequento una scuola cattolica, e per qualche motivo l'Arcidiocesi di cui facciamo parte ha deciso che era assolutamente necessario che noi vedessimo questo film, per cui ha prenotato un casino ("a shit ton") di cinema per più scolaresche. A quanto pare, tutto questo è stato pagato da una ricca famiglia cattolica che voleva davvero che andassimo a vedere il film, e in più sembra che dietro a tutto questo ci sia anche Angel Studios, la compagnia che lo ha prodotto. Penso che abbia a che fare con il fatto che vogliono che i loro investitori credano che questo tipo di film abbia successo, quindi immagino che forzare un sacco di scuole cattoliche a portare i loro studenti al cinema aiuti in questo senso. Onestamente, non sono sicuro di come funzioni tutto ciò, è solo quello che ho sentito da varie fonti. (La seconda "più popolare" recensione di Cabrini su Letterboxd).
Malgrado questo e altri sforzi distributivi, Cabrini è stato un fiasco al botteghino. Un po' mi dispiace, anche se trovavo inquietante l'idea che il regista del film più cospirazionista degli ultimi anni avesse deciso di dedicare un biopic alla patrona degli emigranti italiani (e dei migranti in generale). Diciamo che se avesse avuto un successo paragonabile a quello di A Sound of Freedom, avrebbe fatto notizia anche in Italia, dove Santa Francesca Cabrini è tuttora un'illustre semisconosciuta. A quel punto magari il film sarebbe stato distribuito seriamente anche da noi, e non soltanto qua e là per tre miseri giorni d'ottobre. E forse sarei riuscito a vederlo, ehm, legalmente, scoprendo se si tratta di un buon film o di una puttanata intercontinentale; perché se le recensioni americane sono migliori di quanto ci si aspetterebbe, bisogna sempre ricordare che per loro un film agiografico è una novità, probabilmente non conoscono Luigi Magni e potrebbero essersi anche dimenticati di Zeffirelli o Liliana Cavani. Ma soprattutto non si sono fatti gli ossi con le fiction di Lux Vide. Così magari approfittando del film avrei finalmente trovato l'ispirazione per il pezzo su Santa Francesca Saverio che ogni tanto qualcuno mi chiede di scrivere (una frase, mi rendo conto, molto blog-anni-zero: però davvero, in tanti anni, due o tre persone me l'hanno chiesto. Un numero infinitamente superiore a quelli che mi hanno preteso un pezzo su San Michea).
E invece no. La santa dei migranti (che è anche la prima santa statunitense) ha dimostrato nell'occasione di non avere lo stesso appeal della cospirazione pedofila di Sound of Freedom, della mitomania del veterano di American Sniper, o del Gesù splatter di Passion of the Christ. Evoco questi tre titoli perché erano probabilmente i tre argomenti che rendevano plausibile la sfida produttiva di Cabrini; film che hanno avuto uno spaventoso successo ai botteghini proprio perché pensati per un pubblico diverso, al di fuori dei circuiti abituali della distribuzione; gente che al cinema non ci va mai, al punto che in certi casi la distribuzione deve affittare le corriere, come se si trattasse di un pellegrinaggio – ecco, questi film sono paragonabili a pellegrinaggi postmoderni, e se i primi tre erano rivolti soprattutto a un pubblico bianco e protestante, Cabrini guardava appunto al bacino inesplorato delle comunità cattoliche. Alcune scuole, come si legge sopra, devono aver risposto all'appello: ma non è stato sufficiente
Per quanto riguarda le mie impressioni su questo film, era tutto sommato accettabile. Hanno stipato tutta la mia classe in una sala, quindi mi aspettavo fosse un caos, ma a parte un ragazzo che ha portato un altoparlante e ha suonato dei suoni divertenti di tanto in tanto, non è andata male. Non penso che Cabrini fosse brutto, ma non mi ha colpito particolarmente. Ha chiaramente un messaggio importante da trasmettere, ma nella pratica non risulta così. Inoltre, qualsiasi film che devo vedere per scuola automaticamente mi rende meno interessato, purtroppo.
Francesca Saverio è un personaggio enorme. Ancora prima di sbarcare in America, e non aveva quarant'anni, aveva già combinato abbastanza per passare alla Storia, almeno come fondatrice del primo ordine femminile missionario. L'idea fissa intorno a cui girava sin da bambina era la conquista cristiana della Cina, proprio come l'inquieto gesuita da cui aveva preso il nome. Il vescovo di Piacenza la dirotta verso New York, dove sbarca la prima volta nel 1889, in un momento in cui le prime ondate di immigrati dall'Italia sono confinate al livello più infimo della catena alimentare, guardati con diffidenza anche dalla diocesi cattolica, saldamente in mano alla comunità irlandese. Nel giro di pochi anni Francesca riesce ad accreditarsi come il volto umano della comunità. Dietro all'apparenza ascetica conferitale dalla tubercolosi c'è una grande lavoratrice e organizzatrice. Se gli italiani vedono in lei un'emissaria della carità, gli anglosassoni ne ammirano le capacità imprenditoriali: credo sia l'unica santa di cui si racconta che sia morta alla scrivania, come un vero businessman (eppure morì di malaria, una malattia così italiana ai tempi). Il film in effetti è stato finanziato, tra l'altro, da un milionario della Pennsylvania, J. Eustace Wolfington, che considera la Cabrini la sua grande ispiratrice: non certo in quanto suora, ma in quanto imprenditrice. "Volevano farne una favola, ma io dovevo realizzare un film migliore. Dovevo catturare chi era lei davvero, una donna che non accettava un 'no' come risposta, neanche dal papa, né dall'arcivescovo, né dal sindaco di New York o dal presidente del senato in Italia. Non c'era bisogno di mostrarla mentre predicava e pregava, perché la sua vita è il vero sermone". Ecco, questo mi interessava del film: capire se l'ideologia degli investitori protestanti era riuscita a snaturare la vita di una missionaria cattolica con una spiccata vocazione assistenziale.
Se ogni santo somiglia a un precedente e a un successivo, Francesca Cabrini ha tutte le carte per essere considerata il precedente ottocentesco di Teresa di Calcutta: una piccola donna di fragile salute, che davanti a un continente intero di sofferenza non si perde d'animo e comincia a colonizzarlo fondando conventi su conventi, diventando un personaggio mitico e santificato già in vita.
Si tratta di un precedente molto più epico e avventuroso perché alla fine per Teresa i poveri della terra erano a portata di aeroplano, mentre la Cabrini per raggiungerli in America dovette attraversare l'oceano in transatlantico una ventina di volte, attraversare le Ande a dorso di mulo, ecc. E se il culto di Teresa si è sviluppato in un secolo scettico, davanti a osservatori disposti a mettere in discussione le sue imprese, nel caso di Francesca Cabrini, e in generale di tutti i santi/benefattori ottocenteschi, è veramente difficile riuscire a filtrare qualcosa di oggettivo da tutti i resoconti biografici che per partito preso non potevano parlarne che bene. Quel che sembra di capire è che con la Cabrini la Chiesa cattolica accetta finalmente che le donne possono fare le missionarie, muoversi in un mondo da evangelizzare senza perdere la rispettabilità; magari un po' tardi rispetto a una società in evoluzione, ma giusto in tempo per assumere un ruolo fondamentale nella società delle nuove metropoli americane, dove il Welfare State è perlopiù demandato alla beneficenza dei ricchi, al buon cuore dei pochi che ce l'hanno fatta e non si dimenticano della miseria su cui poggiano le proprie radici. Servono intermediari affidabili tra milionari e poveracci, gente al di sopra di ogni sospetto in grado di percepire donazioni e lasciti e ridistribuirli in modo efficace: le suore missionarie del Sacro Cuore svolgono questa funzione necessaria e diventano un punto di riferimento di tutte le comunità italoamericane. Ai poveri parlano in italiano, ma sono disponibili a insegnare ai loro figli l'inglese. Morta nel 1917, viene beatificata quasi subito ed entra nel calendario già nel 1946: e siccome nel 1909 aveva ottenuto la cittadinanza USA, è anche la prima santa statunitense.
Non è difficile capire perché una santa italiana così importante in America non abbia mai 'forato' qui in patria; la sua leggenda dal 1889 in poi attraversa una delle pagine più imbarazzanti della nostra Storia: quella in cui i migranti eravamo noi, brutti, sporchi e criminali. Oggi la Cabrini viaggerebbe sulle navi che Salvini ordinava di speronare. Ma perché uso il condizionale. Oggi la Cabrini viaggia sulle navi che Salvini ordina di non soccorrere.
Il crollo della mente democratica
30-10-2024, 02:35AmericanaPermalink
– Come ogni bisestile al Ponte dei Morti eccoci qui, a pregare gli dei che non ci mandino altri quattro anni di sventura. Non tanto gli dei, quanto gli elettori statunitensi, i quali però sono altrettanto capricciosi e quasi onnipotenti, per cui in effetti che differenza fa? I nostri nipoti ci giudicheranno molto diversi dai popolani che aspettavano nel Rinascimento la fumata bianca, o nel medioevo che le campane squillassero a festa perché era nato un re? La razionalità è molto sopravvalutata, questa è la lezione che tiriamo dagli ultimi due secoli di Storia, che forse per coincidenza sono stati due secoli molto americani. È veramente assurdo pensare che il destino della terra dipenda dall'umore di un allevatore della Pennsylvania; veramente assurdo ma assolutamente vero, da cui la domanda: com'è possibile che sia andata a finire così? O è stato sempre così, salvo che non ci era ancora chiaro (per cui dovremmo quanto meno salutare lo svelamento)? O in realtà non è affatto così, le elezioni USA non essendo che una bizzarra e sempre più grottesca liturgia, al termine della quale le decisioni verranno prese sempre dallo stesso deep state – che però non ne azzecca una comunque? Non ne ho la minima idea.
– Non ho neanche la minima idea di chi vincerà stavolta l'ennesimo round tra il Male e il Meno Peggio, e a proposito: trovo incredibile, complottisticamente incredibile, che di quadriennio in quadriennio le elezioni diventino sempre più contese e incerte – voglio dire, quante probabilità dovrebbero esserci che l'ago della bilancia debba sempre sospendersi al centro esatto? È come se nel caos crescente gli elettori USA tendessero invece a un equilibrio che in qualsiasi altra elezione avrebbe un senso; e invece duecento anni fa hanno deciso che avrebbero eletto una carica monocratica e niente, non li smuovi, sono sicuri di avere il sistema migliore al mondo e chi li può contraddire. È un sistema che carica su un solo uomo una quantità di potere crescente e intollerabile, una spada di Damocle che farebbe impazzire anche chi non avesse i problemi geriatrici di un Trump; o forse i problemi di un Trump (e di un Biden) sono quello che li immunizza dalla tensione che avrebbe ucciso chiunque altro al loro posto. O forse la tensione li ha già uccisi dentro: vuoi vedere che la demenza senile sia una malattia professionale.
– Kamala Harris invece è viva, ma questo fa di lei una candidata credibile? Lo è diventata senza nemmeno disputare delle primarie che probabilmente avrebbe perso. Con lei, fanno otto anni che i Democratici non riescono a esprimere un leader carismatico; nemmeno quando il competitor è un pagliaccio. Del resto da un leader carismatico ci si aspetterebbe che fosse in grado di cambiare le cose, e questo forse è il pensiero che sta paralizzando la mente democratica: l'idea che prima o poi le cose debbano cambiare, e che tocchi a loro cambiarle. Affrontare la crisi climatica, con i mutamenti drastici che porterà nei comparti industriali ed energetici? Accettare l'emergere di nuove potenze economiche più che militari (ma anche militari), non necessariamente rivali, ma che da qui in poi non consentiranno più agli USA di assumersi quel ruolo di gendarme mondiale che Bush Primo si caricò sulle spalle e che Biden non riesce a scrollarsi? Mettere almeno una pezza ai buchi che Biden ha fatto ovunque? A differenza del suo boss, Kamala Harris conserva le risorse intellettive necessarie a rendersi conto che l'amministrazione che rappresenta è responsabile di un genocidio in Palestina e di una guerra su larga scala in Europa. Trump ha almeno la scusa di non capire cosa succede dove e perché – dopodiché, tra un demente e un criminale immagino che il criminale sia la scelta più razionale: d'altro canto, guarda dove ci ha portato tutto questo raziocinio. Probabilmente se fossi cittadino USA alla fine voterei comunque per la Harris, per il semplice motivo che me lo chiede Bernie Sanders. Se mi sforzo, qualche motivo per preferirla a Trump lo trovo. La deriva ormai esplicitamente nazista di tanti sostenitori di quest'ultimo; il rischio (ormai concretizzato) di una Corte Suprema blindata a destra nei decenni a venire; l'idea che il tizio possa mettersi a improvvisare sul fronte di quella che tra Ucraina e Iran sembra sempre più una guerra mondiale: certo che alla fine sceglierei la Harris. Ma con la consapevolezza di dover scegliere il genocida più efficiente, quello che sporcherà meno.
– L'amministrazione democratica, ci dicono, ha ottenuto grandi risultati per quanto riguarda l'economia. Ci fa tanto piacere; nel frattempo i giovani ucraini sono decimati, la Germania è in stato confusionale, la Corea del Nord combatte per la prima volta su un fronte europeo, i talebani hanno vietato la diffusione della voce femminile (sì, anche il ritorno dei talebani a Kabul è responsabilità dell'amministrazione Biden), i turchi fanno quel che gli pare in Kurdistan e d'altro canto che gli vuoi dire, nel mentre che Israele bombarda al tappeto Gaza e Palestina e dichiara guerra alle Nazioni Unite? Però l'economia tira, ebbene, magari c'era modo di farla tirare senza precipitare il mondo in questa catastrofe. Tutto questo, duole dirlo, è successo nei quattro anni di Biden e sarebbe successo anche senza la parentesi di Trump – stava a Biden tentare un riavvicinamento all'Iran che avrebbe allentato la tensione in Medio Oriente, e non l'ha fatto. Stava a Biden sbloccare la questione palestinese, ma siamo onesti: nemmeno Obama ci aveva provato, cosa avrebbe potuto fare il vecchietto? Stava a Biden evitare che il ritiro dall'Afganistan diventasse una rotta, e non l'ha evitato. Stava a Biden evitare che la tensione in Donbass degenerasse in guerra aperta, ed eccoci qui. Nemmeno Nixon presenta ai posteri un conto tanto sanguinoso, o almeno bisogna ammettere che i massacri perpetrati in America Latina durante l'amministrazione Nixon almeno portavano vantaggi concreti; laddove è veramente difficile capire quali vantaggi strategici siano arrivati a Washington dalla guerra in Ucraina o dal genocidio palestinese. Non dico che siano guerre perse, non è affatto detto che alla fine non le vinceranno: ma sono guerre terribilmente stupide. Potrebbe averle davvero prese un anziano in stato confusionale, o comunque una classe dirigente anziana, abbandonata alla sua inerzia.
– Otto anni fa Trump era ancora considerato un outsider rispetto al ventre molle del Partito Repubblicano; oggi né è il volto più presentabile (il meno peggio!), e la sua stramberia può essere recepita dagli elettori come rassicurante: il ricordo di quattro anni in cui tutto sembrava più semplice. Nel frattempo l'emergenza climatica comincerà a presentare il conto, il che metterà a seria prova la tenuta di tutte le democrazie – non solo gli USA. Ne abbiamo avuto un timidissimo assaggio durante il covid, per cui se vogliamo farci un'idea di come reagirà alla crisi un'eventuale amministrazione Trump2, dobbiamo ricordare come reagì nei mesi del covid. Grosso modo, come tutti i governi occidentali; con qualche lentezza, senza troppo rivendicare le sospensioni delle libertà individuali, ma la paventata fuga nella Negazione non ci fu. Il mondo non è un romanzo di David Foster Wallace, anche se le somiglianze sono innegabili. È chiaro che al suo posto preferirei un presidente che metta al primo punto all'ordine del giorno la fine della dipendenza dagli idrocarburi, ma è anche chiaro che Kamala Harris non è quella presidente.
– Una postilla su Elon Musk, che abbiamo canzonato per quattro anni perché si era comprato quella sola di Twitter, e adesso magari ci vince le elezioni. Può darsi che il capitalismo, nella sua accelerazione, abbia già raggiunto la velocità di fuga dalla realtà, per cui passeremo gli ultimi anni prima dell'estinzione di massa a finanziare missioni su Marte a un bambinone bianco un po' sudafricano. Se andrà così, non potremo dire di non essercene accorti in tempo. Avevamo tutti gli strumenti per frenare in corsa, tranne forse la volontà. Non siamo quel tipo di specie che frena, anche quando i segnali sono chiarissimi. Le formiche forse avrebbero fatto di meglio; forse faranno di meglio. Di noi magari non resterà che qualche razzetto inutile in un posto dove nessuno potrà respirare per trovarlo.
Israele uccide chi vuole, quando vuole, ovunque vuole; e dovremmo smetterla di farci domande
05-04-2024, 02:01Americana, Israele-PalestinaPermalinkSembra successo tutto in un giorno, che per qualche perverso motivo è stato il primo aprile 2024.
Fino a tutto il marzo di quest'anno potevamo ancora essere convinti che:
– I giornalisti avessero ogni diritto di documentare quello che avviene in un teatro di guerra.
– I volontari delle ONG che portano aiuti nelle zone di guerra – col consenso delle forze belligeranti – fossero tutelati, prima ancora che da qualche codicillo internazionale, da un principio di buon senso e di umanità.
– I messaggeri fossero sacri. Lo sono da millenni; è un principio che nell'era contemporanea è stato formalizzato nella definizione di immunità diplomatica. Gli ambasciatori risiedono in sedi extraterritoriali che anche nelle fasi più cruente di una guerra o di un bombardamento non sono mai stati obiettivi militari.
Poi è arrivato il primo aprile, Netanyahu ha annunciato che Al Jazeera non avrà più diritto di operare in Israele (e nei territori che Israele evidentemente occupa), nel mentre che l'esercito israeliano bombardava una sede diplomatica iraniana a Damasco e prendeva di mira, uccidendoli, sette cooperatori internazionali a cui aveva dato il permesso di circolare nella Striscia di Gaza. E a questa organizzazione che prende di mira i giornalisti, prende di mira i cooperatori internazionali, prende di mira i diplomatici, e non lo nega, anzi ormai lo rivendica come suo specifico diritto, noi cosa diremo? La accuseremo di terrorismo, visto che ci terrorizza? La pregheremo di non proseguire quello che un tribunale internazionale ha più volte in questi mesi definito un genocidio? Nel frattempo l'amministrazione Biden le venderà qualche altro jet di guerra di ultima generazione; armi forse un po' esagerate finché l'obiettivo è desertificare la Striscia; ma la speranza ormai evidente è che scoppi presto una guerra diretta con l'Iran; del resto se bombardi un'ambasciata non è che serva un esperto decifratore di messaggi.All these headlines are from the same day pic.twitter.com/rq1qj8sG5P
— Wyatt Reed (@wyattreed13) April 2, 2024
In occasione dell'insediamento
21-01-2021, 03:25Americana, tv, TwitterPermalinkIl Miraggio Rosso (e Bianco, e Blu).
03-11-2020, 23:36Americana, referendum costituzionale 2016PermalinkA un certo punto cominciammo a pensare che poteva anche funzionare come spettacolo. Dall'altra parte del mondo eleggevano la persona più importante del mondo: chi fosse riuscito a stare sveglio di più sarebbe stato il primo a scoprirlo. Per i giornalisti, soprattutto, era molto eccitante: per noi spettatori molto meno, ma ci lasciavamo contagiare dal loro entusiasmo.
Col tempo iniziammo a far caso alla liturgia, e come succede sempre ai neofiti non è che riuscissimo sempre a distinguere cos'era accessorio e cos'era fondamentale: per esempio a un certo punto della nottata capitava che il candidato che stava perdendo convocasse una conferenza stampa e riconoscesse pubblicamente la sconfitta: il cosiddetto "concession speech". La cosa aveva un senso più cerimoniale che effettivo: i voti comunque si contavano fino alla fine, e almeno una volta successe pure che un candidato che aveva concesso la vittoria convocasse un'altra conferenza stampa per rimangiarsela, perché i conteggi andavano per la lunga e anzi valeva la pena chiedere i riconteggi. Però questa cosa del "concession speech" ci rimase, chissà perché. Forse perché siamo mediamente italiani progressisti, ovvero votati alla sconfitta fin da piccoli: e il fatto che un candidato la potesse riconoscere con un bel discorso ci affascinava. Questo malgrado il meccanismo reale fosse molto più complesso, se non proprio farraginoso, con passaggi intermedi ancora ottocenteschi (i Grandi Elettori...)
A un certo punto, come accade sempre con le cose americane, ci si è messo di mezzo il cinema o la tv, coi suoi presidenti molto più veri del vero, i discorsi meglio scritti, gli applausi e i violini ai momenti giusti eccetera, e questo ha fatto colpo su molti di noi molto più di quanto lo ammettessimo. Il confronto con la nostra imperfetta democrazia parlamentare, coi suoi ritmi sonnacchiosi e mediocri, non ammetteva appello. In molti dei più impressionabili tra noi si creò ben presto una convinzione: loro non erano solo la democrazia più vecchia del mondo (e le Province Unite?); erano anche la migliore. Ed erano la migliore non perché fossero i migliori a raccontarsela, come pure Hollywood dimostrava, ma perché... la notte delle elezioni, loro conoscevano già il Vincitore. A un certo punto della nottata, ci spiegavano, il candidato che ne stava prendendo troppe gettava la spugna, faceva un bel discorso, l'arbitro alzava il braccio dell'altro contendente, applausi. Guarda che ti sei sbagliato, rispondevamo, guarda che quella sera hai visto un match di boxe: e anche in quel caso non dovresti crederci troppo, c'è sempre una buona parte di spettacolo, a coprire gli aspetti più crudi. Tutto vano, ormai la carovana dei presidenzialisti italiani era partita, attirata da un miraggio televisivo, verso un deserto di imboscate, colpi bassi e referendum. L'America in cui volevano arrivare somigliava più a una puntata di West Wing con tutti gli attori impeccabili e competenti. Laggiù conoscono il vincitore nella notte delle elezioni, dicevano! E parlavano di un Paese in cui conteggi e riconteggi possono durare settimane, tanto che da sempre le elezioni avvengono tre mesi prima dell'insediamento effettivo. Già le elezioni del 2000 avevano dimostrato quanto importante fosse la Corte Suprema; ma forse pensavamo che un senso di decenza non esplicitato in nessuna Carta Costituzionale avrebbe trattenuto un presidente uscente dal blindarla in suo favore.
Tante cose pensavamo impossibili, che ora si sono avverate. Per esempio stasera abbiamo un candidato che a un certo punto della nottata potrebbe dire che ha vinto anche se non è vero. Uno scenario che Sorkin non aveva previsto, il che ci lascia tutti un po' sgomenti a fissare il vuoto. In un qualche modo sembra che lo Spettacolo abbia preso il sopravvento – una conferenza stampa avrebbe il potere di invalidare scrutini ancora in corso. Il consiglio migliore è sempre quello di andare a letto non troppo tardi: tanto domattina mezz'ora dopo la sveglia ne saprete già quanto quelli che hanno fatto la maratona. Io ovviamente spero che perda Trump, anche se non sono del tutto sicuro che sia la cosa migliore per me in quanto cittadino europeo. In un certo senso il suo primo mandato non poteva dimostrare meglio un vecchio assioma in cui non ho mai smesso di credere, ovvero che l'aggressività esterna sia un modo per scaricare un'energia interiore che altrimenti ci dilanierebbe: credo valga per molte persone e anche per interi popoli. Trump ha ridotto in modo spettacolare l'interventismo delle forze armate USA (senza smettere di finanziarle), e il risultato è un Paese che appare più dilaniato che mai. A questo punto, cosa dovrei desiderare? Quattro anni di tregua con Biden, o lasciare che certi nodi sociali vengano al pettine? Non lo so. Per fortuna non dipende da me. Tra un po' vado a letto e spero di prender sonno. Ho già tanti pensieri, immagino anche voi.
Facce nere e teste dure
31-08-2020, 08:00Americana, razzismiPermalinkFaccio un breve riassunto per chi è nato nel frattempo: negli anni Zero si sviluppò un dibattito giornalistico sull'opportunità o no di disegnare il profeta dell'Islam, e in particolare in vignette satiriche. Questo in una situazione in cui la comunità islamica (sempre più importante in Europa) insisteva abbastanza compattamente sul fatto che raffigurare il volto di Maometto, anche in situazioni non satiriche, fosse blasfemo e offensivo. Il che portò alcuni difensori della libertà di parola e di stampa su posizioni islamofobe, e molti islamofobi a diventare improvvisamente difensori della libertà di parola e di stampa. Fu insomma una delle occasioni in cui prese forma, anche in Europa, quel blocco libertario di destra che negli USA è poi diventata la base del consenso di Trump. Dal canto loro gli integralisti islamici non persero l'occasione per accreditare l'immagine più oscurantista della loro religione: la rivista satirica Charlie Hebdo fu vittima di due attentati; nel secondo la redazione fu massacrata. Ovviamente la stampa europea rispose ribadendo il principio della libertà di stampa e di espressione, mentre dagli USA arrivavano reazioni molto più sfumate: non era affatto impossibile, dall'altra parte dell'Atlantico affermare che i vignettisti francesi se la fossero cercata. Un approccio del genere – cercavo di spiegare – dipendeva dal modo in cui in Nordamerica le minoranze avevano lottato per trovare un modus vivendi, anzi convivendi. E a questo punto mi veniva spontaneo fare l'esempio del Blackface, in quanto tabù arbitrario, imposto da una minoranza e accettato come tale:
Il juke-box dell'indignazione (appunti)
13-06-2020, 11:18Americana, giornalisti, indignazione, razzismiPermalinkLo trovo buffo perché gli USA per tanti versi mi sembrano molto più lontani oggi che venti o trent'anni fa. Il primo esempio che mi viene è la musica: chi segue le classifiche dei brani più venduti e ascoltati sa che quella italiana da qualche anno è quasi completamente autarchica. Dei divi pop americani e inglesi sentiamo ancora parlare molto sui media ma le loro canzoni le ascoltiamo sempre meno – soprattutto i più giovani. C'entra anche il fatto che le canzoni sono sempre meno originali da un punto di vista musicale e sempre più parlate, il che porta non solo gli italiani a preferire il prodotto realizzato nella lingua madre, per quanto ricalcato sui modelli americani. Il che significa anche: rispetto a vent'anni fa magari li copiamo di più ma li capiamo di meno. E anche chi l'inglese in teoria lo sa, lo legge, lo ascolta sottotitolato nelle serie in streaming – non può a volta fare a meno di domandarsi se quel che succede a noi ha un senso o è solo un calco troppo letterale di cose che non capiamo del tutto.
Ad esempio: negli USA un crimine di polizia risveglia il movimento Black Lives Matter, e noi improvvisamente cominciamo a inginocchiarci per la minoranza afroamericana – per carità tutto giusto, ma non potremmo cominciare dalle nostre minoranze, quelle che restano più spesso vittima del nostro razzismo e dei crimini delle nostre forze di polizia? Domanda abbastanza retorica, scusate. Poi scopriamo che negli USA i manifestanti se la prendono con una statua di uno schiavista o di un esploratore e improvvisamente anche noi ci rimettiamo a discutere di una statua – col piccolo problema che statue di schiavisti non ne abbiamo. Ne abbiamo anche poche dei fascisti (del periodo c'è rimasta più architettura che statuaria, e quella è più problematica da rimuovere). E quindi?
E quindi tiriamo fuori il solito Montanelli. Sul quale non ho molto da aggiungere a quanto ho scritto un anno fa, salvo che nel frattempo Severgnini mi ha convinto: quella statua va proprio abbattuta. Non che io abbia letto tutto il pezzo di Severgnini eh? Mi dispiace, dev'esserci un paywall. Mi è bastato il boato delle reazioni, e in generale non apprezzo questa cosa di mandar fuori Severgnini a minimizzare crimini di guerra, manco fosse la Fallaci in stadio terminale: non credo che sarà ricordata come una pagina gloriosa del giornalismo italiano: facciamo che almeno sia l'ultima, buttiamo via il bronzo e non pensiamoci più. Altrimenti tra dieci mesi, un anno, saremo di nuovo lì, sapete? E la prossima volta chi immoleranno? Galli della Loggia? Panebianco? Tiratela giù, date retta. Mettiamola così: o tirate giù una statua che sta diventando un'autocelebrazione insensata del giornalismo italiano (che nessuno a parte i giornalisti italiani sentono la necessità di celebrare), o almeno tirate giù quei paywall che tra un po' nessuno vorrà darsi la pena di scavalcare legalmente.
Rimane il fastidio per una questione che si ripresenta a ondate, e le ondate partono sempre da quel posto oltreatlantico la cui musica ci interessa sempre meno, ma l'indignazione, ehi, con l'indignazione stiamo negli anni '50, è come se avessimo i juke-box coi dischi d'importazione: questa settimana vogliono tutti indignarsi per lo schiavismo, qualche tempo fa non si parlava che di abusi sessuali ecc. ecc. Ora non vorrei essere frainteso (ma so che è inevitabile): sono tutte questioni gravi di cui è sacrosanto parlare, però sarebbe bello che l'agenda ce la scrivessimo da soli, con le nostre scadenze e le nostre necessità, senza andare a rimorchio di hashtag, senza complessi di inferiorità per una civiltà che non è la nostra, e a volte semplicemente non capiamo.
Che è poi il principale guaio con gli americani: siamo così abituati a vederli sugli schermi che li troviamo familiari – molto più di cinesi, indiani, ma persino tedeschi – salvo che è una falsa familiarità. Ad esempio, quando parlano di statue, loro fanno riferimento a un paesaggio urbano e a un modello sociale molto diverso dal nostro. Loro hanno davvero migliaia di statue che rappresentano schiavisti o altre figure controverse. E le hanno perché la loro società nasce dall'incontro/scontro tra diverse comunità che in momenti diversi hanno deciso hobbesianamente di venire a patti invece di ammazzarsi. Lungi dal rappresentare una "storia condivisa", i loro monumenti sono una prosecuzione della guerra civile con altri mezzi. Così i bianchi del sud innalzano statue ai condottieri sconfitti della Confederazione, i nativi americani conservano il sogno di un Crazy Horse Memorial che superi in altezza il Monte Rushmore, e gli italoamericani si erano scelti Colombo. È una guerra fredda civile che si è estesa anche al linguaggio: il "politically correct" non è un codice imposto da una casta di altezzosi intellettuali, ma un protocollo di armistizio perpetuamente in discussione: una minoranza chiede che una parola sia considerata inaccettabile, le altre comunità decidono di accettare la cosa e il protocollo viene aggiornato. Il dibattito non passa per il dipartimento linguistica perché è una questione politica, appunto, non linguistica.
È il concetto nordamericano di tolleranza: almeno chi si riempiva la bocca di Tocqueville ai tempi dell'Esportazione della Democrazia dovrebbe averne notato le differenze rispetto a quello dell'Europa continentale – dove vige, tutto sommato, la logica giacobina per cui chi vince una rivoluzione si prende tutto lo spazio monumentale, abbatte tutto quello che non riesce a riconvertire e fa spazio per monumenti nuovi, mentre chi perde sta fermo un giro e aspetta la rivoluzione successiva. (L'ho chiamata "giacobina" ma forse è una logica più antica, se la Chiesa a un certo punto riconvertì pure il Colosseo). Questo non significa che non abbiamo monumenti discutibili, ma ne abbiamo molti meno e la loro funzione identitaria è più sfumata. Per contro, vivendo intorno a centri urbani di origine medievale, siamo forse ossessionati dalla durata, e ci basta un secchio di vernice su una statua per paventare una damnatio memoriae. Non credo che Montanelli verrà dimenticato se gli tirano giù la statua, anche se confesso di provare una certa nostalgia per quando era un essere vivente che si poteva criticare per le sue opinioni e non un feticcio da condannare per crimini di guerra di mezzo secolo prima ripescati da un dossierino. Poi ripeto: credo che sarebbe utile distinguere la pedofilia (che è un orientamento sessuale) dalla mentalità razzista e criminale dei membri dell'esercito coloniale italiano. Ma sembra sia una distinzione troppo raffinata per l'internet, pare che non sia il momento per i sottili distinguo, bisogna tutti indignarsi e abbattere statue. Potrei anche accettarlo, eh? I movimenti alla fine sono così, spontanei e sommari.
Poi dopodomani in America qualcuno libera un campo di concentramento di visoni, e alè, tutti spontaneamente e sommariamente a liberare i visoni. E se non ne abbiamo? Cessate la caccia alle nutrie! come abbiamo potuto tollerare fino a ieri questa barbara usanza?
La prego mister Vittimismo
07-06-2020, 12:30Americana, giornalistiPermalinkNon riesco a respirare.
Still I Rise
03-06-2020, 12:14Americana, poesia, razzismiPermalinkYou may write me down in history
With your bitter, twisted lies,
You may trod me in the very dirt
But still, like dust, I'll rise.
Does my sassiness upset you?
Why are you beset with gloom?
’Cause I walk like I've got oil wells
Pumping in my living room.
Just like moons and like suns,
With the certainty of tides,
Just like hopes springing high,
Still I'll rise.
Did you want to see me broken?
Bowed head and lowered eyes?
Shoulders falling down like teardrops,
Weakened by my soulful cries?
Does my haughtiness offend you?
Don't you take it awful hard
’Cause I laugh like I've got gold mines
Diggin’ in my own backyard.
You may shoot me with your words,
You may cut me with your eyes,
You may kill me with your hatefulness,
But still, like air, I’ll rise.
Does my sexiness upset you?
Does it come as a surprise
That I dance like I've got diamonds
At the meeting of my thighs?
Out of the huts of history’s shame
I rise
Up from a past that’s rooted in pain
I rise
I'm a black ocean, leaping and wide,
Welling and swelling I bear in the tide.
Leaving behind nights of terror and fear
I rise
Into a daybreak that’s wondrously clear
I rise
Bringing the gifts that my ancestors gave,
I am the dream and the hope of the slave.
I rise
I rise
I rise.
[Ho sempre trovato buffo che il capolavoro di Ben Harper fosse una canzone in cui non suona la chitarra. Nemmeno le parole sono sue, ma di una poetessa che è un personaggio abbastanza incredibile, Maya Angelou. In altri casi quando una cosa mi piace molto provo a tradurla; qui oltre alla famosa questione dell'appropriazione culturale c'è proprio lo scoglio di quel verbo, rise, che in inglese suona spontaneo sia che si tratti di polvere scossa da uno straccio sia di un popolo che si ribella. Qualsiasi equivalente italiano mi suona falso o letterario, un bel problema: ma non il problema di cui si parla qui].
Il chiasso in una casa
15-05-2020, 02:40Americana, anglistica, epidemia 2020, poesia, traduzioniPermalink |
| (Scusi). |
nel dì dopo il decesso
è il più incombente incarico
in tutto l'universo –
Lo spazzolare il cuore
e il metter via l'amore
che non vorremo usare più
fino all'Eternità –
Kateri, il giglio dei Mohawk
17-04-2020, 03:01Americana, repliche, santiPermalink[2014]. Di solito gli irochesi attaccano su due fronti; accerchiano il villaggio; uccidono i guerrieri feriti, gli anziani, i bambini troppo piccoli e in generale chi non reggerebbe la fatica di un lungo viaggio a piedi. Ai restanti prigionieri viene tagliato un dito a scopo di identificazione; nel frattempo un messaggero viene mandato al villaggio per avvertire che la piccola guerra è andata bene. Lungo il cammino i prigionieri che cadono vengono terminati rapidamente a colpi d'ascia e abbandonati insepolti. Quando finalmente arrivano al villaggio, un capannello di osservatori si fa avanti per percuoterli un po'. Vengono spogliati e torturati con più professionalità dalle donne, specie le più anziane ed esperte. A questo punto venivano nutriti e potevano riposare; quindi erano fortemente invitati a danzare in cerchio mentre il consiglio del villaggio deliberava sul loro destino. I nuclei famigliari che avevano avuto un lutto recente avevano la facoltà di adottare uno dei prigionieri, che in caso contrario veniva ulteriormente torturato, ucciso e parzialmente mangiato. Il prigioniero adottato diventava membro della famiglia a tutti gli effetti, e dalla sua disponibilità a impersonare il parente precedente morto in guerra o in malattia dipendeva la sua sopravvivenza: se non riusciva a integrarsi poteva essere ucciso anche dopo qualche anno. Anche la madre di Kateri Tekakwitha divenne mohawk in questo modo, quando era bambina. Di nascita era algonchina, di una tribù cattolica e filofrancese; gli irochesi (di cui i mohawk facevano parte) in questa fase acquistavano armi da olandesi e inglesi, e attaccavano i francesi che si ostinavano a comprare pelli di castoro da altri popoli.

Gli irochesi erano tutto meno che un popolo in simbiosi con la natura. Giunti da sud nel medioevo, miravano a diventare la potenza egemone di tutta la zona tra i Grandi Laghi e il Mississippi che in alcune mappe europee si chiamava invece Nuova Francia. La loro idea di egemonia prevedeva il genocidio e l'assimilazione delle tribù nemiche. Da un punto di vista economico, miravano al monopolio della vendita di pelli del castoro gli europei, e questo era un buon motivo per combattere contro le tribù alleate dei francesi. Pazienza se nel frattempo la caccia sistematica dell'animale lo stava portando all'estinzione in una vasta porzione del suo habitat. Cacciatori e guerrieri erano costretti a viaggi sempre più lunghi, il che aumentava il prestigio e l'importanza delle donne che restavano a casa. Alle donne appartenevano terreni e abitazioni; soltanto loro conoscevano i misteri delle "tre sorelle" (mais, fagioli, zucche), senza le quali anche i più potenti guerrieri non avrebbero saputo come riempire la scodella quotidiana. E tuttavia le donne dovevano sposarsi e avere figli: era l'unico destino concesso. L'infertilità era connessa con la stregoneria e con altre sciagure. D'altro canto, divorziare sembrava straordinariamente facile: bastava posare i mocassini del marito fuori dalla casa.
 |
| non molto credibile |
Nella stessa epidemia però Kateri aveva perso la famiglia e la bellezza: i segni del vaiolo le sfiguravano la fronte. Aveva anche una vista assai debole, il che non le impediva di essere un'artigiana molto abile. La zia che l'allevava non aveva probabilmente né l'interesse né la possibilità di trovarle un guerriero bello e forte: bisognava arrangiarsi. Le fonti gesuite ovviamente non scrivono così, bensì:
Tekakwitha crebbe senza scuola e senza studio, amante soltanto della solitudine e del lavoro, ma la grazia di Dio la condusse per vie misteriose alla pratica eroica di tutte le virtù, specialmente di quella più sconosciuta agli Indiani, la castità.E può anche darsi che abbiano ragione; che Kateri non disprezzasse unicamente il suo promesso sposo, ma il matrimonio e il congiungimento carnale in sé. Persone del genere esistono in tutte le culture e a tutte le latitudini. Fu la scelta di non sposarsi - che nella cultura mohawk l'avrebbe portata dritta a un'accusa di stregoneria - ad avvicinarla ai "vestenera", i missionari gesuiti. Ogni villaggio ne aveva uno: lo prevedeva una clausola di una pace da poco firmata coi francesi. Qui bisognerebbe aprire una parentesi enorme sul ruolo dei gesuiti, che abbinavano a una devozione fanatica una duttilità etnologica veramente in anticipo sui tempi. Ovunque arrivano - e arrivano ovunque, sprezzanti dei rischi di martirio - i gesuiti sanno di non trovarsi semplicemente in mezzo a selvaggi, ma al cospetto di culture da interpretare e studiare. Saranno i primi a pubblicare grammatiche giapponesi e azteche; ma a differenza degli antropologi di oggi, che sono portati a considerare ogni popolo come una nicchia da preservare, anche a costo di impedirsi di conoscerla, i gesuiti sono in missione per conto di Dio. La cultura che si portano con sé, dall'Europa sconvolta dalle guerre di religione, la vogliono spargere nel Nuovo Mondo, innestandola su piante autoctone ed esotiche, nella speranza che da qualche parte nella foresta o nella jungla nasca qualcosa di simile a un regno dei cieli, o anche solo una Repubblica di Indios conversi come in Paraguay. Anche in Nuova Francia erano riusciti a farsi intestare delle seignuries, dei feudi. Il piano era infettare le Sei Nazioni come un virus, portando armi e sacramenti.
 |
| più credibile |
Nei villaggi Mohawk nasceva la contrapposizione tra clan filo-francesi e filo-inglesi. I francesizzanti erano cattolici e meglio armati: i gesuiti riuscivano anche a trafficare armi, benché la cosa non andasse a genio alle guarnigioni francesi. I filo-inglesi difendevano le tradizioni, i riti degli antenati; e anche l’alleanza con gli europei protestanti era a quel punto una tradizione secolare (i protestanti non avevano mai cercato di evangelizzarli; al massimo di ubriacarli con l’acqua-di-fuoco). Gli zii di Kateri erano filo-inglesi e non consentivano ai gesuiti di entrare nella loro casa. D’altro canto erano spesso fuori loro, lo zio a caccia e la zia nell’orto; i gesuiti invece erano liberi di curiosare a casa di chiunque, e presto o tardi padre Jacques Lamberville incontrò anche la diciottenne Kateri.
 |
| Facciata della basilica di Sainte-Anne-de-Beaupré, dalle parti di Quebec City. |
Le fonti gesuite raccontano con dovizia di particolari la vita difficile della conversa Kateri, perseguitata da zie e zii che la volevano sposa e pagana. Monelli del villaggio assoldati per insultarla e prenderla a sassate “al grido di cristiana”. Aggressori inviati dallo zio a “minacciarla di morte facendole roteare una scure sopra il capo”, a cui avrebbe risposto: “Eccomi pronta. Puoi togliermi la vita, ma non la fede”. L’atmosfera diventò veramente pesante solo quando qualcuno mise in giro la voce di una tresca col padre adottivo. Discutendo in pubblico, Kateri lo aveva nominato senza soggiungere, secondo l’uso, l’espressione “mio padre”. Per qualche vecchia malelingua di famiglia questo equivaleva a un’ammissione di colpa.
Ai mohawk filofrancesi, quando se la vedevano brutta, restava la possibilità di scappare nel Canada francese. I gesuiti li aspettavano a braccia aperte: il villaggio che avevano fondato per loro vicino a Salto San Luigi si chiamava Caughnawaga, come quello vecchio dall’altra parte del fiume. Kateri arrivò nel 1677, con una lettera di raccomandazione di padre Jacques.
“Caterina Tekakwitha viene a Salto San Luigi. Vi prego di volervi interessare della sua direzione. Conoscerete presto il dono che vi facciamo; è un tesoro”.I gesuiti di Salto San Luigi non conobbero mai veramente Tekakwitha. Esteriormente, non fece nulla per deludere le aspettative di chi si immaginava un miracolo di castità, il “giglio dei mohawk”. Le pratiche sadomasochistiche che già probabilmente aveva coltivato al villaggio rimasero confinate all’ambito delle sue nuove amiche, tra cui Anastasia Tegonhatsiongo, che aveva conosciuto sua madre, e l’amica del cuore Maria Teresa Tegaiaguenta. Padre Pierre Chaulenec scrive dell’entusiasmo con cui Kateri si accostò al sacramento della Prima Comunione; della sua dedizione al lavoro e alla preghiera; del pudore che le infiammava il volto vaioloso ogni volta che udiva un complimento. Solo di sfuggita accenna alla sua passione per il flagello, durante sessioni che prevedevano tra le millecento e le milleduecento frustate.
Alla ricerca di un terreno comune, uomini gesuiti e donne irochesi lo avevano trovato nel masochismo. Cholenec aveva introdotto flagelli, cilici e cinture di ferro, nella speranza di soppiantare le torture tradizionali. D’altro canto i convertiti e le convertite avevano la sensazione che i gesuiti non raccontassero tutta la storia. L’idea che il dolore auto-inflitto portasse a un’alterazione della coscienza simile a uno stato mistico era già presente nella loro cultura originale: i flagelli dei gesuiti sembravano suggerire la stessa idea, ma i vestenera sembravano restii a condividere tutti i loro segreti. Nel frattempo Anastasia aveva fondato una confraternita di donne che metteva insieme il meglio delle torture europee e amerindie. Kateri dormiva su un tappeto di spine; si praticava tagli rituali; si bruciava con carboni ardenti e si gettava nel fiume in pieno inverno. Nel giro di quattro inverni era morta: aveva 24 anni. I gesuiti al suo capezzale raccontano che il volto, dopo la morte, perse ogni segno del vaiolo e divenne bellissimo. Anastasia la vide risorta ai piedi del suo stesso letto, con in mano una croce luminosa. Maria Teresa udì soltanto la sua voce nel bosco: Di’ al padre che vado in cielo, Adieu. Sulla sua tomba scrissero Ownkeonweke Katsitsiio Teonsitsianekaron, “il più bel fiore mai cresciuto tra i pellerossa”.
La sua venerazione, immediatamente promossa dai gesuiti, incontrò numerosi ostacoli: nel Settecento dopo la guerra dei Sette anni i francesi abbandonarono il Nordamerica; nel frattempo l’ordine gesuita veniva sciolto. Anche gli irochesi furono sconfitti da George Washington (“il Distruttore di Città”). Nel Settecento viene ricordato almeno un miracolo – necessario per qualunque causa di canonizzazione: un gesuita avrebbe curato un bambino protestante dal vaiolo con un frammento ligneo della bara di Kateri – prima però il bambino aveva dovuto convertirsi al cattolicesimo.
A prendere sul serio la causa di Kateri fu la comunità cattolica statunitense, che a metà Novecento non poteva ancora vantare un santo autoctono. Nel 1943 – un anno delicato per i rapporti con gli USA – Pio XII si limitò a dichiararla venerabile. Persino Giovanni Paolo II, il più grande canonizzatore di tutti i tempi, si contentò di renderla beata, segno che alla gerarchia la ragazza mohawk che amava le frustate non è mai realmente andata a genio. Non le hanno nemmeno dedicato una chiesa: soltanto una cappella nella chiesa di S. Francesco Saverio, a Montreal. Kateri è diventata santa a tutti gli effetti soltanto nel 2012, in una delle ultime cerimonie di canonizzazione celebrate da Benedetto XVI. Oggi il vecchio accampamento di Caughnawaga si trova all’interno dell’area metropolitana di Montreal: vi hanno sede almeno una decina di casinò on line, e pare ci sia un fiorente commercio di sigarette di contrabbando.
Prima ancora che le gerarchie cattoliche si interessassero realmente a lei, nel 1966 Kateri era diventata un’eroina di primo piano nel complesso romanzo di un giovane e brillante scrittore canadese, Beautiful Losers. L’insuccesso spinse il suo autore ad abbandonare la letteratura e a concentrarsi sulle canzoni; peraltro se era riuscito a sfondare Bob Dylan, con quella voce, avevano tutti quantomeno il diritto a provarci, no? Si chiamava Leonard Cohen.
Il più efferato eccidio
06-04-2020, 12:32Americana, Bob Dylan, epidemia 2020, Il Post, musicaPermalinkMurder Most Foul (singolo di Bob Dylan, pubblicato all'improvviso il 27/3/2020)
giorno d’infamia per l’eternità...
Buongiorno a tutti, mi chiamo Leonardo e se leggete il Post da un po' forse mi conoscete per quella menata interminabile che sto facendo sulle canzoni dei Beatles – ecco, prima di quella ce ne fu ancora più interminabile sui dischi di Bob Dylan: l'idea era scrivere un pezzo su tutti i dischi del premio Nobel più pazzo della storia della Letteratura, uno alla settimana, e dopo un anno non era ancora finita. Gettai la spugna in occasione di Tempest, il suo ultimo disco di inediti. Davanti a me avevo ancora i suoi tre dischi di cover di Sinatra (il terzo dei quali, appena uscito, era triplo) e non sapevo davvero come affrontarli. Del resto intuivo già che sarebbe stato uno sforzo vano: anche se avessi avuto la velocità di reazione di Achille, sapevo che Bob la Tartaruga avrebbe continuato ad allontanarsi: qualche mese dopo uscì un cofanetto imprescindibile sul suo periodo gospel, qualcosa tipo otto cd.
In seguito che altro è uscito, dunque: #1, un'antologia doppia dei live '62-66 (i ventenni che lo andavano a fischiare al tempo oggi si svenano per acquistare i cofanetti deluxe); #2, un disco con le versioni alternative di Blood On the Tracks, che oltre ad avere un indubbio valore storico sono anche un ascolto gradevole per chi non dedica a Dylan la sua esistenza; #3, la colonna sonora del film che Scorsese ha dedicato alla sua Rolling Thunder Revue; #4 un'altra collezione di versioni alternative del suo periodo country, con tanti duetti con Johnny Cash... e poi qualche giorno fa, forse ne avete sentito parlare, sulle piattaforme di streaming è comparsa all'improvviso una cantilena di 16 minuti intitolata Murder Most Foul ("il più efferato delitto" in inglese shakespeariano). Ora, per quanto non sia il più semplice degli ascolti, si tratta del primo inedito di Dylan dopo otto anni: una pausa ancora più lunga di quella che si prese quasi per tutti gli anni Novanta, tra Under the Sky e Time Out of Mind. Non che nel frattempo se ne sia stato zitto e fermo, il Bardo: ha inciso cover su cover e continuato il suo cosiddetto "tour infinito", che negli anni buoni lo ha portato a suonare più di cento concerti all'anno. Murder Most Foul è comunque il primo brano dopo una lunga astinenza volontaria e... dobbiamo proprio dirlo? Potrebbe anche essere l'ultimo.

Dylan in maggio compirà 79 anni. Non è un periodo semplice per gli anziani, questo: soprattutto per gli anziani che non sanno restare fermi e Dylan a volte è sembrato quel tipo di anziano. Un suo ex chitarrista si è già preso il coronavirus dopo aver suonato a un concerto: ci suonava anche Jackson Browne e pare l'abbia preso pure lui. Speriamo che Dylan abbia preferito stare in casa, memore magari di quella brutta istoplasmosi che nel '97 rischiò di fare di Time Out of Mind un disco postumo.
E però anche questa scelta di pubblicare una canzone all'improvviso, proprio adesso... è un brano su Kennedy, realizzato "qualche tempo fa", il che potrebbe voler dire in qualsiasi momento degli ultimi otto anni. Ci sono molti dettagli che fanno pensare che Murder sia più vicino a Tempest di quanto la data di uscita non ci faccia credere. Il più appariscente è il shakespearismo, se il titolo di Tempest era (come Dylan negò) un'allusione all'ultima opera di Shakespeare. Ultimamente Dylan pensa spesso a Shakespeare, non tanto come a un autore da cui prendere in prestito soluzioni, quanto a uno dei pochi colleghi col quale si può ancora confrontare – vedi quel brano spassoso e molto illuminante del suo bigliettino di ringraziamento agli accademici di Svezia, in cui confessa candidamente che dopo aver ricevuto la notizia del premio il primo autore che gli era venuto in mente era quello dell'Amleto, con le sue preoccupazioni più e meno banali (“Voglio veramente ambientarlo in Danimarca?” [...] “Dove posso procurarmi un cranio umano?”). L'avvicinamento ideale a Shakespeare spiega in parte un certo gusto per le descrizioni violente, gli eccidi e le stragi, che è un altro aspetto di Tempest che ritroviamo echeggiato in Murder (l'insistenza sul dettaglio di quel cervello a pezzi). E come in Tempest, Dylan non si preoccupa di esercitare un minimo di violenza anche sull'ascoltatore, infliggendogli un brano lunghissimo in cui la gabbia delle strofe si ripete uguale all'infinito. Murder potrebbe persino essere uno scarto di Tempest, per quel che ne sappiamo: e allora perché pubblicarlo proprio adesso?
 |
| Amleto (nel senso di Laurence Olivier) |
Un manager accorto – quel tipo di persona che Dylan non ascolta da mezzo secolo – gli avrebbe suggerito di aspettare un anniversario, se non il classico 22 novembre almeno il 29 maggio in cui l'ex presidente avrebbe compiuto 97 anni. Avrebbe avuto senz'altro più copertura, oggi che le canzoni si ascoltano in streaming e un link giusto da un organo d'informazione può voler dire milioni di ascolti in più... ma Dylan non ascolta nessuno, appunto (nemmeno sé stesso: continua a fare concerti proibendo a tutti di registrarli: tra tutti i dischi che pubblica, non esiste un'incisione ufficiale degli ultimi vent'anni di esecuzioni dal vivo). Può darsi che sia il modo tutto suo che ha trovato Dylan per dirci che sta bene – vi ricordate nei primi giorni del lockdown, quando un sacco di vip faceva le dirette streaming? Poi immagino abbiano smesso, io ricordo soltanto Jovanotti che suonava la chitarra per chiunque passasse, una cosa anche simpatica in fondo, una specie di panopticon però coi like e i cuoricini, se uno ha voglia di vedere come sta Jovanotti si sintonizza, ah ecco, suona la chitarra, sembra tutto ok, e Dylan invece? Dylan pubblica sedici minuti di peana sulla morte di Kennedy. Ok.
Ok cosa?
Ok boomer.
Cioè davvero mentre il mondo trema e si domanda come fronteggiare la prima vera pandemia mondiale e tutte le altre crisi economiche e ambientali che ne seguiranno – davvero questo epico reduce dei Sessanta è ancora lì a girare intorno al suo eterno chiodo fisso? Esatto, Dylan è ancora lì e non si muove. La sensazione è proprio quella di non potersi muovere, all'interno di un lockdown mentale che fa impallidire il nostro: poverini, siete in casa da un mese? Io sono rinchiuso nella mia testa da quasi 60 anni. Vi guardate le serie su Netflix? Io guardo il filmato di Zapruder 33 volte in una sera ("È orrendo, un inganno, è crudele, è cattivo, la cosa più brutta che si possa vedere..." ed è l'unica che gli manda in onda il cervello). Murder è una cantilena, non lo dico per offenderla, mi sembra la definizione tecnica più precisa. Una filastrocca tirata per le lunghe da un bambino posseduto. E va bene, illustre Dylan, abbiamo capito che è stato un trauma, il vero choc, la Fine di tutte le Speranze, ma anche l'Inizio, o forse l'Inizio di una cosa che era Finita sul nascere? Un'omega travestita da alfa? L'inizio di una linea temporale sostanzialmente sbagliata da cui Bob ha sempre voluto prendere le distanze – la tempolinea in cui ha rinnegato la sua militanza politica, ha incontrato i Beatles e si è improvvisato rockstar, ha fatto i veri soldi, poi si è quasi ammazzato in moto, ha tentato di nascondersi nel country, eccetera eccetera eccetera. Ecco, tutto questo Dylan sembra considerarlo completamente sbagliato, la deriva inevitabile di quel singolo momento ignominioso in cui spaccarono il cranio al presidente che sfilava per Dallas. Il peccato originale. Siamo perduti da quel momento, sembra volerci dire Dylan: e anche se avesse ragione, sentirla ribadire per sedici minuti non fa esattamente bene all'umore. Non potrebbe semplicemente strimpellare qualcosa come un Jovanotti qualsiasi, giusto per farci sapere che sta bene? No, Dylan è prigioniero di un incubo che torna sempre al momento dello choc primigenio. Se i sintomi nevrotici avessero diritto a una canzone, a Murder Most Foul toccherebbe la coazione a ripetere.

Anche l'ascoltatore che ha una certa esperienza delle interminabili litanie di Tempest, ci mette almeno un minuto su sedici a rassegnarsi all'idea che la filastrocca non è l'inizio in sordina di una canzone un po' più strutturata, e che basso chitarra e violoncello continueranno a cincischiare così all'infinito. Murder Most Foul non è solo una canzone che non finisce mai: è anche una canzone che non inizia mai, un'epica interrotta sul proemio, un Amleto senza vendetta, la storia di un Cavaliere che partiva per liberare l'America ma gli sparano alle spalle quando è appena uscito dal ponte levatoio. Ricorda un poco l'ultima uscita di un altro grande vecchio la cui strada si era appena incrociata con la sua, Martin Scorsese: o perlomeno la mia reazione di fronte a The Irishman non è molto diversa da quella che ho provato ascoltando Murder: cioè, aspetta, lo stai facendo di nuovo? Ancora mafiosi italoamericani, ancora ammazzamenti barbari, ancora le collusioni tra sindacato e malavita, ancora i teamsters? Ancora Hoffa? Dopo Stallone, dopo Jack Nicholson, ma non ce l'hanno avuto un altro sindacalista gli americani che ci dovete sempre raccontare della misteriosa scomparsa di Hoffa? Ma insomma illustre Scorsese, cosa potrai dirmi che non so già proprio perché me l'hai raccontato tu o qualche tuo sodale? Che altro potrò notare se non che la tua mano si è fatta più statica e pesante, i tuoi attori più legnosi e segnati da rughe contro cui poco può la computergrafica?
Ecco: Dylan, come Scorsese, sembra rassegnato a non poterci raccontare più di quello che ci ha già raccontato – è come l'anziano che proprio nel momento in cui cominciamo ad aver voglia di ascoltare le sue storie, scuote la testa sconsolato: le ha finite, può solo tornare su quelle che ha già raccontato e raccontarle in tono più greve, ogni volta un po' più greve. E sia nel caso di Dylan che nel caso di Scorsese la cosa è vera solo fino a un certo punto, ovvero: Scorsese di film sulla mafia non ne ha girati poi così tanti (eppure sembra l'autorità in materia); prima di The Irishman non aveva in realtà mai raccontato una storia di collusioni tra malavita e sindacato (eppure è come se lo avesse fatto), non aveva mai diretto Al Pacino (che sembra fatto apposta per i suoi film). E anche Dylan, quante canzoni aveva dedicato al caso Kennedy prima di Murder? Forse neanche una. Alcune poesie dattilografate a caldo (la più toccante dedicata a Jacqueline Kennedy), che non si trovano nemmeno nel sito ufficiale, e poi un apparente silenzio di 60 anni. L'idea che Dylan sia da sempre ossessionato dall'assassinio Kennedy è uno strano effetto ottico, un trucco di prospettiva. Proprio come Scorsese, che oltre a tornare su un tema già sviluppato (la mafia), si affida a elementi che già altri hanno reiterato prima di lui, non cita soltanto sé stesso ma anche il Padrino di Coppola e il Sergio Leone di C'era una volta in America; in un modo simile Dylan non sta raccontando l'assassinio Kennedy, ma attingendo dall'enorme mole del racconto collettivo che ne esiste già, piazzando qua e là veri e propri indovinelli per i conoscitori più esperti (nel distico “Slide down the banister, go get your coat/Ferry cross the Mersey and go for the throat" c'è un criptico riferimento a due agenti FBI coinvolti nell'inchiesta, Guy Banister e Dave Ferry).
 |
| Chi? |
Proprio come Scorsese che non si preoccupa di raccontare un'epopea mafiosa già cristallizzata da altri autori, allo stesso modo Dylan non si preoccupa affatto di ratificare, con Murder Most Foul, una leggenda smentita dagli storici ma in qualche modo più forte dell'evidenza: l'idea che la Beatlemania sia stata la reazione morale del popolo americano – o almeno della gioventù americana – alla morte di Kennedy. È un'idea affascinante che abbiamo sentito raccontare tante volte, forse mai tanto icasticamente quanto nella beatle-biografia di Philip Norman, Shout!
L'America – Brian [Epstein] non lo sapeva ancora – era già sua: si stava avvicinando alla sua conquista, senza accorgersene, mentre, lontano nel Texas, qualcuno puliva e controllava il meccanismo di un fucile ad alta velocità e sceglieva un punto favorevole da cui far fuoco. L'America si arrese a lui quella mattina di Dallas in cui il corteo presidenziale si mise in moto, estremamente fiducioso e aperto alla luce del sole, e un cineamatore, sul bordo del marciapiede, rivolse la sua cinepresa verso la limousine che trasportava un giovane uomo col capo scoperto. Era il 22 novembre, il giorno in cui, in Inghilterra, fu messo in vendita il secondo album dei Beatles...Questa idea – la Beatlemania come elaborazione del lutto, o forse come mancata elaborazione collettiva del medesimo – è ormai un luogo comune della storia del costume americano; un po' l'equivalente di quando in Italia si racconta che il Sessantotto è finito con Piazza Fontana o gli anni di Piombo col Mundial 1982. Avevo trovato un nome per queste cose – forrestgumpismo, ecco, non era proprio un gran nome, ma Dylan non è mai stato tanto forrestgumpista come in Murder Most Foul, quando dopo due minuti di elegia sembra per un attimo voler ingrandire il campo: "Hush little children you'll understand: the Beatles are comin’, they're gonna hold your hand". A questo punto se non avessimo sentito la stessa leggenda da decine di altre bocche, forse il riferimento ci sfuggirebbe, e invece lo diamo per scontato: hanno ucciso Artù, e ora dal mare arriveranno questi simpatici cavalieri del disimpegno, a incantare e perdere un'intera generazione. E sappiamo anche che Dylan non si sente affatto incolpevole di tutto questo, perché c'era anche lui ad aspettare i Beatles, a offrirgli il primo tiro di joint, convinto che i Beatles conoscessero già le proprietà lenitive della cannabis e che I Want to Hold Your Hand nascondesse riferimenti a tali proprietà. Sappiamo, perché l'abbiamo letto e straletto, che anche se Dylan non ha mai scritto una canzone su Kennedy, ne ha scritte due o tre sulla figuraccia che fece almeno un mese dopo, quando a una cena progressista volevano premiarlo in quanto cantante progressista e lui si mise a dire che si sentiva un po' Oswald e capiva i suoi giovani amici che andavano a Cuba a prendere lezioni di rivoluzione. Sappiamo che quell'episodio non fu (solo) la tipica tirata di un ubriaco che si autopunisce, ma il momento topico di una drammatica svolta di carriera che l'avrebbe portato in pochi mesi da principe del folk militante ritratto su seriosi LP in bianco e nero a rockstar sbruffona con gli occhiali scuri e 45 giri in classifica. Sappiamo tutto questo perché è stato già scritto e riscritto, in una marea di testi che si citano a vicenda, ovvero si tratta di un vero e proprio Canone: il canone dei boomer americani. C'era Kennedy che portava un certo tipo di speranza, ma gli spararono e allora vennero da Liverpool quattro ragazzini con un altro tipo di speranza, e poi fu Woodstock e poi Altamont, Dylan le cita entrambe e chi è previsto sappia non ha bisogno di note a pie' di pagina: è già stato tutto inciso sulla Colonna Traiana dei boomer. In effetti ci sono momenti in cui il citazionismo sembra prendergli la mano, e l'ascoltatore comincia ad avere il sospetto che il vecchio Dylan stia cercando di fare quello che trent'anni fa fece, con più sintesi e sfoggio di virtuosismo, Billy Joel in We Didn't Start the Fire: la storia di una generazione per citazioni, un affresco realizzato con la tecnica del namedropping.
Ci sono in effetti momenti in cui Dylan sembra adottare la stessa tecnica di evocazione di un periodo mediante nomi e frasi fatte, ma in modo meno meccanico e consapevole – a volte sembra condannato a ricorrervi, come il personaggio non troppo secondario della storia che sta raccontando. Lo si sente in alcune citazioni incongrue, che hanno un senso ma allo stesso tempo sembrano maldestre – la più eclatante per me è quella da Tommy degli Who, che se non sbaglio è la prima prova che abbiamo che Dylan abbia mai ascoltato Tommy o qualsiasi altro disco del gruppo di Pete Townshend.
Tommy, mi senti? Sono la Regina dell’Acido,L'idea che nel percorso verso l'oltretomba il presidente abbia potuto incontrare l'Acida Regina di Tommy sorprende come l'orologio da polso in un peplum romano. Più in là Dylan invita Wolfman Jack, il Dj Lupo Solitario di American Graffiti, a suonare per il funerale: segue una lunga playlist che prende una buona parte del pezzo e identifica un altro canone, quello della musica popolare americana prima della caduta (prima della beatlemania). Tutto abbastanza chiaro salvo che a un certo punto esce fuori... Another One Bites the Dust. A questo punto confesso di avere googlato in lungo e in largo alla ricerca di una canzone americana con lo stesso titolo perché l'idea che in un elenco simile, tra la sigla di Twilight Zone (Ai confini della realtà) e il gospel The Old Rugged Cross, ci fossero i Queen, mi urtava più del proverbiale cavolo a merenda. E invece no, e invece Dylan probabilmente ha in testa proprio i Queen e in particolare quel ritornello decontestualizzato: Eccone un altro che morde la polvere.
viaggio in una Lincoln limousine, lunga e nera,
sul sedile posteriore di fianco a mia moglie
e per destinazione l’aldilà.
Sono dettagli dissonanti, sbavature più o meno consapevoli che in un certo senso ci confortano sul fatto che Dylan è ancora il vecchio Dylan, e non è stato sostituito da un generatore di testi di Dylan. Murder Most Foul ricorda, infine, quella che fino a un mese fa in quanto ultima nella scaletta di Tempest bisognava considerare l'ultima canzone di Bob Dylan, Roll On John. E se da una parte era commovente pensare che Dylan si congedasse dalla scena letteraria con un omaggio all'amico e collega John Lennon, dall'altra lasciava perplessi la confezione dell'omaggio, una specie di trasfigurazione mitica della sua breve vita in cui ogni tanto si infilavano citazioni lennoniane risaputissime e abbastanza fuori contesto ("Come together right now over me" non è proprio la prima cosa che ti verrebbe da cantare a un amico caduto), e poi alla fine senza nessun apparente motivo al mondo un celeberrimo verso di Blake, Tyger, tyger, burning bright... Ecco, in Murder Most Foul c'è la stessa volontà di creare una mitologia partendo da riferimenti che tutti i coetanei di Dylan possono cogliere al volo, con qualche dettaglio dissonante che in un altro autore stonerebbe e basta, ma che in Dylan ci conforta in qualche modo sulla genuinità del prodotto – in fondo è Dylan, ha sempre fatto un po' di casino con nomi e date e luoghi. E quindi insomma alla fine sta bene. Il nostro vecchio Dylan. Sì, da qualche parte nello spaziotempo c'è un Dylan migliore che non ha mai dichiarato di essersi sentito Oswald perché Oswald non ha mai assassinato Kennedy, un Dylan che ha continuato a credere nelle canzoni che cambiano il mondo e magari l'ha pure cambiato e adesso è ministro per l'Agricoltura della Repubblica Socialista Democratica Panamericana. Ma anche il nostro Dylan qualcosa di buono l'ha fatto, dai. Abbiti cura, Stay safe stay observant and may God be with you.
Gli altri dischi di Bob Dylan: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan, New Morning, Another Self Portrait, 1971: Greatest Hits II, 1973: Pat Garrett and Billy the Kid, 1974: Planet Waves, Before the Flood, 1975: Blood on the Tracks, Desire, The Rolling Thunder Revue, 1976: Hard Rain, 1978: Street-Legal, At Budokan, 1979: Slow Train Coming, 1980: Saved, 1981: Shot of Love, 1983: Infidels, 1984: Real Live, 1985: Empire Burlesque, Biograph, 1986: Knocked Out Loaded, 1987: Down in the Groove, Dylan and the Dead, 1988: The Traveling Wilburys Vol. 1, 1989: Oh Mercy, 1990: Under the Red Sky, Traveling Wilburys Vol. 3, 1991: The Bootleg Series Vol 1-3 (Rare and Unreleased), 1992: Good As I Been to You, 1993: World Gone Wrong, 1994: MTV Unplugged, 1997: Time Out of Mind, 2001: “Love and Theft”, 2006: Modern Times, 2008: Tell Tale Signs, 2009: Together through Life, Christmas in the Heart, 2012: Tempest, 2020: Murder Most Foul.
Di che ti vanterai, San Lalemant
17-03-2020, 22:54Americana, Il Post, santiPermalink"Piccolo Prete, Piccolo Prete".
"Vecchio Falco, che c'è?"
"Oggi noi moriamo".
"Oggi?"
Di che ti vanterai col tuo Signore? Anche se fossi il più forte tra gli uomini, è Lui che così ti ha creato. Del resto si fa per dire, Gabriel Lalemant: tu non sei certo il più forte degli uomini. Sei miope e hai la scoliosi. I polmoni, potessi sputarli a primavera, li vedresti spugnare sangue. Dio ti ha scelto missionario in Canada e ti ha regalato un'allergia a un parassita della corteccia degli aceri, a maggiore sua gloria. Un premolare ti pulsa impazzito, il dentista più vicino è a una settimana di marcia dal villaggio. Hai sempre freddo, hai sempre fame, in un altro secolo saresti depresso; nel diciassettesimo stai per morire.
Gli irochesi, dice Vecchio Falco. Stanno arrivando, sono in tanti. Hanno i colori di guerra ma se volessero combattere avrebbero aspettato che tornassero dalla caccia i maschi atti alle armi. Sono venuti a distruggere il villaggio, Piccolo Prete. Ammazzeranno noi vecchi, stupreranno le donne, adotteranno qualche bambino. È così che fanno gli irochesi.
"Sei ben informato sui loro costumi".
"E va bene, Piccolo Prete, anche noi uroni facevamo così, ma Grande Prete mi ha dato il Perdono".
"Sì sì il Perdono".
Di che ti vanterai al cospetto di Dio? Anche se fossi il più coraggioso tra gli uomini, è Lui che l'ha deciso. Tu ti saresti semplicemente trovato col coraggio necessario al momento giusto. Del resto si fa per dire, Gabriel Lalemant; tu non sei il più coraggioso tra gli uomini. C'è un punto preciso del basso ventre che te lo sta confermando, la pelle ti si fa d'oca come quando al collegio nell'ora di latino cercavi in qualche modo di non fartela addosso.
"Ma c'è una qualche maniera di... non so, è previsto che possiamo arrenderci?"
"Arrenderci, Piccolo Prete?"
"Sì, non combattere".
"Non credo che possiamo combattere".
"E quindi ci arrendiamo e loro..."
"Ammazzano noi vecchi, violentano le donne e rapiscono i bambini".
"Anche se ci arrendiamo".
"Arrenderci, Piccolo Prete?"
"Non conosci la parola, vero?"
"Mi perdoni, Piccolo Prete".
"Ti perdono, ti perdono, possiamo scappare almeno?"
"Le donne e i bambini possono scappare".
"Le donne e i bambini".
"Ma i guerrieri irochesi sono più veloci".
"Sono più veloci".
"Allora Piccolo Prete dobbiamo fare la... non so come si dice in francese, Piccolo Prete".
"Dobbiamo chiuderci nelle capanne e sparare e lanciare frecce e tenerli occupati".
"Anche fare urla di donna nel frattempo, io credo che Piccolo Prete le sa fare".
"Urla di donna?"
"Io ho sentito Piccolo Prete cantare la messa e credo che gli irochesi crederanno di sentire una donna. Anche molte donne".
"Cioè fammi capire".
"Grande Prete ha già radunato le donne, che portino via i bambini nella foresta. Gli altri vecchi saremo una dozzina. Abbiamo frecce e il fucile di Grande Prete, io forse lo so usare".
"No no no, lascia perdere quell'affare, prima che ti esploda in m-"
"Se fa chiasso è comunque utile, e comunque oggi io muoio. Intanto Piccolo Prete canterà per noi".
"Cantare? Cosa dovrei cantare?"
"Quella che più sembra un verso di donna... alla fine della messa, lei sempre canta quella cosa che fa tedeeeeeu...."
"Il Te Deum".
"Aspetta però. Prima Piccolo Prete deve essere sicuro di una cosa. È importante".
"Cosa c'è"
"È sicuro che non Si arrabbierà?"
"Chi?"
"Il Signore nella Grande Casa".
"Ah, Lui".
"Non si arrabbierà se ti sente cantare il Suo Nome? Mentre noi tiriamo frecce e cerchiamo di uccidere gli irochesi, che Grande Prete ci disse essere peccato".
"Sì beh, ecco, io..."
"Piccolo Prete per favore non m'importa di morire oggi, sono vecchio e sono urone. Ma nel Fuoco Eterno non ci voglio andare, quindi la mia domanda è più seria della vita, capisce?"
"Capisco Vecchio Falco, capisco".
"Se tu canti forte e Lui ti sente, Si arrabbierà?"
"Io... io non lo so".
"Come non lo sa?"
"È complicato".
"Ma tu sei Prete! Tu devi sapere".
Di che ti vanterai col tuo Signore? Anche se fossi il più saggio degli uomini, da chi viene tutta la saggezza? Chi l'ha dispensata agli uomini, dandone tanta ad alcuni, poca o punta a molti, e calcola quanta ne deve aver passata al malaticcio Gabriele Lalement, il giorno in cui gli ha instillato la voglia pazza di fare il missionario in America, che non sembra un'idea saggia da qualsiasi parte tu la guardi, e specialmente all'alba di quel 17 marzo 1649 in cui si muore, e davvero bisogna morire cantando il Te Deum in falsetto, chi può dire se a Nostro Signore la cosa piacerà? Magari era persino il giorno in cui Gabriele ci credeva poco – la gente pensa che la Fede scorra sempre copiosa come un grande fiume in chi ne è degno: e invece no, troppo spesso è uno di quei torrenti capricciosi che in inverno sono rivoli quasi secchi e d'estate vanno in piena, o viceversa; e metti che Gabriele fosse in secca proprio in quel giorno in cui gli toccava di morire, Vecchio Falco, che ti dico?
Non solo Dio è imperscrutabile, ma voi indiani chi vi capisce, e io sto qui in culo al mondo a fare l'interprete tra due entità che non ho mai capito, che vita assurda, che mal di denti, chissà quanti me ne caveranno al palo della tortura prima di trovarmi quello che mi pulsa –
– Entra in scena un ragazzo, spalanca l'uscio senza bussare. Zoppica e mugola una cosa che nel dialetto del villaggio vuol dire porcaputtana Vecchiofalco le merde sono qui. È quel tipo di maleducazione che ti sorregge nei colpi di sfortuna. Non fosse caduto su un ginocchio la scorsa settimana starebbe già cacciando col padre o al limite scappando nella foresta con la madre, ma zoppica e quindi anche lui deve morire oggi. Vecchio Falco gli bisbiglia qualcosa del tipo: ma vergognati, non vedi che sono qui col Prete? Il ragazzo fa finta di accorgersi che c'è il prete. China la testa e congiunge le mani in un tentativo di saluto ossequioso, ma è così nervoso che gli salta fuori un applauso, clap!
"Chiedo perdono, Piccolo Prete, io..."
Questi chiedono perdono continuamente, Grande Prete (Jean de Brébeuf) ha messo loro addosso una paura dell'inferno che in certi casi magari è utile; non in questo.
"Ti perdono, Scoiattolo che c'è?"
"Le mer... Gli irochesi sono qui".
"Lo so".
Zang!
(O qualsiasi sia il rumore di una freccia che si conficca nella fessura tra due pali di una capanna).
"Giù la testa" dice in dialetto Vecchio Falco, ma lo dice e non lo fa, e la capanna non ha vetri, quindi un attimo dopo averlo detto sta fissando la punta di una freccia che gli esce dalla spalla, dunque oggi si muore così? Beh, meglio che restare al palo per un giorno di torture. Sul serio, se è una vita che ci pensi, quando arriva magari ti sollevi. Resta quella questione del Fuoco Eterno da chiarire ed è sempre più impellente, Vecchio Falco già ne annusa la fuliggine. Gabriele sta strisciando verso la cassapanca, lì dentro c'è l'archibugio di Père Jean, un affare arrugginito che con ogni probabilità gli esploderà in mano, d'altro canto gli irochesi ti cavano gli occhi e te li rimettono di brace; scottano una punta di freccia e ti ci sodomizzano, e Scoiattolo? Scoiattolo è in un angolo che piange e chiama la mamma perché questo fanno gli esseri umani, in tutte le civiltà, in tutte le latitudini, quando hanno dodici anni e fuori ci sono i cattivi. Oh mamma mamma mamma mamma mamma ma...
Più forte! Grida Vecchio Falco.
"Oh mamma mamma mamma mamma mamma mamma!"
L'archibugio ora è carico, ma bisogna dar fuoco alle polveri. Sul comodino nell'angolo, c'è ancora la candela accesa...
"Oh mamma mamma mamma mamma mamma mamma!"
"Non basta! Devi piangere come dieci! Fuori devono credere che dieci bambini sono qui!"
"Ma io ho una bocca sola! Non posso..."
"E invece Scoiattolo tu devi. Per tuo fratello, per tua madre, ora tu piangi –
BANG!
Gabriele ha dato fuoco a una carica e si è ustionato una mano e ora sta strillando in falsetto, a maggior gloria di Dio. Bravo Prete, bravo, strilla forte, strilla, anche di più, Vecchio Falco approva con tutto il fiato che gli resta. Qualcuno magari un giorno tirerà fuori un romanzo da tutto questo, o una scena da film, un vecchio un bambino e un prete che eroici resistono nella sagrestia che è l'avamposto del villaggio. Ma questo non è ancora un romanzo, questa è una baracca con un ragazzino in un angolo che piange, un prete in un altro angolo che si tiene una mano e strilla, e un vecchio urone al centro del pavimento che sanguina e approva con la testa, più strilli, più strilli per favore. Ci prova anche lui, auauauauauauauauauauau, ma gli manca il fiato di nuovo. Gli irochesi si sono fermati per un istante, forse un fucile non se l'aspettavano. E non va bene, bisogna fare baccano, bisogna far credere chissà cosa. Dalle altre case si sente il sibilar di frecce, qualche altro vecchio risponde, qualche altro ragazzino terrorizzato grida dalle finestre, quanto tempo riusciremo a fargli perdere mentre le donne scappano? Non si sa, non importa, ogni respiro è un dono di Dio.
"Te Deum laudamus: te Dominum confitemur..."
"No, Piccolo Prete, no".
"E perché no".
"Se non ne è sicuro, Piccolo Prete non deve cantare".
"E perché non dovrei esserne sicuro? Sono un prete".
"Giura, Piccolo P..."
"Te lo giuro".
"Sulla tua anima, giura che il Signore non si arrabbierà".
"Vecchio Falco, sulla mia anima ti giuro che il Signore non si arrabbierà se canto il suo nome mentre i tuoi fratelli combattono per salvare le nostre donne e i nostri bambini. Nel nome del Signore".
"Allora mentre Piccolo Prete canta, io posso andare".
"Te aeternum patrem, omnis terra veneratur..."
"...Mi perdona?"
"Tibi omnes angeli... di che ti devo perdonare?"
"Non lo so Piccolo Prete, non lo so".
"Grazie".
"Tibi caeli et universae potestates:
tibi cherubim et seraphim,
incessabili voce proclam..."
Di che ti vanterai col tuo Signore? Anche se tu fossi il più forte, il più coraggioso, il più saggio degli uomini – ma tu non lo eri. Invece eri Gabriele Lalement: eri malato, e hai salvato un villaggio. Avevi paura e hai combattuto col fucile in braccio, cantando lodi a Dio, e magari era uno di quei giorni in cui nemmeno ci credevi. E sei morto dopo ore di torture, e quando hanno finito ti hanno strappato il cuore e lo hanno mangiato come si mangia il cuore dei condottieri coraggiosi: e al posto dei tuoi occhi miopi avevi due tizzoni ardenti, e di tutto questo quanti possono vantarsi davanti al Signore? Ma se c'è un Regno dei Cieli, è il regno in cui il più forte, il più coraggioso, il più saggio, si chinano al passaggio di San Gabriel Lalemant. E come Scoiattolo giungono le mani, così in fretta che parte l'applauso.
Capire un Caucus
05-02-2020, 12:31Americana, democrazia d'esportazionePermalink |
| IlPost |
Possiamo notare come anche a questo minuscolo livello può succedere che il candidato X prenda meno voti ma più delegati del candidato Y, come insomma la democrazia uninominale non funzioni nemmeno in vitro. Possiamo ignorare la logica circolare per cui il primo Stato a indire una consultazione primaria è quello che influenza le consultazioni primarie successive, e non chiederci più perché uno stato qualsiasi con appena tre milioni di abitanti (tutti bianchi) si sia preso questo diritto, e perché nessuno glielo contesti – sono americani, a loro va bene così, e più non dimandare. L'altro giorno sul Washington Post notavano che nel senato USA le vacche sono meglio rappresentate degli esseri umani, e anche se fosse? In altre nazioni sono sacre, negli USA determinano la differenza tra un territorio più o meno degno di essere rappresentato, è un criterio come un altro, un candidato lo sa e si regola di conseguenza. Alla fine non importa quanto siano astruse le regole, no? Basta che tutti le sappiano in partenza e il gioco ha un senso. Possiamo infatti decidere che è soltanto un gioco.
Possiamo metterci a scrollare metri di smaglianti infografiche alla ricerca dell'unico dato che direbbe qualcosa a noi poveri proporzionalisti, ovvero: ma su quei tre milioni di abitanti di uno stato rurale, quanti sono davvero andati a votare? Che importa, di solito quelli che ci vanno azzeccano il vincitore, e quindi la profezie deve autorealizzarsi anche stavolta. Possiamo metterci lì a spiegare perché funziona così, perché non è sbagliato che funzioni così in terre lontane dove la democrazia non è una cosa arrivata all'ultimo momento (imposta anche un po' da fuori, riconosciamolo) ma una consuetudine secolare con i suoi vezzi, i suoi miti, i suoi riti di iniziazione. Possiamo fare tutto questo, se vogliamo, e allora facciamolo.
Solo una cosa.
Mai più ironie su Rousseau, è chiaro? Perché in confronto al caucus dell'Iowa, Rousseau è una piattaforma affidabile ed efficiente.
Trump resiste grazie ai borghi putridi
07-11-2018, 15:11Americana, democrazia d'esportazionePermalinkAnche se ormai si è capito com'è andata (i Democratici si riprendono la Camera, i Repubblicani tengono il Senato), ci vorrà ancora qualche ora per conoscere tutti i numeri di queste elezioni USA di metà mandato. E anche quando gli ultimi seggi saranno stati assegnati (ballottaggi esclusi) servirà ancora un po' di tempo per avere i due dati che in Europa sarebbero i più importanti di tutti, ovvero: sul 100% dei cittadini USA che si sono recati alle urne, quanti hanno votato democratico, quanti hanno votato repubblicano? In fondo non dovrebbe essere difficile ottenere questo paio di numeri. Ma fate l'esperimento: provate ad andare in uno degli aggiornatissimi speciali on line che le testate anglosassoni più prestigiose hanno dedicato alle elezioni. In mezzo a tanti coloratissimi grafici e tabelle e mappe provate a cercare se c'è questo semplice dato: quanti elettori hanno scelto il partito di Trump, quanti hanno scelto l'altro. Non lo troverete.
Non troverete nemmeno la considerazione che sto per fare, e che credo dovrebbe essere condivisa da qualsiasi sincero democratico (e repubblicano): il sistema elettorale USA è profondamente iniquo, ed è solo in virtù della sua iniquità che un partito continua a governare il Paese e a esercitare il controllo su un ramo del Congresso, malgrado la maggioranza degli elettori abbia votato per un altro Presidente due anni fa e per un altro partito oggi. A questo punto, se si trattasse di un Paese dell'Europa continentale, la questione sarebbe chiusa: è abbastanza ovvio, da questa parte dell'oceano, associare a una maggioranza di elettori una maggioranza parlamentare e un esecutivo. Negli USA non è così e forse sarebbe il caso di cominciare a preoccuparsene di più. È vero, è la culla della democrazia moderna. Ma poi la democrazia è andata per il mondo, è cresciuta, ha imparato a fare di conto.
Negli USA invece è successo qualcosa, o forse è meglio dire che non è successo niente: si vota ancora come due secoli fa, quando ci si recava ai seggi in calesse. In apparenza tutto è più sofisticato: l'informazione, soprattutto, ha fatto passi da gigante e segue le campagne con un grande dispiego di mezzi, ipnotizzandoci con grafici luccicanti che, fateci caso, omettono le percentuali crude degli elettori. Tanto è un numero inutile: contano soltanto i seggi. Al Senato, soprattutto – e infatti i Repubblicani resistono lì. Al Senato ogni Stato esprime due seggi, che sia grande come la California, denso come il New Jersey o quasi disabitato, come l'Indiana. Ecco, prendiamo per esempio l'Indiana. A queste elezioni dovrebbero aver votato due milioni di cittadini, su quattro milioni e mezzo di elettori registrati e sei milioni di abitanti. Al repubblicano Mike Braun è quindi bastato poco più di un milione di voti per ottenere un seggio in Campidoglio, mentre al democratico Beto O'Rourke, che correva per i democratici in Texas, quattro milioni scarsi non sono stati sufficienti (Ted Cruz, il suo avversario repubblicano, ne ha presi appena duecentomila in più). Se l'affluenza fosse più alta (e in queste ultime elezioni sta aumentando), il sistema risulterebbe ancora più iniquo, dal momento che prevede che il mezzo milione di cittadini del Wyoming sia rappresentato a Washington da due senatori, esattamente come i quaranta milioni di cittadini della California. Neanche a farlo apposta, in Wyoming votano per lo più repubblicano, mentre in California la sfida era un derby tra candidati democratici. Il calcolo è abbastanza brutale: il voto di un elettore californiano al Senato vale ottanta volte meno di quello del Wyoming. Chi può avere concepito un sistema così iniquo? Nessuno.
Il principio che assegna due rappresentanti a ogni Stato si trova nel primo articolo della Costituzione del 1787, quando di Stati Uniti ce n'erano appena tredici, tutte ex colonie inglesi aggrappate sulla costa est. I firmatari non potevano sapere quanto sarebbe diventata grande e complessa l'Unione che tenevano a battesimo. Soprattutto non avrebbero potuto immaginare quanto grande sarebbe stato lo squilibrio tra le zone più urbanizzate e quelle che dopo 250 anni risultano ancora scarsamente popolate. Un principio comunque lo avevano ben chiaro, visto che lo avevano appena impugnato per scacciare gli inglesi: non c'è tassazione senza rappresentazione. I californiani pagano meno tasse degli abitanti del Wyoming? Di sicuro non ottanta volte in meno. Perché il loro voto deve valere così poco? Nel Regno Unito dell'Ottocento, anche a causa delle migrazioni interne causate dalla rivoluzione industriale, i distretti elettorali spopolati in cui bastavano poche centinaia di voti per ottenere un seggio a Westminster venivano chiamati Rotten boroughs, "borghi putridi". Il sistema era così iniquo che una riforma si rese inevitabile. Negli USA purtroppo sta succedendo l'opposto: invece di rendere più equo il meccanismo di rappresentanza al Senato, i legislatori approfittano della loro posizione per distorcere quello più proporzionale della Camera, attraverso il procedimento che già nell'Ottocento era stato battezzato Gerrymandering, (dal nome di un governatore del Massachussetts, Gerry, che aveva ridisegnato un distretto a forma di salamandra). Non sono stati soltanto i Repubblicani ad approfittare del diritto di poter ridisegnare i distretti a piacere, ma è soprattutto grazie a loro che qua e là in tutta l'Unione abbiamo distretti a forma di drago o di serpente. Il principio è sempre lo stesso: disseminare le comunità da cui ci si aspetta un voto omogeneo in tante diverse circoscrizioni dove il loro voto risulterà in minoranza. Il Gerrymandering è un fenomeno odioso, ma perfettamente legale, e in un qualche modo autorizzato dalla consuetudine: in fondo la stessa mappa dei Cinquanta Stati (alcuni piccoli e popolatissimi, altri grandi e disabitati) è a suo modo un Gerrymandering.
Il Gerrymandering è solo uno dei tanti fenomeni che di fatto limitano o distorcono il meccanismo elettorale USA. Rispetto ad altri forse ci interessa di più perché a un certo punto abbiamo pensato di importarlo in Italia – del resto si sa, gli americani ci piacciono con tutte le loro magagne. Una delle primissime bozze della riforma costituzionale Renzi-Boschi prevedeva che il Senato italiano diventasse una copia di quello federale americano, con due seggi per ogni regione (tranne la Val d'Aosta). Il risultato non sarebbe stato iniquo quanto quello di Washington, ma comunque il voto di un cittadino lombardo (ce ne sono dieci milioni) sarebbe stato trenta volte meno determinante di quello di un cittadino molisano (ce ne sono appena trecentomila). L'idea per fortuna tramontò abbastanza presto, ma è indicativo anche solo che qualche politico italiano ne abbia parlato come di una proposta ragionevole. La versione definitiva della riforma aveva riabbracciato l'idea che i seggi vanno assegnati in modo più proporzionale, ma anche a causa della necessità di riconoscere alle regioni a Statuto Speciale una quantità fissa di seggi, manteneva un rapporto assolutamente sbilanciato, al punto che il voto dell'elettore molisano sarebbe stato comunque cinque volte più determinante di quello dell'elettore ligure. Uno squilibrio senza senso, che penalizzava le regioni più popolate ed economicamente dinamiche senza un motivo chiaro che non fosse quello di imitare le istituzioni USA, se non nei loro pregi almeno nei difetti più evidenti. La riforma non è passata, probabilmente per altri motivi: ma prima o poi qualcuno tornerà a parlarne, e gli stessi Renzi e Boschi non è che si siano dati per vinti. Ecco, per quando succederà, meglio farsi un appunto: magari certe cose dagli americani le possiamo ancora copiare, ma il Gerrymandering per favore no. Molise e Val D'Aosta sono bellissime regioni che hanno diritto a essere rappresentate equamente, non borghi putridi.
Sii buono come Dylan lo è con te
28-10-2017, 20:14Americana, Bob Dylan, Il Post, musicaPermalink(Il disco precedente: The Bootleg Series Vol. 1-3 (Rare and Unreleased)
Il disco successivo: World Gone Wrong).
la terra sua è nel Texas, il suo nome Diamond Joe.
I suoi soldi li tiene in un vaso tempestato di diamanti,
le procedure della legge non gli hanno mai dato problemi.
1. TI PORTERÒ A CHICAGO
un cofanetto di scarti che non ha venduto come Biograph, ma alla fine farà anch'esso il suo mezzo milione di copie. Insomma gli affari vanno abbastanza bene, senza bisogno di comporre strofe e ritornelli di cui nessuno sente veramente il bisogno. Sennonché...
...la Columbia vuole il suo disco di inediti.
Anche nel 1992.
C'è scritto sul contratto.
E va bene, dice Dylan, facciamo 'sta sceneggiata. Verso l'inizio dell'estate chiama un vecchio amico pluristrumentista, David Bromberg, la cui carriera di cantautore dopo gli anni '70 si è rapidamente arenata, al punto che ha aperto uno studio da liutaio; prenotami uno studio a Chicago, voglio fare un disco di cover. Povero Bromberg. Devono tremarti le gambe, quando Dylan ti dice che vuole fare un disco di cover. Pensa ai precedenti. Esperimenti abortiti come Self Portrait. Pasticci come Knocked Out Loaded. Oggetti deprimenti come Down in the Groove. La cosa più saggia, quando Dylan ti chiede di fare un disco di cover, è scappare. Invece Bromberg prenota l'Acme Recording Studio. Chiama un violinista, un mandolinista e tutta la compagnia pizzicante. Registreranno il primo vero disco di cover di Bob Dylan - non il solito pasticcio rovinato dai ripensamenti. Un disco serio, rigoroso. Un bel disco, probabilmente.
Non lo sappiamo.
Deve ancora uscire.
Povero David Bromberg.
Ho preso cavalli da Diamond Joe, ho firmato il suo contratto.
Mi diede una mandria di ronzini così vecchi che non stavano in piedi.
E sono quasi morto di fame, mi ha trattato così male.
Non ho mai tenuto un dollaro dalla paga di Diamond Joe.
(No, in realtà l'ha pagato. Ma la canzone dice così, e in un qualche modo oscuro le canzoni non mentono).
2. IL RITORNO DEL GEMELLO CATTIVO (o era il buono?)
Quando torna a casa sua in California, Dylan ha una sorpresa: qualcuno gli ha forzato la serratura del garage - più che garage è una piccola sala d'incisione, quella dove i Traveling Wilburys appena nati incisero Handle with Care. Non hanno rubato niente, forse un paio di armoniche (o forse le ha perse Dylan: ha sempre fatto casino con le armoniche). In compenso qualcuno ha lasciato qualcosa. Dei nastri. Dylan non ha nemmeno bisogno di ascoltarli per capire chi è stato: il suo gemello è passato di lì. Quello che non è mai diventato famoso, quello che non è mai passato al rock, quello che continua a strimpellare sui marciapiedi del mondo - in teoria ha la sua stessa età, eppure Dylan è felice che non sia morto di qualche forma di vecchiaia anticipata. Si sa che la vita per strada ti consuma. Vabbe', sentiamo questo nastro - mio dio, è quasi un'ora di roba. Un'ora di voce e chitarra, ma come si fa. Nemmeno nel '64 riuscivi a mantenere l'attenzione per così tanto tempo. E poi senti che voce, mamma mia - non sputa più le sue cattiverie come ai tempi di Blood on the Tracks. Adesso gracchia. La sua glottide è una spina, una puntina di giradischi - ma questa canzone la conosco...
Frankie pulled out a pistol, pulled out a forty-four.
Gun went off a rootie-toot-toot and Albert fell on the floor.
He was her man but he done her wrong.
Frankie and Albert, storia di una tizia che uccise il suo uomo fedifrago a fine Ottocento, al tempo in cui la cronaca nera si diffondeva con le ballate - che roba. Così sei tornato alla fase folkloristica, eh, vecchio Ismaele? beh, almeno adesso hai la voce giusta. Ma a chi credi che possano interessare questi brandelli di antichi giornali? Anche la mano è un po' incerta, una volta sapevi suonare meglio. Si vede che hai avuto problemi alle articolazioni, anche tu...
Frankie got down upon her knees, took Albert into her lap.
Started to hug and kiss him, but there was no bringin' him back.
He was her man but he done her wrong.
Va bene, non è malaccio in fondo, sembra... sembra vera. Suonata da un vecchio cantastorie a un crocicchio. Potrei anche piazzarla da qualche parte nel nuovo disco, per spezzare un po' il ritmo. E poi che c'è? Jim Jones che va a marcire nella colonia penale australiana? Inizio Ottocento ormai. Ismael, stai diventando un museo ambulante.
3. STORIA DELLA CULTURA OCCIDENTALE COME SE FOSSE LA DISCOGRAFIA DI BOB DYLAN
Era un giochino che avevamo iniziato da qualche parte - dunque, i primi dischi acustici sarebbero la fase arcaica. Miti, leggende, echi di guerre civili di duemila anni fa. Con Bringing It All Back Home, e la scoperta del rock, entriamo nell'età classica, che ci regala le maggiori soddisfazioni ma dura pochissimo, chi la vive a momenti manco se ne accorge. Col trauma dell'incidente in moto comincia la fase tardoantica, in cui la barbarie progressivamente penetra entro i confini dell'impero - dapprincipio attraverso le registrazioni nelle catacombe di Big Pink, poi con i riti misterici di JWH - ma è con Nashville Skyline che comincia l'Alto Medioevo: dove c'erano testi filosofici e sapienziali ora si fanno feste danzanti in campagna. I secoli bui si protraggono per tutto il 1970 (Self Portrait, Dylan, se volete New Morning può essere l'alba del Basso Medioevo). Rifioriscono i commerci, si ritorna in tour. Blood on the Tracks non può che essere il Rinascimento quattrocentesco (e allora vedi che in Tangled Up in Blue Dylan non aveva sbagliato secolo?), mente Desire è quello maturo e inquieto di inizio Cinquecento, con le sue tensioni mistiche e simbologie egizie. Street Legal è già manierismo, ma nel frattempo sotto le ceneri cova ben altro; con Slow Train Coming ha inizio la rivoluzione puritana. Cadono teste, i bigotti prendono il parlamento, ma Cromwell comincia a diffidare di loro e dopo la sua morte la repubblica ha breve durata. Già da Shot of Love comincia una lenta transizione da un pomposo barocco a un lezioso rococò, con occasionali tentativi neoclassici (ricordiamo che la classicità per Dylan è il rock and roll). Oh Mercy arriva come un fulmine a ciel sereno: è lo Sturm und Drang? il primo romanticismo? Quindi Good As I Been cosa dovrebbe essere? Forse i fratelli Grimm, la seconda generazione dei romantici che comincia a fare ricerche sul campo. Dylan già si era messo sulle loro tracce con le fiabe e le filastrocche di Under the Red Sky. Ora però fa sul serio - o forse è il suo gemello cattivo, meno incline ai compromessi: le canzoni non si scrivono più, è il popolo che le scrive. Il cantante è solo un medium, un tramite. Attraverso le canzoni possiamo sentire il popolo pensare. Captare le sue emozioni, capire cosa lo appassiona e cosa lo indigna. A volte in realtà non captiamo un bel niente: non ci resta che riflettere davanti a un mistero. Dylan per trent'anni ha riempito il mondo di parole: è ora di tacere e lasciarsi riempire dalle parole del popolo (continua sul Post...)
Was in the summer, one early fall, just tryin' to find my little all and all.
Now she's gone, an' I don't worry: Lord, I'm sittin' on top of the world.
Pat Dylan e Bobby the Kid
26-05-2017, 19:35Americana, Bob Dylan, cinema, Il Post, musicaPermalinklo sceriffo è già sulla tua pista.
I bounty killer ti hanno sulla lista.
Non gli gusta la tua libertà.
È un film imbottito di scene madri, ma la più famosa non è stata girata: nel buio della sala di proiezione, mentre guarda i giornalieri, il grande Sam Peckinpah, (ubriaco, una pistola carica in tasca), si rende conto che una lente è difettosa, che il lavoro di un'altra giornata va sbattuto via. Furioso, si alza, si sbottona e lascia sul telo dello schermo il suo segno - una "S" di urina. Dietro di lui, Bob Dylan si volta verso Kris Kristofferson: non dice niente, ma quello sguardo Kristofferson non lo dimentica più. Kris, ma in che pasticcio mi hai portato?
Passi notti intere, giù in Berenda,
a smazzare carte in un'hacienda,
finché trovi uno che ti stenda,
Billy, se hai bisogno, sono qua.
Un pasticcio che non si sarebbe perso per niente al mondo. Un film sul più famoso fuorilegge del west. Girato dal regista del Mucchio Selvaggio. Nei panni del protagonista l'amico Kristofferson, quel bel cantante country che qualche anno prima aveva retto i bonghi durante la registrazione di Lay Lady Lay. Talmente ghiotta era l'occasione di recitare e scrivere una colonna sonora western, che Dylan, per una volta nella sua vita, si presentò coi compiti fatti. Peckinpah, per dirla con Kristofferson, "non s'intendeva molto di musica", insomma non aveva la minima idea di chi fosse quel trentenne ricciolino che Kristofferson gli stava presentando. Ma il tizio aveva già Billy in canna. Gliela fece sentire. Scritturato. A Billy non si resiste.

Fai la festa a qualche señorita,
nell'ombra di una camera ti invita,
nel buio solitario lei ti guida...
Billy, a casa non ci torni più.
Voi fischiettate ogni tanto? Se vi capita, e se amate Dylan, ci siamo già capiti. Billy è l'abc, il pezzo dylaniano più fischiettabile. Si può andare avanti per giorni interi, e per milioni di variazioni sullo stesso tema triste. "Billy, you're so far away from home". Che ti è successo, Billy? Quale ingiustizia, quale imprudenza, ti ha portato così lontano? Quando i redattori di Mojo stilarono la classifica delle cento canzoni di Dylan, si scordarono di Billy. Sarà gente che non fischietta. Forse è un dono di natura, c'è chi ci nasce e c'è chi per capire Dylan è costretto a cercare barlumi di genio in dozzine di dischi opachi, quando basterebbe saper fischiettare Billy. Una delle melodie più semplici che abbia usato: una di quelle canzoni per cui vale la pena citare Robertson a proposito delle canzoni della Cantina: "non si capiva se fossero sue o no".
Nessuno, che io sappia, contesta a Dylan la paternità della melodia di Billy. Allo stesso tempo, è così basica che sarebbe veramente strano se l'avesse scoperta proprio lui. La incide in tre versioni diverse, come se non sapesse come riempire il disco (e invece parecchio materiale restò fuori). La maneggia come se fosse un interprete, anzi tre interpreti diversi: come se non fosse sua, ma un brano tradizionale che si può leggere in tanti modi e stravolgere a piacere. Come se la stesse cercando, per tentativi: è in cerca di Billy, come in Self Portrait era in cerca di Little Sadie. Se quel disco era l'autoritratto di un cantautore attraverso cover di altri artisti, Pat Garrett è il disco meno personale di Dylan (il primo che non ha la sua faccia in copertina), malgrado non ci sia una nota, una sola parola che non abbia scritto lui.
C'è chi prende mira dietro a specchi,
fori di pallottola sui tetti,
se non muori presto o tardi, invecchi:
Billy, sei rimasto solo tu.
Oggi Billy sembra fatta apposta per un western - il tema ideale qualsiasi panoramica in cui su un tramonto si stagli il profilo di un cowboy dal destino segnato - ma è un errore di prospettiva: prima di Billy le canzoni del film western erano diverse. Le scrivevano i migliori compositori sul mercato. Liberty Valance è di Bacharach (ha anche scritto Rain Keeps Falling On My Head per Butch Cassidy, ma non credo che si possa considerare un brano western). Ci mettevano un sacco di stilemi riconoscibili a colpo sicuro - chitarre country, violini, voci virili, qualche messicanismo - e ritornelli orecchiabili. Dylan i violini ce li ha, di chitarre quante ne vuoi (c'è Roger McGuinn alla 12corde, è la prima volta che incidono assieme); per la voce virile può fare un tentativo, ma Billy è tutta un'altra idea del west. Più elegiaca, più minimale. Può piacere o non piacere, ma finalmente è un'idea - da quand'è che non gliene veniva una?
Billy è il punto di arrivo di un sentiero accidentato che partiva dal 1967, dalla Cantina e da John Wesley Harding - un percorso ascetico, a ben vedere. Via il ritornello, via gli orpelli inutili: un tema solo, insistente come il blues, e in grado di sopportare centinaia di strofe. Quel tipo di ballate che secondo lui una volta la gente ascoltava per ore e ore, prima dell'avvento della radio e del cinema. Billy è già a suo modo un film. La storia che racconta non è molto più oscura ed episodica del copione che Peckinpah si era riscritto. C'è un bandito che dovrebbe fuggire, e invece gira in tondo. C'è uno sceriffo che (spoiler) lo ucciderà, ma un tempo era un suo amico. Le strofe che seguono non sono che variazioni sul tema del conflitto a fuoco. Due canaglie giocano a nascondino in una prateria senza senso, chi non è sceriffo è ladro di bestiame. Entri in saloon da assassino, ne esci con la stella di latta sul petto. In che pasticcio mi hai portato, amico?
Dormi con un occhio mezzo aperto
se con Garrett hai quel conto aperto.
Ogni suono è il La per il concerto
che la sua pistola suonerà.
In che pasticcio mi hai portato, Kris? Mettetevi nei panni di Bob Dylan, per una volta. Ce l'ha fatta: finalmente è sul carrozzone di Hollywood. Gente seria, valori solidi, mica quella bolla di sapone che è il mondo musicale, schiavo dei capricci di ascoltatori teen-ager e critici ventenni. Qui c'è gente che ha fatto la guerra, gente che ha già il suo nome scolpito sul marmo della Storia, James Coburn con tutte le sue meravigliose rughe (non le fanno più delle facce così), e Sam Peckinpah. Questo è il mondo degli adulti: Coburn e Peckinpah. Insieme per lavorare a qualcosa che andrebbe a vedere anche Abram Zimmerman, se fosse ancora al mondo - e sui titoli avrebbe visto il nome finto di suo figlio accanto a quello di quei grandi. Ce l'hai fatta, Robert "Bob Dylan" Zimmerman. Non sei più il ridicolo 'portavoce' di un evanescente 'generazione'. Sei un musicista dal talento riconosciuto e un caratterista di buon livello. Sennonché.
Sennonché siamo nel 1973, e anche il mondo degli adulti sta andato a puttane. Il grande Sam Peckinpah è un alcolizzato furioso che tutte le notti spara alla sua immagine nello specchio. Litiga coi produttori, litiga coi collaboratori, col cast, prima o poi se la prenderà anche con Dylan. Il copione è un casino, sul set a Durango gira di tutto, compreso il virus dell'influenza. Perderanno un sacco di tempo, e alla fine il regista abbandonerà il film al suo destino. Montato alla benemeglio, stroncato anche dai fan di Peckinpah, il disastro eclisserà il valore della colonna sonora - sapete chi ha vinto l'Oscar alla migliore canzone del 1973? Barbra Streisand, The Way We Were. Ora non dico che Billy avrebbe avuto una chance (in lizza c'erano anche Jesus Christ Superstar e Live and Let Die, fu un anno durissimo), ma Knockin' on Heaven's Door non si meritava una nomination? Il fatto è che per qualche tempo nessuno si accorse che per quel film sfortunato Dylan aveva scritto uno o due capolavori.
Viene il sospetto che il vecchio Sam avesse capito prima di tutti, e meglio di tutti... (continua sul Post).
Jackie è nella Casa
01-03-2017, 22:39Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkSignora Kennedy lei non ha / bisogno di scusarsi per il fatto che si trovava fuori sul bagagliaio / negli attimi successivi al momento in cui suo marito era stato colpito. / tutti hanno potuto vedere quel che era successo / in queste fotografie con i propri occhi ... / perché è stata distorta la verità di esseri umani? / a che serve questa immagine eroica? / nessuno è un eroe... / perché sono deliberatamente ingannato con confuse menzogne / a proposito di ciò che vedo con occhi sani / chi sono io per essere insultato così?
Prima di ricomporsi in pubblico e adottare quella maschera cool che ci si aspettava da lui, Bob Dylan ebbe il tempo per lasciarsi sconvolgere dall'assassinio di Kennedy come qualsiasi altro americano. Scrisse quattro 'poesie' a caldo - in quel periodo definiva 'poesia' tutto quello che gli usciva di getto senza preoccupazioni metriche - la prima delle quali era dedicata alla vedova Jacqueline. Più che una poesia è una lettera, senza le affettazioni tipiche del Dylan-alla-macchina-da-scrivere-che-si-crede-un-poeta. È un messaggio di scuse, quello che oggi potrebbe scrivere un personaggio pubblico sulla bacheca di facebook di un altro personaggio pubblico. È anche una riflessione su come i media e le fotografie mettono le persone in cornice o sulla gogna. Nei giorni immediatamente successivi all'assassinio politico più famoso del XX secolo, qualcuno era riuscito a biasimare Jackie Kennedy perché invece di difendere in un qualche modo il marito si era alzata, sporgendosi sul bagagliaio. Ufficialmente lo aveva fatto per aiutare una guardia del corpo a salire sulla berlina. Nell'intervista a Theodore White, giornalista di Life, emerge un altro probabile motivo: un pezzo di testa del presidente Kennedy era schizzato sul bagagliaio; Jackie si era alzato per raccoglierlo. Lo aveva rimesso al suo posto. Era evidentemente in stato di choc. Ma era anche Jacqueline Kennedy: avrebbe tollerato che le cose non fossero al loro posto?
Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis, detta Jackie, a distanza di mezzo secolo, è ancora un personaggio delicato, che impone cautela a chi lo maneggia. Forse addirittura sta diventando più delicata col tempo - ho in mente quella vecchia serie NBC degli anni Ottanta, in cui tutto sommato passava per una signora di buona famiglia ossessionata dagli interni della Casa Bianca - nozione che il regista Larraín o lo sceneggiatore Noah Oppenheim non tentano nemmeno di smentire: si tratta piuttosto di scavarci intorno, di problematizzare la cosa, di spiegare che dietro la cura per soprammobili e passamanerie c'era una riflessione sulla regalità della figura del Presidente, che emergeva ormai dalle brume della prima guerra fredda come l'uomo più potente del mondo. A quel punto era necessario lavorare sui simboli e sulle scenografie: un re deve vivere in una reggia, e sfoggiare una regina consorte. Sennò poi succede come ieri, che ti ritrovi su tutti i giornali una tizia coi piedi sul divano in Sala Ovale, e la cosa potrebbe avere ripercussioni in politica estera.
Un certo tipo di mitologia casabiancana nasce proprio con Jackie, che fu molto criticata in vita per questo (anche dal marito). Oppenheim osa finalmente dichiarare l'evidenza: Jacqueline Kennedy era, nella coppia, la più all'altezza del ruolo. Il marito era un mezzo disastro, un miliardario pasticcione che in tre anni si fece coinvolgere nel flop della Baia dei Porci, nell'escalation del Vietnam, e con la crisi dei missili portò il mondo a un passo dal conflitto atomico. La stampa conservatrice lo trattava più o meno come i liberal ora trattano il nuovo inquilino miliardario. Nel frattempo la moglie trasformava la Casa Bianca in Camelot, che è poi la vera grande eredità del 35mo presidente degli Stati Uniti. Era tempo che Hollywood riconoscesse a Jackie quello che era di Jackie. Senonché ci si è messo in mezzo Pablo Larraín. Una scelta abbastanza bizzarra, ma curiosamente in linea coi tempi, che sono piuttosto confusi.
Ci pensavo l'altro ieri, a Oscar consegnati. Secondo me Hollywood è nel pallone (continua su +eventi!) - non per il caos alla premiazione, quello è un incidente dal quale con un po' di sforzo si può cavare un simbolo, se fossi un mitografo come il giornalista Theodor White - o la stessa Jackie - o Dylan - magari mi ci proverei. Non è neanche Trump il problema (magari lo sarà nei prossimi anni - o magari sarà una soluzione, finalmente c'è un villain all'altezza del ruolo). Secondo me Hollywood non sa più che film premiare. Se la sono tutti presa con La La Land, un film che oscilla continuamente tra il dilettantesco e l'ipercitazionista. Dicevano: 14 nomination sono troppe. Può darsi, ma a chi darle, sennò? Che altri bei film avete visto nel 2016? Siamo onesti: avrebbe dovuto vincere tutto Zootopia. La rosa dei candidati era qualcosa di deprimente. Moonlight è un film che fino a qualche anno fa molti giurati non avrebbero nemmeno visto per intero, un film all'europea, intimista, diciamo pure ombelicale. Ormai il grosso dei budget è concentrato sulle saghe, e le saghe si stanno divorando tra loro: buttano fuori la stessa zuppa sempre più abbondante, sempre più pasticciata, tanto la gente manda giù di tutto.
Non è che non ci siano idee, non è che manchino gli sforzi produttivi coraggiosi. Ma ormai si concentrano sulla tv. Jackie a un certo punto doveva essere una miniserie HBO, e questo spiega in parte lo strano respiro del film - è come se Larraín abbia potuto pescare da una rosa di scene madri, a un certo punto c'è una interminabile mega-sequenza che è un mix di tre finali di tre possibili episodi: Jackie sta parlando al giornalista ma sta anche parlando a un prete, ma sta anche seppellendo Jack, ma sta anche tenendogli in mano il cranio, stretto come un vaso perché ne coli meno sangue possibile. Nel frattempo io mi sto addormentando, ma anche domandando se non è il miglior film che ho visto del 2016; o se non è per caso il peggiore; se Larraín voglia bene a Jackie o se non abbia deciso di prendere in giro gli yanquis in un modo talmente sublime che rischiava di vincerci un Oscar (è abbastanza incredibile che Natalie Portman non l'abbia vinto).
Il film all'inizio doveva farlo Aronofsky con Rachel Weisz, poi si sono lasciati e Aronofsky ha avuto questa pazza idea di proporlo a un regista cileno che a Hollywood non aveva mai lavorato. In un certo senso aveva visto giusto: Jackie era un personaggio perfetto per Larraín. È una pubblicitaria, una mitografa, una persona che vive nel suo stesso racconto. Ma di solito Larraín questi personaggi li racconta da fuori, con un'esibita freddezza, che a Hollywood non si può che stemperare. La Jackie di Larraín è una comunicatrice navigata, ma è anche una donna sconvolta che si aggira per i corridoi della 'sua' casa bianca come Jack Nicholson in quell'albergo. Dice cose molto sottili ma anche cose pazzesche. A un certo punto si lamenta con Bob che l'assassino sia solo un comunista da due soldi: se almeno l'avessero ammazzato per i diritti civili, avrebbe avuto più senso, no? È sotto choc, ma è anche un po' mitomane. Perché il suo autista si ricorda di Lincoln e non degli altri presidenti assassinati? Perché ha abolito la schiavitù? No: perché ci fu un funerale in pompa magna. E quindi ci vogliono più cavalli! Più cannoni! Poi cambia idea. Poi la cambia di nuovo. In una miniserie forse Larraín avrebbe trovato il ritmo. Qui è tutto contratto, mescolato secondo libere associazioni, al punto che sembra un sogno e forse a un certo punto stavo sognando sul serio.
Io la rispetto Signora Kennedy / ma non ho bisogno di fotografie per fornire rispetto... / il mio rispetto nasce da motivi che sono nel mio animo / che non posso toccare / né spiegare...
Non mi sento meglio sapendo che lei è umana / Lo sapevo da sempre
Bob Dylan
Jackie è all'Impero di Bra alle 20:20 e alle 22:30; al Fiamma di Cuneo alle 21:10.
Kennedy è morto, Dylan ubriaco
20-01-2017, 23:34Americana, Bob Dylan, Brecht, Il Post, musicaPermalink"Subito signore".
Lo stava ancora versando quando Zantzinger cominciò a colpirla sulla schiena e in testa. Sbrigati brutta nera figlia di puttana. Hattie continuò a servirlo e poi si ritirò in cucina, mentre Zantzinger ricominciava a tirar calci alla moglie. Hattie si sentiva svenire, lo disse ai colleghi: mi sento male, quell'uomo mi ha così tanto turbato ("that man has upset me so"). Morì in ospedale otto ore dopo: emorragia cerebrale. Era ipertesa, forse non lo sapeva.
Ma voi che filosofate sulle disgrazie, e criticate tutte le paure, tenete ancora a posto i fazzoletti. Questo non è il momento delle lacrime.
 |
| La moglie in seguito dichiarò: nessuno tratta bene i negri come mio marito, qui da noi |
Pochi secondi dopo, il disastro sociale che è Bob Dylan decide di spiegare che lui si sente un po' come Oswald, il cecchino di fede comunista che aveva freddato Kennedy a Dallas (una pedina dei cubani?) "Ho visto qualcosa di lui in me stesso", farfuglia. "Non pensavo che saremmo arrivati a questo punto, ma... devo avere il coraggio di ammettere di aver sentito le cose che lui sentiva... beh non al punto da sparare". Dall'attentato non era passato neanche un mese, nessuno aveva smesso di pensarci. Qualcuno comincia a fischiare, lui invoca la Costituzione, il diritto di parola e ringrazia per il premio anche a nome di quelli che vanno a Cuba. "O Dio", scriverà in seguito in una lettera di scuse, "cosa avrei dato per non essere lì" (qualcuno ancora si domanda come mai a Dylan non piacciano le premiazioni?)
Qualche anno fa successe una cosa del genere a Cannes. Lars Von Trier, all'apice della sua carriera, di fronte a un plotone di giornalisti, circondato da Charlotte Gainsbourg e Kirsten Dunst, cominciò a spiegare che per anni aveva pensato di essere ebreo, ma adesso era diverso, adesso un po' capiva Hitler, come doveva essersi sentito "seduto nel suo bunker, alla fine..." Fu cacciato dal festival del cinema. Era stato un altro esperimento? Aveva voluto testare la tolleranza di uno dei circoli culturali più progressisti del mondo? O era stato punito da un superego capriccioso che gli rimproverava il successo mondano, che da sempre cerca di sabotarlo? ("Feci uscire tutto quello che avevo in testa e dissi: sii onesto, Dylan, sii solo onesto").
William Zanzinger, che a 24 anni
possedeva 200 ettari di piantagione di tabacco;
e genitori facoltosi che lo proteggevano,
e amici altolocati nello Stato del Maryland,
si fece arrestare scrollando le spalle.
Imprecava e scherniva, e mostrava la lingua,
e fu fuori su cauzione, in pochi minuti.
Ma tenete ancora a posto i fazzoletti.
Questo non è il momento delle lacrime.
Quando assesta il primo colpo di bastone alla sua reputazione di cantante di protesta, Dylan ha un un disco pronto. Uscirà in gennaio. Sarà il suo disco più politico: i tempi stanno per cambiare. Niente più buffonate, niente talking, appena due canzoni d'amore, ma tristi, asciutte, rassegnate. Niente cover, tutti testi originali. Anche le musiche, tutte di Bob Dylan - o almeno così sarà scritto in copertina, e chi non sarà d'accordo se ne farà una ragione. Sarà il disco definitivo per il folk di protesta: nessuno potrà più farne uno migliore. Sarà il suo disco più impegnato: ma, ecco, cos'è l'impegno per Dylan? Come funziona, a cosa serve? A suscitare indignazione per la morte solitaria della cameriera Hattie Carroll, per l'assassino dell'attivista Medgar Evans, per la povertà che spinge Hollis Brown a uccidere i suoi figli, per i minatori disoccupati di North Country Blues, vittime precoci della globalizzazione? ("Dicono che è molto meno caro giù in Sudamerica, dove i minatori lavorano quasi per niente"). O serve a capire gli assassini, a sentirsi nei panni di Hollis Brown, di Zantzinger, di Oswald? Bisogna entrare nelle persone, cercare di capirle da dentro, o non sarà meglio osservarle da lontano, a una distanza prudente? Dylan il problema se lo è posto. È da anni che ci lavora.
Una cosa che a questa altezza ha già scartato senza rimpianti è la satira. Lo abbiamo visto cimentarcisi con Talkin' John Birch Paranoid Blues, un brano in cui aveva creduto così tanto da cercare di proporlo in diretta televisiva. Se in seguito gli avvocati della Columbia gli avevano impedito di inciderlo nel secondo disco, ora le cose erano davvero cambiate. Blowin' in the Wind era stata una bomba, The Freewhelin' aveva venduto bene, Dylan stava diventando importante e nessuno gli impediva di cambiare qualche riga del testo e inserirlo nel nuovo disco. Non ci pensa nemmeno. In John Birch aveva preso di mira l'uomo comune del Midwest; aveva descritto le sue paure come paranoie, ridicole ossessioni di un ignorante. Ma Dylan è un uomo del Midwest. È lì che si è formato, è quel mondo che gli interessa recuperare. Le sue radici individuali, rimosse nei primi dischi, riaffiorano finalmente in North Country Blues. La paura di morire in un olocausto nucleare - o soffocato in un rifugio antiatomico - Dylan la conosce per esperienza diretta: era la stessa che le maestre gli avevano infuso a scuola durante le lezioni e le prove di evacuazione. Il razzismo non è un problema astratto, un virus esotico isolato nel Sud del Paese: Dylan lo ha sperimentato a Hibbing, Minnesota, quando ancora si chiamava Robert Zimmerman ("A Hibbing, i finlandesi odiavano i boemi, i boemi odiavano i finlandesi e praticamente tutti odiavano gli ebrei"). Per ridere di tutto questo dovrebbe ridere di sé stesso. Ma se ride di sé stesso, chi lo prenderà più sul serio? Dylan rideva degli anticomunisti, finché un comunista non ha sparato al Presidente. Dovrebbe fingere che non è successo, che le cose a questo punto non cambiano?
My name it is nothin',
My age it means less.
The country I come from
is called the Midwest...
Un'altra possibilità rapidamente scartata è la canzone indignata: quella che punta il dito contro un male del mondo, più o meno specifico. Anche qui non mancano esempi di precoci tentativi: una delle sue prime canzoni, The Death of Emmett Till, era il racconto indignato di un altro fatto di cronaca, la storia vera di due buzzurri razzisti che avevano ammazzato un bambino afroamericano e l'avevano fatta franca, sulle note di House of the Rising Sun. È un pezzo efficace per quanto ingenuo (ma non lo sono tutti i pezzi di protesta? Non lo sono tutti i pezzi folk?) Dylan avrebbe potuto cantarlo a Washington senza imbarazzi. Invece se ne è sempre vergognato. Non tanto dell'ingenuità dei versi, quanto di aver pensato di poter scrivere una canzone del genere. Dalla morte di Emmett Till a quella di Hattie Carroll il passo sembra breve. Ma qualcosa è successo. Qualcosa che non ti aspetteresti da un folksinger con robuste radici nel tessuto culturale americano. Dylan ha scoperto Bertolt Brecht.
("Hai letto molte cose di Brecht?"
"No, però l'ho letto").
Dylan è un autodidatta, in molti sensi. Il modo con cui si confronta con la cultura, in cui impara le cose è del tutto particolare, pre-moderno in un certo senso. In Chronicles dà l'impressione di poter afferrare i concetti soltanto quando qualcuno glieli riduce alla forma orale. Può essere un amico o un tizio incontrato per caso durante una gita in motocicletta: un matto o un profeta. Quando a vent'anni comincia a farsi delle domande sulla Guerra Civile, trova indispensabile chiedere un parere a Van Ronk - il quale non fa che ribadire un'ovvietà da sussidiario. Dylan era perfettamente in grado di leggere un sussidiario, ma aveva bisogno di sentirsi dire certe cose da un Van Ronk. Dylan in realtà legge più di quanto sembri, ma anche quando si tuffa nella libreria del suo padrone di casa, descrive la sua esperienza come un incontro con scrittori in carne e ossa: Balzac sembra un suo amico, beve litri di caffè, perde un dente e si domanda: "cosa significa?" ("Balzac is hilarious").
Hattie Carroll, che era cameriera in cucina,
con 51 anni e dieci bambini,
che serviva portate e gettava immondizie
e che in vita non sedette mai a capotavola
e che non rivolgeva mai parola ai clienti,
e che raccoglieva gli avanzi dai tavoli,
e su un altro piano svuotava i portacenere,
fu uccisa da un colpo inferto da un bastone
che girando nell'aria piombò in quella stanza,
determinato a uccidere ogni gentilezza,
e non aveva mai fatto niente a Zanzinger!
Ma voi che filosofate di disgrazie, e criticate tutte le paure, tenete ancora a posto i fazzoletti. Questo non è il momento delle lacrime.
 Quanto all'incontro con Brecht, esso non passa nemmeno dalla pagina scritta: Dylan ascolta Jenny dei pirati in un teatro di Christopher Street, mentre aspetta Suze Rotolo che lavora dietro le quinte. Forse non c'è modo peggiore di accostarsi al teatro epico brechtiano, quello che a uno spettatore disincantato non dovrebbe offrire allo spettatore "suggestioni", ma "argomenti". Il Dylan ventenne è lo spettatore meno brechtiano che si possa immaginare. Quando nel buio della sala ascolta la storia della Fregata Nera, "tutta vele e cannoni", che arriva in città per raderla al suolo e salvare una sola persona, la suggestione è potentissima, gli argomenti scompaiono. È il ricordo dell'infanzia a Duluth, Minnesota, porto internazionale sul Lago Superiore, dove le navi andavano e venivano in continuazione e "l'intenso fischio delle sirene ti prendeva per il collo e ti toglieva il senno... sembrava sempre annunciare qualcosa di grande".
Quanto all'incontro con Brecht, esso non passa nemmeno dalla pagina scritta: Dylan ascolta Jenny dei pirati in un teatro di Christopher Street, mentre aspetta Suze Rotolo che lavora dietro le quinte. Forse non c'è modo peggiore di accostarsi al teatro epico brechtiano, quello che a uno spettatore disincantato non dovrebbe offrire allo spettatore "suggestioni", ma "argomenti". Il Dylan ventenne è lo spettatore meno brechtiano che si possa immaginare. Quando nel buio della sala ascolta la storia della Fregata Nera, "tutta vele e cannoni", che arriva in città per raderla al suolo e salvare una sola persona, la suggestione è potentissima, gli argomenti scompaiono. È il ricordo dell'infanzia a Duluth, Minnesota, porto internazionale sul Lago Superiore, dove le navi andavano e venivano in continuazione e "l'intenso fischio delle sirene ti prendeva per il collo e ti toglieva il senno... sembrava sempre annunciare qualcosa di grande".Jenny dei pirati è una canzone bastarda (continua sul Post).
Mr Dylan va a Washington
13-01-2017, 20:53Americana, Bob Dylan, Il Post, manifestaiolismi, musicaPermalinkUna pallottola da un cespuglio si prese il sangue di Medgar Evers...
Tra il festival alla Brandeis University e il concerto alla Carnegie Hall ci sono appena cinque mesi, ma i tempi stanno decisamente cambiando, non solo per Dylan. Il ragazzo ha iniziato a vendere dischi - non tanto i suoi, all'inizio: è la versione di Blowin' in the Wind di Peter, Paul and Mary a essere entrata in top ten. Ma è Joan Baez soprattutto che lo ha preso sotto la sua ala. Con già tre dischi d'oro all'attivo, la Baez non è soltanto una cantante folk: lei è popolare davvero. Il suo pubblico è molto più esteso di quello del folk festival di Newport (dove comunque chiama sul palco Dylan in luglio); più trasversale della piccola comunità di studenti e hipster metropolitani che cercano nel folk una connessione sentimentale con l'America vera (il Paese reale, lo chiameremmo oggi). Lo si vede chiaramente appena un mese dopo.
Il 28 agosto centinaia di migliaia di manifestanti marciano su Washington per chiedere pace, lavoro e diritti civili. Se guardate le foto, è uno di quei casi in cui in Italia si parla di un milione, un milione e mezzo (centomila per la questura). L'80% erano afroamericani e probabilmente non avevano mai assistito a concerti folk. Ma Joan Baez aveva le carte in regola per prendere il microfono - qualche ora prima che il reverendo Martin Luther King annunciasse "I had a dream" - e intonare Freedom, intonare We Shall Overcome. La Baez però si era portata anche Dylan. Che occasione storica per cantare Blowing in the Wind davanti a centinaia di migliaia di persone, no? Pensate che Dylan la coglierà?
E poi vi stupite che non vada a Stoccolma. A un pubblico così diverso dal solito, il giovane cantautore bianco non propone il suo primo (e fin qui unico) successo, l'unico brano che avrebbero potuto sentire in radio; l'unico di cui qualcuno avrebbe potuto canticchiare un ritornello - è vero che da qualche parte del corteo lo avevano già intonato Peter Paul e Mary, ma nessuno se la sarebbe presa per un bis. A un pubblico tanto affamato di cori da chiesa e/o da stadio, Dylan propone un pezzo che ha appena scritto e non ancora registrato, una canzone che conosce solo lui, ispirata un po' alla Bibbia un po' alla Jenny dei Pirati di Bertolt Brecht, When the Ship Comes In. Nel filmato si vede la Baez arrivare in un secondo momento, un po' a sorpresa, quasi come se avesse capito solo in quel momento che c'era bisogno di dare una mano - ma neanche lei sa le parole, e allora che fa? Canta la melodia. Con l'acustica approssimativa che doveva esserci, con quel benedetto ragazzo che si ostina a masticare parole nuove davanti al microfono, l'unico modo di salvare l'esibizione è far sentire la melodia. Lei se ne rende conto subito, e interviene. Una professionista, lei.
(Non tutti quelli che amano Dylan sono obbligati ad amare la Baez. Ma di solito più conosci lui, più scopri di stimare lei).
Gli sceriffi, i soldati, i governatori sono pagati, e i federali e i poliziotti; ma il povero bianco è nelle loro mani come uno strumento. Nelle scuole gli insegnano dall'inizio che le regole e le leggi sono dalla sua parte, per proteggere la sua pelle bianca e conservare il suo odio perché non veda mai le cose come stanno, e il ruolo che gli è capitato; ma non va incolpato. È solo una pedina nel loro gioco...
 |
| "Ma cosa sta dicendo?" |
Due mesi l'artista emergente fa una data al Carnegie Hall. La registrazione è così buona che alla Columbia pensano di farne un disco; hanno già mandato in stampa la copertina quando cambiano idea, non si è mai capito il perché. Live at Carnegie Hall 1963è il disco che ha rischiato di essere il primo live ufficiale di Dylan, dieci anni prima di Before the Flood. I brani hanno circolato per trent'anni su bootleg abusivi prima di entrare, un po' alla spicciolata, nel catalogo ufficiale: una nuova versione di Talkin' John Birch Paranoid Blues e un inedito, Who Killed Davey Moore?, escono nel primo volume della Bootleg Series nel 1991; una Hard Rain e When the Ship Comes In usciranno nel settimo volume, la colonna sonora del documentario No Direction Home di Scorsese. Allo stesso volume viene allegato un minialbum con sei canzoni, che è quello a cui stiamo facendo riferimento adesso, perché Dylan senz'altro ci interessa ma non siamo fanatici. Se fossimo fanatici, potremmo recuperare tutte le canzoni del concerto dall'edizione limitatissima in sette 33giri di tutti le incisioni di Dylan del 63, che la Columbia ha stampato per evitare che dopo 50 anni scadano i diritti (ne esistono soltanto cento copie in vinile).
Restiamo sui brani del miniLP, che ci sarebbe già tanto da dire. Il concerto comincia con quella che dovrebbe essere la prima versione mai incisa di The Times They Are A-Changin', un brano che attualmente su Spotify risulta ascoltato 48 milioni di volte - il doppio di Blowing in the Wind. Tra le canzoni di Dylan, solo Like a Rolling Stone la sorpassa. Io quando l'ho risentita in tutto il suo nudo splendore, sui titoli di apertura di Watchmen, non la ascoltavo probabilmente da 15 anni. È chiaro che quando chiede ai genitori di dont't criticize what you can't understand non mi fa più l'effetto che mi faceva alle scuole medie. È chiaro che se dovessi ridurre tutto Dylan a un verso solo probabilmente sceglierei proprio "don't criticize what you can't understand", che è poi quello che ha ripetuto ai critici per mezzo secolo, invano. (In effetti, cosa stiamo facendo in questo esatto momento?) Ma se ora l'ascolto nella sua prima versione live è perché sto cercando di toglierla dal suo involucro di canzone-famosissima-di-BD e cercare di calarla in un contesto storico, sociale - in realtà qualsiasi contesto andrebbe bene, pur di riuscire ad ascoltarla con orecchie nuove. Per me è sempre stata un buffo ossimoro, una canzone vecchia che parlava di rivoluzione, di cose nuovissime che sarebbero arrivate. Lasciamo perdere.
Restiamo all'ottobre '63; quell'estate Dylan ha visto i manifestanti sul mall di Washington, ha ascoltato il reverendo King; gli hanno chiesto di cantare una canzone ma forse lui non aveva quella giusta da cantare. Pochi giorni dopo il suo amico bluesman e scrittore Tony Glover lo va a trovare nel suo appartamento sulla Quarta Strada. Sul tavolo di lavoro i soliti scartafacci. Glover intravede un paio di versi che già nel '63 sembrano i meno dylaniani in assoluto: "come senators, congressmen, please heed the call". Venite senatori e deputati, per favore, ascoltate l'appello. A quel punto Tony racconta di aver detto: "ehi, ma che roba è?" (What is this shit, man?), per sentirsi rispondere; beh, sai, sembra che sia la roba che alla gente piace ascoltare. Seguirà un mezzo secolo di ritrattazioni, in cui Dylan negherà di aver mai cercato coscientemente di cambiare il mondo con le canzoni, o di aver mai ambito a un ruolo da portavoce di un movimento o di una generazione. Forse l'unico modo di riascoltare The Times con orecchie vergini è tentare un po' di sano revisionismo: c'è stato un momento in cui ci ha davvero provato, in cui si è messo a tavolino e ha tentato di costruire la canzone adatta per la prossima Grande Marcia. La sua We Shall Overcome. E c'è riuscito?
Oso rispondere di no (continua sul Post).
Dylan è un rapper?
05-01-2017, 20:24Americana, Bob Dylan, Il Post, musicaPermalinkQuesta qua è a proposito del Picnic sul Monte Orso, che non c'è mai stato... era previsto che ci fosse, ma non è andata così. È stato due anni fa a New York City, quando organizzarono un picnic sul Monte Orso per la gente che era stata in casa lungo tutto l'inverno... vendevano biglietti per il picnic, ma un gruppo di persone si mise d'accordo e cominciò a stampare biglietti falsi per il picnic, e li vendevano anche loro. Così sulla nave alla fine c'era il doppio di persone di quelle che avrebbero potuto starci, sulla stessa nave, cioè... la nave era per tremila persone e ci salirono seimila persone.
E il picnic non ci fu, perché la nave colò a picco (risate).
The Freewheelin' Bob Dylan esce ufficialmente il 27 maggio del 1963. Due settimane prima Dylan ha partecipato a un festival folk in Massachussetts, presso la Brandeis University. Se nella scena hip del Village era già un personaggio di un certo rilievo, a dieci miglia da Boston è ancora un signor nessuno: non è così scontato che qualcuno si dia la pena di registrarne la performance. Il nastro di Brandeis University (l'originale?) fu ritrovato nell'archivio di Ralph Gleason, critico musicale e cofondatore del Rolling Stone, dopo la sua morte. Siccome non erano ancora passati 50 anni, la Columbia aveva ancora il diritto esclusivo di ripubblicarlo, cosa che fece nel 2010.
Per i dylaniti di stretta osservanza si tratta di un documento importante: c'è la prima registrazione pubblica di The Ballad of Hollis Brown, un blues degli Appalachi secco e gelido, la storia di un contadino affamato del Sud Dakota che col suo ultimo dollaro compra sette cartucce per far fuori moglie, figli e sé stesso. Ispirato da un fatto di cronaca, scartato dalla scaletta dell'album del '63, Hollis Brown diventerà uno dei nuclei emotivi dell'album successivo, The Times They Are A-Changin', il disco più serio, più politico del primo Dylan. L'unico pezzo di The Freewheelin' che suggeriva un'evoluzione del genere era Masters of War, che in questo nastro segue immediatamente Hollis Brown.
 |
| L'unica foto che abbiamo. Respect. |
Tanto per cominciare, non sono blues. Né da un punto di vista musicale (la progressione degli accordi è diversa) né storico: non nascono in seno alla comunità afroamericana, ma sono la bizzarra invenzione di un mandolinista del South Carolina, Christopher Allen Bouchillon, che aveva un sacco di cose da cantare ma - dicono le cronache - era orribilmente stonato, sicché il produttore che lo snidò a metà anni Venti gli suggerì di limitarsi a declamare i suoi testi mentre strimpellava. Erano comunque versi concepiti per essere cantati, con un pattern abbastanza regolare: quattro tetrametri giambici, accoppiati con rime baciate. C'è già la possibilità di raddoppiare le sillabe accelerando il flow, come faranno i rapper decenni dopo. Un primo effetto comico nasce proprio nel contrasto tra la musica - che sembra assolutamente cantabile - e l'ostinazione della voce solista a ignorare la melodia. Un secondo effetto nasce dall'aggiunta alle strofe di un commento finale senza più vincoli metrici.
Il primo Talking blues Bouchillon lo registrò nel 1927, con un discreto successo. Se volete considerarlo l'inventore del rap, perché no: nella mia lunga vita ho visto consegnare il titolo ad artisti bianchi meno antichi e meritori, da Steve Tyler a Debbie Harry a Joe Strummer a.. a... Celentano. Non c'è dubbio che Bouchillon abbia iniziato a declamare su una nota sola molto prima di loro. Il fatto che la sua tecnica nasca dalla necessità di superare un handicap lo accosta senz'altro a molti rapper di oggi che danno l'impressione di non riuscire a passare dal do al sol senza autotune. Ma Bouchillon non è senz'altro il primo ad aver parlato su un accompagnamento musicale. Altri bluesmen stavano già inserendo recitativi tra i ritornelli cantati, il che si avvicina già più all'idea del rap moderno (Dylan ruberà qualcosa anche da loro, vedi le varie versioni di I Shall Be Free). Malgrado il nome, invece, il talking blues di Bouchillon avrà più successo presso le comunità folk e country. Woody Guthrie si impossesserà della formula aggiungendo soltanto quella sua verve particolare che aveva conquistato il giovane Dylan sin dal primo ascolto ("Era poetico e duro e ritmico. Aveva una tale intensità e la sua voce era come un pugnale [...] Buttava dentro il suono dell'ultima lettera di una parola ogni volta che ne aveva voglia e l'effetto era quello di un pugno"). Dopo Dylan, e grazie a lui, si cimenteranno col talking blues Jonny Cash, Phil Ochs, e in Italia, con devozione quasi filologica, Francesco Guccini.
Il talking blues è il primo tipo di canzone folk che Dylan ha provato a scrivere. Come sappiamo uno dei due brani originali del suo disco di esordio era già un talking affinato e tagliente, Talkin' New York, in confronto al quale A Song to Woody sembra molto più ingenua. Dylan sembra un po' più maturo, più esperto delle cose della vita, quando si esprime coi talking blues: dopo averne scritti un paio può pure raccontare in giro di aver viaggiato in treno merci per il Delta in compagnia di questo o quel bluesemen e aspettarsi che qualcuno gli creda. Ancor prima di Talkin' New York, Dylan dovrebbe aver scritto uno dei pezzi eseguiti alla Brandeis, Talkin' Bear Mountain Picnic Massacre Blues. Noel Stookey (il Paul del trio Paul, Peter and Mary) racconta di aver incontrato Dylan al Gaslight, e di avergli allungato una copia dell'Herald Tribune con un articolo sul tragicomico naufragio di un battello nel fiume Hudson. Il giorno dopo Dylan gli avrebbe fatto sentire la prima versione del suo Talkin'. Curiosamente Stookey rammenta con precisione la data: 19 giugno del 1961. Quando Dylan lo usa per chiudere il suo set alla Brandeis, il brano ha ormai due anni e Dylan lo indossa come un pantalone sformato: ormai ha imparato come allungare il recitativo a fine strofa a suo piacimento. In generale alla Brandeis Dylan dà l'impressione di appoggiarsi sui talking come se li considerasse i brani più sicuri del suo repertorio: anche chi non conosce la nuova promessa del folk newyorchese ascoltando Talkin' Bear Mountain almeno si fa una risata. Di Talkin' World War III abbiamo già parlato: si tratta di uno dei brani più interessanti e personali di The Freewheelin'.
Beh mi sentivo davvero giù
Non sapevo proprio che fare più.
I comunisti son pronti alla guerra
Arrivan dal cielo, arrivan da terra
(Non mi daranno pace...)
Un discorso a parte lo merita Talkin' John Birch Paranoid Blues, che fu levato dalla scaletta di The Freewheelin' all'ultimo momento (esistono rarissime copie del 33 giri che lo contengono). Non solo: era il brano che Dylan intendeva cantare in tv, all'Ed Sullivan Show, il 12 maggio. È un brano divertente che si prendeva gioco dei membri di un'associazione anticomunista radicata in particolare nel Midwest. La JBS esiste ancora, tra i suoi fondatori ci sono quei fratelli Koch che hanno dato una grande mano anche al movimento del Tea Party. Al tempo accusavano Martin Luther King di essere un pupazzo nelle mani dei sovietici, e Kennedy un traditore della Repubblica. E tuttavia nella primavera del '63 i tempi sembrava che stessero cambiando. Che i giorni della caccia alle streghe di McCarthy fossero alle spalle lo si capisce anche solo dal fatto che lo stesso Ed Sullivan fosse ben contento di presentare il brano: fu il primo a protestare quando gli avvocati della CBS si opposero alla messa in onda. Ma come - chiese il presentatore - possiamo fare sketch sul presidente Kennedy e non su un'associazione di qualche decina di migliaia di membri?
A quel punto, piuttosto di cambiare canzone, Dylan rifiutò di partecipare al programma (continua sul Post)
Il Bob a ruota libera
31-12-2016, 12:46Americana, Bob Dylan, Il Post, musicaPermalinkNel 1963 Tom Wilson era un promettente produttore trentenne. Non aveva ancora avuto l'idea di fornire a The Sound of Silence un accompagnamento elettrico, il gesto che di fatto rimise assieme i misconosciuti Paul Simon e Art Garfunkel e li proiettò verso la fama mondiale; non aveva ancora scoperto Zappa, né prodotto i Velvet Underground. Ma aveva già lavorato coi giganti del free jazz, Sun Ra e Coltrane. Quando alla Columbia gli chiedono di aiutare un nuovo folksinger a completare il suo album, non sembra molto convinto: "pensavo che il folk fosse roba da scemi (dumb guys). Lui suonava come quegli scemi, ma quando quelle parole saltarono fuori, restai sbalordito". Si tratta ovviamente del nostro Bob Dylan, che in quei mesi è già diventato uno degli artisti più cool in città. Anche se il suo primo disco ha venduto soltanto 5000 copie; anche se continua a suonare in seminterrati come il Gaslight (però Furio Colombo quando passa nota una fila di ragazzine che cerca di entrare). Anche se le nuove canzoni per ora è più facile leggerle che ascoltarle: gli spartiti di Blowin' In The Wing e Oxford Town escono su rivista prima ancora che le canzoni siano incise.
(Persino io ho vissuto qualche anno in cui non sapevo chi fosse Dylan, ma già conoscevo una canzone che faceva Risposta non c'è, o forse chi lo sa, la luna nel vento sarà. La cantavano gli scout più grandi con le chitarre, rintanati sul fondo delle corriere; leggevano testo e accordi su fotocopie di ciclostili che circolavano liberamente, senza più indicazioni di autori e coi titoli sbagliati. Che in fondo era esattamente quel tipo di fama a cui aspirava Dylan prima del '63: spargere le sue note anonime nel mondo, come Woody Guthrie e tutti gli altri bardi più o meno sconosciuti di cui si sognava erede).
Il 1963 cambia tutto, o almeno in seguito ci siamo convinti di questo. In primavera escono due album che in teoria fanno tabula rasa dell'immaginario giovanile e della storia della musica: uno è proprio The Freewheelin' Bob Dylan, il primo capolavoro di Dylan; l'altro è il 33giri di questo nuovo gruppo inglese, i Beatles. Anche loro all'apparenza non fanno nulla di nuovo e neanche di troppo intelligente. Anche i loro brani possono essere smontati pezzo per pezzo, e rivelare gli antecedenti, anche meno clamorosi: c'è ancora molto rock'n'roll (un genere che da qualche anno era passato di moda), qualche ballata, qualche incursione spericolata nel rhythm and blues... nulla di eccezionale. Anche loro un po' scemi, un po' poser, con un'agguerrita fanbase di ragazzine. Quello che fa la differenza, nota Bob (o almeno così racconta 40 anni dopo), è un imponderabile elemento di simpatia. Istintivamente, Lennon e McCartney azzeccano la tonalità della nuova generazione: pur muovendo da radici più complesse, più contorte, Dylan fa la stessa cosa. Più delle parole conta il personaggio che stai costruendo, o meglio: il personaggio che riesci a costruirti, con quelle parole.
Sono mesi intensi. Dylan è diventato maggiorenne (al tempo succedeva a 21 anni) il che ha fornito al suo nuovo manager una scusa per rinegoziare il contratto con la Columbia; è stato addirittura in Europa in una balorda tournée - un regista inglese dopo averlo visto e ascoltato aveva deciso di scritturarlo per un dramma televisivo alla BBC; lui per l'occasione aveva dimostrato quell'inettitudine alla recitazione che tante frustrazioni arrecherà a lui e ai suoi fan più affezionati. Ma insomma, in città i giornalisti cominciano a parlarne bene. Pete Seeger e Dave Van Ronk, l'aristocrazia folk, lo invitano sui palchi, ai festival, sul divano quando c'è bisogno. Il nuovo disco sta crescendo, non è che il ragazzo si trovi sempre a suo agio in sala di registrazione: diversi esperimenti andranno buttati via - però quel che resta sembra proprio roba buona. Più originale del solito. Quasi ogni pezzo ha una sua storia, un suo pedigree, un paio di ballate hanno progressioni armoniche che puoi far risalire al Settecento. Ma basta attraversare la strada, anzi, un corridoio alla Columbia, e c'è già chi la pensa in un modo completamente diverso: il folk? Roba da scemi.
Sono quelle percezioni che ad alcuni dylaniti sfuggono. Oggi dissezionare le radici è fin troppo facile. Woody Guthrie, il blues del Delta, il folklore inglese, sono a portata di clic. È facile rendersi conto che il cantautore ventenne era una spugna imbevuta di antichità europee e americane; le fonti dirette e indirette sono lì apposta per autorizzare qualsiasi deriva erudita: lo stesso Dylan ci tiene a farci sapere che in lui convergono il blues di Robert Johnson, il simbolismo di Rimbaud, l'espressionismo di Jenny dei Pirati. E allo stesso tempo, tutta questa roba è un po' da scemi. Tutto il revival folk, questa sottocultura del Village che tiene in piedi qualche caffè, che se ti sbatti ti può far vendere qualche migliaio di dischi. Roba da studenti. Specchietti per le allodole. È un sospetto che sfiora lo stesso Bob, quando all'inizio del suo blues omonimo avverte: le canzoni folk di oggi le scrivono a Tin Pan Alley (il quartiere degli editori di musica commerciale).
È fin troppo facile oggi prendere The Freewheelin' e smontarlo nei suoi fattori primi - per scoprire che su 13 pezzi Dylan è responsabile sì e no di un paio di melodie (c'è di nuovo un ragtime sparato a cento all'ora Honey, Just Allow Me One More Chance, e a ben vedere anche Don't Think Twice è un ragtime), e che certe invenzioni (la progressione di Girl of the North Country) sono fortuite, magari causate dal fatto che non conosceva gli esatti accordi di Scarborough Fair, o magari l'aveva ascoltata una volta sola e se la ricordava in una scala diversa. È fin troppo facile perdersi nell'enciclopedia dei rimandi, ed è il modo migliore per non capire l'impatto del disco nel 1963. Persino Blowin' in The Wind non era un'aria originale, ma nel '63 chi poteva saperlo? Solo Pete Seeger ricordava di aver sentito il canto degli schiavi ribelli, No More Auction Block, da cui Dylan aveva preso la strofa. Quel che crea veramente la tabula rasa non è Dylan, ma l'ignoranza del pubblico a cui si rivolge. Questi ventenni suoi coetanei, o di poco più giovani, che Guthrie non lo ascoltano e non lo ascolteranno mai. Di Robert Johnson deve ancora uscire un LP. Per loro The Freewheelin' suona assolutamente nuovo e fresco. E Dylan non fa nessuno sforzo per suggerire il contrario: il folk, dice, ormai si fa a Tin Pan Alley. Forse ce l'ha col folk commerciale, quello che sta per riempirgli le tasche appena gli artisti più affermati di lui cominceranno a incidere le sue canzoni. Forse ce l'ha col suo pubblico di finti poveri e hipster (il termine esisteva già, anche se indicava più spesso i bohemién bianchi che ascoltavano il jazz). Forse non ce l'ha con nessuno: sta solo suggerendo di non essere preso sul serio.
Per fare un esempio: una prestigiosa rivista studentesca ha indetto un concorso: scrivete una canzone sui fatti di Oxford. A Oxford, Mississippi, il presidente Kennedy ha dovuto mandare la Guardia Nazionale per tenere aperta l'università - altrimenti i bravi cittadini del posto avrebbero sparato a James Meredith, primo studente universitario afroamericano. Dylan partecipa al concorso con questa canzoncina che sembra incaricarsi di deludere qualsiasi aspettativa: racconta di essere stato a Oxford (non è vero) e di avere incontrato la sua ragazza - e il figlio della sua ragazza - in mezzo ai fumogeni. Nel frattempo è morto qualcuno e bisognerebbe investigare. Fine.
È difficile capire come l'autore di bozzetti del genere possa essere stato identificato come portavoce politico di una generazione (continua sul Post).
Capitan Fantastico scende in città
15-12-2016, 18:12Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkLassù sulle montagne, dove l'aria è più buona e il capitalismo non arriva, vive senza chiedervi il permesso la famiglia Cash. Sono filosofi e carnivori; di giorno cacciano e disossano i cervi e la sera, intorno al fuoco, bivaccano studiando la teoria delle stringhe. Scalano montagne, affilano lame, sono buddisti ma armati. Un giorno scenderanno a darvi una lezione. Non si sentono superiori a nessuno; lo sono.
Fino a qualche anno fa non succedeva mai, e quest'anno è capitato già più volte, di ritrovarmi di fronte a un film americano pensando "beh ma preferivo la versione italiana". Non so se abbia più a che fare con la salute del cinema USA o con la mia. Il paragone tra Captain Fantastic e Le meraviglie di Alice Rohrwacher non ha molto senso, comunque: anche se entrambi sono molto piaciuti a Cannes. Da una parte un prodotto d'autore europeo, drammatico (con qualche virata nel simbolico), dall'altra un comedy-drama americano, uno di quei film da Sundance che di indipendente non hanno nemmeno la confezione; l'ennesimo tentativo di far convivere le suggestioni del ritorno alla natura con un linguaggio che infallibilmente ne restituisce immagini patinate. È una di quelle situazioni in cui i famosi production values americani, quei livelli ineguagliati di professionalità e organizzazione, si ritorcono contro la macchina: fai fatica a spiegarci Henry David Thoreau se i tuoi strumenti sono quelli con cui si gira la pubblicità di uno shampoo... (continua su +eventi!)

Matt Ross ha voluto girare un film diametralmente opposto alla sua opera prima, 28 Hotel Rooms: là c'erano soltanto due attori in 28 camere d'albergo diverse (da cui il titolo), qui c'è tutto l'Ovest, dalle foreste dello Stato di Washington fino ai campi di golf del New Mexico, uno schiaffo alla miseria e alla siccità; e una famiglia di selvaggi sapienti che è un trionfo di casting - ragazze e bambini hanno tutti pochi minuti per lasciare un segno, e ce la fanno. E poi c'è Viggo Mortensen, padre-padrone illuminato, che per metà film sembra davvero l'uomo più saggio del mondo: com'è prevedibile, basterà scendere un po' a valle perché tutto venga messo in discussione. Ma appunto, è un po' troppo prevedibile. È capitato ad autori più esperti di Ross di scontrarsi con lo stesso argomento, e di consegnare agli spettatori qualcosa di irrisolto o ambiguo (vedi Into the Wild). È come se intorno all'argomento ci fosse qualcosa di sostanzialmente sacro: magari ritornare alla natura è impossibile, ma non è comunque consentito riderne.

Il manuale di base della sceneggiatura televisiva prevede che l'eroe si scontri con le convenzioni; che a ogni parziale successo corrisponda l'accettazione dei propri limiti; le convenzioni sono elastiche, si lasciano penetrare, ma in cambio l'eroe deve capire che hanno un senso. Captain Fantastic deve accettare di essere un po' meno fantastic; passare dalla caccia all'agricoltura; in cambio resterà un filosofo e continuerà a conservare la sua famiglia bellissima. È un finale che ha un senso soltanto al cinema o in tv, e soltanto in America. Qui da noi è diverso, al punto che di un film così forse non sappiamo che farcene. Captain Fantastic questa settimana resiste solo al Fiamma di Cuneo (giovedì 15, venerdì 16, lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 alle ore 21; sabato 17 ore 17.30 - 20.00 - 22.30; domenica 18 ore 15.00 - 18.00 - 21.00).
Obama tramonta, Snowden resta (ma a Riotta non va proprio giù)
27-11-2016, 02:16Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, giornalisti, internetPermalinkRicordate il giorno in cui avete pensato di coprire la webcam del vostro computer, il giorno in cui non vi è sembrata più una paranoia? Quando è successo? Difficilmente prima dell'estate del 2013. In primavera l'ex agente NSA Edward Snowden aveva abbandonato la sua postazione di lavoro alle Hawaii portando con sé in una card più di due milioni di documenti riservati dei servizi americani (e inglesi, canadesi, australiani, neozelandesi). In giugno li aveva consegnati ai reporter del Guardian che lo avevano raggiunto in una stanza d'albergo di Hong Kong. Qualche giorno dopo il suo avvocato riusciva a metterlo su un aereo. Snowden sperava di trovare asilo in Sudamerica, ma una volta arrivato in Russia, gli USA gli hanno revocato il passaporto. È ancora là.
Man mano che l'astro di Obama tramonta, è più facile accorgersi di come Edward Snowden sia una delle figure più importanti dell'ultimo decennio. Non ha semplicemente gettato una macchia sul presidente più cool di sempre; non si è limitato a rivelare segreti militari, non ha soltanto bruciato qualche agente di antiterrorismo: Snowden ci ha fatto coprire le webcam. Se prima dell'estate del '13 avevamo qualche sospetto di essere spiati dalle nostre compagnie telefoniche, da lì in poi abbiamo dovuto accettarlo: non c'è paranoia che non si stia realizzando. Ogni smartphone è una cimice, ogni videocamera fa rapporto a qualche grande fratello. A inizio 2013 sarebbe stata la premessa di un film di fantascienza distopica: tre anni dopo è già materiale per Oliver Stone.
Forse la storia più congeniale a essergli passata per le mani dai tempi di Nato il 4 luglio, a cui fin troppo somiglia. Prima di questo film la nostra idea di Snowden oscillava tra l'hacker e l'attivista per i diritti civili; ma lo Snowden di Stone è per prima cosa un veterano. Si ricomincia dal solito addestramento da accademia militare: correre nei boschi, strisciare nel fango, urlare sissignore all'istruttore. Potrebbe essere l'inizio dell'ennesimo film di guerra, se il giovane Edward non si fratturasse le ossa alzandosi dalla brande con troppo zelo. Non importa, gli spiega l'ortopedico: ci sono altri modi per servire la tua patria. Ma anche quando si dimetterà dalla CIA per scrupolo, trasformandosi in una specie di contractor privato; anche quando sceglierà di tradire il suo Paese, lo Snowden di Stone resterà a suo modo un soldato, proprio come il Kovic di Nato il 4 luglio che aveva bisogno di scoprire la militanza pacifista per rimettersi a urlare ordini ai sottoposti. Snowden è disciplinato e responsabile, Snowden valuta i pro e i contro di ogni situazione; rispetta il presidente come comandante-in-capo; prova devozione filiale per i superiori e un malcelato disprezzo per i camerati che per far carriera compiono gesti irresponsabili. E come il cecchino di American Sniper, di cui è una specie di gemello buono, ha una donna che vorrebbe proteggere e che in un qualche modo lo protegge.
Stone prende una complicata storia di leak e di intelligence e la smonta fino a trovare i fattori primi, umani, che funzioneranno anche con gli spettatori digiuni di crittografia. Se il rischio è accreditare il personaggio come un genio del computer, Stone lo corre volentieri. Non ha mai avuto la mano leggera, ma forse in questo caso c'era proprio bisogno di trasformare entità astratte in immagini potenti. La webcam che diventa un occhio: un ragazzino con la camicia in fuori che in qualche ufficio dall'altra parte del mondo può spiarti l'account facebook per antiterrorismo o per capriccio. Stone preferisce girare all'estero, ma quel che vuole realizzare è proprio il caro vecchio blockbuster americano: non esita a mettere al centro una storia d'amore; ce la mette tutta pur di inserire sequenze che non stonerebbero in film di spionaggio o di azione. E come Michael Moore, sente l'esigenza di ricordarci a ogni pié sospinto che è altrettanto americano dell'America che sta criticando (continua su +eventi!)

A Washington c'è un posto dove gli innamorati
mettono i lucchetti?
PS: per un approccio più completo, segnalo questa epica recensione di Gianni Riotta sulla Stampa, che vi riassumo per sommi capi e per divertimento:
Primo paragrafo: nel 1932 Walter Duranty, un giornalista del NYT vinse un Pulitzer con un'inchiesta filostalinista (che c'entra con Snowden, vi chiederete? Dopo lo spiega);
secondo paragrafo: Zizek è affascinato da Trump e Stone bazzica il Cremlino: Putin gli avrebbe affidato un documentario sull'Ucraina (in realtà Stone ha prodotto un documentario di un regista ucraino naturalizzato negli USA, vabbe', dettagli);
terzo e quarto paragrafo: l'avvocato russo di Snowden è un uomo di Putin, Snowden è una sua marionetta, anche Stone è una sua marionetta e inoltre a una festa ha messo una mano sul collo della documentarista Laura Poitras. Nel romanzo che l'avvocato russo ha scritto sul caso Snowden tutti i nomi sono cambiati, il che non c'entra veramente nulla col film ma Riotta si mette a elencarli, per dimostrare che ha letto il libro (e il film, lo avrà visto?);
quinto paragrafo: Snowden ha arrecato gravissimi danni al controterrorismo, almeno a detta delle agenzie americane e francesi di controterrorismo. Kerry voleva arrestarlo, invece Oliver Stone ci ha fatto un film. È un regista che ha vinto degli Oscar, ma anche a un giornalista stalinista una volta hanno dato un Pulitzer, vi ricordate? Credevate che Riotta fosse andato fuori tema, eh? E invece no, tutto torna. E il film? Beh, il film lo liquida in una riga: "girato con telecamerine spia per effetto, è intriso di «superparanoia». Capita, come capitò a Duranty, cui, 90 anni dopo, vorrebbero togliere il Pulitzer". In realtà non risulta che Duranty fosse affetto da superparanoia, con o senza virgolette. L'ossessione di Riotta per un vecchio premio Pulitzer ha radici abbastanza contorte: qualche anno fa Glenn Greenwald (nel film è Zachary Quinto) definì un intervento di Riotta su Snowden "the opposite of journalism". Qualche mese dopo vinse il Pulitzer, appunto, per lo scoop su Snowden. Si vede che il critico cinematografico della Stampa se l'è legata al dito.
L'America di Tom Ford, incubo patinato
22-11-2016, 02:22Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkSusan (Amy Adams) si annoia. Alla sua età, col suo reddito, è praticamente un must. Susan ha una ricca casa e un maggiordomo; una galleria d'arte che gestisce con sempre meno convinzione; un marito ricchissimo che la tradisce nel modo più discreto; e un fantasma del passato, un ex marito scrittore fallito (Jack Gyllenhaal) che dopo 19 anni le invia un manoscritto. Il mondo di Susan è finzione, ma ricorda: il mondo vero è molto peggio.
 |
| ...That you're tired of yourself and all of your creations... |
 |
And you say, “Oh my God, Am I here all alone?”
|
 |
| Standing on a corner a ringin' my bell, Up stepped the sheriff from Thomasville. He said 'Young man is you name Brown? Remember you blowed Sadie down." |
Sei sicuro che vuoi fare come gli americani, Matteo Renzi?
10-11-2016, 13:55Americana, referendum costituzionale 2016, Renzi, VeltroniPermalinkIo non ho la minima idea di chi vincerà il quattro dicembre, ma penso che la riforma sia brutta, e che fosse ancora più brutta nelle prime stesure, quando ancora il Senato delle Regioni era concepito come l'assurdo Senato Americano: quello in cui tutti gli Stati eleggono lo stesso numero di senatori, compreso il Vermont dove sono bastati 190.000 voti; in California ce ne sono voluti 4.800.000, venticinque volte tanto. Si tratta evidentemente di un sistema iniquo e arcaico, ma è difficile rinunciarvi dopo due secoli di successi; più difficile è capire perché in Italia qualcuno lo volesse introdurre, offrendo a trecentomila molisani la stessa rappresentanza di dieci milioni di lombardi - dopo vent'anni di leghismo! Ci scrissi qualcosa sul sito dell'Unità - pazzesco quel che pubblicava una volta il sito dell'Unità.
Poi magari la Boschi si accorse che qualcosa non andava e cambiò di nuovo la bozza; ma il solo fatto che l'abbiano proposta e divulgata lascia sgomenti - è come l'inglese di Renzi, anzi, molto peggio: da una parte sei contento che Renzi stia migliorando la sua pronunzia e che la Boschi abbia scoperto che in Italia la densità di popolazione varia sensibilmente di regione in regione; dall'altra è un po' imbarazzante veder crescere in diretta questi aspiranti riformatori e statisti: cioè per carità bravini, la stoffa c'è, ma non siamo a un talent show, bisognava arrivare già preparati.
È dal dopoguerra che gli italiani guardano con ammirazione agli USA - i democristiani più di altri. Fino a un certo punto qualsiasi ipotesi di modificare la costituzione in senso americano rimane comunque circoscritta alle fantasie di un Pannella o un Almirante. Quand'è che la passione per le cose di Washington si trasforma in una vera e propria tensione riformatrice che contagia persone altrimenti ragionevoli? Il 2008 mi sembra un ottimo termine a quo. A primavera, la sconfitta del Pd di Veltroni - non fu per la verità una sorpresa, quella volta forse persino i sondaggi ci azzeccarono: ma ci si aspettava senz'altro qualche punto percentuale di più e soprattutto nessuno immaginava la completa sparizione della sinistra. Delusi da un bipartitismo ancora molto imperfetto, diversi elettori italiani del PD si appassionano alla più emozionante campagna elettorale statunitense, quella con Obama prima contro la Cinton e poi in finale contro McCain (con la Palin spalla comica). C'è una vignetta dell'allora sconosciuto Makkox che esprime il lato patetico di quell'entusiasmo. L'ipotesi veltroniana, qui ho cercato di spiegarlo, proponeva una interiorizzazione dell'antiberlusconismo: visto che sconfiggere il Berlusconi reale sembrava per il momento impossibile, occorreva eliminare il berlusconismo dentro di noi. Smettere di nominarlo, smettere di pensarci, purificarsi. Guardare all'estero era l'unica possibilità, e all'estero quella di Obama era l'unica favola a lieto fine. Alcuni non hanno distolto lo sguardo per otto anni, e sì che molti dettagli non tornavano; le tensioni razziali, le stragi a mano armata a cui il POTUS ha assistito indignato e impotente, l'approccio un po' dilettantesco alla crisi in Medio Oriente, lo scandalo della NSA e il trattamento riservato ai whistleblower. Tutto questo non ha impedito a Obama di essere straordinariamente cool fino all'ultimo, e tanto bastava. Veniva bene in tutte le foto, faceva battute divertenti, è stato un presidente fantastico.
Negli stessi anni prende piede in Italia un timido tentativo di riformare l'Italia in senso semipresidenziale - senza avvertire i cittadini, il che è un problema a parte: cioè se almeno lo avessero detto chiaramente, si sarebbe potuta apprezzare la franchezza. Non è a dire il vero il primo e forse nemmeno il più sostanziale: già l'introduzione dell'uninominale del 1993 - e soprattutto l'abitudine di Berlusconi di mettere il suo cognome bene in evidenza sul simbolo - avevano preparato il terreno. Tuttora, chi si lamenta che Renzi non sia stato "eletto dal popolo", ha probabilmente in mente il modo in cui Berlusconi e Prodi sono usciti vincitori dalle elezioni tra '94 e '08: molti elettori avevano la sensazione di votare per l'inquilino di Palazzo Chigi oltre che per il parlamento (avevano torto?) La riforma Renzi e Boschi non fa che proseguire la tendenza: l'idea che la sera delle elezioni si debba conoscere il vincitore è una suggestione quasi hollywoodiana - se socchiudi gli occhi ti sembra di vedere i coriandoli rossi e blu. Renzi si allena a fare i discorsi, tutti lodano il suo Concession Speech alle primarie del 2012, sembra di stare in uno di quei videoclip di Vasco Rossi o Ligabue che giravano negli USA per darsi un tono - non importa dove, bastava un incrocio qualsiasi, il primo parcheggio con un concessionario appena fuori dall'aeroporto.
A un certo punto tutti si mettono a parlare di Accountability, che viene molto imprecisamente tradotto "votami per cinque anni e se faccio un disastro ne discuteremo poi". L'obiezione che l'Italia non è una repubblica presidenziale, che è il parlamento a nominare il capo del governo, a concedergli la fiducia e a potergliela ritirare in qualsiasi momento, viene liquidata con fastidio: roba da vecchi! Vecchi! Guarda invece Obama quanto è cool. Nel frattempo Obama aveva perso da un pezzo la maggioranza del Congresso, e dopo aver faticato a varare una riforma sanitaria, non ha più potuto far nulla per limitare la vendità delle armi da fuoco - solo dei discorsi accoratissimi all'indomani di ogni strage. Fantastici discorsi. Renzi & co. avranno senz'altro preso appunti.
Ieri un'elezione ha regalato a Trump la presidenza (malgrado la Clinton abbia avuto più voti) e un'ampia maggioranza al congresso e al senato. Per molti è stata una doccia freddissima; magari salutare. L'uomo più cool del mondo sta lasciando la Casa Bianca: forse è l'occasione per maturare un minimo distacco critico. Obama non ha rottamato la vecchia America; non ha mai avuto i numeri per farlo; per gran parte del suo doppio mandato è stato poco più che un'anatra zoppa. Adesso la palla passa a Trump, che avrà almeno all'inizio molto più margine d'azione. Certo, dopo quattro anni gli americani giudicheranno. Sono comunque notevoli i disastri che un capo del governo, attorniato da un parlamento plaudente, può fare in quattro anni. L'Italia è una cosa molto diversa, ma appunto: siamo sicuri di voler fare come loro o addirittura peggio di loro? Il fatto che presto o tardi qualche populista pericoloso possa aggiudicarsi il 41% dei suffragi è un buon motivo per regalargli un premio alla Camera, eliminargli il contrappeso del Senato, e aspettare cinque anni per vedere come va? Ammesso che gli americani si possano permettere questo tipo di accountability, noi possiamo?
Questo mi sembra un terzo buon motivo per votare No al referendum.
Gli altri motivi:
1. Non si riscrive la carta costituzionale col martello pneumatico.
2. Non si usa una brutta legge elettorale come moneta di scambio.
3. Non mi piacciono le riforme semipresidenziali.
Hanno vinto i Muri - e se avessero ragione?
09-11-2016, 19:10Americana, razzismiPermalink |
| Il confine USA/Messico, adesso. |
Dunque a un certo punto forse ci siamo convinti che la Storia non potesse andare che in un senso: che frontiere e dogane fossero cose ottocentesche, superabili; che l'immigrazione - non importa quante tensioni avrebbe creato - fosse un meccanismo irreversibile e tutto sommato arricchente; che dalla delocalizzazione dell'industria verso i Paesi in via di sviluppo avremmo tratto tutti più benefici che danno e in un certo senso è così (lo sto scrivendo su una tastiera molto economica, prodotta in qualche Paese lontano che non conosco). Tutto questo avrebbe certo generato qualche malcontento, ma ehi! Sono cose che si risolvono, basta trovare politici convincenti che sappiano fare discorsi commoventi.
Qualche resistenza alla globalizzazione negli ultimi trent'anni c'è stata, ed è capitato anche a me di prendervi parte. Avevamo idee vaghe (non che qualcuno in seguito abbia dimostrato di averne di più precise), denunciavamo speculazione finanziaria e paventavamo il riscaldamento globale. Non avevamo tutti i torti, non avevamo tutte le ragioni. Ci mancava però un modello, un'alternativa strutturata (quello che nel 1814 era il liberalismo e nel 1917 era il marxismo) e quindi siamo andati alla deriva: alcuni si sono fatti l'orto bio, altri lottano per il diritto di Renzi a governare senza la maggioranza, alcuni entrambe le cose. Nello stesso periodo, a volte persino nelle stesse piazze, c'era chi la tagliava molto più semplice: se il futuro è la globalizzazione, abbasso il futuro, torniamo indietro. Alziamo gli steccati, rimettiamo le frontiere, Schengen è un errore, l'euro è un errore. È banale constatare che stiano vincendo loro: da questo punto di vista l'elezione di Trump non è così sorprendente. Prima c'è stata la Brexit, e a questo punto è lecito immaginare che seguirà la Francia con la Le Pen. Persone diverse, programmi diversi, un'idea comune: il Muro. La globalizzazione vista come un'invasione di persone e una fuga di risorse. Un'idea che ovviamente un vasto schieramento progressista, di cui cui faccio parte, ha ritenuto per tutto questo tempo sbagliata e perdente. Non si ritorna indietro.
Ma se invece ci stessimo sbagliando?
 |
| (NON-È-UN-MURO) |
Anche qui, Trump non ha davvero inventato niente, visto che tutto sommato un muro tra USA e Messico c'è già (ha aggiunto solo il tratto guascone del palazzinaro: lo faccio io ma lo pagano i messicani). Tutti questi muri sono senz'altro esecrabili, ma funzionano o no? Perché alla fine la Storia va così. Non ci giudica per la nostra bontà o cattiveria, ma per quello che realizziamo. Forse riderà di Trump, se Trump si dimostrerà un inetto: se le frontiere resteranno un colabrodo, la produzione industriale non tornerà negli USA, e il riscaldamento globale presenterà il conto. A me piace pensare che andrà così, ma come faccio a esserne sicuro? Molte cose che ho letto e a cui ho creduto potrebbero essere solo storie a cui volevo credere.
Siccome tra queste cose c'è qualche materiale un po' pessimista e neomalthusiano, ho il forte sospetto che il futuro sarà molto fosco: che alcune risorse scarseggeranno - stanno già scarseggiando - e che questo porterà a guerre e carestie. Magari molti elettori di Trump pensano la stessa cosa. Alcuni saranno meno scolarizzati di me, ma la loro reazione è poi così poco intelligente? Quando arriva l'uragano, ci si tappa in casa. Non serve avere una laurea. Ha senso perder tempo a far loro la morale? Non mi pare. Perché non sto facendo la stessa cosa? Non lo so.
Cioè alla fine mi è chiarissimo perché molti americani hanno votato Trump: faccio fatica a ricordarmi il perché io non voto analoghi personaggi. Non credo nei Muri - in Italia poi li trovo proprio tecnicamente irrealizzabili. Ma è una credenza, non il risultato di ragionamenti, o calcoli, o esperimenti. È la mia bandiera, e se la Storia riderà di me io comunque non sarò lì per soffrirne.
Come andranno le elezioni (non mi sbaglio mai)
08-11-2016, 15:19Americana, Berlusconi, sondaggiPermalinkDomattina - se vince Donald Trump - pubblicherò un pezzo in cui prendo in giro tutti quelli che si sono fidati dei sondaggi - ancora ci cascate, è incredibile! - tutti quelli che pensavano che Trump non potesse vincere perché faceva discorsi divisivi, perché aizzava le paure del suo elettorato, mentre nel mondo post-obamiano a un certo punto qualcuno ha deciso che gli unici messaggi che dovrebbero farti vincere le elezioni sono quelli ottimisti ed entusiasti. Lo vedete che invece la paura vende benissimo? Scriverò. E del resto anche i clintoniani quando se la sono vista brutta non hanno forse cominciato a paragonare la presidenza Trump a un'apocalisse, non hanno tentato di spaventare gli indecisi? E così - anche se domani vincesse Trump - avrò dimostrato il mio punto.
Poi mi chiedono com'è che non mi sbaglio mai. Per la verità è facile. Di solito non ci provo neppure. Non avevo la minima idea su chi avrebbe vinto in UK, su chi vince domani, su chi vincerà il referendum. Dei sondaggi non mi fido e scommesse non ne faccio. C'è gente che si butta sempre sui pronostici, è una specie di malattia. Quelli che Trump doveva vincere in giugno, poi è sceso nei sondaggi e hanno scritto che lo faceva apposta perché era spaventato persino lui, poi è risalito di nuovo e... non so cos'abbiano scritto, li ho persi di vista. Buona notte a tutti (anche se andate a letto presto, domattina ne saprete quanto tutti gli altri).
Proprio come un blues del vecchio Dylan bloccato sulle rive del Colorado River mentre lo aspettano a Stoccolma
21-10-2016, 17:30Americana, musicaPermalink |
| Oltre a un autoritratto di Bob Dylan, è anche un disco di straordinaria, enigmatica bruttezza. |
You got a lotta nerve to say you are my friend
Dopo 25 anni che l'ascolto, non sono ancora sicuro se mi piace o no. L'unica certezza, è che nessuno mi ha fatto ascoltare così tanti dischi brutti. Probabilmente nessuno ha fatto più dischi brutti di Bob Dylan: nessun altro poteva permettersi tanti passi falsi, e tanto pesanti. La storia è nota: nel '62 è uno dei tanti ragazzi che cerca di farsi notare cantando testi politici su vecchi giri di chitarra folk, una sottocultura che sarebbe stata probabilmente dimenticata di lì a poco se proprio lui non avesse impresso al genere un'accelerazione improvvisa. Reminiscenze bibliche, intonazioni sardoniche e picaresche, sketch satirici, una zuppa di tante cose che rendono i suoi quattro dischi folk un ascolto godibile ancora a cinquant'anni di distanza. Poi, quando tutti sapevano ormai cosa aspettarsi dal buon vecchio Bob Dylan, la svolta elettrica: il cantautore liquida improvvisamente l'attivismo politico, mette insieme una band come quelle che vanno in Inghilterra, tratta da poveri fanatici i suoi vecchi sostenitori, e realizza altri tre dischi, altri tre capolavori di un genere che non esisteva, che si inventa lui traccia dopo traccia. Dylan appartiene alla storia della musica, alla storia della lirica inglese e, fino al 1966, alla storia del costume: la sua prima apparizione elettrica al festival di Newport sancisce la nascita della rockstar del Novecento, quella che non si lascia etichettare dal genere musicale di appartenenza, ma cambia continuamente le carte in tavola. Se Dylan non avesse abbandonato il folk per il rock, se Dylan non avesse dimostrato che il pubblico seguiva il personaggio e non il genere musicale, i Beatles sarebbero rimasti una boy band? Il successo è immenso e insostenibile. Alla vigilia di un tour con sessanta date fa un incidente in moto e muore a 25 anni prima di poter invecchiare e vincere un Nobel: molto prima che a qualcuno possa venire in mente di consegnarglielo.
The gypsy's door was open wide, but the gypsy was gone.
 |
| Rock Dreams |
I'm just average, common too, I'm just like him, the same as you. I'm everybody's brother and son, I ain't different than anyone. It ain't no use a-talking to me: it's just the same as talking to you.
Anche Dylan a metà anni Settanta soffriva di quella peculiare alienazione dei divi dell'epoca, sempre più distanti dal loro pubblico; anche Dylan a un certo punto cominciò a mettersi in maschera sul palco, ma alla fine di It Ain't Me Babe doveva pur suonare l'armonica e quindi se la levava. Tutti gli schermi che ha provato, tutte le conversioni, non hanno veramente funzionato. Qualche travestimento gli è comunque rimasto sottopelle ed è finito per far parte della persona di cui ogni tanto sentiamo parlare. In fondo non è quello che succede a tutti? Salvo che a tutti non capita di fare la storia della musica a vent'anni. Però davvero: da ragazzini campiamo di intuizioni. Crescendo facciamo qualche incidente, mettiamo famiglia, ci arrabattiamo come possiamo, da qualche parte in noi c'è ancora un po' dell'antico genio ma lo ritroviamo sempre meno spesso. Nel frattempo cerchiamo almeno di imparare un mestiere, Dylan ad esempio ha provato a diventare un buon musicista. Con esiti alterni. E poi diciamo bugie, quante ne diciamo.
I was so much older then...
Dal '66 in poi, Dylan e la Storia cominciano a divergere. Anche lui come Bowie cambierà più volte genere e travestimenti, ma mentre Bowie sarà sempre impegnato ad anticipare le mode o a cavalcarle, Dylan sembra periodicamente assorto in un tentativo di segno opposto. Country nel periodo psichedelico, fervente cristiano nei grassi anni Ottanta, di nuovo folk negli anni dell'hip-hop, e ultimamente canta Sinatra e altri successi natalizi. Non è mai dove lo vogliamo, sarebbe strano vederlo a Stoccolma.
I cagnolini della guerra
27-09-2016, 01:36Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, guerra, traffico d'armiPermalinkVoi cosa combinavate a 22 anni? Nel 2006, Efraim Diveroli gestiva dal tinello del suo appartamento una ditta scalcinata che gli aveva passato il padre per levarselo di mezzo. Cercava di vincere appalti per forniture all'esercito. Appena l'esercito metteva il bando su un sito, Diveroli si metteva a cercare le forniture più a basso costo che trovava. Le forniture erano armi, fucili e munizioni, raccattate il più delle volte a prezzi di saldo dai magazzini dei Paesi del vecchio blocco sovietico. Qualche volta vinceva un appalto, qualche volta lo perdeva, e nel giugno del 2006 ne vinse uno per trecento milioni di dollari. Questo faceva Efraim Diveroli a 22 anni - e a 24 era in galera. Ma non c'è rimasto poi tanto, e in seguito non ha nemmeno cambiato mestiere - solo il nome alla ditta. In fondo cos'aveva fatto di male? aveva soltanto smerciato munizioni albanesi agli afgani filo-USA, senza sapere che erano di fabbricazione cinese. Pare che per il Pentagono non sia un problema se armi i tuoi alleati con Ak-47 degli anni Sessanta e con proiettili recuperati in qualche bunker in Albania, magari da un tizio che è sulla blacklist e usa come prestanove un ventiduenne sovrappeso di Miami. Però se scopre che è roba fatta in Cina, è un guaio, ehi, con la Cina c'è un embargo. La guerra è così. L'America è così. E Trump non ha ancora vinto, pensa
Un film come War Dogs si scrive da solo, ma se l'avesse scritto Scorsese saremmo tutti più felici (continua su +eventi!)
 |
| Fa ridere perché sono al Ministero della Difesa ma si sono appena fatti una canna e quindi sono in para dura AH AH AH (no sul serio forse sono troppo vecchio, boh), |
Un film come War Dogs si scrive da solo, ma se l'avesse scritto Scorsese saremmo tutti più felici. Un bel vortice di avidità e dissipazione, l'ascesa e la caduta dell'ennesimo personaggio posseduto dallo spirito animale del capitalismo eccetera. Invece è toccato a Todd Phillips, reuccio della stoner comedy, avete presente, quei film coi ragazzi americani che si fanno le canne (il che pare sia divertente in sé, almeno questa è la spiegazione che mi do: i giovani americani vanno al cinema a vedere giovani americani farsi le canne, perché ciò li diverte). Molto spesso c'è Jonah Hill, che in Wolf of Wall Street faceva proprio da anello di congiunzione tra la stoner comedy e l'universo adulto (ma ancora più stonato) di Scorsese. E benché Jonah e la sua spalla perfettina Miles Teller, mentre inseguono i loro sogni avidi, citino più volte Scarface di De Palma, è a Scorsese che Phillips torna in continuazione. E va benissimo: siamo tutti in crisi di astinenza da Scorsese, in quella fase in cui non si va tanto per il sottile e mandi giù di tutto, anche Bradley Cooper che fa il ricercato internazionale (del resto produce lui). War Dogs avrebbe potuto riuscire meglio: l'epopea di due ragazzini americani ignoranti che si ficcano in guai più grandi di loro meritava forse una narrazione più distesa; ma la formula originale per miscelare il moralismo con la fascinazione per il crimine la conosce solo Scorsese, e se la tiene ben stretta. O forse si sarebbe potuto insistere di più su come l'esercito americano si sia voltato dall'altra parte per non vedere da dove i fornitori gli procuravano le armi - imbroglioni di mezza tacca, ragazzini che fotoscioppavano i bilanci, a un certo punto andava bene di tutto, e se non ci si fossero messi in mezzo i giornalisti forse Diveroli starebbe ancora trafficando kalashnikov della guerra fredda. Magari lo sta ancora facendo. Hill e Teller sono in parte, ma non sembrano giovani come effettivamente erano Diveroli e il suo socio Packouz: del resto a 22 anni qui da noi sei ancora un ragazzino. I due protagonisti sembrano già sulla trentina, quel momento nella vita in cui certe porte si chiudono, magari una compagna resta incinta e sì, se un tuo vecchio amico ti avesse proposto di trafficare munizioni in medio oriente, tu saresti stato abbastanza disperato da accettare. Trafficanti è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo alle 20:20 e alle 22:45; al Cinecittà di Savigliano alle 20:20 e alle 22:30.
Un'altra estate, un'altra Purga
08-08-2016, 18:15Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, traffico d'armiPermalinkL'idea va avanti dal 2014. Un budget contenuto, un regista giovane che dal primo episodio si è liberato dell'ansia di strafare, un concetto originale anche se un po' passé: un carnevale per adulti, una notte in cui, in un'America futura appena un po' fascistizzata, tutti possono "sfogarsi" commettendo tutti i reati che vogliono. Con tutte le armi che vogliono. A un primo livello, abbiamo una satira dell'ossessione particolarmente americana per le armi da fuoco. E andrebbe già benissimo così. Ma la carta vincente della Purga (nella versione italiana lo traducono Lo Sfogo e fa ridere lo stesso) è la sua grezzissima ipocrisia: la scelta di stare sempre dalla parte delle vittime, encomiabile se non venisse da chi ha inventato il marchingegno di tortura.
The Revenant, due ore e mezza di saporita ricerca della vendetta e cinque minuti finali per dire che la vendetta è una cosa ingiusta. Ecco, The Purge fa la stessa cosa: mette da una parte i buoni, pacifisti e tolleranti; dall'altra dei personaggi che sono un po' repubblicani, un po' nazisti, un po' satanici, insomma il peggio del peggio del peggio, e non vedi l'ora che i pacifisti li massacrino. Naturalmente questi ultimi devono esitare un po', devono essere perseguitati e costretti, perché sono pacifisti. Ma quando alla fine succede, ecco, è una gran Purga, volevo dire un grande Sfogo. DeMonaco gioca col senso di colpa dello spettatore progressista con un cinismo d'altri tempi: dai, sfogati, ti senti in colpa? Lo sai perché ti senti in colpa? Perché sei un ipocrita. Sfogati un altro po', ti farà bene. E così via, episodio dopo episodio.
Quest'anno poi è tempo di elezioni, e The Purge non poteva assolutamente perdere l'occasione: si scopre così che, malgrado tutto finora ci lasciasse pensare il contrario, l'America di The Purge è ancora una democrazia, e che non c'è oligarchia satanica che non possa essere rovesciata dal voto popolare ogni quattro anni: basta conquistare gli anziani della Florida ed è fatta. C'è addirittura una candidata (Elizabeth Mitchell, la dottoressa di Lost) che promette di abolire la barbara usanza che pure ha aumentato l'indotto delle armi e della sicurezza, e ha ridotto drasticamente la disoccupazione. Ovvio che il partito al potere voglia farle la pelle, approfittando della notte della Purga. Nel frattempo trovi stranieri - turisti della Purga - che vanno in giro per la capitale degli Stati Uniti travestiti da Abraham Lincoln e da Statue della Libertà, per sfogarsi su innocenti passanti americani. In un vicolo qualcuno sta ghigliottinando qualcun altro, tutto regolare. Teeen-ager birichine vanno in giro cosparse di sangue brandendo seghe elettriche. Però chi va al cinema aspettandosi esattamente questo, un'ora e mezza di violenza folle e insensata, ci rimane sempre male, perché? Perché questa roba rimane sullo sfondo, è la spezia con cui DeMonaco attira gli spettatori al cinema. Ma poi li vuole intrattenere con qualcos'altro che è una specie di agenda politica, progressista a suo modo, e scorrettissima. (Continua su +eventi!)
 |
| Questi sono i Buoni, multietnici come è giusto che sia. Ammazzano tantissima gente, ma per un buon motivo e senza goderne troppo visibilmente. |
I Cattivi sono gente vecchia e sanguinaria, tutti rigorosamente bianchi (sembrerebbe una proiezione distopica se non avessimo visto un pubblico del genere alla Convention repubblicana): adunati in una chiesa presbiteriana, conducono riti orgiastici che prevedono l'eliminazione di poveri e senzatetto. Quanto ai Buoni, sono tutti minoranze etniche, perlopiù afro e latinos, con facce che non vedi di solito a Hollywood e che gridano blaxploitation (Betty Gabriel). I soli bianchi dalla loro parte sono il candidato donna e il suo gorilla, l'efficiente e spigoloso Frank Grillo, l'unico sopravvissuto dal film precedente. Il candidato dei tristi satanici invece è un pretino, abbastanza simile ad alcuni rivali di Trump alle primarie - nemmeno un visionario come DeMonaco poteva immaginarsi Trump candidato. Il risultato non è semplicemente un sano film di fuga metropolitana che adatta i temi dei Guerrieri della notte o di 1997: fuga da New York ai nuovi tempi e allo spirito di fraternità interrazziale di Fast and Furious; è anche il manifesto politico più sfacciato che credo di aver visto in vita mia. Per un'ora e mezza non fa che dirti che i cattivi sono i bianchi ricchi, tranne quella che, con molta sensibilità e diplomazia, guiderà la rivolta dei ghetti. Non so quanto lo staff di Hilary Clinton possa apprezzare. Tanto le elezioni si vincono coi voti dei pensionati in Florida. Però quando un giorno i nostri figli ci chiederanno: papà, cosa hai fatto per evitare che vincesse Trump? DeMonaco avrà almeno la risposta pronta: con un budget medio-basso ho fatto il film di propaganda più smaccato di sempre. L'ho fatto con tutta la violenza che serviva per conquistare le sale dei quartieri più malfamati d'America. Di più di così un regista di genere cosa poteva fare? La notte del giudizio: Election Year è all'Italia di Saluzzo alle 20 e alle 22:15, e al Fiamma di Cuneo alle 21:15.
Ma Trump non è Berlusconi
03-03-2016, 01:10Americana, Berlusconi, Giuliano FerraraPermalinkParagone ormai abusato non solo tra giornalisti italiani, a cui non sembra vero poter vantare vent'anni di esperienza di un mitomane col parrucchino (il che dimostra che in vent'anni non hanno messo a fuoco il problema): la cosa sta prendendo piede anche tra gli anglosassoni; per esempio ieri il Financial Times definiva Trump un "Berlusconi americano", benché privo del suo fascino e del suo talento per gli affari ("albeit without the charm or business acumen"). Ok, divertente. E forse la maggior somiglianza col caso italiano non sta nei due personaggi, ma proprio nella reazione incredula e stizzita che scatenano presso il ceto intellettuale, non solo a sinistra: effettivamente il passaggio dalla sottovalutazione all'indignazione al panico qui in Italia l'abbiamo vissuta più di vent'anni fa. E abbiamo capito - purtroppo un po' meno di vent'anni fa - che insistere sulle gaffes del tizio non fa che renderlo più forte verso il suo serbatoio elettorale: del resto in Italia l'anti-intellettualismo lo studiamo da un secolo, siamo passati per il fascismo e il qualunquismo ed evidentemente non abbiamo ancora trovato il vaccino efficace.
Detto questo, chi paragona Trump a Berlusconi mostra di non aver capito qual era il vero problema con Berlusconi: non il parrucchino, non le barzellette e le figuracce, le smorfie ai vertici internazionali (per quanto, via, chiamare kapò un europarlamentare tedesco) e nemmeno l'imbarazzantissima esuberanza sessuale, che è poi il motivo per cui all'estero lo conoscono e ce lo ricordano ridacchiando. Non è nemmeno il populismo - o meglio, il populismo è un problema grave, ma esisteva prima di Berlusconi e non è affatto tramontato con lui. E allora cosa?
C'è bisogno di ricordarlo? A quanto pare sì. Berlusconi possedeva quasi metà dell'etere televisivo, in spregio della normativa (Rete4 avrebbe dovuto finire sul satellite); e quando vinse le elezioni modificò la normativa e mise le mani anche sull'altra metà, quella pubblica. Nel frattempo era uno dei principali editori italiani, e uno dei principali concessionari di pubblicità, che raccoglieva sul mercato e rivendeva alle sue aziende. In sostanza per qualche anno in Italia non ci furono direttori di reti televisive e tg che lui non approvasse direttamente o indirettamente: malgrado fior di opinionisti assunti in queste reti o dai suoi giornali ci spergiurasse che no, Berlusconi non vinceva le elezioni grazie alle televisioni: che il fatto che continuasse a esercitare quel controllo, arrivando a fare i nomi di chi non voleva più in RAI, fosse semplicemente una coincidenza, una cosa che gli capitava di fare perché si sa, la tv è sempre stata il suo pallino.
Quanto a Trump, per quel che ne so è un palazzinaro e una celebrità televisiva. Ma non possiede la CBS, né la FOX, né la CNN né una delle Big Three: che di conseguenza possono decidere di parlare di lui come vogliono. Anche molto male. Forse avrete intravisto anche voi lo spezzone dello show di John Oliver (definirlo "comico" è riduttivo) dedicato a Trump: venti minuti di demolizione sistematica del personaggio, andati in onda su HBO e poi rimbalzati via internet in tutto il mondo. Ecco, questo su un canale televisivo italiano nel 2002 sarebbe stato impossibile. Negli USA invece si fa abitualmente, e si continuerà a fare persino nel malaugurato ma sempre più probabile caso in cui il mitomane di turno vinca le elezioni. Perché davvero, non è che le televisioni siano indispensabili per farti vincere.
Però in Italia aiutano.
Ognuno poi ha i suoi parametri, le sue pietre di paragone: il mio canarino-in-miniera è Giuliano Ferrara, a cui Trump dà un certo fastidio. Per il populismo? Ferrara ne ha avallati di peggiori. Per il cattivo gusto? Parliamo del tizio che si mise il rossetto e andò in piazza col cartello "siamo tutti puttane", per solidarietà col capo accusato di avviare minorenni alla prostituzione. E allora, insomma, cosa c'era in Berlusconi che Ferrara non riesce a trovare in Trump? Secondo me è una questione preconscia: Ferrara non pensa, Ferrara annusa. E per quanto inspiri, non riesce a sentire quell'odore di vero potere che gli darebbe alla testa. Per un Berlusconi si sarebbe messo in mutande; per un Bush era disposto a millantare consulenze con la CIA; per Trump niente. Lo trovo molto indicativo.
E Trumbo prese la macchina da scrivere
11-02-2016, 13:13Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink"Mi appello al primo emendamento".
"La mamma è comunista?"
"No".
"E io?"
"Facciamo il test. Se a scuola un tuo compagno non ha la merenda, tu cosa fai? Gli dici di trovarsi un lavoro? Gli offri un prestito al cinque per cento?"
"Papà..."
"O condividi la tua merenda con lui?"
"Non credo che questo sia proprio il comunismo classico, sai".
"Ah no?"
"Il comunismo è quando i miei compagni senza merenda, essendo diventati la maggioranza, si impadroniscono delle merende di chi le ha e le collettivizzano".
"Vabbe' ma non è che dobbiamo proprio entrare nei dettagli".
"Papà, ma questo dialogo deve avvenire proprio mentre tu mi fai fare un giro su un pony nel nostro bellissimo ranch?"
"Che ti posso dire, io l'avrei scritto diversamente. Ma Hollywood ha sempre l'ultima parola, quando sarai grande capirai".
Trumbo (Jay Roach, 2015).
 |
| La sua posa iconica (gli hanno anche fatto una statua). Purtroppo se ci provi col laptop rischi la vita. |
Trumbo è uno di quei classici film con cui Hollywood si specchia in sé stessa, trovandosi non priva di difetti ma dopo tutto irresistibile - film che a noi sudditi di periferia non dicono un granché, ma che qualche nomination la portano sempre a casa. Stavolta è Bryan Cranston, più noto per i suoi ruoli televisivi (Breaking Bad), che si ritrova in lizza per l'Oscar tra Di Caprio e Fassbender. Come tutti i biopic più convenzionali, Trumbo è più interessante per le cose che decide di non raccontare: il protagonista compare in scena già fatto e finito, un radical chic che discetta di giustizia sociale mentre firma contratti milionari. Non interessa la traiettoria che lo ha portato fin lì, ma quel che accade dopo: la caduta in disgrazia di lui e degli Hollywood Ten, i mesi di detenzione che un atteggiamento più prudente e meno idealista avrebbe potuto evitare - e soprattutto la faticosa risalita, nei dieci anni di esilio in cui l'ex sceneggiatore-più-pagato-d'America si ritrova a sbarcare il lunario scrivendo robaccia per il mercato di serie B. Solo perdendo il suo snobismo - e il suo ranch - il Trumbo del film diventa un personaggio simpatico, un poveraccio che tira la carretta mentre i figli crescono e smettono di capirlo, un forzato della macchina da scrivere che deve dimenticare la lotta del proletariato e buttar giù ogni sera cento pagine di sparatorie e inseguimenti.
Così, dopo averlo allontanato e poi riabilitato, Hollywood si rimpossessa di Trumbo costringendolo a rinnegare il comunismo, non a parole ma nei fatti: trasformandolo in un caporale che smista il lavoro ai sottoposti, e la sua lotta per la libertà di opinione in una americanissima battaglia personale per rivedere il suo nome nei titoli iniziali. I dialoghi coi famigliari e col personaggio fittizio di Louis C.K. - un compagno arrabbiato che non riesce a rinnegare il suo radicalismo e cede al rancore e al cancro - puntano tutti lì: Trumbo deve partire comunista col ranch per finire come un eroe che paga ai figli il college e ambisce a una gloria puramente individuale, una bella statuetta e un applauso.
 |
| FOR THE MONEY AND THE PUSSY! |
Goodman è ancora una volta impiegato col contagocce, ma è il vero centro del film - anche perché la storia di Trumbo è affidata a Jay Roach, un regista che ha esordito con Austin Powers e proseguito con la saga di Ti presento i miei. Roach non è del tutto immune da un certo timore riverenziale, ma si capisce che l'idea che il celebratissimo Trumbo abbia passato anni a scrivere robaccia per gli analfabeti gli piace parecchio. Sarà stato anche un comunista, ma a salvarlo sono stati dei mezzi gangster ignoranti che volevano far soldi e picchiavano con le mazze da baseball - lo vedi figliola? Hollywood alla fine vince sempre.
Uomo nero inferno bianco
07-02-2016, 08:15Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink |
| Nessun Gesù verrà a salvarvi |
Incredibile chi puoi trovare nella merceria di Minnie in una notte di bufera. Anziani generali del Sud, ex schiavi criminali di guerra. Cacciatori di taglie, sceriffi, boia e malviventi da impiccare, tutta la filiera della giustizia. Cowboy che tornano dalla mamma per Natale e stallieri messicani che sanno suonare il pianoforte. Gente di ogni tipo, razza e qualifica - anche se qualcuno magari non è proprio chi dice di essere. Ma nella bufera che differenza fa.
Sotto la neve saranno tutti uguali.
 |
| Starting to see pictures, ain't ya? |
Non resteremmo comunque storditi dagli attrezzi di scena, da quel luccicante feticcio che è il 70mm, dal coraggio con cui questo figlio di Hollywood continua a ignorare le regole di casa e ricreare un cinema che non sarà il più originale del mondo, ma è completamente a sé? Da anni gioca in un campionato a parte, per forza vince sempre. Nessun altro regista avrebbe preso in mano soggetti come Basterds e Django, nessun altro sarebbe riuscito a farne due film non ridicoli. L'Odioso Ottetto, viceversa, sulla carta sembrava un'idea meno folle: un delitto nella stanza chiusa, calato in quel preciso contesto storico che continua a tormentare gli spettatori americani: la guerra civile tra le razze, mai dichiarata, mai terminata.
Ad avere dei dubbi, stavolta, era lo stesso Tarantino. Quando una bozza di sceneggiatura cominciò a circolare abusivamente, sembrava voler cogliere l'occasione per rinunciare al film. Due cose pare gli abbiano fatto cambiare idea: la prima fu una lettura pubblica che andò benissimo, e che ha lasciato fin troppo il segno nella realizzazione. L'Ottetto che alla fine Tarantino ha girato, malgrado la ricercatezza della fotografia, è quasi un radiodramma. Verso il finale, dopo un colpo di scena escogitato per prendere alle spalle chi ha letto la vecchia bozza, ci si sorprende a domandarsi come abbia fatto il regista ad arrivare a tre ore. La storia non è più complicata del solito, Tarantino semplicemente non ha fretta - lui può permetterselo - e anche i suoi infreddoliti attori sembrano innamorati delle frasi che recitano. Tutti se le rimasticano nel loro accento preferito. È un film di dialoghi che sembrano monologhi.
L'altro fattore che ha convinto Tarantino a girare l'Ottetto è stata l'insistenza di Samuel Leroy Jackson (continua su +eventi!). Così come Joy è un film che David O. Russell doveva a Jennifer Lawrence, The Hateful Eight somiglia a un compenso per tutti i servizi che questo attore grandissimo ha reso a Tarantino - che effetto fa rendersi conto che non gli aveva ancora dato un ruolo da protagonista? E ripensando alla carriera di Jackson tra Spike Lee, Star Wars e Marvel (Per il Guinness dei primati è l'attore più profittevole in attività), che effetto fa pensare che in vent'anni l'Academy Awards si sia vagamente ricordato di lui solo con una nomination per Pulp Fiction? Se la metti in questi termini, anche l'ultima polemica sulla mancanza di candidati afroamericani all'oscar sembra meno pretestuosa.
The Hateful Eight è al Cityplex di Alba alle 16, 17, 19, 21 e 22; al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo alle 15:40, 19:10, 21:30 e alle 22:30; all'Impero di Bra alle 18:30 e alle 21:30; al Fiamma di Cuneo alle 15:40, 19:10 e 22:30; al Multilanghe di Dogliani alle 21:35; ai Portici di Fossano alle 18:15 e 21:30; al Bertola di Mondovì alle 18 e alle 21; all'Italia di Saluzzo alle 15:30, 18:30 e 21:30; al Cinecittà di Savigliano alle 21:30.
La vendetta è un piatto che si conserva a -40°
22-01-2016, 14:35Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink |
| Il Sud Dakota secondo Iñárritu. |
 |
| Il Sud Dakota com'è davvero. |
"Chi?"
"Quei due ragazzi, alla fine li hai ammazzati?"
"Fitzgerald e Bedger? Ah, no".
"E perché no?"
"Bedger era un ragazzino, e quanto a Fitzgerald..."
"Non avevano la stessa età?"
"...Si era già arruolato. Se gli avessi torto un capello mi avrebbero impiccato. Ci siamo messi d'accordo con 400 dollari, e mi restituì il fucile. Questo qui".
"Non erano 300 dollari?"
"Infatti".
"Ma hai appena detto 400".
"Mi sarò sbagliato. Figliolo, quando hai visto la morte in faccia, e hai sopravvissuto a una bufera di neve accucciandoti nella carcassa di un cavallo..."
"Ma era giugno".
(Se vi è piaciuto Il viaggio di Arlo, non perdetevi la versione per adulti, col mille per cento di sangue e cicatrici in più, e un'animazione digitale ancora più raffinata - l'orso sembra vero! Padre e figlio si scambiano le parti, c'è un po' più di sangue e di visioni dall'oltretomba, e Di Caprio presta la voce - il rantolo - a un mammuth ferito ma non domo).
 |
| Il salvaschermo più costoso mai realizzato |
A Iñárritu interessa il cinema vero, quello senza green screen e altri trucchetti, quello che si fa con la pellicola, e l'esposizione naturale, e gli animali veri, e le ferite e i colpi di tosse veri - come se tutta questa verità non costasse comunque milioni di dollari. Gli interessava il ritorno alla naturalezza, anche se l'orso che cerca di finire Di Caprio battendolo come un materasso è un prodigio di computergrafica. Con l'ipocrisia ingenua e inconsapevole di quei milionari che sognano il ritorno alla natura ma hanno più in mente il triathlon - a proposito, c'è anche il saggio capo indiano che si lamenta perché il viso pallido gli ha tolto tutto. E nessuno che gli dica: senti nonno, tra venticinque anni potrei anche capire, ma siamo nel 1820, "tutto" cosa? A momenti non c'è un solo viso pallido in tutto il Dakota, e comunque appena arriva lo scotenni e gli rubi il bottino di caccia, a chi la vuoi raccontare? Non ci hai fatto gli affari anche tu, coi visi pallidi, finché t'è convenuto? Eh, ma questi bianchi sono cattivi sul serio. Rubano le donne, impiccano per divertimento, aggiungendo un cartello di spiegazione come i nazisti - anche se nessuno sa leggere in un raggio di trecento miglia.
È difficile sfuggire a The Revenant, alla sua fotografia da National Geographic, al titanismo essenziale del suo eroe, maschiaccio di poche parole laddove pare che il vero Hugh Class fosse un affabulatore, magari pure un contaballe. Questa parte del suo ruolo se la prende Tom Hardy che prosegue il suo stato di grazia: un antagonista nervoso e rapace che non sta in scena per più di mezz'ora, ma ha più dialoghi di tutti gli altri personaggi messi assieme. Iñárritu ha coraggio da vendere, e anche stavolta non si può che dargliene atto. Dopo due ore senza una sola scena in interni, cominci a capire quello che intendeva Cimino mentre affondava sul ponte dei Cancelli del cielo: i film dovrebbero essere viaggi, dovrebbero prenderti di peso e portarti in un altro luogo, in un altro tempo.
Cosa sta succedendo allora a Hollywood, se Cimino sprofondò e Iñárritu ha preso 12 nomination? Siamo entrati in una nuova età del cinema, o il nuovo regista pazzo è un po' meno pazzo, un po' più paraculo di quanto non voglia sembrarci? Disprezza i fumettoni, ma il suo eroe sembra avere lo stesso fattore rigenerante di Wolverine. Vuole le luci naturali, ma sa che la gente verrà a vedere l'orso finto. Vuole la storia vera, ma poi se la reinventa da capo a piedi, ricattandoci col sentimento più a buon mercato - l'amor paterno. Il vero Glass era un fanfarone che si fece duecento miglia per trecento dollari e un fucile. Il Glass del film deve attraversare canyon e ghiacciai per vendicare un figlio. È una storia talmente costruita che alla fine Iñárritu se ne vergogna - e anche stavolta, come in Birdman, il finale manda un po' a gambe all'aria il film.
Vorrebbe essere profondo, vorrebbe essere autocritico, vorrebbe rivedere le sue stesse premesse. Ha fatto sanguinare Di Caprio, ha opposto bianchi sterminatori a pellerossa in armonia con la natura, e alla fine ci ha ricordato che la vendetta è un buon trucco per costruirci attorno un film - ma che resta sostanzialmente una cosa sbagliata, ragazzi, mi raccomando non vendicatevi a casa. Che gli puoi dire? Bravo è bravo. Ma resta lì sospeso nel bianco delle sue bufere fantastiche, né troppo pazzo né troppo furbo per arrivare davvero al punto. The Revenant è al Cityplex di Alba (21:30), al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:30, 22:10), all'Impero di Bra (19:45, 21:45), al Fiamma di Cuneo (21:00), al Baretti di Mondovì (21:00), all'Italia di Saluzzo (21:30), al Cinecittà di Savigliano (21:30)
È lunga la strada per Selma
31-03-2015, 00:11Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, razzismiPermalinkIl tuo maestro e modello ti fa salire nella sua macchina. Mentre guida a velocità di crociera ti spiega che non ne può più; che non è sicuro di quello che sta facendo; che per colpa sua anche stavolta qualche brava persona si farà male o verrà uccisa; che malgrado questo anche stavolta probabilmente non cambierà niente; e che quindi forse bisognerebbe ripensare tutta la strategia; ma ci vorrebbe del tempo; e quel tempo lui non l'ha, è troppo stanco.
E ti chiede come la pensi. Te lo ricordi immenso, quando eri un ragazzino nella folla che stava ad ascoltarlo: adesso è lì in macchina con te, ti apre il suo cuore e ti mostra che è marcio. Cosa facciamo adesso? Ti avanza un po' della fede che distribuiva ai vecchi tempi? Selma è stato salutato come un "film necessario". Purtroppo i film necessari non sono necessariamente buoni film. D'altro canto prima o poi qualcuno doveva spezzare l'incantesimo per cui la figura più importante della comunità afroamericana, l'uomo per cui si chiudono scuole e uffici ogni terzo lunedì di gennaio, non era ancora stato celebrato nelle sale cinematografiche. Ancora negli anni Novanta era paradossalmente più facile realizzare film su personaggi controversi come Malcolm X o le Pantere nere, piuttosto che mettere a fuoco l'uomo-immagine del movimento per i diritti civili. Evitare il taglio agiografico era impossibile, e forse lo è ancora.
A quasi sessant'anni di distanza Martin Luther King, jr continua a essere un simbolo più che un uomo. Anche in sede storiografica non si nota una grande esigenza di sottoporre il mito a una revisione; il peggio che si osa dire su di lui è che gli piacevano più donne di quante un reverendo sposato avrebbe dovuto permettersi, ma il biografo che ha osato definirlo un "donnaiolo" si è poi pentito, è stato frainteso, ecc.. E siccome il pubblico non sembra pronto (né negli USA né altrove) per un leader sessualmente esuberante, anche stavolta non lo vedremo rialzarsi in mutande da un letto non suo. È vero che telefonava a tarda notte a donne sposate (l'FBI aveva accesso ai tabulati), ma solo perché aveva bisogno di sentire un gospel dal vivo. L'adulterio è ammesso, ma non esibito - d'altronde è così importante? In un certo senso sì, uno degli aspetti della grandezza di MLK è proprio il fatto che sopravvisse ai ricatti dell'FBI di Hoover che credeva di poterlo inchiodare alle sue scappatelle sessuali. Il reverendo impersonato da Daniel Oyelowo di fronte alla moglie non nega e non si difende: assume la sua smorfia contrita d'ordinanza e va avanti. Lo stato disastrato del suo matrimonio non è che una tra tante ragioni di frustrazione. È un MLK perennemente imbronciato, insicuro, disilluso, ed è probabilmente l'unico MLK umano che Ava DuVernay poteva permettersi di mettere su pellicola. Di un MLK più machiavellico, che di concerto con Lyndon Johnson manda freddamente bambini e anziane signore in prima linea contro i peggiori sceriffi dell'Alabama - e nel frattempo combina anche qualche festicciola in albergo - per ora nessuno sente l'esigenza.
È un film necessario, si diceva; una certa gravitas era indispensabile, ancorché un po' soporifera; più che al botteghino Oprah Winfrey, Brad Pitt e gli altri produttori guardavano alle scuole che lo proietteranno intensamente nella seconda settimana di gennaio. Ma è proprio qui che Selma delude, ed è un peccato... (continua su +eventi!) perché tutto sommato offre un buon ragguaglio sulle tecniche di non-violenza, e sui sacrifici che comportano (non a caso gran parte dei leader sono ministri di culto: del resto se il tuo metodo di lotta implica la possibilità di ritrovarti inerme davanti a poliziotti armati e fanatici razzisti, la fede in una trascendenza non è obbligatoria ma può aiutare). Il guaio è che Selma regge la prova ferro-da-stiro, ovvero è un film che si può tranquillamente guardare mentre si è in tutt’altro affaccendati, senza perdersi nessuno snodo fondamentale. Al massimo qualche primo piano di Oyelowo corrucciato, o di Carmen Ejogo corrucciata, o Tom Wilkinson perplesso (fa il presidente Johnson, e il film a quanto pare non gli rende onore) o Tim Roth governatore cattivo.
Il film ha il torto di dare per scontata l’attenzione del pubblico, dopo un paio di scene madri iniziali di fronte alle quali commuoversi è obbligatorio. Parlo da insegnante: un film del genere non lo proietterei in un’aula magna: se passa la prova ferro-da-stiro, passa anche la prova smartphone. Per parlare degli stessi argomenti ricorrerò a Mississippi Burning, che ormai ha trent’anni ma almeno offre una chiave per decifrare l’odio di quei razzisti che in Selma sono raffigurati più o meno come orchetti di Tolkien, senza storia né psicologia; oppure li fregherò con Alì, che col pretesto dell’epica sportiva racconta di Emmett Till e dei musulmani neri; e integrerò con qualche scena di Amistade da calcio nello stomaco – quel tipo di calci che i ragazzini sanno apprezzare. Niente di personale: ma se Selma mi ha un po’ annoiato, figuratevi i miei studenti.
Come tenere i negretti al loro posto
28-08-2014, 17:33Almanacco, Americana, anniversari, Leonardo sells out, razzismiPermalinkA casa del pastore Wright arrivarono alle due del mattino, senza infilare cappucci bianchi o altre pagliacciate: che bisogno c'era di nascondersi? Erano armati e avevano le torce. C'erano Roy Bryant e il fratellastro JW Milam, e qualcun altro che lavorava con loro e forse era nero. Chiesero a Wright di vedere gli amici di famiglia, i tre ragazzi di Chicago venuti in villeggiatura. Chi dei tre era passato dalla bottega di Bryant quattro giorni prima, chi dei tre aveva rivolto la parola alla moglie di Roy? Fu Emmett a rispondere: sono stato io. Aveva quattordici anni, ma sembrava più grande. Gli dissero di vestirsi, che doveva venire con loro. Il pastore non protestò troppo, sapeva cosa stava rischiando. Solo la zia fece un po' di baccano. Senza vergogna offrì del denaro a Bryant e Milam. Finsero di non averla sentita. Infilarono il ragazzo nel pick-up e sparirono. Mose Wright attese venti minuti, poi prese la macchina e si diresse verso il centro del paese. È là che l'avrebbe ritrovato, se i due volevano soltanto dargli una lezione e poi lasciarlo libero. Ma Emmett non era pratico della zona e c'era comunque rischio che si perdesse.
Emmett fu picchiato con criterio, forse col calcio di una pistola. In un fienile, e poi di nuovo sul pick-up. In una baracca in mezzo a una piantagione, e sul pick-up di nuovo. Non riuscivano a lasciarlo andare. Ammesso che l'idea iniziale fosse davvero di risparmiarlo, il ragazzo non stava reagendo nel modo giusto.
Ciao Satana, credo sia ora di andare
16-08-2014, 03:08Almanacco, Americana, fb2020, Leonardo sells out, musicaPermalinkDi lui non si sa praticamente nulla. I testimoni orali, i tizi che si sono intascati qualche soldo per raccontare qualcosa ai documentaristi, sono gente che per cento dollari ti suona quel che vuoi ascoltare - vuoi il patto col diavolo? Ti racconto il patto col diavolo. Vuoi il drama? Gli morì la moglie di parto. Anzi era una fidanzata. Minorenne ovviamente. Anzi erano due. Due minorenni entrambe morte di parto. Vuoi il mistero? con la chitarra era una schiappa, ti giuro, l'ho sentito. Poi gli muore la fidanzata incinta e lui scompare per un anno, e quando si rifa vivo suona come un dio. No. Dio decisamente non suona così. Dio non vuole sentire i lamenti d'amore uscirti dallo stomaco come i crampi, Dio non vuole sentire che hai un limone da spremere nel bassovita, Dio in questa storia non c'entra nulla. Decisamente.
La storia che si impone sulle altre, in queste situazioni, è quella più romanzesca. È un musicista girovago, quando arriva in città mette il cappello sul marciapiede e suona quel che vuoi sentire. È abbastanza eclettico, ma ha una sua personalità. In breve riesce sempre a farsi invitare a suonare in un locale. Bisogna avere una voce squillante e un gran repertorio - lui peraltro sembra in grado di riprodurre qualsiasi canzone a comando. Se non sa il testo se lo inventa, e in breve ha inventato una nuova canzone. Alle donne piace. Di solito ne sceglie una - o si lascia scegliere - e quando il locale chiude, lui dorme da lei. Una diversa per ogni città. A Greenwood sta dalla moglie del gestore. Non è una grande idea. Con lui c'è un suonatore di armonica che diventerà famoso come Sonny Boy Williamson. A un certo punto Sonny Boy si accorge che all'amico hanno passato una bottiglia di whisky aperta. Gliela sfila di mano, la bottiglia si rompe, che cazzo fai? "Amico, non farlo mai più. Non bere mai più da una bottiglia che non hai visto aprire". "Amico, non levarmi mai più una bottiglia dalla mano, hai capito?" "Ho capito".
Non sappiamo nemmeno dove sia sepolto - tre cimiteri si contendono il privilegio, ma le tre tombe sono state rimesse a posto molti anni dopo, quando Robert Johnson - si chiamava così - diventa improvvisamente famoso, di una fama che mai si sarebbe sognato. I nastri che aveva inciso in una camera d'albergo a San Antonio, e più tardi in un piccolo studio di registrazione a Dallas, vengono ristampati su album e diventano l'opera omnia del più grande bluesman di tutti i tempi. 29 canzoni, alcune registrate persino un paio di volte, in fretta, da un tizio che non aveva mai inciso nulla e avrebbe potuto suonare centinaia di pezzi in stili molto diversi, ma gli avevano chiesto un certo tipo di blues e, perdio, pagavano.
Robert Johnson nella sua vita ha probabilmente ascoltato solo un paio delle sue canzoni incise a 78 giri. Non sappiamo nemmeno se si sia piaciuto, ma è facile immaginare che si sia sentito a disagio, di fronte a una voce più stridula, e una chitarra più svelta. L'etichetta per cui incideva era solita accelerare i nastri anche del 20%. Così l'indiscussa bravura di Johnson alla chitarra diventa qualcosa di disumano. Quando Keith Richards l'ascolta per la prima volta a casa di Brian Johnson, si domanda chi sia l'altro chitarrista. "Robert Johnson". "Sì, ma chi è l'altro che suona con lui?"
Il vero Robert Johnson probabilmente suonava più piano, e aveva una voce più bassa, simile agli altri bluesmen del tempo. Non suonava soltanto blues - l'unico ragtime che ha inciso è assolutamente brillante, non l'esercizio di un dilettante - e non era necessariamente malinconico o dannato come ci piace sentir raccontare. Ma il vero Robert non esiste più. Quello che abbiamo è stridulo e dannato, e non c'è filologia musicale che ci possa convincere a farne a meno.
La leggenda del patto col diavolo a un incrocio è probabilmente soltanto una bella storia. Chi ha studiato un po' più la vicenda sostiene che l'apprendistato musicale di Johnson sia durato almeno due anni. Sappiamo persino il nome all'anagrafe del suo maestro, non il diavolo, ma un tal Ike Zimmerman. Pare che sia vero che suonasse nei cimiteri - sono posti tranquilli dopo l'ora di chiusura, nessuno ti disturba e puoi esercitarti. Ike Zimmerman non ha mai inciso niente. Volendo possiamo tranquillamente immaginarcelo come il più grande genio musicale del Novecento.
L'intercettatore che finì intercettato
08-08-2014, 23:58Almanacco, Americana, Leonardo sells outPermalink |
| The Mary Rose Stretch |
C'è un contrappasso incredibilmente ironico, nella vicenda di Nixon, che altri meglio di me avranno già fatto notare: il presidente che voleva intercettare i suoi avversari finì intercettato. Il Watergate comincia con una maldestra squadra di spioni repubblicani che cercano di incidere su nastro le conversazioni dei democratici, e finisce con Nixon costretto a divulgare i nastri delle proprie conversazioni alla Casa Bianca. A rileggerlo, uno non ci crede. I passi falsi che condussero l'uomo più potente del mondo verso l'uscita di scena sono di una goffaggine oggi implausibile.
I guai veri per Nixon cominciano nel luglio dell'anno precedente, quando un membro del suo staff ammette di fronte alla commissione d'inchiesta del Senato che sì, tutto quello che si dice nello Studio Ovale è registrato. C'è una specie di streaming, una monumentale opera di archiviazione su nastro che va avanti dal 1972! Il procuratore Archibald Cox chiede a Nixon di consegnare i nastri; Nixon non vuole saperne. Propone di consegnare un riassunto delle conversazioni a cura di un senatore (John C. Stennis) che è notoriamente duro d'orecchi. Cox si impunta: vuole i nastri. Nixon decide di silurarlo. Ma non è così facile. Il superiore di Cox è il procuratore generale Elliot Richardson. Quando Nixon domanda a Richardson di sollevare Cox dall'incarico, Richardson si dimette. Nixon si rivolge immediatamente al suo vice, William Ruckelshaus, e gli rinnova la richiesta di far fuori Cox. Si dimette anche Ruckelshaus. È il famoso "massacro del sabato sera", dato che tutto avviene nella sera del 20/10/1973. Termina con Nixon che si fa portare in limousine alla Casa Bianca Robert Bork (dall'avvocatura di Stato), lo nomina procuratore generale e gli mette in mano la penna per firmare la rimozione di Cox. Il Congresso monta su tutte le furie, i cittadini cominciano a mandare telegrammi di protesta, i sondaggi danno gli elettori favorevoli all'impeachment al 44% (i contrari al 43%) e alla fine il successore di Cox non potrà non richiedere gli stessi nastri. Molto prima di poterli ascoltare, parlamentari e cittadini sono ormai sicuri che contengano cose incriminanti. Ma in realtà il primo nastro a far davvero parlare di sé contiene soprattutto silenzio.
Diciotto interminabili minuti di silenzio, là dove doveva esserci stata una conversazione. Chi ha cancellato quel nastro, che non era mai uscito dalla Casa Bianca? Il capro espiatorio porta il gentile nome di Rose Mary Woods, segretaria personale del presidente, che ammette di aver danneggiato il nastro premendo il pedale sbagliato durante una chiamata telefonica. Rec invece che Stop. Sono incidenti che succedono. Però Rose Mary dovrebbe aver premuto il pedale per almeno diciotto minuti. Lei si ritiene responsabile soltanto dei primi cinque. Ma era così facile sbagliarsi? Quando le chiedono di ripetere l'errore nel suo ufficio, Rose Mary diventa la protagonista di uno scatto famoso, battezzato "The Rose Mary Stretch". È il momento in cui Nixon comincia a diventare ridicolo. Nel frattempo i tecnici a cui viene sottoposto il nastro scoprono che non è stato cancellato una volta, bensì nove. Il peggio comunque deve ancora arrivare.
Arriva a fine luglio '74, quando viene divulgato il nastro noto come la "pistola fumante". È una conversazione di due anni prima in cui Nixon propone di contattare la dirigenza della CIA per forzare l'FBI a cessare le indagini sul Watergate, per motivi di sicurezza nazionale. Il contenuto è sufficiente per accusare Nixon di aver ostacolato un'inchiesta federale. Ormai le dimissioni sono una scelta obbligata. Dopo aver ottenuto la grazia dal suo successore, Nixon continuerà a lottare per riottenere il possesso dei nastri, appellandosi al primo emendamento e lamentando l'intrusione della sua privacy. Dopo varie sconfitte, 25 anni dopo una corte gli darà ragione. I nastri e le trascrizioni oggi sono custoditi presso il Richard Nixon Presidential Library and Museum.
Oggi si registra ancora ogni conversazione nello Studio Ovale? Non saprei. In compenso so che cinque anni di mie conversazioni private sono state messe da Google a disposizione di un'agenzia di intelligence degli Stati Uniti. Google stessa mi ha di recente fatto sapere che ha intenzione di controllare sistematicamente quel che scrivo, dato che potrei pur sempre essere un orribile criminale. Il terminale su cui sto scrivendo ha una webcam che si può attivare a distanza, identificarmi e segnalare la mia presenza. Da questa distanza, l'imperatore Nixon scompare come un ladro di polli.
Il giglio dei Mohawk
17-04-2014, 13:31Americana, cultura, Il Post, religioni, santiPermalink
17 aprile - Santa Kateri Tekakwitha (1656-1680), vergine mohawk
Di solito gli irochesi attaccano su due fronti; accerchiano il villaggio; uccidono i guerrieri feriti, gli anziani, i bambini troppo piccoli e in generale chi non reggerebbe la fatica di un lungo viaggio a piedi. Ai restanti prigionieri viene tagliato un dito a scopo di identificazione; nel frattempo un messaggero viene mandato al villaggio per avvertire che la piccola guerra è andata bene. Lungo il cammino i prigionieri che cadono vengono terminati rapidamente a colpi d'ascia e abbandonati insepolti. Quando finalmente arrivano al villaggio, una piccola folla si fa avanti per percuoterli un po'. Vengono spogliati e torturati con più professionalità dalle donne, specie le più anziane ed esperte. A questo punto venivano nutriti e potevano riposare; quindi erano fortemente invitati a danzare in cerchio mentre il consiglio del villaggio deliberava sul loro destino. I nuclei famigliari che avevano avuto un lutto recente avevano la facoltà di adottare uno dei prigionieri, che in caso contrario veniva ulteriormente torturato, ucciso e parzialmente mangiato. Il prigioniero adottato diventava membro della famiglia a tutti gli effetti, e dalla sua disponibilità a impersonare il parente precedente morto in guerra o in malattia dipendeva la sua sopravvivenza: se non riusciva a integrarsi poteva essere ucciso anche dopo qualche anno. Anche la madre di Kateri Tekakwitha divenne mohawk in questo modo, quando era bambina. Di nascita era algonchina, di una tribù cattolica e filofrancese; gli irochesi (di cui i mohawk facevano parte) in questa fase acquistavano armi da olandesi e inglesi, e attaccavano i francesi che si ostinavano a comprare pelli di castoro da altri popoli.

Gli irochesi erano tutto meno che un popolo in simbiosi con la natura. Giunti da sud nel medioevo, miravano a diventare la potenza egemone di tutta la zona tra i Grandi Laghi e il Mississippi che in alcune mappe europee si chiamava invece Nuova Francia. La loro idea di egemonia prevedeva il genocidio e l'assimilazione delle tribù nemiche. Da un punto di vista economico, miravano al monopolio della vendita di pelli del castoro gli europei, e questo era un buon motivo per combattere contro le tribù alleate dei francesi. Pazienza se nel frattempo la caccia sistematica dell'animale lo stava portando all'estinzione in una vasta porzione del suo habitat. Cacciatori e guerrieri erano costretti a viaggi sempre più lunghi, il che aumentava il prestigio e l'importanza delle donne che restavano a casa. Alle donne appartenevano terreni e abitazioni; soltanto loro conoscevano i misteri delle "tre sorelle" (mais, fagioli, zucche), senza le quali anche i più potenti guerrieri non avrebbero saputo come riempire la scodella quotidiana. E tuttavia le donne dovevano sposarsi e avere figli: era l'unico destino concesso. L'infertilità era connessa con la stregoneria e con altre sciagure. D'altro canto, divorziare sembrava straordinariamente facile: bastava posare i mocassini del marito fuori dalla casa.

Kateri però non voleva sposarsi. Quando le presentarono un pretendente (a 14 o a 17 anni), se la squagliò senza tante cerimonie. Ora faccio l'avvocato del diavolo: Kateri non era un buon partito. Non per via delle origine algonchine, dal momento che l'abitudine a rimpolpare le famiglie con prigionieri di altre tribù aveva reso gli irochesi un melting pot più amalgamato del nostro: dopo l'epidemia del vaiolo del 1662 gli etnologi calcolano che il 90% dei mohawk non fossero di origine mohawk.
Nella stessa epidemia però Kateri aveva perso la famiglia e la bellezza: i segni del vaiolo le sfiguravano la fronte. Aveva anche una vista assai debole, il che non le impediva di essere un'artigiana molto abile. La zia che l'allevava non aveva probabilmente né l'interesse né la possibilità di trovarle un guerriero bello e forte: bisognava arrangiarsi. Le fonti gesuite ovviamente non scrivono così, bensì:
Tekakwitha crebbe senza scuola e senza studio, amante soltanto della solitudine e del lavoro, ma la grazia di Dio la condusse per vie misteriose alla pratica eroica di tutte le virtù, specialmente di quella più sconosciuta agli Indiani, la castità.E può anche darsi che abbiano ragione; che Kateri non disprezzasse unicamente il suo promesso sposo, ma il matrimonio e il congiungimento carnale in sé. Persone del genere esistono in tutte le culture e a tutte le latitudini. Fu la scelta di non sposarsi - che nella cultura mohawk l'avrebbe portata dritta a un'accusa di stregoneria - ad avvicinarla ai "vestenera", i missionari gesuiti. Ogni villaggio ne aveva uno: lo prevedeva una clausola di una pace da poco firmata coi francesi. Qui bisognerebbe aprire una parentesi enorme sul ruolo dei gesuiti, che abbinavano a una devozione fanatica una duttilità etnologica veramente in anticipo sui tempi. Ovunque arrivano - e arrivano ovunque, sprezzanti dei rischi di martirio - i gesuiti sanno di non trovarsi semplicemente in mezzo a selvaggi, ma al cospetto di culture da interpretare e studiare. Saranno i primi a pubblicare grammatiche giapponesi e azteche; ma a differenza degli antropologi di oggi, che sono portati a considerare ogni popolo come una nicchia da preservare, anche a costo di impedirsi di conoscerla, i gesuiti sono in missione per conto di Dio. La cultura che si portano con sé, dall'Europa sconvolta dalle guerre di religione, la vogliono spargere nel Nuovo Mondo, innestandola su piante autoctone ed esotiche, nella speranza che da qualche parte nella foresta o nella jungla nasca qualcosa di simile a un regno dei cieli, o anche solo una Repubblica di Indios conversi come in Paraguay. Anche in Nuova Francia erano riusciti a farsi intestare delle seignuries, dei feudi. Il piano era infettare le Sei Nazioni come un virus, portando armi e sacramenti (continua sul Post...)
12 anni di solitudine
26-02-2014, 03:47Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, razzismiPermalinkappena una trentina, inclusi titoli che hanno poco a che fare con gli schiavi d'America. La stessa fonte conta 180 film sulla Shoah, esclusi i documentari. Perché la schiavitù è nove volte meno cinematograficamente interessante? È semplicemente l'effetto di un senso di colpa ancora non rielaborato dal pubblico bianco americano? Forse c'è qualcosa di più, se anche l'afro-britannico Steve McQueen ha preferito affidarsi a una fonte eccezionale come l'autobiografia del "free negro" Solomon Northup. Nato libero nello Stato di New York, carpentiere e violinista, Northup nel 1841 è vittima di un sequestro di persona. La sua identità viene cancellata e sostituita con quella di uno schiavo fuggitivo. Northup (Chiwetel Ejiofor, che debuttò con Amistad e difficilmente sarà mai più tanto vicino all'Oscar) non è il solo ad avere perso la sua libertà in questo modo, ma è tra i pochissimi che riuscì a riconquistarla, dopo dodici anni, e l'unico che pubblicò la sua storia. C'è persino chi ha criticato McQueen per avere scelto un'angolazione tanto particolare: l'avventura di Northup è una traiettoria eccentrica rispetto alla storia del popolo afroamericano. I suoi compagni di schiavitù sono satelliti lontani con cui è entrato in contatto per un fatale errore, e che non potranno seguirlo verso la libertà. Ognuno - ce ne accorgiamo più volte nel film - ha un suo destino che non può essere diviso con altri.
E d'altro canto Northup ha il grosso pregio di assomigliare a noi, nati liberi, terrorizzati dalla sola idea di perdere il nostro status. Solo il suo punto di vista poteva fornirci quel biglietto per l'inferno (e ritorno) che McQueen voleva staccare. I film sulla schiavitù, forse, non si fanno perché è difficile riuscire a sintonizzare il pubblico sulla stessa onda delle vittime: con la Shoah è più facile? Ma anche nei migliori film sulla Shoah (Spielberg, Polanski), fate caso all'importanza di quei momenti in cui il cittadino medio-borghese scopre all'improvviso di aver perso il suo status di essere umano. McQueen aveva bisogno di qualcosa del genere: mostrarci un afroamericano educato, una bella casa, splendidi figli, una moglie intraprendente. La stragrande maggioranza dei neri nati schiavi non aveva nulla di tutto questo, ma noi non riusciremmo a empatizzare con gente nata e morta nelle baracche. Tarantino ha risolto lo stesso problema inventandosi un pistolero supercool, ma solo a Tarantino è concesso di risolvere in questo modo i problemi (continua su +eventi!)
Il punto è che se non esiste nel film un nero eccezionale, educato come Northup o esplosivo come Django, lo spettatore rischia di identificarsi più facilmente coi bianchi - dal momento che è molto spesso un bianco anche lui. Magari non vorrebbe, perché è uno spettatore civile e democratico, ma non è così difficile sentirsi addosso i panni dello schiavista buono e imbarazzato (Cumberbatch), o del carnefice frustrato (Fassbender). Quest'ultimo sembra proseguire il viaggio nella solitudine intrapreso nel precedente film di McQueen, Shame: il coito è ancora una volta un combattimento facile che ti lascia vincitore di un corpo inerte e sconosciuto. Non sorprende che McQueen abbia reso espliciti i rapporti tra lo schiavista e la schiava Patsey (Lupita Nyong'o), a cui il testo del 1853 alludeva soltanto. Più curiosa è la scena - molto intensa - in cui Patsey chiede a Northup di ucciderla per porre fine alle sue sofferenze. Neanche questa c'è nel testo originale, forse. Dico forse perché può darsi che lo sceneggiatore John Ridley abbia equivocato un passo del libro in cui era la moglie del padrone, gelosa, a chiedere a Northup di uccidere Patsey. Nel lapsus, tutta la nostra incapacità di capire l'alieno, lo schiavo: Patsey è esistita davvero, davvero fu frustata a sangue per aver cercato di procurarsi un sapone. Probabilmente era violentata con regolarità dal suo padrone e malmenata dalla padrona. Desiderava di morire? Non lo sappiamo, ma probabilmente è un desiderio che noi proveremmo al suo posto.
 |
| "Dunque, dovresti pronunciarla più o meno così..." |
Eppure il suo discorso ha una funzione fondamentale. A differenza di quel che può lasciare intendere la locandina, Northup non tenta mai la fuga. Un tentativo narrato nel libro viene rimosso nella sceneggiatura. L'unica strada verso la libertà ammessa nel film è quella interiore: Northup deve rimanere umano, ricordare la sua libertà, i tempi in cui sapeva leggere e scrivere: finché dopo dodici anni di solitudine finalmente il caso gli mette davanti un uomo che questa umanità la sa riconoscere. Quest'uomo è Brad Pitt, e il suo discorso dice, semplicemente, che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Lo ha scritto Jefferson in cima alla Dichiarazione. Ma è d'accordo anche lo schiavista Fassbender, salvo ribadire che i negri non sono uomini. Chi ha criticato la mano leggera di McQueen nei confronti della religione (strumento di asservimento degli schiavi...) forse non ha fatto caso al fatto che anche il fondamento dell'uguaglianza, più volte difeso nel film da Northup e da altri, è religioso: senza nozioni di evoluzionismo o dna, l'unico garante di questa uguaglianza è quell'Ente supremo che Jefferson prudentemente aveva lasciato in controluce. Siamo tutti uguali perché Lui ci ha creato così: è davanti a lui che lo schiavista dovrà rispondere di aver frustato una povera ragazza. Forse non è lo stesso dio arcano evocato dagli schiavi negli spiritual, ma è ancora oggi un assioma che la società non discute, non se lo può permettere. Tutto il resto sono dispute nominalistiche, anche oggi, quando ci diciamo convinti che tutti i cittadini siano uguali - ma non tutti sono degli di essere chiamati nostri concittadini. Quelli che raccolgono i pomodori per pochi euro alla giornata quasi sicuramente non lo sono. Possiamo passare due ore al cinema a vedere un film di schiavi senza neanche sprecare un pensiero per loro.
12 anni schiavo è al Fiamma di Cuneo (21:00), al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:00, 22:45) e all'Aurora di Savigliano (21:15).
Tempi duri per Llewyn Davis
10-02-2014, 10:47Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, musicaPermalinkWintertime in New York town
The wind blowing snow around
Walk around with nowhere to go
Somebody could freeze right to the bone
I froze right to the bone
Tempi duri a New York. Senza un dollaro in tasca, senza un posto dove posare la chitarra e il sedere; un partner che ti armonizzi il ritornello; qualcuno che ti spieghi dove stai sbagliando, un gatto fuggito da riportare ai tuoi ultimi amici. Tieni duro Llewyn Davis, il vento freddo che spazza Washington Square forse è un annuncio di primavera. Sta per sbocciare l'ultima grande stagione del folk, non mollare Llewyn Davis. Forse sei vittima di un incantesimo, e un estraneo a migliaia di miglia se la spassa col tuo destino. Forse questo non è semplicemente il tuo show; non sei che la comparsa che fischia nell'ombra e nell'ombra ritorna. Cosa stai facendo della tua vita, Llewyn Davis? (continua su +eventi!)

A proposito di Davis è un film che può lasciare estasiati o sgomenti. Se non vi piace il folk; se non apprezzate i primi dischi di Dylan; se mantenere lo sguardo su un menestrello per quattro strofe e altrettanti ritornelli rientra nella vostra idea di noia, non provateci nemmeno. Ma anche chi colleziona i dischi di Phil Ochs o Van Ronk può rimanere interdetto dallo sguardo raggelante che i Coen buttano sul Greenwich Village del 1961. Un attimo prima che tutto esploda, il loro eroe immaginario Llewyn Davis è tentato dal fallimento; pronto a partire con la prima nave, il destino lo ributta a terra e lo aspetta in un vicolo. Chi ha il palato per le storie di sventura e fallimento apprezzerà immensamente A proposito di Davis.

Non so se sia il caso di A.O. Scott, il critico del New York Times che lo ha messo al primo posto nella Top10 del 2013. Alle pendici della stessa classifica, sei film ex aequo presentati come variazioni di un edonismo senza scrupoli “Just look at all my stuff!” It’s capitalism, baby! Grab what (and who) you can, and do whatever feels good. We’re all going to hell (or jail, or Florida) anyway. Il grande Gatsby, The Wolf of Wall Street, The Bling Ring, Spring Breakers, Pain and Gain e American Hustle: sei storie di avidità e autoaffermazione. Nel frattempo i Coen guardano come sempre altrove, e si inventano il biopic senza senso di un cantante senza direzione e senza pubblico, uno dei 999 che non ce la farà. Vittima di oscure maledizioni, Davis attraversa le leggende degli altri senza rendersene conto; ama il folk ma non la gente (in inglese è la stessa cosa); incide un successo e non se ne accorge; sfigato parente di re Mida, trasforma in merda ogni cosa che incontra. In un 1961 parallelo, Holly Golightly e Paul Varjak non trovano più il gatto e proseguono ognuno per la propria strada, e di chi è la colpa.
A proposito di Davis è allo Stella Maris di Alba (21:00); al Cinelandia di Borgo S. Dalmazzo (20:20, 22:40); al Multilanghe di Dogliani (21:00); ai Portici di Fossano (21:15).
HIV Texas Cowboy
04-02-2014, 03:35Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, finché c'è salute, omofobiePermalinkDottore, te lo dico un'ultima volta: posa quella siringa e lasciami andare. Non sono una delle vostre cavie fottute. Non è ancora mutato il retrovirus che si porterà Ron Woodroof nella tomba. Forse avete sentito parlare di Dallas Buyers Club come del film in cui un bellone di Hollywood riscatta un passato di orribili commedie romantiche in serie, perde millanta chilogrammi e si sistema in uno dei ruoli preferiti dalla giuria degli Oscar: il sieropositivo macilento ma non domo. E a questo punto magari in voi sta già suonando un allarme: film ricattatorio, buoni sentimenti, moribondi che si abbracciano con soprani in sottofondo. Disattivate quell'allarme. Dallas Buyers Club è un western. E Matthew McConaughey (che è sempre stato un ottimo attore; purtroppo le commedie romantiche pagano di più) è un vero Texas cowboy a cui puoi togliere tutti i chili che vuoi - gliene restano abbastanza per mandarti al tappeto. Gli sguardi che ogni tanto gli riserva il transgender Rayon (Jared Leto, anche lui memorabile) sembrano tradire il punto di vista del regista: troppo facile commuoverci con sieropositivi gentili o raffinati, oggi soffrirete e piangerete per un puttaniere omofobo che puzza di rodeo e vive in una baracca.
 |
| Voglio però ricordarti com’eri (Uno studio comparato delle locandine dei suoi film, da Cracked.com) |
Prima di diventare un film, Dallas è stato un soggetto proposto e rifiutato per vent’anni. Affinché la “storia vera” diventasse una storia vendibile, è stato forse necessario rendere Ron molto più cowboy di quanto non fosse l’originale: metterlo in groppa a un toro (benché appassionato di rodeo non ne cavalcò mai uno), togliergli la figlia, affinché in una scena topica rimpiangesse di non averne mai avute; enfatizzarne l’omofobia, tema caro a Vallée; e soprattutto mettergli contro l’intero Dallas Mercy Hospital, il ranch dove i malvagi dottori sperimentano intrugli nocivi per arricchire le multinazionali.
Le cose sono ovviamente più sfumate di così; persino nei titoli di coda si ammette con una certa onestà che l’AZT, il veleno che secondo Ron stava facendo una strage, è ancora oggi uno degli ingredienti del cocktail di farmaci che tiene in vita milioni di sieropositivi. E d’altro canto la macchina farmaceutica, vista dall’individuo, è davvero un Moloch spaventoso contro cui ribellarsi: Ron ha la sfortuna di ammalarsi nel momento in cui i sieropositivi cadono come mosche, le multinazionali stanno cominciando a sperimentare farmaci su di loro, e il rischio di accelerarne la morte è calcolato. Di fronte a un destino tagliato così male, Ron si ribella e ha almeno la fortuna di trovare la persona giusta: in una clinica messicana, un medico radiato ma ancora abbonato a Lancet, che gli fa provare il peptide T, non ancora approvato negli USA. Pensa se invece incontrava un Vannoni.
 |
| “Matthew McConaughey… GHIGNA STUPIDAMENTE PER 90 MINUTI!” “Esatto, è tutto quello che succede” (NY Times). (Da Cracked.com). |
Dallas Buyers Club è al Vittoria di Bra alle 20:15 e alle 22:30 e al Fiamma di Cuneo alle 21:10; francamente non so se resisterà oltre giovedì (magari poi torna nelle sale dopo gli Oscar). È il tipico film di nicchia che molti preferirebbero guardare in lingua originale. Non abbastanza per farlo programmare in una sala della provincia di Cuneo, questo si sa. Ma abbastanza per rendere la versione sottotitolata in streaming un’alternativa interessante, ancorché illegale. Come può difendersi la distribuzione italiana da una concorrenza così sleale? Magari una settimana dopo il debutto nelle sale americane si potrebbe mettere in commercio una versione on line sottotitolata: qualche spilorcio continuerebbe a rubare, ma molti pagherebbero volentieri anche sei o sette euro, come al cinema. Oppure si può lasciare tutto com’è, doppiare l’accento texano di McConaughey, e terrorizzare i potenziali ladri di contenuto con qualche spot terrorizzante all’inizio dei dvd. Se hanno scelto questa seconda strada si vede che funziona.
La doppia o quadrupla vita di Walter Mitty
01-01-2014, 03:08Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, invecchiarePermalinkA cosa pensa Walter mentre gli parli? Cosa sta guardando mentre fissa nel vuoto? A volte semplicemente Walter è altrove, prigioniero di un film che non è mai il suo. In questi casi occorre aspettare un attimo, resettare, e tutto riparte come prima. Su Tvtropes la chiamano Daydream surprise: è quel momento di pazzia in cui un personaggio, fino a quel momento ritratto in un contesto realistico, all'improvviso compie qualcosa di folle (ad es. lanciarsi da un grattacielo). Ma è solo un sogno: un attimo dopo la storia ritorna sui binari del realismo quotidiano. Se la fantasia in questione permette al personaggio di sfogare un enorme potenziale di violenza repressa si parla invece di Indulgent fantasy segue. È il caso della sequenza più spettacolare del film, la lotta onirica tra due skater che precipitando da un ascensore sbriciolano il cemento di Manhattan; la prova della resistenza di Matrix nel nostro inconscio collettivo. Un attimo dopo siamo di nuovo nell'ascensore della Time-Life, non è successo nulla. È solo Walter che sogna ad occhi aperti. Non sarebbe Walter Mitty, altrimenti.
In inglese esiste anche l'aggettivo, "mittyiesque". Per il World English Dictionary "mitty" è un personaggio finzionale caratterizzato da sogni a occhi aperti elaborati e grandiosi. Nel gergo dell'esercito è un miles gloriosus, un fanfarone che si attribuisce successi immaginari. Ma nel 1939 Walter Mitty era semplicemente il protagonista di un raccontino di James Thurber, più famoso come vignettista del New Yorker. Un ometto insignificante che accompagna sua moglie a fare shopping e inganna il tempo immaginandosi al centro di scene d'azione che rivelano una fantasia già dominata da stereotipi cinematografici: ufficiale di marina durante una tempesta, chirurgo di fama mondiale, imputato di omicidio, pilota della RAF, condannato per fucilazione. L'intreccio è esile, ma le potenzialità sono immense, così il solito Samuel Goldwyn ne acquista i diritti.
Il film che esce dieci anni dopo è già completamente diverso dal racconto: ora Walter è uno scapolo svagato ma di bell'aspetto (Danny Kaye) che dopo qualche dubbio pirandelliano scopre che il complicato intreccio noir intorno a lui non è un sogno nutrito dai giornaletti pulp, ma è la realtà: compresa la bionda Virginia Mayo che sta cercando di salvare i gioielli della corona olandese eccetera. In sostanza è come se avessero comprato i diritti della metamorfosi di Kafka per girare un thriller sull'uomo scarafaggio. Thurber si è già dissociato, ma il suo Mitty ormai è patrimonio dell'umanità: nel '52 George Axelrod lo ribattezza Richard Sherman e gli scrive attorno la commedia The Seven Year Itch, la crisi del settimo anno: noi però lo conosciamo col nome italiano del film di Wilder che uscirà qualche anno più tardi, Quando la moglie è in vacanza, con Marilyn Monroe che combatte l'afa in quei modi originali. Probabilmente Sherman è il personaggio più simile al Mitty originale: non un giovane pronto a lanciarsi all'avventura, bensì un quarantenne esposto all'Itch, il prurito che ti coglie quando ti rendi conto che la tua vita ha preso una forma precisa, e che ormai sarà sempre più difficile voltarti, provare un'altra posizione, anche solo per curiosità - ecco, proprio in quel momento qualcosa che se ne stava buono da anni comincia a prudere. Gli ometti di Thurber erano spesso disegnati alla mercé di donne immense, che ad altre longitudini li avrebbero aspettati a casa con il mattarello.
Il Mitty tipico della mia generazione invece è Zach Braff quando in Scrubs alzava gli occhi in quell'espressione estatica... (continua su +eventi!) Anche il figlio di Samuel Goldwyn, indovinate, Samuel Goldwyn Jr, a metà anni Novanta pensava a un Mitty più giovane, visto che lo immaginava tagliato su Jim Carrey. È curioso che Mitty esca nelle sale assieme alla Regina delle Nevi (o a quel che resta di lei): sono due progetti che rimbalzano da quasi vent’anni – per Mitty furono coinvolti a turno Ron Howard, Spielberg, Owen Wilson, Sacha Cohen – e in entrambi casi il problema era lo stesso: la storia. Non funzionava mai, e così registi e attori venivano risucchiati da qualche altro soggetto meglio definito. Accantonato l’intreccio pulp del vecchio film, Mitty non riusciva a diventare il personaggio di una storia tutta sua. Tre anni fa Ben Stiller entra nel progetto come attore; in seguito ne diventa anche il regista, e forse è in quel momento che il film ha preso la svolta che lo ha reso in qualche modo possibile. Il risultato che è uscito nelle sale sembra un compromesso, un po’ faticoso ma riuscito, tra un film di Ben Stiller attore, con numeri fracassoni che si richiamano al genere delle parodie demenziali, e un film di Ben Stiller regista. Quest’ultimo è un professionista meno demenziale di quanto potremmo ricordarci: ha esordito tantissimo tempo fa, con Reality bites (Giovani, carini e disoccupati), è stato il primo a intravedere il potenziale drammatico nelle smorfie di Jim Carrey (The Cable Guy) e poi ha girato soltanto altri due film, molto divertenti ma decisamente sopra la media della commedia ridanciana per famiglie (Zoolander e Tropic Thunder).
Il suo Mitty sembra un Frankenstein ottenuto ricucendo due script nel tentativo di ridurre al minimo i dani. Nella prima mezz’ora è il Ben Stiller che piace ai bambini di ogni età, quello da Notte nel museo, a cui grazie agli effetti digitali succedono cose assurde e buffissime che però stavolta non sono mai davvero divertenti; è come se uscissero dal cilindro di un prestigiatore in una giornata no. Aggiungi che il dilagare dei “movie movie” ci ha un po’ resi diffidenti verso gli sketch parodici. A un certo punto il film salta su un binario diverso e nel secondo tempo Mitty ha praticamente smesso di sognare a occhi aperti: non se lo può più permettere. Sta girando il mondo alla caccia di un fotoreporter vecchia scuola (Sean Penn che si prende in giro da solo, almeno io spero che ci sia molta autoironia). Ogni tanto il primo film fa capolino con intermezzi assurdi, squali e risse aeroportuali; addirittura prende le forme di un nerd di Los Angeles che riesce a trovarti al telefono anche sull’Himalaya. Il secondo film nel frattempo non è che abbia scelto la via più originale: il cattivo è ancora una volta il responsabile risorse umane che deve curare una fusione aziendale (=cacciare un sacco di gente con la scatola di cartone). Però almeno la storia è ambientata in un’azienda vera, anche se re-inventata da capo a piedi: la redazione di Life, nel momento in cui interrompe l’edizione cartacea per trasferirsi su internet (anche lì sarebbe durata poco). È l’occasione per sciogliere un’elegia fuori tempo massimo al bel passato analogico, le foto da sviluppare in camera oscura, i telegrammi, i trentatré giri eccetera. Se non si è capito, stiamo parlando di quarantenni che cominciano a sentire quei pruriti imprudenti e tirano giù dal solaio i vecchi skateboard, le magliette dei Buzzcocks, i piani per un Interrail mai fatto. Se il vostro partner rientra anche solo vagamente nel quadro, tenetelo lontano da questo Walter Mitty: è pericoloso. Anche i ragazzini che si aspettano il Ben Stiller buffo potrebbero restare un po’ delusi. Altri meno giovani saranno felici di rivedere Shirley MacLaine, ti voglio bene Shirley MacLaine.
Non so a che categoria appartenesse il tizio che sedeva alla mia destra. Non ha taciuto per metà film. A un certo punto nel terso cielo d’Islanda sono comparsi stormi d’uccelli. “Vedrai che adesso disegnano la faccia della ragazza”, ha detto lui. Due secondi dopo il volto di Kristen Wiig sorrideva sullo schermo. Mi è caduta la mascella sotto la poltrona – dopo un anno di recensioni per i pregevoli cinema di Cuneo pensavo di essere diventato un po’ più esperto, e invece prendo ancora lezioni dal primo spettatore natalizio che incontro. Ne devo mangiare di popcorn.
I segreti di Walter Mitty è al Cityplex di Alba (20:00 22:15); al Cinelandia di Borgo S. Dalmazzo (15:10, 17:40, 20:10, 22:40); al Multisala Impero di Bra (16:10, 20:20, 22:30); ai Portici di Fossano (18:30, 20:30, 22:30).
Pimp My Francis Scott Fitzgerald
17-05-2013, 12:42Americana, anglistica, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, provinciaPermalink|
Ciao, sono tornato. Cioè, non me ne sono mai veramente andato via |
Giulietta Capuleti, se proprio volete la verità, non si è mica uccisa. Nel director's cut inedito ha dato retta ai genitori, si è sposata il suo pezzo grosso di Verona Beach e adesso ha tre bambini, un conto offshore e una terza abbondante mastoplatica - sta già cominciando a stirarsi le rughe. Anche Romeo non si è ucciso, ha solo messo un po' di chili. Ha fatto la guerra, il giro del mondo in barca a vela, un semestre a Oxford e tante altre cose, non tutte legali. Ma è ancora lui, è il Romeo di Baz Luhrmann: si innamora al volo, e ogni volta è per sempre. Tanto carino e ombroso, eppur gioviale e alla mano, però ogni tanto gli scappa la pazienza e capisci che potrebbe ammazzare qualcuno. Ha sicuramente ammazzato qualcuno. Probabilmente il modo migliore per apprezzare il Grande Gatsby 3D è prenderlo per il sequel di quel vecchio Romeo+Juliet che ci fece conoscere sia Luhrmann che Di Caprio. Eravamo tutti molto più giovani, tranne il testo di Shakespeare. Quello era già stato condito in tutte le salse, Bernstein ci aveva già musicato West Side Story, cosa ci si poteva aspettare di più? Lo abbiamo scoperto allora, cosa aspettarci da Luhrmann: più tutto. Il cielo stellato a Luhrmann non basta, lui nel firmamento come minimo ci vuole la nebulosa di Andromeda ingrandita un milione di volte. Non c'è un pedale che abbia mai premuto con cautela, lui sa solo schiacciare a tavoletta: più luce, più colore, più melodramma, più baraccone, più canzoni, più buffoneria, più divismo, ma anche più aderenza al testo. Luhrmann lo tradiva meno di Zeffirelli, con la sua Verona toscaneggiante e le sue calzamaglie improbabili. Perché in fondo poi cos'è Romeo e Giulietta se non una storia di tamarri che si sfottono fino alle estreme conseguenze, e allora forse è giusto affidarsi a Luhrmann che è il più tamarro di tutti. Non che Zeffirelli sia la damina inglese che vorrebbe essere, eh; ma Luhrmann è di più. Più grosso. Più luccicante, più rumoroso. Luhrmann è uno che ti pimpa di brutto, Baz, mi è piaciuto come hai pimpato Shakespeare, perché non ti cimenti con qualche capolavoro della letteratura americana del Novecento? Non tirarti indietro, Baz, pimpami Francis Scott Fitzgerald!
Il Grande Gatsby è un film che va visto in 3d, mai mi sarei immaginato di scrivere una cosa del genere. Ma forse non avevo mai visto un vero 3d. Quello di Luhrmann fa impallidire Iron Man: niente oggetti lanciati al pubblico, ma una girandola di fondali di cartone - all'inizio sembra un film di animazione - come un libro pop-up. Il Grande Gatsby 3d è, in effetti, un libro pop-up, come quelli che si comprano ai bambini che non sanno ancora leggere per stupirli con i personaggi di cartone che spuntano fuori dalla pagina appena la apri. Fitzgerald scrive: "automobile", Luhrmann te la fa spuntare dallo schermo, lucida come un giocattolino appena uscito dal negozio. Scrive "luce verde", e lui ti mostra la luce verde, cinque, sei, venticinque volte, nessun bambino analfabeta deve perdersi la pregnanza della metafora. Anche l'insegna con gli occhiali, si è capito cosa rappresentano gli occhiali? Volete che ve la mostri un'altra volta? Non c'è problema (continua su +eventi!)
Baz una sua idea ce l'ha. Scordatevi tutto quello che avete imparato nella classe di letteratura. Scordatevi il libretto che leggevate al liceo per darvi un tono. Scrostate la superficie, le frasette ben tornite. Soprattutto dimenticatevi tutti i cataloghi sugli anni Venti messi assieme in seguito da stilisti e trovarobe, tutta roba che si è incrostata su un libro di scarso successo man mano che diventava un feticcio culturale e finiva nei programmi scolastici. Scordatevi i maglioncini di Redford e gli sbuffi di Mia Farrow, perché è a quello che pensate il più delle volte che fate finta di pensare a Scott Fitzgerald. E ogni volta scivolate senza accorgervene dal West all'East Egg perché è da là che vorreste venire, non dal quartiere dei truzzi midwest in odor di camorra. Ma guardate meglio: non vedete? Gatsby era un tamarro, e lo siete anche voi. Cosa c'è di più tamarro, arcaico e tribale del suo potlach per amore, cosa c'è di meno elegante e più scemo di caracollarsi a Manhattan in macchina nel solleone, chiudersi in una suite al Plaza e pretendere di comprarsi non solo il tuo amore, ma anche il tuo passato. Gatsby, Nick, Daisy, Tom, sono tutte falene impazzite del midwest che corrono verso le luci della città senza sapere come ci si comporta. Come il loro creatore, Scott di Saint Paul, Minnesota. Non esattamente quell'arbiter elegantiarum che col tempo ci siamo immaginati che fosse (e anche lui, del resto, all'inizio Gatsby lo aveva chiamato Trimalcione). Aveva gusti discutibili: vedi l'entusiasmo per la brutta copertina originale, che nelle edizioni anglosassoni è diventata un elemento paratestuale obbligatorio: tanto che l'idea che qualche editore la voglia sostituire con una copertina ispirata al film, magari una foto di Di Caprio, desta scandalo in molti lettori. Luhrmann se la ride: a vedere il suo baraccone anni Venti verranno tutti comunque. I bambini e gli analfabeti faranno "ooh" per tutto il primo tempo, con la gioia di chi si imbosca a una festa. Gli intellettuali noteranno la lungaggine della seconda parte, quando le munizioni a coriandoli sono tutte sparate e l'energia orgiastica cede il passo alla fatica di dover comunque raccontare una storia.
Ma ci terranno lo stesso a vederlo fino alla fine, per assicurarsi che il libro era meglio, proprio come i lettori dei fumetti di Iron Man che sedevano nella stessa poltrona, con gli stessi occhialini, una settimana prima. The Great Gatsby forse non vi piacerà, ma vi piacerete da soli mentre lo stroncherete. È una tamarrata galattica, è pimp my Scott Fitzgerald, è Baz Luhrmann in tutto il suo splendore di cartone, e Leonardo Di Caprio è la migliore sagoma che gli sia mai capitata tra le mani (ma anche Maguire e Carey Mulligan, citiamoli, sono cartonati perfetti).
Il Grande Gatsby 3d è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo alle 19:50 e alle 22:40, e al Multisala Impero di Bra alle 21:30. La versione in 2d è presente in molti altre sale in provincia e persino a Cuneo, ma secondo me vale la pena di vederlo in 3d.
1980: Fuga dal pianeta dei barbuti
01-03-2013, 12:07Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, medio orientePermalinkTeheran, 1980; durante l'assalto all'ambasciata americana, sei diplomatici escono dalla porta di servizio e si nascondono all'ambasciata canadese. Per riportarli a casa l'agente CIA Tony Mendez escogita la copertura più assurda della storia dell'agenzia: si finge il produttore di un film di fantascienza, in cerca di location orientaleggianti. La beviamo? Il problema con Argo è un po' questo perché, come capita a molte storie vere, è abbastanza inverosimile. Girare un film di fantascienza a Teheran durante la crisi degli ostaggi, con le barbute Guardie della Rivoluzione in giro a caccia di occidentali? Eppure dicono che andò proprio così, le Guardie se la bevvero e non si accorsero che i sei accompagnatori dell'agente Mendez non erano registi fotografi e sceneggiatori, ma sei diplomatici in fuga.
 |
| La locandina finta (del 2012) del film finto (del 1980) |
 |
| Una locandina finta del 2012 del film vero del 2012. |
 |
| Poster vero (2012) del film vero (2012). |
La squadra messa in piedi da Mendez, con un produttore ignorante e sboccato e il truccatore del Pianeta delle scimmie (John Goodman, gli vuoi subito bene) assomiglia più a una gang di soliti ignoti che a una cellula della CIA. Allo stesso tempo, è anche un film meno manicheo di Zero, probabilmente per l'impostazione un po' liberal, da nuova Hollywood, dei produttori (c'è anche George Clooney): il film chiarisce subito, nel preambolo, che prima dei cattivoni barbuti c'era un figlio di puttana sostenuto da Washington, Reza Pahlevi. Lo ribadiscono ogni tanto lungo il film gli agenti della Cia, molto più cinici e umani dei gelidi quadri di Zero. Nonostante questo il film è stato criticato per il modo in cui descrive tutti gli iraniani come fanatici barbuti. Eppure pare che in Iran vada fortissimo, non solo al mercato clandestino dei DVD: lo proiettano nei cinema di nascosto. Del resto se avete almeno visto Persepolis (scritto e disegnato da una testimone diretta) l'onnipresenza minacciosa delle Guardie della Rivoluzione non vi stupirà più di tanto. Senza dubbio il film calca la mano, si inventa un quasi-linciaggio al Bazar che non c'è mai stato: ma che una finta troupe canadese potesse essere circondata da iraniani incattiviti, non guardie della rivoluzione, ma parenti di vittime delle torture di Pahlevi, non è così inverosimile.
Eppure non è vero: e sostituire il verosimile al vero è un'operazione delicata. Argo e Zero hanno questo in comune: romanzano un eclatante fatto della Storia recente, mantenendo però un registro così realistico che rischiano di sostituirsi alla Storia, più che descriverla. Per esempio: Argo trasforma un'operazione in gran parte congegnata dall'intelligence canadese in una missione CIA, che poi sembra quasi l'iniziativa di un agente solitario, Mendez: non è andata affatto così. Anche gli inglesi ci fanno un'immeritata brutta figura (non è vero che respinsero i sei fuggitivi, se li passarono ai canadesi fu perché ritenevano la loro ambasciata più sicura). Il colpo di scena che movimenta l'ultima mezz'ora è del tutto inventato, l'operazione filò molto più liscia e non ci fu nessun inseguimento all'aeroporto. Dove il film si tradisce è probabilmente nella sua ossessione per la simultaneità, poco plausibile nel 1980. Per dire, ci sono televisori dappertutto, in cucina, in bagno, dappertutto: sono scatoloni ingombranti, ma stanno dove oggi starebbero tablet e notebook. Affleck e compagnia fanno il possibile per recuperare il sapore analogico dei file cartacei, delle telefonate criptate, ecc.; ma a un certo punto vogliono farci credere che bastassero pochi secondi da Washington per prenotare un aereo a Teheran: faccia refresh, dice Mendez all'addetta all'imbarco, vedrà che la prenotazione c'è. Un refresh nel 1980. In realtà i biglietti li avevano comprati i canadesi, molto per tempo (bellissima l'immagine dei bambini iraniani che ricompongono i documenti tritati in ambasciata, strisciolina dopo strisciolina: hacker analogici, l'immagine del mondo non è ancora stata convertita in pixel ma ormai i tempi sono maturi).
 |
| Poster vero (1980) del film finto (1980). |
Argo è in programmazione al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (ore 20.00 e 22.30) e al Cinecittà di Savigliano (ore 22.30). Buona visione.
Il Grande Osama Bianco
08-02-2013, 11:32Afganistan, Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, guerra, terrorismoPermalinkZero Dark Thirty è un film unico nel suo genere: l'autobiografia di un personaggio vivente che forse non conosceremo mai. Nel film si chiama Maya ed è l'agente della CIA che ha passato quasi dieci anni a cercare Bin Laden, finché non l'ha trovato (forse) e l'ha fatto ammazzare (così dicono, ma perché hanno buttato il corpo in mare immediatamente? E perché non hanno divulgato al pubblico nemmeno una foto? Vabbe', storia vecchia, parliamo del film).
C'è stato un momento - non posso dire quale - in cui guardando il film della Bigelow mi sono accorto che stavo tifando per i cattivi, i malvagi terroristi islamici. È stato un solo momento, comunque imbarazzante. Il punto è che dopo un'oretta nei corridoi della CIA, trascorsa a guardare dei professionisti seri e poco empatici alle prese con procedure standard che prevedono la tortura di alcuni mentecatti, quando finalmente un mentecatto riesce a organizzare un tranello e ammazzarne un po', ti viene spontaneo pensare qualcosa del tipo toh, beccatevi questa yankees, chissà se succede a tutti. Probabilmente no. Zero Dark Thirty è un film ambiguo, il che andrebbe benissimo, se fosse un sistema per disorientare lo spettatore e costringerlo a rivedere le sue opinioni. Da quel che ho letto in giro però non mi pare che le cose siano andate così: ognuno ha semplicemente pescato nell'ambiguità del film quello che serviva a sostenere la propria tesi preconfezionata. Per aver mostrato semplicemente come funzionavano gli interrogatori dei prigionieri (waterboarding, musica ad alto volume ecc.), la Bigelow è stata accusata di apologia di tortura. Per Michael Moore invece il film sarebbe la dimostrazione che la tortura è inefficace, infatti Bin Laden viene trovato soltanto dopo che Obama la proibisce (ma l'inchiesta era partita molto prima, dalla soffiata di un tizio sottoposto a waterboarding...) Per Andrew Sullivan è addirittura un atto di accusa ai criminali che governavano nel 2002 (quando Sullivan li sosteneva), ma in fondo è inutile porsi il problema di quel che pensa Sullivan, tra qualche anno avrà cambiato di nuovo idea. Se però uno spettatore medio entra convinto che la tortura possa essere necessaria per prevenire stragi come quella dell'11/9, non sarà Zero Dark Thirty a fargli cambiare idea: il film a un certo livello di lettura sembra proprio dire che Bin Laden è stato trovato anche grazie al waterboarding.
Se ne parli con un cinefilo puro ti dirà che è un film, soltanto un film: mostra cose che semplicemente sono successe, e lo fa molto bene. La sequenza dell'attacco al compound di Abbottabad è senz'altro lo stato dell'arte del film di guerra nel 2012: tra cinquant'anni guarderemo ancora Zero Dark Thirty se vorremo sapere come era fatta la guerra ai nostri tempi. Purtroppo era una cosa molto noiosa, con elicotteri invisibili e occhiali infrarossi da una parte e kalashnikov impolverati dall'altra, un lunghissimo estenuante match di nervi tra Juventus e Nocerina di cui peraltro conosci già il risultato finale. E i giocatori della Nocerina sono brutti, sporchi, fanatici. Ciononostante, quando fanno almeno un gol... (continua su +eventi!) mi è venuto da alzare il pugno, ma è un problema credo solo mio.
Forse ha ragione chi sostiene che la Bigelow è diventata una specie di regista embedded. Dopo il successo di The Hurt Locker (premio Oscar alla faccia blu dell'Avatar dell'ex marito Cameron) si è subito rimessa a scrivere un altro film di guerra vera, non videogiocata: all'inizio doveva raccontare la battaglia di Tora Bora (in cui Bin Laden non veniva trovato), poi la scoperta del vero nascondiglio dello sceicco del terrore l'ha portata a riscrivere la sceneggiatura in corsa. Film del genere sono interessanti e persino necessari, però per girarli devi avere dei contatti nell'esercito, forse anche nell'Agenzia - ed è gente preparata, magari non sono bravissimi a trovare Bin Laden, ma è indubbio che ai registi la sappiano raccontare. I giornalisti embedded sono inquadrati nell'esercito senza la possibilità di vedere le cose dal di fuori: non c'è scelta, l'unico modo di vedere la guerra è assumere il punto di vista di chi la fa. Allo stesso modo la Bigelow non può permettersi di mettere in dubbio la sua fonte. Col tempo forse scatta anche una specie di sindrome di Stoccolma: a forza di stare in mezzo ai soldati (o agli agenti CIA) non puoi che sviluppare un po' di simpatia per questi uomini rudi, per queste donne tutte d'un pezzo che lottano contro mille avversità per uno scopo, e se torturano qualche talebano nelle gabbie lo fanno comunque con professionalità e senza partecipazione emotiva, figurati, poi si sfogano vezzeggiando le scimmiette nella gabbia più piccola. Per la verità, da quel poco che sappiamo, i carcerieri sadici (e le carceriere) non sono affatto mancati; però la Bigelow non ce li mostra, non ha tempo. Deve raccontarci la storia di Maya, piccola grande Maya, che sola contro tutti e contro tutto riesce a trovare Bin Laden e poi - siccome ai suoi superiori alla fine sembra che non interessi più di tanto questo Bin Laden - pianta una grana infinita finché Obama non si decide a farlo ammazzare.
Maya, ha osservato qualcuno, a suo modo non è meno fanatica dei tizi che vuole eliminare. Sotto ai capelli rossi di Jessica Chastain (bravissima) è ancora e sempre il capitano Achab che non si darà pace finché la Balena Bianca non sarà catturata, e con la Balena tutto il dolore e tutto il terrorismo del mondo. Non ha un passato e, una volta liquidata la Balena, nemmeno un futuro; non si capisce nemmeno come possa far carriera, visto che l'unica cosa che ammette di saper fare è dare la caccia a Bin Laden, con risultati (per i primi nove anni) piuttosto frustranti. In un qualche modo, comunque, i compagni la rispettano e i superiori la temono, e lei va dritta per la sua strada finché la Storia non le dà ragione. Quella che vuole raccontarci la Bigelow, per sua stessa ammissione, è la success story di una persona che non tradisce la sua fede. "Tutti noi come esseri umani possiamo identificarci con il credere in qualcosa - crederci così tanto che non rimane nient'altro nella nostra vita" (tutti? Sul serio?) La narrazione americana procede per success stories: anche la biografia complessa di Lincoln deve essere bignamizzata da Spielberg in un singolo episodio in cui lui deve avere ragione e tutti gli altri torto, a onta di tante altre situazioni in cui gli altri acceleravano e lui frenava, e del chiaroscuro degli eventi precedenti e successivi. Alla fine della fiera Zero racconta la stessa storia dei film di ballerini da talent: devi credere fortissimo nel tuo successo finché si autoavvera; tutti i falliti che ti scorrono attorno non ci hanno creduto abbastanza forte.
Per una Maya testarda che cerca Bin Laden e alla fine incoccia nella pista giusta, chissà quanti agenti hanno continuato a brancolare per dieci anni nel buio, leggendo e rileggendo verbali di interrogatori tradotti alla carlona, bevendo caffè e mangiando ciambelle a spese del contribuente senza cavarci un ragno dal buco - ma la Bigelow ci mostra solo Maya, quell'una su mille che ce l'ha fatta. E ci mostra il mondo con gli occhi di Maya: un luogo pieno di maschi lenti che non vogliono convincersi che Maya ha ragione. Neanche quando un superiore glielo dice chiaro e tondo: Bin Laden è morto, o comunque chissenefrega di Bin Laden, il terrorismo è ovunque, le cellule si scambiano informazioni via internet... Maya non capisce, non può. Nemmeno per un istante l'attraversa il dubbio di essere una semplice pedina: trova intollerabile che una volta rintracciato il compound i dirigenti esitino a fiocinare la Balena. L'unica spiegazione che riesce a darsi (ed è l'unica che ci offre la Bigelow) e che vogliano essere assolutamente sicuri che quello sia proprio Bin Laden e non, poniamo, un trafficante di droga: sono rimasti traumatizzati dalla figuraccia di Colin Powell che mostrava delle foto di camion alle Nazioni Unite spergiurando di aver trovato le Armi di Distruzione di Massa in Iraq. Nemmeno il dubbio che ai piani alti non preferissero tenersi un Bin Laden anziano, stanco, tracciato, piuttosto di farlo fuori a rischio di scatenare rappresaglie e una prevedibile gara tra i successori per conquistarsi sul campo la carica di "Numero uno di Al Qaida". Nemmeno il sospetto che l'ordine finale non sia dovuto all'esasperazione di un direttore che non ne può più di vedersi Maya tutte le mattine che tiene il conto dei giorni col pennarello, ma a un presidente che magari comincia a pensare alla campagna per la rielezione. Niente. Un pezzo grosso saudita offre un'informazione fondamentale? Sarà senz'altro perché gli hanno offerto una Lamborghini, i sauditi sono tutti bambinoni viziati. Così almeno le fonti governative devono averla raccontata alla Bigelow, ma potrebbe anche essere andata diversamente: qualche pezzo grosso saudita potrebbe aver deciso che era il momento politico adatto per mollare l'osso, e la Lamborghini potrebbe essere stato un semplice lubrificante di una trattativa più complessa. Non è che ci voglia molto per farsi venire il dubbio, ma la Bigelow non sembra nutrirne, né ha l'aria di credere che ne debbano nutrire i suoi spettatori.
Solo in un fotogramma l'arcigna Maya si scioglie in un sorriso: quando un soldato, in attimo di relax alla vigilia della battaglia, ammette con un commilitone di essere convinto che Bin Laden c'è, soltanto perché ci crede lei, Maya, e in Maya lui confida. Lì tutto il femminismo della Bigelow si stacca come una concrezione calcarea, e sotto riusciamo a vedere ancora la fanciulla medievale che gode nel vedere il cavaliere pronto a morire per lei. Perlomeno io l'ho vista, ma forse è solo un problema mio eccetera.
Zero Dark Thirty è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (ore 21). Buona visione.
Un Lincoln quasi Obama
24-01-2013, 19:36Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, elezioni 2013, fb2020, ObamaPermalink"La bussola ti indica il nord, ma non ti mostra dove sono le paludi", dice più o meno Abraham Lincoln al leader radicale Thaddeus Stevens durante uno dei dialoghi che scandiscono il film. La frase sembra fatta apposta per essere citata, linkata, twittata all'infinito da un certo pubblico che temo sia quello che soprattutto Spielberg aveva in mente (dico "temo" perché ahimè, ne faccio parte): i progressisti moderati, liberal ma non troppo. Quelli che si incazzano con gli amici che votano Ingroia anche se su tanti argomenti starebbero molto più a sinistra di quanto starà mai qualsiasi Ingroia: la nostra bussola indica quel Nord, ma noi abbiamo anche una carta del territorio e sappiamo che in mezzo c'è un'enorme palude e che forse toccherà passare da Sud, attraversando Monti, forse addirittura Casini. Sono cose che succedono e ci fanno vergognare, ma di cosa, poi? Di avere cartine aggiornate?
Spielberg, come il migliore cinema americano, ha la bussola e ha la cartina: non dimentica il nobile ideale a cui tendere (l'abolizione della schiavitù) ma non si sottrae alla complessità del reale (bisogna comprar voti al Congresso uno scilipoti alla volta), anzi ci si tuffa con passione, restituendo agli spettatori una sintesi affascinante anche se, nel caso di Lincoln, più utile a discutere il presente che il passato a cui fa riferimento. Questo è un altro tratto tipico di Spielberg: se la Guerra dei Mondi parlava dell'11 settembre, Minority Report del Patriot Act, Lincoln potrebbe essere definito il primo biopic su Barack Obama. Tony Kushner, lo sceneggiatore di Angels in America e Munich, ha lavorato per più di tre anni, leggendosi scaffali di libri sul personaggio, per poi uscirsene con uno script in cui la first lady e la sua sarta nera (personaggio storico) assistono alle sedute del Congresso, una circostanza veramente poco probabile a metà Ottocento. Di fronte a invenzioni come queste, tanto più sleali quanto più il film sembra garantire la solita precisione filologica spielberghiana di Schindler's o del Soldato Ryan, il regista non ha trovato di meglio che affermare che una ricostruzione come Lincoln è da considerarsi "un sogno". La Storia americana ci mette gli arredi e i costumi, ma sotto barbette e giacche blu i protagonisti siamo sempre noi, sognanti noi stessi. All'inizio del film un pugno di soldati yankee bianchi e neri imbarazza Lincoln recitando un suo celebre discorso a memoria. Gli storici storcono il naso, i soldati della Guerra di Secessione erano perlopiù analfabeti ed è improbabile che cercassero sui giornali testi di discorsi scritti in piccolo per impararli nelle trincee, come i fans di Obama che li trovano su youtube. Ma nel sogno accadono queste cose: che i discorsi schiudano le porte e spezzino le catene, e che i cittadini le imparino a memoria per motivarsi mentre scannano i ribelli. Più tardi il film darà l'impressione di credere che un buon discorso a quattr'occhi di Abe "l'onesto" Lincoln a un deputato avversario possa riuscire dove non riesce l'offerta di incarichi e prebende. La parola è più forte della corruzione. Ci crediamo?
Gli americani ci credono, tanto che spesso si fanno governare dagli avvocati: dateci un podio, fateci leggere un’arringa, dicono gli avvocati Abe e Barack, e vi solleveremo il mondo (il fatto che sia Abe che Barack siano stati anche comandanti in capo, e il mondo lo abbiano cambiato più coi cannoni e i droni che con le chiacchiere, scivola in secondo piano). È una cosa di cui ci accorgiamo ogni volta che Obama fa un discorso ufficiale – qualche giorno fa per esempio ha giurato su un paio di bibbie per il re-insediamento, una formalità. Negli USA è anche uno spettacolo, Beyoncé ha cantato l’inno e tutti si sono arrabbiati perché era in playback, ma non è questo il punto. Il punto è che milioni di persone negli USA, nel mondo, persino in Italia, sono pronti a dare a un discorso formale un senso politico: c’è una diffusa convinzione che Obama cambi il mondo con le parole che dice, più con i droni che comanda. Alcuni si lamentano che in Italia non funzioni così: perché i nostri politici non fanno discorsi altrettanto belli e importanti? Tanto vale chiedersi perché non friggiamo il bacon e il baseball ci annoia, comunque dipende da fattori storici: la centralità del sermone nella cultura protestante, la diffidenza italiana per la retorica da cui il fascismo dovrebbe averci vaccinato, ma anche la difficoltà dell’italiano medio a mantenere l’attenzione per più di tre minuti, per cui delle infinite dirette di Santoro o Floris nelle conversazioni del giorno dopo resistono solo due o tre scambi di battute estemporanee.
Temo che uno spettatore italiano possa avere qualche difficoltà a capire cosa succede in Lincoln, un film dove Spielberg dà per scontate veramente troppe cose sul personaggio, il che non è da lui. A scuola non lo studiamo molto, gli anni intorno al 1860 sono già fin troppo ricchi di date e battaglie e trattati da memorizzare; già ci rammentiamo a malapena che i grigi sono gli schiavisti e i blu sono i buoni; ma il fatto per esempio che i Repubblicani siano per l’abolizione della schiavitù e i Democratici contrari ci fa girare la testa, sembra un mondo alla rovescia. Secondo una tendenza dei biopic moderni, il film preferisce concentrarsi su un periodo molto ristretto della vita del protagonista. Il risultato lo fa assomigliare, più che a un bell’affresco spielberghiano, al pilota di una miniserie televisiva di lusso, o se preferite a una season finale di West Wing in costume. L’episodio descritto risulta probabilmente sopravvalutato rispetto al contesto: si tratta della battaglia congressuale per far passare il Tredicesimo Emendamento, che abolisce formalmente la schiavitù su tutto il territorio dell’Unione. Se non fosse passato, gli Stati del Sud riammessi dopo la sconfitta avrebbero potuto reclamare gli schiavi che si erano emancipati durante la guerra, compresi quelli che avevano combattuto per anni con la giacca blu. Così almeno la pensa Lincoln, che come ogni politico è molto bravo a convincerci che la prossima battaglia è quella definitiva, quella più importante, quella da cui dipende il destino delle future generazioni. Gli storici sono un po’ più scettici: all’abolizione si sarebbe anche arrivati in altri modi, non è detto che il decisionismo di Lincoln (in altri casi molto più prudente) sia stato il metodo migliore. Ma questo comunque è il Nord che la bussola addita a Lincoln per tutto il film, mentre si destreggia nelle paludi del Campidoglio proprio come fa Obama quando scende a compromessi col demonio per far passare la riforma sanitaria o superare il Fiscal Cliff. Barack può stare sereno, Abe fece di peggio: mentre un suo pool di maneggioni corteggiava i senatori democratici a scadenza di mandato, lui si permise di allungare di qualche mese la guerra con un Sud in ginocchio per evitare che la pace cambiasse gli equilibri del Congresso, gravandosi la nobile coscienza di qualche migliaio di ragazzini morti in più. Ma se la tua bussola ti mostra il Nord giusto, non c’è palude che ti possa insozzare. In Italia diciamo semplicemente “il fine giustifica i mezzi”, e non ci facciamo un film sopra: un po’ perché non siamo capaci di scrivere un procedurale, un po’ perché da noi i guerriglieri parlamentari sono visti con diffidenza, sia quando acquistano scilipoti un tanto al chilo sia quando si riducono a precettare senatori a vita in fin di vita. Un’altra cosa di cui diffidiamo sono i politici che si affidano troppo spesso alle battute, anche se quelle di Berlusconi non si possono neanche lontanamente paragonare alle storielle da avvocato messe in bocca allo straordinario Daniel Day-Lewis.
Ma insomma il film vuole farci pensare – il film ha un disperato bisogno di farci pensare – che un presidente che sappia quel che è giusto non deve risparmiarsi a ottenerlo da riottosi organismi democratici, anche con metodi ai limiti della decenza e della legalità (solo “ai limiti”: Lincoln tecnicamente non corrompe, offre solo incarichi federali; non mente al Congresso, racconta solo verità parziali). Siccome il film non parla d’altro (dieci secondi di battaglia, qualche grana famigliare tutto sommato dimenticabile), siamo autorizzati a pensare che la grandezza di Lincoln consista in questo suo machiavellismo etico. Non è vero: Lincoln è stato molto altro che il film ha deciso di non mostrarci. Un presidente di guerra, da principio recalcitrante, e poi determinato a intestarsi uno dei più sanguinosi massacri della storia dell’umanità, il primo conflitto industriale con le trincee, la dinamite e le armi a ripetizione. Ma Spielberg preferisce mostrarcelo sbigottito davanti alle fosse comuni, indeciso se graziare un disertore. Thaddeus Stevens, il memorabile personaggio interpretato da Tommy Lee Jones, può essere scambiato dallo spettatore inesperto per un radicale di ultraminoranza: viceversa, da esponente di spicco della corrente maggioritaria tra i Repubblicani, si stava avviando a diventare il “dittatore” del Congresso nei primi anni della ricostruzione post-bellica. Ricostruzione che fallì, platealmente, nel tentativo di trasformare di punto in bianco gli schiavi delle piantagioni in cittadini elettori, forse anche a causa del radicalismo con cui Stevens e i suoi colleghi la portarono avanti. Il tentativo di imporre l’uguaglianza con le baionette federali portò alla nascita del Ku Klux Klan e alle leggi segregazioniste che per un altro secolo fecero degli afroamericani dei cittadini di serie B. Una palude che né Stevens né Lincoln avevano previsto. I due personaggi, pur simpatici e interpretati al meglio, non hanno la profondità di un autentico machiavelli come Oskar Schindler, ed è un peccato, soprattutto per l’impegno che ci ha messo anche stavolta Daniel Day-Lewis. Il suo Lincoln rimane un bravo avvocato e un simpatico conferenziere, con una vita privata non semplice e una vita pubblica sfibrante: un uomo leale, astuto, amabile eccetera eccetera, il presidente che molti americani vorrebbero, e infatti ce l’hanno.
Lincoln stasera è al cinema Fiamma di Cuneo (ore 21); al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (21:10), al Multisala Vittoria di Bra (21:00), al Multilanghe di Dogliani (21:05), al Cinecittà di Savigliano (21:30). Dura due ore e mezza.
Il Siegfried Nero
18-01-2013, 09:54Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, razzismiPermalinkAlla vigilia della guerra Civile il dottor Schultz (un Christopher Waltz di nuovo divertentissimo) si aggira per il Sud praticando questo mestiere di recente invenzione, il cacciatore di taglie. Django è lo schiavo che ha liberato perché lo aiuti a identificare una banda di criminali. Ma Django (Jamie Foxx) non è un "negro" qualunque, uno come lui ne nasce una volta su diecimila. Ogni volta che lo buttano a terra, risorge in una versione più cool. Dopo l'orgia citazionista di Kill Bill in parecchi lo avevamo dato per perso, Quentin Tarantino, nella sua cineteca di vhs sbiadite: avrebbe frullato per sempre tutto quello che gli veniva in mente per un pubblico che comunque dimostrava di mandare giù qualunque cosa. Abbiamo dovuto ricrederci con Inglourious Basterds, dove il regista ha messo a punto il congegno che ritroviamo perfettamente oliato nella lunga parte centrale di questo film: un'estenuante trappola per gli spettatori, che in Django hanno ancora meno digressioni e siparietti per tirare il fiato - per salvare la sua principessa l'eroe scende in un inferno vero, un luogo dal quale non si risale senza aver venduto un po' d'anima, dove ci attende un luciferino Leonardo Di Caprio e il suo terribile schiavo-patrigno (Samuel L. Jackson, micidiale). Se in Basterds ci ritrovavamo per qualche minuto a vivere il dissidio e la vergogna di un padre di famiglia che per salvarsi tradisce gli ebrei che ha nascosto, in Django dobbiamo reggere la vista di fuggitivi sbranati senza tradire un sentimento. Tutto questo, per qualche strana alchimia che Tarantino ha raggiunto dopo anni in cui non sembrava nemmeno provarci, capita ai personaggi sullo schermo, ma capita anche a noi sulla poltrona. Siamo cavalieri senza paura ma con moltissime macchie, dobbiamo scegliere con chi stare e il più simpatico spara alle spalle di mestiere (continua su +eventi). Si scherza anche, si ride persino, ma sempre con la mano alla fondina e il dito sulla sicura.
Astensione in the UK
07-11-2012, 01:19Americana, astensionisti maledetti, cattiva politica, ObamaPermalink |
| Affluenza in the USA (magari se clicchi si ingrandisce, chissà) |
L'abitudine a caricare il non-voto di un significato politico, di attribuirgli una componente di protesta, o addirittura potenzialità eversive, per cui se tanta gente non votasse si aprirebbero senz'altro i sigilli di qualche apocalisse o palingenesi rivoluzionaria, è una delle tante scemenze che inquinano il dibattito politico italiano. Altrove l'astensione è così poco considerata che nemmeno ne parlano: per fare un esempio un po' cialtrone (scusate, sono un po' stanco), giusto stasera cercavo il dato sull'affluenza alle elezioni britanniche del '97 e sulla pagina wiki inglese non c'era. Non è una distrazione, la pagina è ben fatta. Secondo me è proprio che a un lettore britannico dell'astensione non frega più di tanto: è una curiosità, non ha nessun significato politico.
Quel famoso dato sulle britanniche del '97 mi interessava perché in questa settimana è scattato (in modo molto goffo all'inizio, ma pazienza) un dibattito su Tony Blair, sul senso che possa avere evocare Tony Blair quindici anni dopo in un contesto così diverso come l'Italia. È chiaro che per Renzi rifarsi a Blair implica tutta una serie di cose, alcune sensate altre meno; tra queste l'idea di conquistare gli elettori allo schieramento avverso, con una campagna fresca a base di messaggi propositivi e facce giovani ecc. ecc.; cosa che tutti gli riconoscono. Il problema è che, appunto, nessuno si ricorda più dell'astensionismo. Che in quell'occasione fu piuttosto alto. Insomma, Blair seppe convincere tanti indecisi, ma anche no.
Se uno poi va a vedere al numero crudo dei voti, scopre (se ho capito bene; ma sono un po' stanco) che il New Labour rispetto a quello Old di cinque anni prima ne guadagnò, sì, ma due milioni. Mica tanti. Quel che veramente fece la differenza è che i Tories ne persero cinque, di milioni. I liberaldemocratici persero poco meno di un milione... basta, il resto sono più o meno bruscolini. Quindi dove andarono tutti i voti persi? Astensione. Ora, non voglio dire che Blair non convinse tanti ex elettori di Thatcher col suo entusiasmo e la sua faccia fresca e la sua idea molto precisina su cosa fosse il Bene e su come fosse esecrabile (e bombardabile) il Male; quello fu senz'altro un fattore. Un altro fattore fu che molti ex elettori di Thatcher erano disgustati dal suo successore Major e non andarono semplicemente a votare. Secondo me vale la pena di ricordarlo. Buona notte e forza Obama.
La passione apocrifa di SJ
28-10-2011, 01:22Americana, Il Post, interfacce, internet, mitiPermalink
Sì, forse per capire come si parla di Jobs negli USA dovremmo partire da quel tipo di mitologia. Non è un caso che uno dei più grandi amici di Steve Jobs sia Larry Ellison, uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti, il numero uno di un'azienda ancora più grande di Apple, per certi aspetti, Oracle (che produce, per semplificare, database). Ellison è un altro trovatello che si fa dal nulla, e tra i due scoppia una vera e propria amicizia che con alterne vicende è durata per tutta la vita.
Due trovatelli in cima ad Apple e Oracle. Poteva succedere fuori dalla California?
Questa è una cosa che viene spesso trascurata. Almeno nel libro ho cercato di sottolineare che in quegli anni '70 la California, e in particolare quell'area geografica tra San Francisco e Los Angeles o più specificatamente la Silicon Valley, è un'area con delle caratteristiche peculiari che in un qualche modo predestinano l'esistenza di personaggi come Jobs. È un'area in cui, per volontà di un'università – Stanford – e di un complesso militare che pure è presente, si concentrano aziende di elettronica e di informatica. Le stesse scuole superiori offrono corsi di elettronica, e siamo alla fine degli anni '70! Jobs e il suo futuro socio Wozniak frequentano corsi di elettronica a scuola a cavallo tra '60 e '70: Wozniak vince premi per la costruzione fai da te di primi marchingegni elettronici. Se Jobs fosse nato in qualsiasi altro posto del mondo io sinceramente non so dirti se sarebbe diventato Mr Apple. So sicuramente dirti che quella è una zona su cui le occasioni e le possibilità sono tante. C'è una frase di Jobs che ho messo all'inizio del libro perché mi è parsa molto significativa: “Non esiste una “punizione” per aver fallito in questa Valle. Né economicamente, né psicologicamente. Nel senso che se hai un’idea e inizi la tua attività, anche se fallisci, sei considerato generalmente meglio di prima, per il semplice fatto che nel frattempo hai acquisito una serie di nozioni importanti in diverse discipline”.

Metto su Aquarius?
Fra qualche secondo... La Whole Earth Catalog nasce nel 1968 con un testo introduttivo celebre, che dà l'idea del clima che si stava respirando: in questo incipit, Stewart Brand scrive: “Siamo come Dei, e potremmo anche abituarci ad esserlo. Fino ad ora il potere e la gloria generati lontano da noi individui, e cioè attraverso il governo le grandi aziende, le istituzioni formali, la Chiesa, hanno avuto successo, ma adesso è l'individuo che deve creare in autonomia una propria strada”.
Sento già su di noi l'ombra gelida di Paulo Coelho.
Eh, sì, Coelho è di quella generazione, anche lui hippie, infanzia travagliata... l'ultima volta che l'ho visto intervistava Sean Parker (quello di Napster e Facebook) a cui chiese di commentare il film The Social Network.
Allora già che ci siamo parliamo dell'influsso orientale, del viaggio in India... Io ho sempre un certo pregiudizio verso questi personaggi che vanno in India in un periodo storico così particolare, cioè mi chiedo oggettivamente cosa potesse offrire l'India a questi occidentali, a parte diverse varietà e dosaggi di sostanze. Ho letto su Wired l'aneddoto di Steve Jobs che si lascia rasare i capelli da un guru, e lo stesso Jobs ammetteva di non aver la minima idea del perché l'avesse fatto. Insomma sempre quest'India surreale in cui accadono cose simpatiche e incomprensibili. Cosa tira fuori Jobs dall'India, secondo te?
Secondo me una delle lezioni di quel periodo è proprio la necessità di cercare la propria strada. Vuoi una frase ad effetto? Secondo me si sono saldati insieme il percorso alla ricerca di una “luce interiore” e la dottrina della predestinazione di matrice calvinista. Matura in Jobs una fede nelle grandi possibilità del singolo individuo di trovare la propria vocazione. Jobs vive questa ricerca in modo molto personale. Proprio nel periodo del viaggio in India l'adozione e la ricerca dei propri genitori naturali sembrano ossessionarlo, tanto da suggerirgli di assoldare un detective per cercarli.
Possiamo dire la banalità per cui Steve Jobs in India ha trovato la fede in sé stesso?
Sì. Jobs, nella prima biografia semiautorizzata descrive il suo viaggio a Micheal Moritz dicendo: “Non stavamo andando alla ricerca di un posto dove stare per un mese ed essere illuminati. Fu una delle prime volte in realtà in cui realizzai come probabilmente Thomas Edison avesse fatto molto di più per migliorare il mondo di quanto non avessero fatto Karl Marx e Neem Karoli Baba messi assieme.
Ecco, in India l'inventore capisce che deve concentrarsi sulle sue idee. Una cosa abbastanza calvinista, perché io per esempio nella mia mentalità veterocattolica se vado in India penso subito a Madre Teresa e ai poveri. È anche il motivo per cui mi passa anche la voglia di andarci... Invece quando Jobs e compagni si chiedono come possono aiutare i poveri del mondo, la loro risposta è: concentrandoci su noi stessi, arricchendoci finché la nostra ricchezza non avrà qualche ricaduta anche su di loro. Questo magari ci porta al discorso della Foxconn, che imbarazza particolarmente noi italiani, che avremmo tutti voglia di prostrarci e adorare Steve Jobs (perfino Sinistra e Libertà), però poi ci ricordiamo che è un capitano d'industria che fa lavorare gli operai cinesi a pochi centesimi l'ora, insomma uno schiavista.
Bisogna ovviamente dire che Apple non è l'unica azienda a utilizzare fornitori terzi in Cina. Molte altre aziende lo fanno: questo non giustifica Apple, ma mi domando cosa non giustifichi Apple, visto che la responsabilità ultima e prima di ciò che succede a Foxconn è di Foxconn. Dopodiché noi possiamo fare il passaggio ulteriore, cioè senza metterci le famose bistecche sugli occhi possiamo domandarci se è sostenibile da un punto di vista etico che Apple, punta di diamante di un certo sistema industriale, sia strutturata come tante altre aziende lasciando la testa pensante e progettante in California e le mani assemblanti in Cina; anche dal punto di vista di quella che viene chiamata sostenibilità d'impresa. Ecco, Apple ha fatto una serie di mosse per arginare quello che sicuramente è un problema oggettivo, quello dei suicidi alla Foxconn, un fornitore che non garantisce i diritti minimi: ma sinceramente allo stato attuale queste attività mi sembrano ancora poco convincenti. È una questione che dovremmo porci da un punto di vista squisitamente economico, ovvero: Apple esisterebbe se non esistesse un fornitore terzo di assemblaggio del tipo Foxconn, con quel che ne consegue a livello economico? Questo è una delle domande su cui si potrebbero fare ulteriori inchieste, e non sarei sicuro della risposta.
Certo, da noi in Italia pensare ai computer, neanche necessariamente Apple, è già una cosa progressista; poi però a un certo punto i progressisti si ricordano che in Cina i computer che ci liberano dall'ignoranza del regime televisivo li assemblano gli operai sfruttati e ci resta un dissidio interiore. Ma secondo me questo dissidio Steve Jobs non l'aveva, era fuori dalla sua prospettiva di vita. Per quel poco che lo conosco non credo che si sia mai posto il problema se la sua ricchezza, la sua capacità straordinaria di fare soldi su soldi si basasse o no sullo sfruttamento di qualcun altro. Non è che si rispondesse di no, secondo me è proprio che non si poneva il problema, non faceva parte del suo universo morale...
Trashmen didn't get my trash today
17-08-2010, 00:12Americana, cinema, jukebox '10, musicaPermalinkMy Own Private Obama
20-01-2009, 02:28Americana, migranti, ObamaPermalink Obama è uno specchio
Obama è uno specchioNoi, in realtà, di Obama sappiamo poco.
Ne sappiamo poco perché finora ha fatto poco; e anche quel poco che ha fatto ci interessava meno del mito che gli abbiamo costruito intorno.
A questo punto non ha nemmeno senso chiedersi chi Obama sia: ancora un po' di tempo e lo vedremo. Forse è più interessante domandarsi cosa abbiamo voluto che fosse fin qui.
Ora è facile osservare che in Obama ciascuno di noi ha visto più o meno quel che voleva vedere, con l'entusiasmo acritico del tifoso che cerca riscatto dopo anni di sconfitte della sua squadra. Come se Obama dovesse per forza giocare per noi. Ma sì: dava l'impressione di essere sempre dalla nostra. Qualunque cosa dicesse (ma poi cosa diceva in realtà? Boh).
Non c'è neanche bisogno di fare esempi, ma facciamoli: i trentenni di belle speranze esclusi dalla stanza dei bottoni lo hanno seguito come il Mosè della loro generazione attraverso il Mar Rosso del vecchiume; i baby-boomers già rincoglioniti ci hanno rivisto Kennedy pari-pari (esattamente come col giovane Clinton, 16 anni fa); i nerd hanno visto in lui il trionfo dell'aggregazione via internet; gli afroamericani lo hanno visto afroamericano; i liberal hanno voluto vederlo liberal; gli evangelici lo hanno visto evangelico; persino qualche musulmano sarà riuscito a vederlo musulmano; e così via.
Non spetta a me stabilire quale di queste proiezioni sia più o meno sballata dalle altre, né pronosticare chi taglierà per primo il traguardo della gara tra i delusi-da-Obama; mi limito a notare che finora ognuno di noi ha usato Obama più o meno come uno specchio – ma gli specchi presto o tardi deludono, per costituzione.
Voglio dire che Obama ci deluderà, perché non può corrispondere a ciascun nostro ideale – e se anche lo facesse, ogni nostro segreto ideale ha un lato oscuro, di cui ci accorgiamo soltanto le rare volte che lo vediamo realizzato.
Anch'io naturalmente mi sono fatto il mio Obama su misura. Non l'ho voluto troppo di sinistra, perché so che non reggerebbe la prova della realtà; non l'ho preteso filopalestinese, era troppo chiedere: se per una volta rifiutasse di usare il veto all'Onu sarebbe già un miracolo al di sopra delle mie aspettative. Si vede che invecchio, da quanto poco sono disposto a farmi illudere.
Non è un trentenne brillante, il mio Obama; non è un MLK più sexy, non giocherella con l'iphone, ma ha anche lui un suo dettaglio personalizzato. Il mio Obama è fondamentalmente un figlio d'immigrato.
Non è nemmeno il colore in questione, qui: è lo stesso colore di milioni di statunitensi da generazioni. Ma il padre di Obama era un keniota – e, pare, neanche il massimo dei padri.
L'Obama che mi porto a scuola oggi è un figlio di extracomunitari che viene accolto da una società multietnica senza una piega, e nel giro di una generazione porta un cognome buffissimo sulla targhetta dell'ufficio più famoso del mondo. Questo è quanto basta per creare una leggenda, e quel che conta ancor di più della leggenda: un precedente.
Potrà gasarvi un Presidente cool, vi elettrizzerà un presidente telematico, ma quello che cambia veramente per me sta semplicemente in quel cognome assurdo. Diversissimo e simile a tutti i cognomi assurdi che mi trovo intorno a scuola: cinesi, magrebini, rumeni. Nessuno di loro, per quanto sgobbone, diventerà Presidente. Ma oggi sanno che non è giusto. Questo è quello che Obama ha già insegnato a loro e a me. Ed è parecchio.
The Future's So Bright
05-11-2008, 17:41Americana, cattiva politica, l'era dell'ottimismo, Obama, VeltroniPermalink
Non è un Paese per Obama
Occorrerebbe essere musoni irriducibili per non essere contenti oggi, semplicemente, a prescindere da chi sia e da cosa farà di qui a due mesi questo Obama: intanto ha vinto, e un anno fa sembrava impossibile. Dico sempre che sarei felice di sbagliarmi: per una volta è davvero così. Sarà un grande presidente? Non è detto. Peraltro, non è nemmeno sicuro che l'America sia ancora la grande nazione di appena otto anni fa. Ma intanto Obama ha vinto. Essere razzisti, oggi, è ancora più cretino di quanto non lo fosse venti ore fa. Non basta questo, per essere contenti?
E questo ci deva bastare. Lasciamo perdere l'Italia, per una volta. Non perché non sia importante – ma oggi non c'entra quasi nulla. Ha ragione Cacciari: è patetico appicicare su Obama il simbolino di questo o quel partito italiano. Per essere più chiari: la vittoria di Obama è una cosa grandissima, ma non avvicina di un giorno solo la fine di Berlusconi e del Berlusconismo. Ha più a che vedere col giorno in cui vedremo Balotelli in nazionale. E col giorno in cui i cinesi di via Paolo Sarpi, se angariati, non chiameranno l'ambasciatore della Repubblica Popolare, ma il loro consigliere comunale eletto da loro – questi sono i regali che ci porta Obama. Per Veltroni, invece, niente. Ma non è neanche colpa sua.
Sì, senza dubbio non è l'Obama italiano. Lo abbiamo già detto: uno è giovane, l'altro no; uno infiamma le folle e l'altro no; uno è l'outsider, l'altro no... ma non è nemmeno questo il punto. Se anche avessimo un Obama italiano, non vincerebbe le elezioni, esattamente come Kobe Bryant trapiantato nell'Udinese non segnerebbe per forza un gol. La politica italiana e quella statunitense sono due sport diversi, con regole diverse. Diverso è persino lo scopo del gioco. Il voto americano è un Atto di Fede. Per quattro anni i cittadini americani crederanno in Obama, poi si vedrà. Il voto italiano è un attestato di appartenenza. Essere di sinistra o di destra, per noi è ormai un destino.
Ora ci racconteranno che Obama ha vinto conquistando il centro. È il solito modo di vedere l'America con lenti italiane. In un certo senso è vero, c'è un centro che Obama ha conquistato, ma non è quello a cui punterà Veltroni o il suo successore. Il centro che Obama ha fatto suo è una moltitudine di persone che non sono di sinistra o di destra perché, semplicemente, non hanno quasi mai votato. Ma queste moltitudini, in Italia, non ci sono. E questo non perché la politica italiana sia peggiore di quella americana, come opineranno gli opinionisti del provincialismo inestirpabile. Anzi: paradossalmente l'exploit di Obama in Italia è impensabile proprio perché noi andiamo a votare quasi tutti. Non c'è nessun ventre molle in cui affondare. Le parti sono fatte più o meno dal 1994: metà centro-sinistra, metà centro-destra. L'alternanza non la fanno i cosiddetti indecisi, ma i transfughi, le leggi elettorali in continua evoluzione, le composizioni e scomposizioni di alleanze e cespugli, e infine gli astensionisti (che spesso praticano un astensionismo consapevole e selettivo: rifondaroli delusi da D'Alema nel 2001, berlusconisti mosci nel 2006).
Il fatto che una democrazia iper-partecipata non sia per forza una buona democrazia è di un'evidenza che personalmente mi schianta. Ma è andata così: il dibattito politico si è sovrapposto alle rivalità tra comuni medievali e dinastie signorili; al punto che a vent'anni dalla fine ufficiale di tutte le ideologie ancora non si riesce a discutere di problemi concreti per più di una settimana tra cittadini, anche giovani, senza che tutto precipiti in un'astratta contesa tra Rossi o Neri. Forse è per questo che nella loro infinita saggezza i Padri Costituenti accollarono alla comunità le spese di gestione degli stadi, affinché la plebe potesse ivi menarsi unicamente per futili motivi, lasciando la politica a quelli che avessero tempo e pazienza per preoccuparsene seriamente; eppure non è bastato, anzi forse è stato controproducente: oggi le indicazioni di voto te le danno in curva. Nel frattempo mi è capitato di sentire degnissime persone mormorare: ma perché non facciamo votare soltanto i laureati? Ipotesi discutibile, ma per ora vorrei solo far notare come l'America di Obama stia percorrendo la strada nella direzione inversa. Forse ci troveremo in mezzo. Nel frattempo al candidato nero è bastato riempire qualche green perché intellettuali conservatori cominciassero a intravedere lo spettro delle adunate naziste.
Metafora per metafora, proviamo con l'economia: è come se Obama avesse lanciato un prodotto (la politica) in un mercato emergente, un Paese in cui il 40% dei potenziali clienti ancora non aveva bene idea di cosa fosse. Ma l'Italia è un mercato saturo, dove dal 1948 in poi il 90% degli italiani ha acquistato un partito, e da allora al massimo lo può cambiare ogni venti, dieci, cinque anni: come l'automobile, sì, più si va avanti e più vien voglia di disfarsene alla svelta. Il berlusconismo finirà soltanto quando non riuscirà più ad azzeccare un modello. Non è detto che ci voglia ancora molto: ma non si capisce perché la vittoria di Obama dovrebbe accorciare i tempi. In ogni caso è meglio farci trovare con un buon modello per quel giorno. Perché lo so, sembra impossibile, ma potrebbe anche essere domani.
Crossing Fingers All Around The World
03-11-2008, 21:48Americana, Obama, pessimismoPermalink
Mediocrazia
01-10-2008, 18:14Americana, futurismi, snobismiPermalink
Ma anche qualcuno quaggiù
28-09-2008, 00:25Americana, cinema, coccodrilliPermalink Maestri di vita (12): Paul Newman siede al tavolo.
Maestri di vita (12): Paul Newman siede al tavolo.Ognuno di noi è figlio, oltre che di una madre e di un padre, anche di una talvolta complicata, talvolta banale serie di circostanze che hanno fatto incontrare queste due persone invece di chiunque altro. Io, per esempio, sento di dovere qualcosa a Paul Newman.
Questa verità l’avevo sempre sentita tenuta dentro di me, senza riconoscerla, fino al ritrovamento, in un cassetto, di una fototessera di mio padre del 1970. Era come la tessera mancante di un puzzle. La verità, banale e sconvolgente insieme, mi investì di colpo. Tante domeniche pomeriggio d’infanzia, passate a giocare ai lego sul tappeto, mentre in tv davano un film di quell’attore un po’ sbruffone. Perché mi ricordavo solo i suoi film? Perché solo il suo nome? Di colpo tutto andava al suo posto.
Mia madre, da giovane, apprezzava i film di Paul Newman. Mio padre, da giovane, era l’articolo più somigliante a Paul Newman che la bassa padana potesse offrire. La somiglianza non aveva nulla di eccezionale, e soprattutto il formato era ridotto, perché l’altezza media di un popolo è proporzionale al benessere, e questa fu zona depressa fino al 1950.
Ora, prima che vi mettiate strane idee in testa, è giusto che lo sappiate: io assomiglio a mio padre, ma a Paul Newman neanche un po’. Ingiusto, ma è così.
E tuttavia a volte mi chiedo se questa assurda, banale circostanza, non potrebbe spiegare qualche aspetto del mio carattere. Io in fin dei conti potrei essere definito una persona pacifica e conciliante, proprio come mio padre (che non mi ha mai detto quei famosi No che aiutano a crescere). D’altro canto, è evidente che io non sono davvero una persona pacifica e conciliante, bensì un egocentrico sbruffone. Da chi ho preso? Da mia madre no, da mio padre nemmeno. E allora?
Credo che Paul Newman sia il mio attore preferito. Di lui ricordo molto bene due film. Il secondo, in italiano, si chiamava Lo Spaccone (The Hustler, 1961). Il ruolo perfetto per lui, no? Ma era uno dei suoi primi, in bianco e nero.
Lo Spaccone, a memoria, mi sembra il film più alcolico che io abbia mai visto. Ci si ubriaca solo a guardarlo, ti alzi dalla poltrona che ti gira la testa. Peggio di così c’è solo Morire a Las Vegas, ma a Las Vegas Nicholas Cage sa benissimo che beve per uccidersi; invece nello Spaccone la gente beve senza neanche rendersi conto che nuoce gravemente alla salute. Si fuma anche molto. È un film di altri tempi (ricordo un dialogo pomeridiano tra lui e lei: “Cosa fai oggi?” “Niente”. “Ti va di bere?”)
Lo Spaccone sarebbe un film sul biliardo, ma, come si dice in questi casi, il biliardo non è che una metafora della vita. All’inizio Newman è convinto di essere il più grande giocatore del mondo, e non smetterà di crederci per tutto il film. Ma gli va tutto male, perché? Perché è uno spaccone. A biliardo si gioca così: si invita un pollo e si finge di essere più polli di lui: si perde un po’, e quando il pollo è cotto a puntino lo si spenna. Ci vuole concentrazione, sangue freddo, killer instinct. Paul Newman non ha nulla di tutto questo. Invece di cercarsi polli giù al molo, va davanti al più grande giocatore di biliardo vivente e lo sfida a regolar tenzone. E per dimostrare che è sicuro del fatto suo, tra un colpo di stecca e l’altro beve bourbon come una spugna. E vince, stravince, e beve, perché è un genio. Finché dopo dodici ore di stecca non succede qualcosa. Il suo agente gli consiglia di ritirarsi, ma lui deve andare avanti. Non si è accorto che il vecchio maestro lo sta per spennare, da pollo che è.
Dodici ore dopo lo svegliano, abbracciato al termosifone, e lo avvertono che la partita è finita, e lui ha perso tutto. Ma tranquilli, questo è solo l’inizio del film.
Ora, però, visto che non siete degli sprovveduti, e film americani ne avete visti tanti, con un piccolo sforzo potete immaginarvi da soli come continua. È il solito canovaccio: all’inizio del film il giovane di belle speranze fa una brutta figura, cade in disgrazia, ma poi capisce quali sono stati i suoi errori, e verso la fine del film torna sui suoi passi e trionfa nel luogo dove era stato umiliato. In mezzo, di solito, incontra anche una bella ragazza.
Così vanno i film, in America, e così vorremmo che fosse la nostra vita: siamo persone eccezionali che hanno fatto degli errori, ma con qualche piccolo aggiustamento…
Lo Spaccone però non ce la fa. Resta Spaccone fino alla fine, e anche quando vince, in realtà perde tutto. Insomma, è un completo disastro. E un paio di volte alzandomi dalla poltrona traballante, mi sono chiesto: ma non avrò per caso preso da lui?
Per fortuna poi penso al primo film che mi ricordo di avere amato, che è La Stangata (The Sting,1973: abbiamo la stessa età). Per me non ci sono film più belli, ma è anche vero che sono anni che non vado a ricontrollare.
In questo film, se ci fate caso, Newman assume un ruolo vagamente paterno nei confronti del vero protagonista, che sarebbe Robert Redford: lo spettatore tende a immedesimarsi in quest'ultimo. All’inizio del film, poi, Newman non sembra altro che un alcolizzato di mezza età, come se avessero chiuso Lo Spaccone in una cantina e lo avessero tirato fuori dopo quindici anni. Ma poi c’è la scena del poker sul treno.
Newman e Redford sono saliti su un treno per tendere un tranello a un boss che gioca a poker in un vagone (ma che, ve lo devo raccontare?) È Newman che va a gettare l’esca. Prima però entra in una toilette e si mette a fare gargarismi col bourbon. Che fai, gli chiede Redford. Non lo vedi? Risponde lui. Ci metto un po’ d’acqua. Altrimenti non lo reggo.
Anche se so che non è vero, mi piace pensare che La Stangata sia il seguito dello Spaccone. Che il protagonista sia sempre lo stesso, solo che ora ha finalmente capito il trucco fondamentale della vita: allungare il bourbon. Nella vita non bisogna essere sbronzi. Bisogna sembrare sbronzi. Chi non lo capisce è un fallito, anche se è il miglior giocatore di stecca del mondo. Chi lo capisce non ha più nient’altro da imparare.
Quando Paul Newman arriva nel vagone del poker, col colletto aperto e scravattato, la bottiglia di bourbon in mano e l’aria da imbecille, la partita è sua.
Nello stesso modo (occhi socchiusi, aria da scemo, vestiti spiegazzati: e riflessi pronti, sangue freddo, e lo stesso freddo nel cuore) vorrei sapermi sedere anch’io un giorno al tavolo della vita.
O pace o deserto
23-07-2008, 19:28Americana, giornalisti, Israele-Palestina, medio orientePermalinkObama ai palestinesi: sarà pace
E subito penso: wow, forte Obama. Poi leggo meglio:
Obama ai palestinesi: sarà pace
'Israele, Gerusalemme capitale'
A questo punto bisogna spiegare cosa c'è di sbagliato nell'indicare Gerusalemme Capitale. Gerusalemme è già la capitale di Israele, no? Non proprio. Cioè: per gli israeliani sì. Gerusalemme è la capitale israeliana "complete and united" per legge, dal 1980. Ma l'Onu, che per la città aveva altri piani, considera quella legge una violazione del diritto internazionale. Di fatto, le ambasciate risiedono a Tel Aviv. Nessun Paese membro dell'Onu, a parte Israele, riconosce alla città santa lo status di capitale israeliana. Nemmeno gli Stati Uniti di George Malvagio Bush. Finché un giorno arriva Obama. Incontra i palestinesi. E gli dice quel che ha detto. Chissà i salti di gioia a Ramallah.
Ma poi l'avrà detto davvero? E' estate, fa caldo, può darsi che l'istintivo entusiasmo per Obama abbia giocato un brutto tiro all'articolista, vediamo. Scorro l'articolo e ci capisco meno di prima. E sono uno che un po' di Medio Oriente lo mastico, figuratevi il lettore digiuno. Giudicate voi.
Sul futuro di Gerusalemme il senatore dell'Illinois ha però precisato: "Quello di capitale è uno status finale che dovrà essere deciso dai negoziati e in accordo con i palestinesi. La comunità internazionale, inclusi gli Usa, non riconosce la rivendicazione israeliana di Gerusalemme come sua 'eterna e indivisa capitale'"Se ho capito bene: Capitale sì, Unita e Indivisibile no. Ecco, questo rappresenta una cauta apertura alla Palestina, o almeno ad Al Fatah, che ha sempre reclamato Gerusalemme Est come capitale del futuro Stato palestinese. La dichiarazione è importante soprattutto se si confronta con una di Obama di inizio giugno, in cui Gerusalemme era considerata non solo capitale israeliana, ma anche unita e indivisibile. A questo livello, un palestinese moderato come Abu Mazen può ritenersi persino ottimista per il solo fatto che Obama sia andato a trovarlo a Ramallah - anche perché l'alternativa è un McCain che con i palestinesi nemmeno ci vuole parlare; poi bisognerebbe anche verificare quanti palestinesi ancora si sentano rappresentati da un moderato come Abu Mazen, dopo vent'anni di prese in giro: ma è un altro discorso.
Torniamo alla dichiarazione di Obama. Ce la leggo soltanto io, tra le righe, una certa arroganza? Da una parte il candidato sa già dove vuole arrivare: Gerusalemme Centro agli israeliani, e Ger. est ai palestinesi. Però, attenzione, quello è solo lo "status finale" a cui arrivare dopo tanti negoziati. Come a dire: discutete pure, basta che alla fine si arrivi alla conclusione che ho proposto io. In pratica si chiede ad Abu Mazen (e solo a lui: se Hamas vince di nuovo le elezioni, ciccia) di star seduto, stringer la mano al premier israeliano di turno e sorridere per altri 2-3 anni, per arrivare a un risultato che magari i consulenti di Obama hanno già messo nero su bianco in un dossier.
D'altro canto è abbastanza ingenuo leggere una dichiarazione così dal punto di vista dei palestinesi. In questo momento piacere ad Abu Mazen è l'ultimo problema di Obama. Il dieci per cento dell'elettorato americano dà l'impressione di credere alle storie che lo dipingono come un musulmano travestito da cristiano. In una situazione del genere un viaggio in Israele gli serve soprattutto per mettere una solida pietra sui pettegolezzi, per farsi inquadrare con la quippah in testa, per rassicurare gli israeliani, e soprattutto gli americani che a Israele ci tengono. Che poi ci possa scappare una cauta apertura ad Abu Mazen, è quasi miracoloso. Insomma, la dichiarazione di Obama vuol dir poco, ma poco è meglio di niente.
Forse, più che la dichiarazione, il problema è l'articolo che ci sta intorno; e ancora più dell'articolo, il titolo che ci sta sopra. Quando si critica il messianismo di Obama, si intendono casi come questi: non c'è un politico al mondo che a proposito della Palestina non si sia riempito la bocca della parola "pace". Ma se lo dice Obama, sembra che "pace" da parola debba diventare al più presto realtà. Obama dice "pace", e improvvisamente i palestinesi smettono di avere motivi per farsi esplodere o dirottare i bulldozer. Conta poco o niente che la "pace" proposta da Obama risulti alla maggior parte degli abitanti dei Territori un ultimatum inaccettabile; l'importante è accreditare Obama come uomo nuovo in possesso di soluzioni. Anche se a ben vedere sono soluzioni che rischiano di sorpassare a destra quelle di Bush. Ma Bush è il passato: Obama è il nuovo, e ciò che è nuovo è buono.
Sfonderò i vostri armadietti maledetti
06-04-2008, 11:48aborto, Americana, cinema, famiglie, Giuliano FerraraPermalink Un luogo appena un poco più comune
Un luogo appena un poco più comuneBasta armadietti
È giusto, prima di parlare di un film del genere, che il piccolo recensore confessi le sue idiosincrasie. Perché magari Juno potrebbe essere una pietra miliare del cinema mondiale, tipo Quarto Potere od Odissea nello Spazio, e tuttavia non sarei riuscito ad apprezzarlo appieno dal momento che è un film con gli armadietti e io, quei fottuti armadietti dei licei americani, non li sopporto più, levatemeli dagli occhi.
Non è colpa degli americani – che ci possono fare? Loro hanno gli armadietti, è giusto che li mostrino. E hanno anche le cheerleader e i bibitoni dai colori improbabili, e il ballo di fine anno… è normalissimo e comprensibile che continuino a fare film su queste cose. Si tratta di un problema mio: a un certo punto della mia vita ho iniziato a sentire una voce nella mia testa che mi diceva BASTA COI FOTTUTI ARMADIETTI e questo forse pregiudica la mia capacità di recensire Juno.
Forse ho visto troppi telefilm, fatto sta che a un certo punto il mio immaginario ha sviluppato un’intolleranza agli scaffali grigi lungo i corridoi. L’impressione di conoscere le scuole di laggiù meglio delle italiane, oltre che illusoria, è frustrante, perché in quella italiana ci lavoro, e benché ricopra una mansione di grande responsabilità il mio personale armadietto è largo 40x20cm.: ogni mattina che m’inginocchio per aprirlo, ripenso agli immensi armadietti degli imperialisti americani. Non sono la persona più adatta a parlare di Juno.
Non so se l’ho mai spiegato, ma l’America mi fa paura. Meno della Cina, ma un po’ più del Perù. Si può viaggiare per giorni e giorni e si resta in America. Cambierà il paesaggio (non tanto), ma le città avranno nomi simili, i ristoranti i nomi identici, e nei licei le bionde faranno le cheerleader e le more ascolteranno punk. Tu pensi che sia un luogo comune. Ma l’America è precisamente questo: un immenso luogo comune. Quando esce un film, e tutti dicono che è un film diverso dagli altri, tu ti aspetti precisamente che rovesci il luogo comune. Ma un luogo comune rovesciato è ugualmente comune, come quella canzone che ascoltata all’incontrario suona uguale. Così Juno arriva a scuola, apre il suo armadietto, scambia due scortesie col bulletto di torno, e ci spiega che in realtà ai bulletti piacciono le more postpunk, mentre alle bionde piacciono i professori, avete capito come ragiona Juno? È questo che mi spaventa dell’America. La quantità ti porta a ragionare per categorie. Al massimo riconoscono che le categorie si comportano in modo un po’ più complesso (pensavi che le bionde si filassero i terzini di football? sbagliato), ma questo non toglie che le categorie esistano, e tu ci sia dentro. Hai capito, individuo di una piccola nazione esotica? Tu in realtà non esisti. La tua individualità è una somma di variabili che noi abbiamo individuato e quantificato da tempo. Esistono i nerd, esistono i fighetti, esistono quelli che prenotano la limousine per il ballo di fine anno ed esistono quelli che trovano il ballo una stronzata ma sotto sotto gli rode. Più su esistono i ricchi che vivono tra mobili per ricchi in case da ricchi nei sobborghi da ricchi, e i non ricchi che hanno lo sportello del frigo adorno di cento calamite.
Quello che mi fa più paura in questo modo di pensare, è che probabilmente gli americani hanno ragione. Se prendiamo 200 milioni di persone, e li facciamo vivere in una fascia geograficamente abbastanza omogenea, vedremo che le personalità si allineano lungo determinati standard sociali, e che l’individualità non può essere che un’illusione. Un’illusione che probabilmente è più facile coltivare in una penisola stretta e stretta ricca di paesaggi e climi diversi, dove sulle due sponde dello stesso fiume si parla un dialetto diverso. Comunque io preferisco tenermi la mia illusione di individualità, e voi tenetevi quei fottuti armadietti.
(Qui non parlo più di Juno)
A un certo punto della mia vita ho fatto la pace coi luoghi comuni. Dal momento che esistono, e funzionano, ho capito che devo imparare ad usarli e a non essere usato da loro. Per esempio io ho un blog, non so se ne avete sentito parlare. Su questo blog a volte scrivo dei racconti, li scrivo molto brevi con la scusa che sono per il blog, e siccome non ho spazio per costruire personaggi a tutto tondo (ma avendo lo spazio probabilmente mi mancherebbe la capacità), nella tazzona oversize dei luoghi comuni c’intingo alla grande, e quando i commentatori s’incazzano io sghignazzo. “Ehi, Leonardo, ho letto il tuo pezzo sugli imprenditori arroganti e i benzinai pachistani con la faccia gentile, bella roba, eh? Forse non al livello di quello sugli omosessuali petulanti, ma insomma quando arriva il pezzo sui negri col senso del ritmo?” Tempo al tempo, arriverà anche quello, non fatemi pressione. Siccome non ho pretese di naturalista ottocentesco, né di monologhista interiore novecentesco, ma vorrei semplicemente descrivere la mia società in abbozzi sintetici ed efficaci che arrivino a più gente possibile, io ho da tempo incluso i luoghi comuni nella mia cassetta degli attrezzi, e non credo di falsificare la realtà quando li uso, anzi.
Forse l’ultimo Virzì mi è piaciuto tanto perché ci leggo la stessa premessa: perché darsi pena ad evadere dai luoghi comuni, quando la realtà stessa è ben più macchiettistica del vero? Virzì descrive la realtà abitata da tizi come quel manager della Telecom che incita a vincere come “Napoletone a Waterloo”: l’avete visto tutti. Sembrava o non sembrava un provino di Tutta la vita davanti? Ma probabilmente i critici l’avrebbero trovato troppo caricaturale. E allora non prendetevela con Virzì, l’Italia è questa. Se mai mi piace che Virzì abbia scelto l’opzione della vecchia commedia all’italiana: dati gli stereotipi, carichiamoli finché scoppiano. Il suo è un film dove la gente litiga, impazzisce, imputtanisce, in generale fa male a sé stessa e agli altri. Questo mi piace, tanto più ultimamente al cinema m’imbatto sempre più spesso in film che praticano una via opposta.
(Adesso parlo di Juno, raccontando quasi tutta la trama)
Juno è per l’appunto un rappresentante di questa seconda via, che potrei descrivere così: siccome i luoghi comuni esistono, li diamo per scontati, li accenniamo appena appena, e poi lavoriamo per sottrazione. E quindi, caro spettatore che conosci a memoria tutto lo sfondo umano del liceo americano: ti aspetti che Juno sia una sedicenne irresponsabile e deficiente? Ecco, no, vedrai che non è così irresponsabile e deficiente. Ti aspetti che il suo ragazzo sia nerd e immaturo? Dai, non è così nerd, corre gli 800 metri e si preoccupa dell’alito. Ti aspetti che la migliore amica sia una bionda senza cervello? Scoprirai che ne ha abbastanza per dare a Juno i consigli migliori. Ti aspetti che la matrigna manicure voglia più bene ai cani che a Juno? E invece no, anche lei ha un gran cuore. Forse la madre affittuaria è una donna in carriera maniaca delle creme? Ma al centro commerciale gioca per dieci secondi con una bambina bionda, e quindi probabilmente sarà una brava madre. Forse suo marito è un Peterpan con la crisi dei quarant’anni, pronto a gettarsi su una 16enne incinta di suo figlio? Ehi, ehi, piano, messa così potrebbe sembrare un mostro, e invece vedete che anche lui si ferma subito, capisce il suo errore, chiede il divorzio, naturalmente consensuale e collaborativo perché mostrare un litigio coniugale in un film fa trooooppo anni Novanta, insomma… è un luogo comune.
Il problema è che un luogo comune “impoverito” non è meno comune di prima: è semplicemente appiattito, una versione bidimensionale della realtà (e come tale forse in grado di suscitare un effetto cromatico che solo le ragazze riescono veramente ad apprezzare, il famoso effetto Klimt), dove non ci sono più veri conflitti e tutto è così… carino, ma così carino, che a un certo punto fantastichi di Juno che torna a casa dalle prove del complesso e ci trova Javier Bardem che ha ucciso tutta la sua famiglia con una bombola da enfisema (avete notato che i marciapiedi sono identici? Ma tutta l’America suburbana è così, anche quando la girano in Canada).
Immaginate la storia di Juno scritta e girata da un cultore del conflitto grottesco. La ragazzina scopre d’essere incinta: piange, strepita, poi si mette a cercare dei genitori seri. Perché mai dovrebbe trovarli al primo colpo? Quando mai nella vita è buona la prima? Io mi sarei preso venti minuti almeno di tour nelle case degli aspiranti genitori: madri isteriche, fratelli bulimici, padri passivi aggressivi con uncini appesi al garage, non mi sarei fatto mancare nessun luogo comune, dal momento che tutti questi luoghi comuni sono documentati nella cronaca, sono stramaledettamente veri. Poi avrei fatto litigare Juno con padre e matrigna: so benissimo che esistono genitori che sanno prendere le cose con filosofia, ma che gusto c’è a mostrarli in un film? Io al cinema voglio vedere la gente che litiga, è una cosa che Aristotele chiamava catarsi, e funziona: dopo torno a casa placido come un agnellino e se trovo mia figlia a letto con un cingalese sono io che la prendo con filosofia.
Invece un film carino e pacificato come Juno mi rende nervoso, finisce che litighiamo per una svolta a sinistra, non è certamente questo lo scopo dell’arte. E anche il Peterpan, l’avrei voluto un po’ più stronzo, perché che gusto c’è a mostrarci uno stronzo senza mordente? Siamo tutti stronzi così, ma quando andiamo al cinema vorremo vedere uno stronzo assoluto, qualcuno che prenda su di sé i nostri vizi e li potenzi al massimo, onde farcene realmente vergognare (o al limite darci la consolazione dei vili: sono pur sempre meno stronzo di lui). Un fighetto ex grunge coi sensi di colpa non ci fa neanche arrabbiare, non ci fa nulla, quasi quasi ha ragione lui, genitori non ci si improvvisa. Dateci una vera canaglia. E il ragazzo di Juno, lo vogliamo caratterizzare in qualche modo? Non è troppo nerd, non è troppo atleta, non è troppo niente, gelatina al gusto di gelatina, nessuno si innamora veramente di un tipo così.
I luoghi comuni esistono, ma non diventano più interessanti a smussarne le punte e a ricoprirli di melassa. Ma quel che è paggio è che in questo modo si tradisce l’adolescenza di cui si vorrebbe parlare, che non è – per quel che ne so e che mi ricordo – un’età carina. Ma neanche un po’. È un’età grottesca e piena di conflitti, in cui si urla e si strepita per un biglietto dei Tokyo Hotel – figurarsi per un bambino. È l’età dei brufoli, e Juno non ne ha: questo per me chiude ogni discorso. E poi, scusate, è un’età manichea. Se ti piacciono gli Stooges, non suoni i Moldy Peaches. I Moldy Peaches li mangi vivi e li vomiti nel vaso della matrigna, perché se ti piacciono di Stooges e Patti Smith l’ultima cosa che vuoi dare di te è un’immagine “tanto carina”.
Certo, se facciamo finta che i sobborghi americani (e quelli italiani, di riflesso), siano pieni di ragazze carine e vitali e sotto-sotto-sotto-sagge come Juno, è chiaro che l’aborto diventi una cosa assurda: che bisogno ce n’è? Nove mesi di nausea e poi un bel pianto, in casa tutti capiscono le tue scelte, fuori è pieno di simpatici ricchi che non vedono l’ora di prenotare il pargolo, insomma, per raschiarlo via bisogna essere veri mostri. Così l’estetica “carina” finisce anche suo malgrado per contribuire alla battaglia dei più salottieri degli attivisti pro-life. Anche se… ma quindi i ratzingeriani atei sono favorevoli all’adozione da parte dei single? No, perché non lo sapevo. E Ratzinger lo sa? Forse è anche per quello che non manda nessuno alle loro manifestazioni. Vabbè, si consolino coi pomodori di Bologna, città generosa.
from afar you'll see me: I'm a Sensation.
24-02-2008, 10:49Americana, tg, tvPermalinkL'altro giorno, in uno di quei servizi di avvicinamento alla cerimonia degli Oscar, intervistavano dei vip italiani in America. La domanda era audace: Obama o Hilary?
La prima a rispondere è stata Romina Power, che in scioltezza ha spiegato le sue ragioni per Hilary: ha letto i suoi discorsi, ha già apprezzato la presidenza del marito, ecc. ecc.. Stacco rapido su Raoul Bova, che esclama: “Obama!”
E il giornalista: “Perché?”
E in quell'attimo, la fronte del grande attore s'increspa leggermente, come solcata da un pensiero: Ma che stronzo, oh. Sono qui per te, sono Raoul Bova, il più figo d'italia in base alle più recenti rilevazioni, mai preteso d'essere una cima ma sono simpatico e disponibile, tu mi fai una domanda di politica estera e ti rispondo pure al volo, e tu insisti? Cioè: già tanto se so i nomi dei candidati. E allora dillo, che vuoi farmi fare una figura di merda.
...poi si ricompone e risponde: “...non so. È una sensazione”.
Obamiano d'Italia che leggi qui, che ti ridi? Che ti credi? Che questo fosse un post scritto per dileggiare Raoul? Ma a me sta simpatico Raoul, è un tipo a posto. Qui si parla di te. Tu ce l'hai un motivo sensato per tifare Obama? Raoul è sincero, lui non è che abbia proprio letto il programma. Neanche i discorsi. Lui c'ha una sensazione. Ma tu, li hai fatti i compiti? Sei in grado di dimostrare la tua superiorità intellettuale su Raoul? Fatti avanti, coraggio.
(Prendetela come un invito a spiegare il programma di Obama a uno che c'ha poco tempo e voglia, oltre che una scarsa fiducia nelle sensazioni sue o di Raoul).
(Il video l'ho visto su Dave, ma onestamente non sono ancora riuscito ad arrivare alla fine).
Walter è OK, noi siamo OK, Alleluja!
20-02-2008, 18:36Americana, campagna elettorale (permanente), cattiva politica, elezioni politiche 2008, religioni, VeltroniPermalink Ex voti?
Ex voti?Oggi ho scoperto che le verità dipendono anche da chi le afferma. L'ho scoperto leggendo la seguente affermazione di un politico italiano:
"Il trasferimento in Italia di un modello statunitense si fonda più sull'indicazione del nuovo come speranza che sulla politica come soluzione dei problemi"Beh, che dire - sacrosanto. Il problema è che il politico in questione è Ciriaco De Mita, che in 45 anni di onorato servizio in Parlamento tutti questi problemi non è che li abbia proprio risolti, eh.
La lettura dell'episodio in chiave "nuove speranze vs vecchie cariatidi" potete farvela su qualche altro blog, o al limite da soli. Io ne propongo un'altra, giusto per variare un po': la deriva protestante del PD.
Cosa significa protestante? Banalmente, significa che al concetto cattolico di "perdono dei peccati", che rende gli italiani quei lagnosi peccatori sempre pronti a pentirsi, sostituisce il concetto protestante di "grazia". Per Lutero l'uomo non si salva in virtù delle opere buone che può commettere (e che comunque sono una goccia nell'oceano della malvagità universale), ma solo perché Dio gli dona la Fede. Se hai la Fede, sei salvo. Incollo da un vecchio pezzo mio:
Quando andai in Scozia, mi capitò di andare a un paio di liturgie della locale chiesa protestante. Solo un paio di volte, per cui sarò costretto a generalizzare.
In quella situazione caso quel che mi ha stupito di più sono le parole degli Inni. In quella chiesa non facevano che cantare: Dio è grande, Dio è con me, ho trovato la via, wow. Una cosa entusiasmante, sul serio. E il sermone del pastore era sullo stesso tono.
Ora, non so se avete presente le canzoni che si cantano in una qualunque chiesa cattolica la domenica, ma vi garantisco che all'80% sono variazioni sul tema: Dio mio, che razza di povero piccolo peccatore che sono. Quando poi il prete attacca l'omelia, non fa che ribadire il concetto: ragazzi, quanti stupidi peccati avete fatto questa settimana? Perché non date più retta a quel che dice Gesù, eh, non avete sentito il Vangelo?
Una liturgia piuttosto demoralizzante, specie se ripetuta per tutte le domeniche di una vita. Ma i cattolici sono fatti così: hanno bisogno di sentirsi nel Peccato, è parte della loro quotidianità. Quello che li spinge a migliorarsi, e nei casi peggiori a tormentarsi, è l'idea di doversi liberare dal Peccato.
Come i cattolici vivono nel Peccato, i Protestanti vivono nella Grazia. Loro, se vanno in chiesa la domenica, è per sentirsi parlare della Grazia. Quanto al Peccato, non è più così difficile da individuare. È Peccato tutto quello a cui hanno rinunciato da quando vivono nella Grazia. Può essere il sesso, la droga, l'alcol, o qualsiasi altro impedimento che è stato superato, è stato vinto.
 La mia ipotesi è che il PD - anche a causa dell'americanofilìa del suo segretario - stia scivolando in una deriva protestante, oltremodo favorita dalla marcia trionfale di Barack Obama, il personaggio più messianico in circolazione (via Gilioli). Tutto ciò che dice Veltroni mi sembra che suoni semplicemente: "Io sono ok, voi siete ok, se abbiamo fede ce la possiamo fare!"
La mia ipotesi è che il PD - anche a causa dell'americanofilìa del suo segretario - stia scivolando in una deriva protestante, oltremodo favorita dalla marcia trionfale di Barack Obama, il personaggio più messianico in circolazione (via Gilioli). Tutto ciò che dice Veltroni mi sembra che suoni semplicemente: "Io sono ok, voi siete ok, se abbiamo fede ce la possiamo fare!"Sì, ma perché "deriva"? Che problema c'è ad essere protestanti? Beh, se dovete farvi eleggere in una nazione di cultura cattolica, qualche problema c'è. Per questo lo scetticismo di De Mita nei confronti del nuovo corso non è liquidabile tanto alla leggera. De M. rappresenta un tipo di elettore insofferente alle promesse a lungo termine, più incline al do ut des immediato, verificabile entro i confini della propria circoscrizione elettorale: il fedele cattolico che a Dio non si permette di chiedere niente, ma è continuamente affaccendato a mercanteggiare davanti all'altare del Santo del Paese: se mi fai questo favore t'accendo la candela, se mi fai questa grazia ti faccio un regalino... Molto prima di andare al voto, l'Italia era la terra degli ex voto. Una riforma nel senso protestante del termine potrebbe essere un po' prematura.
Non che non ci abbiano già provato. Forse che Berlusconi non si presentava già come Uomo della Provvidenza? Forse che non ostentava i segni del suo successo, da bravo calvinista? Sì, giusto. Però Berlusconi temperava questo americanismo alla Mike Bongiorno con sane dosi di pragmatismo cattolico. Per esempio, l'enfasi sulle opere. Sapete che i cattolici, a differenza dei protestanti, credono nell'importanza delle Opere. Pur essendo gocce nel famoso oceano di malvagità, esse sono l'unica espressione della nostra fede. Questo punto di vista è bene illustrato dalla breve Lettera di San Giacomo (2,14-18):
A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: "Andate in pace, scaldatevi e saziatevi", ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede; se non ha opere, è per sé stessa morta. Anzi uno piuttosto dirà: "Tu hai la fede, e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede".
Berlusconi ha capito abbastanza presto che gli italiani, più che alla Fede, guardano alle Opere, o meglio: a chi gli chiede di avere Fede, rispondono "mostraci le Opere". Così l'enfasi sul Nuovo Miracolo Italiano si è sempre accompagnata a proposte concretissime: "un milione di posti di lavoro!" "Abolirò l'ICI!", ecc.. Che poi queste promesse non fossero sempre esaudibili, ha un'importanza relativa: diciamo che gli italiani non si lasciano convincere dalle visioni a lungo termine, ma amano essere coglionati con proposte il più possibile concrete. Spero che al PD ne tengano conto, mentre rifiniscono il programma.
chi fa sempre divertire i grandi ed i piccin?
20-10-2007, 18:16Americana, animali, cinemaPermalinkE questo cos'è? Non ci sono già stati abbastanza cartoni con il gatto e il topo? (I manager della MGM ad Hanna e Barbera, nel 1940).
 Una delle principali differenze tra la realtà e l’animazione è il topo. Il topo di cartone è istintivamente simpatico: canta, balla e si fa beffe dei grandi. Il topo vero è una bestia orrenda, un parassita e un untore. Questa differenza, che abbiamo tutti afferrato in età prescolare, è uno dei grandi misteri della cinematografia. Perché Disney, tra una varietà infinita di animali esotici e da cortile, si fissò sul topo? Perché Mickey il Topo ha fatto il botto e Felix il Gatto no? Nel Trecento i ratti sui bastimenti che venivano da Oriente portarono un’epidemia di peste che dimezzò la popolazione europea: la salvezza fu un nuovo animale domestico importato dall’Africa, il gatto. Eppure i bambini tifano per Jerry e contro Tom.
Una delle principali differenze tra la realtà e l’animazione è il topo. Il topo di cartone è istintivamente simpatico: canta, balla e si fa beffe dei grandi. Il topo vero è una bestia orrenda, un parassita e un untore. Questa differenza, che abbiamo tutti afferrato in età prescolare, è uno dei grandi misteri della cinematografia. Perché Disney, tra una varietà infinita di animali esotici e da cortile, si fissò sul topo? Perché Mickey il Topo ha fatto il botto e Felix il Gatto no? Nel Trecento i ratti sui bastimenti che venivano da Oriente portarono un’epidemia di peste che dimezzò la popolazione europea: la salvezza fu un nuovo animale domestico importato dall’Africa, il gatto. Eppure i bambini tifano per Jerry e contro Tom.E non i bambini di oggi, disinfettati ai limiti della sterilità, che di topi ne vedono solo sullo schermo piccolo o grande. I bambini degli anni '40 che in mezzo ai topi ci vivevano, in case con buchi nel battiscopa e rumori in cantina. Al cinema ridevano (grandi e piccoli) per il topo di cartone; poi rincasavano e controllavano le trappole.
Magari il tifo per il topo era il primo accenno di ribellione del piccolo di casa: una specie di solidarietà tra le piccole creature sempre affamate. Ci saranno stati bambini che di nascosto portavano briciole al roditore. Credo che uno dei passaggi cruciali della pre-adolescenza sia quando ti accorgi che Jerry non è poi così simpatico, anzi, a ben vedere è uno stronzo, e cominci a tifare per il suo avversario frustrato. Fine della solidarietà tra le piccole creature: diventi grande, cominci ad avere paura dei germi e a sviluppare il senso della proprietà: giù le mani dalle nostre provviste, parassita!
Cosa c’è nella stanza 101? (Winston del Grande Fratello)Ratatouille è un film piuttosto strano, anche per la media della Pixar. Per quanto la consociata della Disney rifugga le trame scontate, tutti i suoi film mantengono un sano contenuto morale, di quelli che si possono condensare in due righe e che mettono d’accordo grandi e bambini (i grandi devono lasciare lo scetticismo nel vestibolo, s’intende): per esempio Mosters & co. dimostra che la fantasia vince sempre sulla paura, Nemo ricorda ai genitori che i figli devono imparare a nuotare da soli, proprio perché il mondo è vasto e alieno come l’oceano; Cars insegna a grandi e piccini il valore dei rapporti umani, che trionfa sulla grande competitività universale. E così via. Anche Ratatouille ha una morale e un lieto fine, ma zoppicano. Sembrano appicicati per contratto.
Tutto ciò per dire che davanti a Ratatouille si sta a bocca aperta per l’esperienza della visione che dà, quasi travolgente. È su questa sensazione di realismo cartoonesco che poi si muove l’amore per i personaggi (Secondavisione)
Il film (che è bellissimo, se non avete la fobia dei topi, ed è andato meglio in Francia che negli USA) non è americano al 100%. L’idea è di Jan Pinkava, britannico d’origine boema, già premio Oscar per un corto. Gli uomini della Pixar devono averne apprezzato soprattutto il senso della sfida: dopo aver creato con Cars un mondo cromato e arrugginito, in cui l’automobile è Natura, i canyon hanno le sagome di vecchie cadillac e le nuvole sono strisce di pneumatici, stavolta si trattava di stravolgere uno degli archetipi dell’animazione: il Topo. Togliere al Topo il cravattino di Jerry e le braghette di Mickey. De-antropomorfizzarlo, riportarlo alla natura, alla sua condizione di scroccone purulento. E poi rimettersi nel suo punto di vista: il punto di vista di un animale braccato, per il quale anche una vecchia zia borgognona è un orco sterminatore, e la sua vecchia spingarda lancia razzi Terra-Aria.
È ingiusto, ma è normale: ai bambini piacciono gli animali piccoli, vispi e birichini.
L’altra scommessa era il cibo. L’ultima frontiera del digitale è rendere l’organico coi pixel: le croste croccanti, il verde delle muffe, il ribollire di una salsa. E dopo avere programmato cibo vero e ratti veri, farli interagire in un film per bambini. Trasformare un’orda di ratti sporchi e scrocconi nel personale di un ristorante francese: una sfida impossibile, salvo che nulla è impossibile per gli uomini della Pixar. La morale del film è la sfida stessa: non tutti hanno talento, ma se ce l’hai puoi fare qualsiasi cosa. Puro calvinismo: la fede è un dono che sposta le montagne. Rémy è il ratto aspirante chef, che per cucinare deve servirsi dello sguattero Linguini: il modo in cui impara a guidare il suo strumento umano, tirandogli i capelli per condizionarne i movimenti, è una stupenda metafora del mestiere dell’animatore (e di qualunque arte o mestiere): migliaia di tentativi e ore di lavoro, anche solo per affettare un tubero. Ma se hai talento puoi solo farcela, e infatti Rémy ce la farà. Titoli, fine.
Ecco, questa è la crosta croccante del film. Quello che c’è dentro, però, è un po’ meno dolciastro: come se qualche spezia europea fosse riuscita a salvarsi anche dopo che Pinkava ha lasciato la Pixar e il progetto è passato a Brad Bird. Il retrogusto amaro si percepisce soprattutto nelle prime sequenze: più tardi, quando si avventurerà in quel mondo pieno di coltelli, carrelli e altre insidie, sarà impossibile non prendere le parti del Piccolo chef. Ma all’inizio della storia Rémy non è necessariamente un personaggio simpatico. È il figlio del Capo di un branco accampato nel solaio di una casa di campagna. Il suo fiuto straordinario lo rende prezioso per la sopravvivenza della “famiglia”, grazie alla sua capacità di riconoscere il cibo avvelenato. Per il resto, il padre e i fratelli non hanno la minima considerazione per le sue capacità. Per il padre il cibo è solo carburante, ai fini dell’unica missione di vita: sopravvivere, malgrado gli umani. Di fronte a questi orchi enormi, che massacrano i ratti senza pietà, la famiglia non ha altra scelta che scappare e mangiare, mangiare e scappare, senza dividersi mai.
È una vita che Remy non sopporta. A lui piace il mondo degli uomini: gli odori della dispensa, i programmi di cucina, i libri di ricette. Sarà la sua imprudenza a causare la fuga in città della famiglia. In città del resto la vita dei ratti non è molto diversa: la famiglia è sempre la famiglia, e il cibo è sempre carburante. Ma non per Remy. Lui passerà definitivamente dalla parte dei nemici, degli assassini, degli uomini.
REMY: Prima o poi il piccolo deve lasciare il nido
IL PADRE: Noi siamo ratti! Non lasciamo il nido! Lo facciamo più grande!
Ecco la polpa europea. Rémy è un migrante, come Fievel: ma se Fievel sbarca in America era l’epopea nostalgica degli emigranti europei negli USA, Ratatouille racconta l’emigrazione e l’inurbazione con tutta l’ambiguità dei problemi irrisolti di oggi. Gli emigranti hanno due vie (le hanno sempre avute): o si ghettizzano, cristallizzando i costumi e i valori della società di provenienza e isolandosi in un mondo percepito come ostile, o si integrano. Ma integrarsi significa spezzare le radici, tradire la razza. Non ci riescono tutti, e nemmeno Rémy, che pure tratta i suoi simili veramente con la puzza sotto il naso. In Africa i tipi come Rémy li chiamano noir blanchi, neri imbiancati: eppure anche lui preferisce non tagliarsi del tutto i ponti alle spalle: nottetempo scivola nella dispensa del ristorante che lo ha accolto, e ruba un po’ di roba buona per il fratello. La cosa gli scappa naturalmente di mano, proprio come succede quando la tua famiglia esce dal medioevo e viene a bussare nel tuo superattico per chiederti un favore: il problema di Rémy è lo stesso problema di Michael Corleone, è il problema di tutti gli onorati membri della società che hanno ancora qualche legame con le Famiglie.
Ma non ci sono gatti in America! E ti regalano il formaggio! (Fievel sbarca in America)
Verso i tre quarti il film, per quanto divertente, sembra proiettato verso un finale tragico: Rémy ha servito gli umani senza riuscire a integrarsi veramente, e intanto la Famiglia che fa affidamento su di lui è sempre più numerosa, sempre più affamata. Poi c’è il finale, appicicato un po’ così, che non racconto: dico solo che è incredibile la sfacciataggine con cui pretende di salvare capra e cavoli, Famiglia e civiltà. Quando le cose al mondo non stanno così, decisamente: uomini e ratti non possono convivere nello stesso ristorante. È una cosa che semplicemente non succede, nella realtà.
Tutti in coro noi cantiamo viva Topolin. Topolin, Topolin, viva Topolin, (Full Metal Jacket)
D’altro canto è un cartone animato, e nei cartoni animati i topi sono simpatici e la fanno franca. Detto questo, qui propongo il mio finale: dopo decenni di clandestinità Remy riesce a imporsi come un cuoco degno del genere umano, apre un ristorante a Duisberg, e una sera tutti i suoi parenti vengono sterminati nel parcheggio da una banda di roditori concorrenti. Perché la vita è dura, se nasci ratto. Rémy lo diceva già all’inizio. Nei film americani poi ti raccontano che anche il ratto può crescere, scoprire i suoi talenti, tradire i famigliari e poi ritrovarli, diventare famoso e apprezzato. Ma gli europei hanno abbastanza Storia da parte per concludere che non è quasi mai vero. E questo è tutto, gente.
la Storia si fa coi Se (e coi Ma)
16-10-2007, 10:01Americana, Bush, deliri, raccontiPermalink Il mondo di Junior
Il mondo di JuniorHOUSTON – dal nostro inviato
Il premio Nobel 2007 accetta finalmente d’incontrarmi nello splendore neopalladiano della sua villa nel centro del Texas. La stanza in cui ci stringiamo le mani – ironia della sorte – è ovale. Quando glielo faccio notare, abbozza un sorriso di circostanza. Non ha capito il riferimento.
“Ovale, come l’ufficio del Presidente… sa, nella Casa Bianca”.
Ridacchia. Ha capito. “Ah, già… lo sa, ci penso così poco ultimamente. La vita è breve, e se dovessi alzarmi tutte le mattine pensando che stavo per diventare Presidente… E comunque ‘ste ville le fanno tutte uguali, ci ha fatto caso? Anche Washington è tutta così. È uno stile di architettura sudista, penso”.
Sto per interromperlo spiegandogli che il suo ‘stile sudista’ in realtà è neoclassico settecentesco di derivazione veneta… ma per fortuna riesco a controllarmi. Non sono venuto a dare lezioni di storia dell’arte, sono venuto a intervistare l’Uomo che ha Salvato il Mondo, secondo il Time dello scorso dicembre – e a quanto pare anche secondo i giurati di Stoccolma. E ho già commesso un imperdonabile errore. Eppure il suo staff me lo ha spiegato bene: quando si parla con Junior, meglio evitare le allusioni. Fa una certa fatica ad afferrarle. Non è un problema di intelligenza, ma la conseguenza di quella lieve forma di dislessia che gli è stata diagnosticata soltanto in età adulta. Un difetto congenito che non gli ha impedito di farsi eleggere governatore del Texas e di arrivare a un passo dalla poltrona più ambita del mondo: quella di Presidente degli Stati Uniti. Evidentemente i bei discorsi non sono tutto. Soprattutto se puoi contare sulla famiglia giusta.
“Mi sento ancora spesso con mio padre”, ammette Junior; “i suoi consigli sono stati molto preziosi. Quando Gore voleva invadere l’Iraq a tutti i costi, il suo parere ha contato più di qualsiasi cosa, per me”.
“Ma poi la ha diseredata, o sbaglio?”
“Stronzate. Tutte stronzate. Al tempo della campagna per l’autonomia i giornalisti hanno voluto dipingerci come nemici a tutti i costi… bastardi”.
“Eh-ehm”.
“Beh, sì, intendo i giornalisti yankees. Quelli che stanno a NY, o a Washington, a imbrattare la carta, ha presente?”
“Ma adesso stanno parlando molto bene di lei. Non ha letto…”
“Nooo. Io non leggo la carta. C’è il cavo, c’è internet, chi ha bisogno di tutta questa carta? È quel che rimane di un mondo vecchio”.
Mi guardo intorno – e improvvisamente, con un tuffo al cuore, realizzo che non ho visto un solo libro in tutta la villa. Non uno. George Bush Junior, premio Nobel per la Pace 2007, non ne ha bisogno. Ecco un’altra cosa dura da mandare giù.
Del resto, questa è la vita dell’Uomo che ha Salvato il Mondo. Una paradosso infinito, una continua sfida ai luoghi comuni. Il petroliere che ha chiuso col petrolio; il cow-boy che ha portato la pace nel mondo; il repubblicano amico dei palestinesi: l’ultima notizia che gli porto dai Territori è la proposta di intitolargli il corridoio autostradale Gaza-Gerusalemme. Lui finge di non averlo già letto su internet, e ci scherza sopra:
“Un’autostrada? Buffo, qui in Texas non intitoliamo le autostrade. Hanno solo dei numeri. In ogni caso mi sembra prematuro… voglio dire, sono ancora vivo. Dalle mie parti cominciano a dedicarti le cose soltanto quando sei sotto sei piedi di terra… beh, ma immagino che Barghouti sappia quel che fa. È un tipo a modo, lo ammiro molto”.
“Avrebbe mai pensato di dire una cosa del genere, otto anni fa?”
“No, perché? Otto anni fa non lo conoscevo. Per la verità tutta la faccenda degli ebrei e dei palestinesi a quei tempi non m’interessava molto. Guardavo soprattutto all’America, ai problemi interni. Sarei stato un presidente alla Monroe, l’america agli americani e via dicendo”.
“Fino all’11 settembre…”
Sospira. Conosce bene questa domanda – gli è stata posta da migliaia di giornalisti, negli ultimi sette anni.
“Senz’altro l’11 settembre mi avrebbe cambiato. Voglio dire, l’11 settembre mi ha cambiato, proprio come ha cambiato il presidente Gore. È come se ci fossimo svegliati tutti su una mina. Credevamo di essere i Numeri Uno. Credevamo che tutto il mondo ci amasse, che volesse diventare come eravamo noi. Invece è saltato fuori che il mondo ci odiava. Era invidia, era rabbia, era un ammasso di cose che non avevamo pensato. Comunque, cosa vuole sapere esattamente? Se io al posto di Gore avrei bombardato l’Afganistan? Senz’altro l’avrei fatto. Chiunque l’avrebbe fatto. Anche il reverendo Martin Luther King l’avrebbe fatto. Siamo americani, prima di ogni altra cosa. Se ci attaccano rispondiamo, è normale”.
“Magari lei avrebbe attaccato in un modo diverso”.
“Forse. Mah. Queste cose le decidono i generali, vede. Mi viene sempre da ridere quando sento che chiamano Gore il comandante in capo. Lui sì e no sa indicare l’Afganistan sulla cartina. Per mesi è andato dicendo che dall’Afganistan avrebbe attaccato l’Iraq, finché non gli hanno spiegato che i due Paesi non confinano”.
“Via, adesso esagera”.
“Non lo so. Posso dire che avrei dato più soldi all’intelligence: in fin dei conti ho sempre pensato che se ci serviva la testa di Bin Laden non era necessario destabilizzare mezza Asia per ottenerla. In realtà dopo l’11 settembre i talebani erano terrorizzati. Bastava bombardarli un po’, e poi fare un’offerta. Mio padre le guerre le faceva così: bastone e carota. E a volte gli andava bene. Non sempre, eh… Ma Gore… lo sa anche lei com’è fatto Gore. È… un democratico. Non gli bastava arrestare i terroristi, lui voleva scaraventare tutto il fottuto Afganistan dal medioevo tribale alla democrazia, trasformare quel paese di montanari musulmani in una Svizzera. In fondo ragionava come i Sovietici, e infatti le ha prese per un bel po’, proprio come i sovietici”.
Non è la prima volta che sento paragonare la politica di esportazione della democrazia di Al Gore all’imperialismo sovietico. “Lo sa”, replico “in Europa prima dell’11 settembre molti pensavano che i i veri guerrafondai in America fossero i repubblicani”.
“Che stronzata”, sbotta lui. “Pensi a Roosevelt. O a quello della Prima Guerra, come si chiamava?”
“Woodrow Wilson”.
“Esatto. Tutti democratici”.
“Ma hanno salvato il mondo”.
“Sì, e questo gli ha dato un po’ alla testa. Pensi al Vietnam. Kennedy ci ha portato nel Vietnam, e Nixon ha fatto quel che ha potuto per portarci via. Noi repubblicani non abbiamo mai amato la guerra. Ovvio che la facciamo, se ci trascinano. Ma chi è così pazzo da amare la guerra? Io ho fatto carte false per non andare in Vietnam, e non me ne vergogno. Tutti questi reduci democratici che mostrano le cicatrici per un seggio al congresso mi fanno vomitare. Dicono di odiare la guerra, e a momenti ci riportavano in Iraq”.
Per essere un Nobel per la Pace, Bush Jr sceglie le parole con ben poca diplomazia. Ci vuole molto fiuto per annusare dietro il cafone texano in camicia a quadri l’aristocratico wasp, nato e cresciuto dalle parti di Yale. In fondo Bush è l’esatto contrario del sogno americano: invece di farsi da solo, sembra aver voluto disfare (da solo) tutta l’eredità culturale che la sua ricca famiglia gli deve pure aver trasmesso. Da laureato in Storia a cow-boy dislessico, da petroliere ad ambientalista. Il vero giro di boa fu probabilmente lo scandalo Enron. “Un vero disastro. L’11 settembre ci ha fatto arrabbiare col mondo, ma Enron e Kathrina ci hanno fatto arrabbiare con noi stessi. Non c’era un Bin Laden a portata di mano su cui scaricare le colpe”.
Per certi osservatori è sorprendente come Bush Jr sia uscito pulito dallo scandalo Enron, all’inizio del 2002. L’azienda che mandò sul lastrico migliaia di risparmiatori americani aveva finanziato pesantemente la sua campagna presidenziale. “Cosa posso dire? Quando corri per la Casa Bianca accetti soldi da tutti. Anche Gore fece lo stesso. È uno dei problemi di questo Paese: bisogna essere maledettamente ricchi per fare i presidenti, e ancora non basta. Devi fare i debiti. Poi ti ritrovi seduto in cima al mondo con un sacco di debiti da pagare, di favori da ricambiare. Non è sano, neanche un po’. Anche se volesse sbaraccare da Kabul, in questo momento Gore è legato mani e piedi all’Halliburton e alla Blackwater. E anch’io probabilmente sarei stato un pupazzo nelle loro mani, se avessi vinto”. Ma ‘per fortuna’ aveva perso: la temporanea assenza dalla vita politica gli permise di rifarsi una verginità che gli elettori texani avrebbero molto apprezzato. Di lì a pochi mesi avrebbe stravinto le elezioni di mid-term, con una campagna imperniata sulla questione morale, approdando al Congresso come speaker della maggioranza repubblicana. A questo punto, quando tutti i principali commentatori politici americani davano ormai per scontata la ripetizione del duello presidenziale del 2000, Bush stupì tutti con la prima proposta di legge sull’autonomia energetica e l’opposizione alla guerra in Iraq. Due grossi colpi alla sua popolarità presso i repubblicani, che alla fine preferirono candidare Rudolph Giuliani. “Ho la massima simpatia per Rudie”, dice Bush, “e non ho mai pensato di ricandidarmi una seconda volta. Non m’interessava battere Gore, ed ereditare i suoi problemi. Lui era impastoiato con la sua guerra in quelle sabbie mobili afgane, non so nemmeno se ci siano le sabbie mobili laggiù, ma ho reso l’idea, no? L’impressione è che i talebani fossero invincibili sul campo. Avremmo potuto mandare laggiù il doppio di marines e il doppio di tank, e avremmo soltanto sprecato tutto quanto. Io ho cominciato a domandarmi se la guerra non si potesse risolvere in un altro modo. Perché i musulmani continuavano ad arrivare da tutto il mondo per combattere in quel buco… in quel Paese dimenticato? Chi li riforniva? Per dirla in parole povere: Where’s the money? Chi finanzia tutto quanto?”
Rampollo di una dinastia di petrolieri, Bush non doveva faticare molto a trovare una risposta. “È chiaro che dietro a tutta la jihad c’erano i petrodollari. Gli emirati del Golfo, quegli inferni ad aria condizionata… sanno di essere seduti su una mina peggiore della nostra. Hanno la disperazione di chi sta per finire la benzina e restare al buio. In più hanno una paura matta della rivoluzione islamica. Così finanziano gli sceicchi alla Bin Laden, che almeno la rivoluzione la fanno all’estero. D’improvviso tutto mi è parso così sciocco e inutile… da una parte mandavamo i nostri ragazzi a morire, dall’altra continuavamo a comprare benzina per i nostri Suv e a finanziare i terroristi che li avrebbero uccisi… dovevamo uscirne, e alla svelta. Così feci quella prima proposta sull’autonomia: l’America doveva bloccare le importazioni e re-imparare a vivere delle proprie risorse energetiche”. All’inizio Bush fu accusato di voler semplicemente favorire il petrolio texano per questioni di lobby. Ma le aperture sulla propulsione a idrogeno e sul biodiesel brasiliano spiazzarono anche i suoi più accesi detrattori. “Anche i nostri pozzi stanno finendo, è tempo di ammetterlo e cominciare a diversificare. Guardi quello che è riuscito a fare Lula in Brasile col biodiesel… una cosa fantastica. E i pannelli solari, perché no? Il giorno che in Texas non riusciremo a pompare più petrolio, resterà ancora sole in abbondanza per tutti. So che mio padre non la pensa così, ma io continuo a credere che il petrolio non sia il destino dell’America”.
“Invece sull’Iraq andavate d’accordo”.
“Le faccio vedere una cosa”. Mi mostra un quadro. A ben vedere si tratta di una mappa. Di solito si appendono ai muri mappe antiche: questa invece è ingiallita, sgualcita, ma moderna. “È una delle cartine di lavoro di mio padre. Se guarda bene, ci trova le ditate del generale Schwarzkopf. Ora: la vede questa macchia verde scuro? Sono le zone a maggioranza sciita. Lei lo sa cosa sono gli sciiti?”
“Una setta musulmana, direi”.
“Ecco, bravo, lei è uno preparato. Sa cosa sono gli sciiti. Magari sa anche che in Iraq e in Iran sono la maggioranza. Beh, posso garantirle che nel 2003 a Washington ancora nessuno sapeva chi fossero. E volevano andare a Bagdad! Esportare la democrazia! Se fossimo andati a Bagdad, gli sciiti sarebbero venuti a gettare fiori sui nostri carri armati, e il giorno dopo avrebbero sgozzato tutti i sunniti, e votato l’annessione all’Iran. A quel punto gli ayatollah iraniani avrebbero avuto libero accesso ai laboratori atomici di Saddam Hussein, e magari anche al suo uranio – ammesso che Saddam Hussein fosse davvero in grado di procurarsi dell’uranio”.
“Tony Blair ne è convinto”.
“Tony Blair è un socialista. Hanno tutti questa mania di cambiare il mondo, con l’amore o con la forza. Sono molto fiero di aver fatto il possibile per evitare quel disastro. Ho preso questa fottuta carta di mio padre e ho convinto tutti i pezzi grossi repubblicani: se andiamo in Iraq, tempo un anno e gli iraniani fanno una buca radioattiva in Israele: sul serio volete passare alla storia per questo? io non sono molto bravo a fare i discorsi, ma si vede che Dio mi ha aiutato, perché li ho convinti”.
“E così alla fine si è preso la sua rivincita morale su Gore”.
“Non la vedo in questo modo. In realtà dovrebbe soltanto ringraziarmi. A quest’ora avrebbe già perso due guerre – non un bel bilancio. Invece tutto sommato ormai l’Afganistan è pacificato, anche se non assomiglia ancora molto alla Svizzera, devo dire”. Sorride sornione. “Ma il progetto oppio per cibo sta dando buoni risultati. E in sovrappiù abbiamo avuto anche la testa di Bin Laden”.
Un bel trofeo per la Bush Foundation. Ma c’è chi dice che sia un falso. Su internet continuano a circolare nuovi video dello sceicco del terrore.
“Non so cosa dire. Abbiamo il Dna, le impronte dentali, abbiamo tutto. Ma ci sarà sempre qualcuno convinto che è una montatura. C’è anche chi dice che le torri gemelle le ho fatte buttare giù io. Non è che posso replicare a tutte queste stronzate”.
Nel 2004 l’astro di Bush sembra già appannato. Alcune sue iniziative – la partecipazione a un summit informale tra israeliani e palestinesi – non sono comprese dai suoi compagni di partito. Nel frattempo Giuliani sfida Gore giocando la carta del patriottismo dell’11 settembre, ma gli americani gli preferiscono il Commander in Chief. “Rudie si è difeso bene, ma ha pagato il fatto di non avere una posizione netta sulla guerra”. L’anno successivo, il secondo grande shock della recente Storia americana: l’uragano Kathrina. Stavolta Bush è implacabile nell’accusare tutti i responsabili del disastro, dal sindaco di New Orleans fino al Presidente. “I democratici hanno chiacchierato per anni di riscaldamento globale”, dice, “e al primo uragano tropicale hanno reagito come dei boy scout di città. Il vero uragano che ha distrutto New Orleans non è stato Kathrina, ma l’incompetenza”. Da Kathrina in poi Bush è riuscito ad accreditarsi come il leader del nuovo ambientalismo. In pochi ricordano che ai tempi della campagna 2000 era Bush, e non Gore, a respingere il protocollo di Kyoto. “In effetti Kyoto non mi ha mai convinto”, ammette, “perché è troppo poco. Una misura omeopatica. Occorre darsi molto più da fare. Tagliare le emissioni di gas serra del 90% entro il 2009. Possiamo farcela. È alla nostra portata”. Fino al 2005 Bush non escludeva la necessità di cercare nuovi pozzi “autarchici” nell’incontaminata Alaska. Oggi non ne parla più. “Solo gli stupidi non cambiano mai idea. Fino a qualche anno fa non ero sicuro che il riscaldamento globale fosse colpa dell’uomo. A dire il vero non ne sono sicuro nemmeno oggi, ma chi se ne frega? Forse non siamo stati noi a scaldare il mondo, ma possiamo pur sempre dare una mano a raffreddarlo. Questo è come la penso io”.
Prima di abbandonare il Congresso nel 2006, Junior ha avuto la soddisfazione di vedere trasformata in legge federale la sua seconda proposta sull’“autonomia sostenibile”. I fatti dei mesi successivi gli hanno dato ragione in modo spettacolare. L’intensità della guerriglia afgana è calata drasticamente. In Egitto e in Iran gli scioperi di massa hanno costretto i governi a indire nuove elezioni. In Iraq la nuova giunta militare sta negoziando l’estradizione di Saddam Hussein. Qualche effetto positivo c’è stato anche per l’Europa, quando il blocco delle importazioni di petrolio negli USA ha abbattuto i prezzi al barile. L’altra faccia della medaglia sono gli attentati: l’esplosione del Boeing dirottato nei cieli di Philadelphia lo scorso settembre (intercettato da un missile prima che puntasse su Washington , secondo alcuni) e le fiale di gas nervino rinvenute nella subway di New York, fortunatamente senza conseguenze. “So che è terribile quello che sto per dire. Ma gli attentati sono una prova che avevamo ragione. Sono colpi di coda. Bisogna andare avanti a domare il bronco”.
Negli ultimi due anni, Bush è diventato un battitore libero. Ufficialmente è ancora iscritto al Partito Repubblicano, anche se ha preferito non candidarsi al Congresso. “Mi sono stancato di parlare per gli altri. Troppi compromessi. Oggi preferisco parlare per me”. In effetti le sue ultime uscite su Cina e Russia sono state particolarmente ruvide anche per un tipo come lui. “Io la vedo molto semplice: quelle non sono democrazie. Non basta aprire i mercati per creare una democrazia. Sono ancora due regimi a partito unico, dove gli oppositori vengono perseguitati e uccisi. Gli americani non dovrebbero avere nulla a che fare con questa gente. Ma i cinesi ci tengono per… i cinesi hanno queste enorme riserve di dollari, che m’impensieriscono molto. Non è giusto che ci possano ricattare in questo modo. Il solo pensiero è umiliante. Fossi ancora un politico, chiederei a gran voce il boicottaggio delle Olimpiadi. Fortuna che non lo sono”.
Cos’è, oggi, George W. Bush? Tante cose. Per esempio, il coproduttore dell’ultimo chiacchieratissimo film di Michael Moore sulla riforma sanitaria. “Lo sa che Moore era di sinistra? È uno dei tanti radicali che sono rimasti stomacati dalla gestione del conflitto in Afganistan. Ma le sue idee sulla riforma sanitaria o sul porto d’armi non sono né di destra né di sinistra, sono ragionevoli e basta. Quando parlavo di conservatorismo compassionevole, molti storcevano il naso. Ma continuo a pensare che ‘compassione’ sia una bellissima parola. Sa cosa significa?”
“Soffrire insieme”.
“Ehi, lei conosce l’inglese in un modo fantastico per essere un… un…”.
“Un italiano. Grazie”.
“Voi italiani conoscete l’importanza della sofferenza. Non vi vergognate a piangere. Vede, il problema di noi americani è che ci siamo costruiti un’immagine di noi stessi come… come il primo della classe che non piange mai, il terzino di football che non cede un metro. E poi davanti all’11 settembre siamo crollati. Abbiamo iniziato a soffrire e ci siamo vergognati della nostra sofferenza. Non dovevamo vergognarci. Solo attraverso la sofferenza possiamo capire gli altri. In fondo Dio si è fatto uomo per questo, no? per cercare di soffrire con gli uomini. Quando sono andato in Palestina, la prima volta, non ci capivo un fottuto accidente. Non riuscivo a capire perché si litigassero quelle colline spelacchiate. Ho chiesto in giro, ho provato a farmi spiegare. E ho sofferto. Ho provato a soffrire con loro. Ho capito che una guerra di sessant’anni è una cosa che non si può cancellare in un giorno.”. Junior è anche l’uomo che al termine di un’estenuante trattativa ha fissato i confini del nuovo Stato Federale di Israele in Palestina. “Ci siamo ispirati a quello che ha fatto Clinton con la Bosnia. Come dire: un gran pasticcio, sempre meglio della guerra, però. Gli israeliani possono continuare a chiamarlo Israele, i palestinesi hanno finalmente un pezzo di terra che si chiama Stato. E Gerusalemme è la capitale bilingue, come Bruxelles. Durerà? E che ne so io? Anche la Bosnia, del resto, sta in piedi per miracolo. Mi piace pensare che il tempo giochi a favore della pace”.
Dopo la missione di Bush in Israele, Bush è stato nominato Uomo dell’Anno dal Time, anzi “L’Uomo che ha salvato il Mondo”. “Beh, mi piacerebbe provarci, non dico di no. Ma in realtà i tempi erano maturi per la pace. Ho sempre pensato che una volta risolta la questione palestinese, il Medio Oriente si sarebbe calmato da sé. Resta molto da fare, certo. Iraq e Siria non sono ancora democrazie. Neanche Roma è stata fatta in un giorno. Ma sono felice di poter dire che oggi è un giorno migliore dell’11 settembre 2001. E ne sono fiero”.
“È sicuro di non avere rimpianti?”
“Rimpianti? No, per cosa?”
“Vede, lei si è dato molto da fare in questi anni. Eppure ogni volta che lei fa qualcosa, c’è sempre qualcuno come me che si chiede… che le chiede… perché non ha vinto nel 2000? Oggi il mondo sarebbe molto migliore se lei avesse vinto nel 2000, non trova?”
Sorride. “La Storia non si fa con i Se. Ma le voglio mostrare un’altra cosa”. Apre un cassetto della scrivania. Tiro un sospiro di sollievo: quello che ha tra le mani è un libro. Di carta.
“È un memorandum scritto da Al Gore quando era vicepresidente. Lo sa di cosa parla? Del riscaldamento globale. In quel periodo Gore era un maniaco dell’argomento, lo sapeva?”
“Mi pare di averne sentito parlare, ma…”
“Aveva fatto delle ricerche, si era consultato con gli esperti. Le sue conclusioni erano già piuttosto catastrofiche. Poi ha vinto le elezioni e… puf, tutto scomparso. Troppo impegnato a dar la caccia a Bin Laden. Lo sa una cosa? Molta gente pensa che Gore sia uno stupido. Io lo conosco un po’. È senz’altro un fighetto di città, ma non è uno stupido. È quella sala di Washington che ti rende stupido. La gente non ci crede quando ripeto che preferisco non esserci mai stato. Ma è così”.
“E quindi non si candiderà”.
“No, assolutamente. Non ha visto la spilletta?”
“Ma davvero pensa che Moore abbia qualche chance?”
“Perché no? Abbiamo già avuto un attore alla Casa Bianca, e se l’è cavata piuttosto bene. Certo, non ha il fisico di Schwarzenegger. Ma è 100% americano. Sarà un ottimo presidente”.
“E non diventerà anche lui più… stupido?”
“Più di così? Naaah, difficile”.
chi fa sempre divertire i grandi ed i piccin?
30-08-2007, 16:31Americana, animali, cinema, delitti e cronaca, mafie o camorrePermalink Una delle principali differenze tra la realtà e l’animazione è il topo. Il topo di cartone è istintivamente simpatico: canta, balla e si fa beffe dei grandi. Il topo vero è una bestia orrenda, un parassita e un untore. Questa differenza, che abbiamo tutti afferrato in età prescolare, è uno dei grandi misteri dell'umanità. Perché Disney, tra una varietà infinita di animali esotici e da cortile, si fissò sul topo? Perché Mickey il Topo ha fatto il botto e Felix il Gatto no? Nel Trecento i ratti sui bastimenti che venivano da Oriente portarono un’epidemia di peste che dimezzò la popolazione europea: la salvezza fu un nuovo animale domestico importato dall’Africa, il gatto. Eppure i bambini tifano per Jerry e contro Tom.
Una delle principali differenze tra la realtà e l’animazione è il topo. Il topo di cartone è istintivamente simpatico: canta, balla e si fa beffe dei grandi. Il topo vero è una bestia orrenda, un parassita e un untore. Questa differenza, che abbiamo tutti afferrato in età prescolare, è uno dei grandi misteri dell'umanità. Perché Disney, tra una varietà infinita di animali esotici e da cortile, si fissò sul topo? Perché Mickey il Topo ha fatto il botto e Felix il Gatto no? Nel Trecento i ratti sui bastimenti che venivano da Oriente portarono un’epidemia di peste che dimezzò la popolazione europea: la salvezza fu un nuovo animale domestico importato dall’Africa, il gatto. Eppure i bambini tifano per Jerry e contro Tom.Cosa c’è nella stanza 101? (Winston del Grande Fratello)
E non i bambini di oggi, disinfettati ai limiti della sterilità, che di topi ne vedono solo sullo schermo piccolo o grande. I bambini degli anni '40 che in mezzo ai topi ci vivevano, in case con buchi nel battiscopa e rumori in cantina. Al cinema ridevano (grandi e piccoli) per il topo di cartone; poi rincasavano e controllavano le trappole. Magari il tifo per il topo era il primo accenno di ribellione del piccolo di casa: una specie di solidarietà tra le piccole creature sempre affamate. Ci saranno stati bambini che di nascosto portavano briciole al roditore. Credo che uno dei passaggi cruciali della pre-adolescenza sia quando ti accorgi che Jerry non è poi così simpatico, anzi, a ben vedere è uno stronzo, e cominci a tifare per il suo avversario frustrato. Fine della solidarietà tra le piccole creature: diventi grande, cominci ad avere paura dei germi e a sviluppare il senso della proprietà: giù le mani dalle nostre provviste, parassita!
E questo cos'è? Non ci sono già stati abbastanza cartoni con il gatto e il topo? (I manager della MGM ad Hanna e Barbera, nel 1940).
Ratatouille è un film piuttosto strano, anche per la media della Pixar. Per quanto la consociata della Disney rifugga le trame scontate, tutti i suoi film mantengono un sano contenuto morale, di quelli che si possono condensare in due righe e che mettono d’accordo grandi e bambini (i grandi devono lasciare lo scetticismo nel vestibolo, s’intende): per esempio Mosters & co. dimostra che la fantasia vince sempre sulla paura, Nemo ricorda ai genitori che i figli devono imparare a nuotare da soli, proprio perché il mondo è vasto e alieno come l’oceano; Cars insegna a grandi e piccini il valore dei rapporti umani, che trionfa sulla grande competitività universale. E così via. Anche Ratatouille ha una morale e un lieto fine, ma zoppicano. Sembrano appicicati per contratto.
Tutto ciò per dire che davanti a Ratatouille si sta a bocca aperta per l’esperienza della visione che dà, quasi travolgente. È su questa sensazione di realismo cartoonesco che poi si muove l’amore per i personaggi (Secondavisione)
Il film (che è bellissimo, se non avete la fobia dei topi, ed è andato meglio in Francia che negli USA) non è americano al 100%. L’idea è di Jan Pinkava, britannico d’origine boema, già premio Oscar per un corto. Gli uomini della Pixar devono averne apprezzato soprattutto il senso della sfida: dopo aver creato con Cars un mondo cromato e arrugginito, in cui l’automobile è Natura, i canyon hanno le sagome di vecchie cadillac e le nuvole sono strisce di pneumatici, stavolta si trattava di stravolgere uno degli archetipi dell’animazione: il Topo. Togliere al Topo il cravattino di Jerry e le braghette di Mickey. De-antropomorfizzarlo, riportarlo alla natura, alla sua condizione di scroccone purulento. E poi rimettersi nel suo punto di vista: il punto di vista di un animale braccato, per il quale anche una vecchia zia borgognona è un orco sterminatore, e la sua vecchia spingarda lancia razzi Terra-Aria.
L’altra scommessa era il cibo. L’ultima frontiera del digitale è rendere l’organico coi pixel: le croste croccanti, il verde delle muffe, il ribollire di una salsa. E dopo avere programmato cibo vero e ratti veri, farli interagire in un film per bambini. Trasformare un’orda di ratti sporchi e scrocconi nel personale di un ristorante francese: una sfida impossibile, salvo che nulla è impossibile per gli uomini della Pixar. La morale del film è la sfida stessa: non tutti hanno talento, ma se ce l’hai puoi fare qualsiasi cosa. Puro calvinismo: la fede è un dono che sposta le montagne. Rémy è il ratto aspirante chef, che per cucinare deve servirsi dello sguattero Linguini: il modo in cui impara a guidare il suo strumento umano, tirandogli i capelli per condizionarne i movimenti, è una stupenda metafora del mestiere dell’animatore (e di qualunque arte o mestiere): migliaia di tentativi e ore di lavoro, anche solo per affettare un tubero. Ma se hai talento puoi solo farcela, e infatti Rémy ce la farà. Titoli, fine.
È ingiusto, ma è normale: ai bambini piacciono gli animali piccoli, vispi e birichini.
Ecco, questa è la crosta croccante del film. Quello che c’è dentro, però, è un po’ meno dolciastro: come se qualche spezia europea fosse riuscita a salvarsi anche dopo che Pinkava ha lasciato la Pixar e il progetto è passato a Brad Bird. Il retrogusto amaro si percepisce soprattutto nelle prime sequenza: più tardi, quando si avventurerà in quel mondo pieno di coltelli, carrelli e altre insidie, sarà impossibile non prendere le parti del Piccolo chef. Ma all’inizio della storia Remy non è necessariamente un personaggio simpatico. È il figlio del Capo di un branco accampato nel solaio di una casa di campagna. Il suo fiuto straordinario lo rende prezioso per la sopravvivenza della “famiglia”, grazie alla sua capacità di riconoscere il cibo avvelenato. Per il resto, il padre e i fratelli non hanno la minima considerazione per le sue capacità. Per il padre il cibo è solo carburante, ai fini dell’unica missione di vita: sopravvivere, malgrado gli umani. Di fronte a questi orchi enormi, che massacrano i ratti senza pietà, la famiglia non ha altra scelta che scappare e mangiare, mangiare e scappare, senza dividersi mai.
REMY: Prima o poi il piccolo deve lasciare il nido
IL PADRE: Noi siamo ratti! Non lasciamo il nido! Lo facciamo più grande!
È una vita che Remy non sopporta. A lui piace il mondo degli uomini: gli odori della dispensa, i programmi di cucina, i libri di ricette. Sarà la sua imprudenza a causare la fuga in città della famiglia. In città del resto la vita dei ratti non è molto diversa: la famiglia è sempre la famiglia, e il cibo è sempre carburante. Ma non per Remy. Lui passerà definitivamente dalla parte dei nemici, degli assassini, degli uomini.
Ecco la polpa europea. Remy è un migrante, come Fievel: ma se Fievel sbarca in America era l’epopea nostalgica degli emigranti europei negli USA, Ratatouille racconta l’emigrazione e l’inurbazione con tutta l’ambiguità dei problemi irrisolti di oggi. Gli emigranti hanno due vie (le hanno sempre avute): o si ghettizzano, cristallizzando i costumi e i valori della società di provenienza e isolandosi in un mondo percepito come ostile, o si integrano. Ma integrarsi significa spezzare le radici, tradire la razza. Non ci riescono tutti, e nemmeno Remy, che pure tratta i suoi simili veramente con la puzza sotto il naso. In Africa i tipi come Remy li chiamano noir blanchi, neri imbiancati: eppure anche lui preferisce non tagliarsi del tutto i ponti alle spalle: nottetempo scivola nella dispensa del ristorante che lo ha accolto, e ruba un po’ di roba buona per il fratello. La cosa gli scappa naturalmente di mano, proprio come succede quando la tua famiglia esce dal medioevo e viene a bussare nel tuo superattico per chiederti un favore: il problema di Remy è lo stesso problema di Michael Corleone, è il problema di tutti gli onorati membri della società che hanno ancora qualche legame con le Famiglie.
Ma non ci sono gatti in America! E ti regalano il formaggio! (Fievel sbarca in America)
Verso i tre quarti il film, per quanto divertente, sembra proiettato verso un finale tragico: Remy ha servito gli umani senza riuscire a integrarsi veramente, e intanto la Famiglia che fa affidamento su di lui è sempre più numerosa, sempre più affamata. Poi c’è il finale, appicicato un po’ così, che non racconto: dico solo che è incredibile la sfacciataggine con cui pretende di salvare capra e cavoli, Famiglia e carriera. Quando le cose al mondo non stanno così, decisamente: uomini e ratti non possono convivere nello stesso ristorante. È una cosa che semplicemente non succede, nella realtà.
Tutti in coro noi cantiamo viva Topolin. Topolin, Topolin, viva Topolin, (Full Metal Jacket)
D’altro canto è un cartone animato, e nei cartoni animati i topi sono simpatici e la fanno franca. Detto questo, qui propongo il mio finale: dopo decenni di clandestinità Remy riesce a imporsi come un cuoco degno del genere umano, apre un ristorante a Duisberg, e una sera tutti i suoi parenti vengono sterminati nel parcheggio da una banda di roditori concorrenti. Perché la vita è dura, se nasci ratto. Remy lo diceva già all’inizio del film. Nei film americani poi ti raccontano che anche il ratto può crescere, scoprire i suoi talenti, tradire i famigliari e poi ritrovarli, diventare famoso e apprezzato. Ma gli europei hanno abbastanza Storia da parte per concludere che non è quasi mai vero. E questo è tutto, gente.
contiene sconvolgenti rivelazioni
28-08-2007, 11:26Americana, giornalisti, in edicola, invecchiare, Israele-Palestina, YalePermalink Cadendo, dalle nuvole a terra
Cadendo, dalle nuvole a terraIn Italia la stampa fa mediamente schifo, e si sa; i blog sono solo diari adolescenziali, e quindi uno come fa per tenersi aggiornato? Di solito ci si abbona a Internazionale. C'è il meglio della stampa estera, giornalisti che vivono nel mondo vero e non nell'isoletta di Corona e Briatore, eccetera.
Sull'ultimo numero di Internazionale ho trovato un fondo di Paul Kennedy che mi ha discretamente sconvolto. E' anche on line, così potete farvene un'idea da soli. Kennedy parla di numeri. Ammette che "i dotti editoriali pieni di statistiche invitano anche il lettore più attento a girare pagina. Ma ci sono alcuni articoli pieni di dati che a mio avviso meritano un'attenta riflessione". Kennedy ne cita due che lo hanno addirittura "turbato". Sentiamo.
Il primo è un articolo del Financial Times che documenta la crescita demografica nella striscia di Gaza. "Tra il 1950 e il 2007 la popolazione di Gaza è passata da 240mila a quasi un milione e mezzo di abitanti, a causa dell'alto tasso di natalità delle famiglie palestinesi". Se gli statunitensi fossero cresciuti allo stesso ritmo, adesso sarebbero quasi un miliardo. Questo significa che "ci sono molti più giovani arabi (frustrati, arrabbiati e disoccupati) che giovani israeliani, e il loro numero sta crescendo così rapidamente da renderli incontrollabili. Se questo è vero, allora tutte le missioni di pace degli Stati Uniti o dell'Unione europea potrebbero essere inutili". Pensa un po'.
Il secondo è un pezzo del "Catholic Worker" che già nel titolo censisce la popolazione carcerata USA: "2.193.798 e continuano ad aumentare". Sono raddoppiati in meno di un decennio. Nessun Paese ha così tanta gente in carcere (nemmeno la Cina). Gli europei ne hanno sette volte in meno, in proporzione alla popolazione. Di fronte a queste cifre Kennedy ammette di rimanere confuso.
Io invece mi sono spaventato. E non tanto per la crescita demografica di Gaza, né perché gli americani stanno per avere un carcerato ogni cento abitanti. Mi sono spaventato perché Kennedy è un professore di storia di Yale, che scrive saggi di politica internazionale e ha una sua proposta per riformare l'Onu, e in questo editoriale sta lettteralmente cadendo dalle nuvole. Voglio dire, davvero là fuori c'è qualcuno che ancora non sa che la Striscia di Gaza sta scoppiando perché il tasso di crescita dei palestinesi è uno dei più grandi al mondo? Davvero un intellettuale USA può ignorare che il suo sistema economico e sociale poggia saldamente sul network di prigioni più strutturato e accogliente del mondo? Come fanno a presentare questi dati come novità sconvolgenti, come fanno a non saperle già? E se Kennedy, che sta a Yale, queste cose le ha imparate la settimana scorsa, come si spiega che io, vivendo nell'isoletta di Lele Mora e Materazzi, le so già?
Chi me le ha insegnate? Nemmeno me lo ricordo. Sono cose che mi sembra di conoscere da sempre; tanto che al limite mi aspettavo di leggere su Internazionale un pezzo che le smentisse come leggende urbane. Magari un fondo muffito di Sandro Viola sui ragazzini della prima Intifada. Magari uno di quei reportage di Marco D'Eramo dagli USA, che prendevo con le molle perché erano stampati sul Manifesto, e adesso sta a vedere che il Manifesto guardava più in là. Insomma, salta fuori che anche nell'edicola Italia ci si può fare una cultura.
Si tratta di quei semplici dati che tanti anni fa mi hanno fatto prendere una parte piuttosto che un'altra: se non sapessi che gli americani attingono dalla criminalità reclusa come da un enorme bacino di lavoro sottopagato, magari potrei essere un filoamericano anch'io. Se non sapessi che in Palestina tra qualche anno ci saranno più che palestinesi che israeliani, forse griderei forza Israele anch'io. E invece sapevo queste cose, perché le ho lette da qualche parte e non ho mai trovato nessuno che le smentisse. E non solo le sapevo, ma a un certo punto le davo persino per scontate, le consideravo banalità su cui non soffermarsi, come il due più due.
Ora mi viene il sospetto: ma quelli che mi hanno accusato, prendendosi anche sul serio, di essere antiamericano o antisemita, queste cose le sapevano? Io ero convinto di sì. Ero convinto che le sapesse anche Camillo, anche se magari non ci insisteva troppo. Eppure capita che negli USA un opinionista di area liberal le trovi sconvolgenti. Figurati i neocon, i neodem, i neolib e tutti gli altri.
Ora, qui non si tratta di sentirsi più intelligenti di un prof di Storia che sta a Yale. Per carità. L'intelligenza non c'entra molto con l'accesso alle informazioni: quello che mi schianta è che io, dei prof di Yale, degli opinionisti liberal, della grande stampa americana e internazionale, sotto sotto mi fidavo. Speravo di trovarci un centro di gravità, un brandello di oggettività nel marasma globale. E' abbastanza terrorizzante accorgersi che a volte ne sanno meno di me. Anche perché io, onestamente, non ne so molto.
Ha anche a vedere con la crisi dei trent'anni. Non importa quanto complesso stesse diventando il mondo: fin qui avevo sempre contato sull'esistenza di uomini con la barba grigia in grado di assorbire informazioni e restituire analisi di saggezza. Ma da qui in poi il rischio di imbattersi in rincoglioniti con l'aria da guru aumenta a ritmo esponenziale.
Ormai il mondo è roba nostra, ne rispondiamo noi. E' un'idea che mi spaventa, più di Gaza e Guantanamo. Mi dà le vertigini, o piuttosto l'impressione di precipitare dalle nuvole a un mondo dove ci si aspetta seriamente che io sappia quel che accade. Vien voglia di chiudersi nella stanza, rileggersi i fumetti.
po po po po po po po
24-03-2007, 00:24Afganistan, Americana, avercela con D'AlemaPermalink Il fatto è che in diplomazia siamo fortissimi.
Il fatto è che in diplomazia siamo fortissimi.Non molto spettacolari, ma otteniamo tutto quel che ci serve. Proprio come ai mondiali.
E quindi lo abbiamo fatto: abbiamo scambiato un giornalista italiano con cinque pericolosissimi talebani che ci siamo fatti dare da Karzai – il tutto sotto il naso degli americani – che, in teoria, sarebbero la superpotenza che ha il controllo militare dell’Afganistan. Non solo: mentre combinavamo questo capolavoro, D’Alema era a cena con la Rice, che ufficialmente non s’è accorta di niente. Alla fine si è perfino “compiaciuta per l’esito della vicenda”. In seguito qualcuno (forse Blair) le avrà spiegato che la vicenda consisteva in uno scambio di ostaggi. Una cosa che gli americani non avrebbero mai permesso di fare (l'ultima volta che abbiamo provato a fare qualcosa del genere in Iraq, hanno preso a schioppettate il nostro agente) ma noi lo facciamo lo stesso, perché siamo una squadra fortissimi. Po, po po po po, po.
Due considerazioni brevi, ma non serie:
1) La Rice è un bluff. Non basta essere il secondo Segretario di Stato donna (dopo l’Albright), non basta essere il secondo Segretario di Stato nero (dopo Powell), non basta essere il primo Segretario donna e nero. Chi l’ha poi detto che una donna nera debba esser brava per forza? Non potrebbe semplicemente essere scarsa? Dopo sette anni di pasticci in politica estera non possiamo sempre e solo dar la colpa al Texano con gli Occhi da Macaco. Ti sei fatta abbindolare dai baffetti di un tizio che in Italia di solito fa lo sparring partner di Berlusconi. Può l’esercito più potente del mondo perdere una guerra? Se lo metti in mano a gente così, chissà, vediamo.
2) Forse, dopo decenni di prove e riprove e sforzi di un’intera nazione, ce l’abbiamo fatta: abbiamo trovato un lavoro per Massimo D’Alema. Qualcosa che riesce a fare bene: la diplomazia d’alto bordo. Qui da noi non ce la racconta più da un pezzo, ma là fuori c’è tutto un mondo di diplomatici e segretarie che ci cascano ancora. E allora vai. Ministro degli Esteri a vita. Un altro peso in meno.
antiamerica
23-01-2007, 03:25Americana, Bud SpencerPermalink Il fattore B
Il fattore BMa l’anti-americanismo dev’essere di sinistra per forza? E non mi riferisco, per carità, a quello residuale di neo e post-fascisti. No, guardo più in basso, terra-terra: c’è davvero bisogno di sfoggiare un’ideologia, per farsi stare sulle palle gli americani?
E se fosse populismo, semplicemente, populismo bello e buono? Populismo ipocrita, perché sputa nel piatto atlantico in cui sforchetta avidamente da 60 anni; populismo sacrosanto, perché fondato su episodi oggettivamente difficili da mandar giù: Ustica, Cermis, e tante altre tragedie di cui, non avendo il diritto di conoscere la verità, ci siamo conquistati quello di covare dubbi e dietrologie da qui all'eternità.
Ma scusate: davvero nel 2007, per essere un comunista, mi è sufficiente protestare perché un estraneo pretende di accamparsi perpetuamente in casa mia? Ma ci hanno pensato bene, a destra, prima di montare questa polemica? Perché l’aspirazione a non avere estranei armati in casa è la cosa più naturale e qualunquista del mondo: ha più a che vedere col mito dei sacri confini della Patria (o più semplicemente del mio orticello) che con l’internazionalismo socialista. Insomma, è una tigre che Berlusconi & co. dovrebbero coltivare per primi, invece di lasciare il campo libero a populisti fai-da-te come i noglobbal. E non ci sarebbe niente di male: dopotutto quand'è che Berlusconi sarebbe stato un vero filo-americano? Quando ha prestato un fondale di cartapesta al vertice di Pratica di Mare? O per i due contingenti omeopatici mobilitati per la guerra al Terrore? Forse è anche grazie ad amici così, che Bush si trova nella peste in cui si trova.
E poi, sì, d’accordo, amiamo tutti la cultura americana, i film il rock e così via. Ma non abbiamo mai apprezzato la loro cucina, i loro sport di squadra assurdi e la loro arroganza. È un rapporto complesso, come ogni rapporto tra padrone e sottoposto. A volte prevale l’odio di classe (e Sanguineti è contento), altre volta la solidarietà aziendale. Dipende anche da come vanno le cose.
Ultimamente vanno male, e non è mica colpa nostra. Se volessimo disegnare un grafico dell’antiamericanismo storico, ci troveremmo due picchi: uno a metà anni Settanta, con l’escalation in Vietnam. Una guerra orribile, senz’altro: ma soprattutto, una guerra persa.
L’altro picco arriva dopo l’undici settembre: anche in questo caso, cos’è che ci rende davvero invisi gli americani? Il fatto che combattano tante guerre, o il fatto che non le vincano?
Tra un picco e l’altro, i gloriosi anni Ottanta, quando Reagan vinceva il bluff della Guerra Fredda costruendo missili e guardandosi bene dall’adoperarli: l’operazione militare stelle-e-strisce più eccitante della mia infanzia fu lo sbarco nell’isoletta di Granada (metà dell’impresa consisteva nel rintracciarla sull’atlante).
Detesto Reagan quanto Bush II, ma non posso non notare la differenza: il primo vinceva senza combattere, il secondo fa tutto il contrario. E indovinate un po’: alla gente piacciono i vincenti (Scoop!) Vi disturba l'antiamericanismo? La prossima volta, provate a vincere una guerra.
Nessuno ama gli arroganti, anche quando portano doni. E tuttavia li sopportiamo volentieri – finché sono potenti e ci difendono. Ma se cominciano a perdere i colpi, perdono anche il loro appeal, e il comunismo c’entra ben poco. L’antiamericanismo che annuso in questi giorni ha una fragranza assai più familiare. Sembra di stare di nuovo in quei film con Bud Spencer, gli unici a mettere in scena la vita nell’indotto delle basi americane. Quei film con gli americani alti robusti e biondi, stereotipo di chiara derivazione dagli übermenschen nazisti. Quanto sono bravi, quanto sono tosti, quanta soddisfazione a pigliarli a calci in culo. Non lo faremo mai, ma lo abbiamo tutti sognato da bambini.
E se alla radice dell’antiamericanismo della mia generazione ci fosse soltanto... lui? Altro che Bertinotti. Lo spettro di Bomber, Bulldozer, quel personaggio a mille nomi che comincia sempre per B e finisce sempre col suffisso di Spencer. Il virus dell’antiamericanismo popolare che viaggiava libero in provincia, in un ventennio di sogni 100% americani. L’uomo che rese ridicolo il western, portò il poliziesco a Napoli, sconfisse il contingente NATO a football e poi a boxe. E adesso milita in Forza Italia. I suoi film vanno in onda ogni sei mesi, su Rete 4. Berlusconi ci dovrebbe fare un pensiero: tenersi caro Bush II, o Carlo Pedersoli? Io non avrei dubbi, è chiaro. Ma ognuno ha il fattore B che si merita.
- è già ottobre
02-10-2006, 01:26Americana, autoreferenzialiPermalinkSul serio? Mi sembra di star bene.
Non fosse per qualche sciocchezza ogni tanto. Per esempio: per strada sorrido ancora agli sconosciuti. Me la farò passare.
- i want to be a part of it
11-09-2006, 03:2011/9, Americana, anniversariPermalinkMa questo 11 settembre 2006, non vi sembra un po’ in ritardo?
In che senso? In nessun senso. Indubbiamente oggi è l’11 settembre 2006, eppure: cinque anni? solo cinque anni? In America sembravano almeno sette, otto. Quattro euro fanno cinque dollari, non sarà così anche per gli anni? Di là il tempo passa più in fretta. O succedono più cose. O c’è più tempo per pensarci sopra. O altri motivi che conosco.
Insomma, non ho la minima idea del perché, ma posso scommettere una cosa. Scommetto che stamattina capiterà a tutti voi, tra Internet tv e giornali italiani, di imbattersi nel Pezzo Autoreferenziale Tipico Sull’11 Settembre. Quello, per intenderci, scritto rispettando la seguente scaletta:
L’11 settembre di cinque anni fa io ero [da qualche parte] a [fare qualche cosa], quando mi dissero che le due torri erano crollate [oppure lo vidi alla tv, o il telefono, internet, l’autoradio] e pensai: niente sarà come prima.
Fine.
Oltre ad averne letti e straletti, di pezzi così, a volte li abbiamo pure scritti: in fondo a cosa serve un blog, se non puoi nemmeno raccontare dov’eri l’11/9/01? Qualche anno fa qualcuno organizzò persino un blog collettivo per raccogliere tutte queste cose autoreferenziali che, evidentemente, interessavano ancora a qualcuno. E oggi? Oggi credo di no: se il genere sui media va ancora forte, è per inerzia, o più semplicemente perché raccontare i fatti propri è un modo molto economico di riempire colonne. E anche in tv dopo i soliti filmati (più o meno gli stessi), qualche servizio sulle esequie ufficiali, qualche clip inedita o rara di Bin Laden, di spazio probabilmente ce n’è. Si potrebbe occupare con qualche riflessione (tenendo sempre presente che Niente Sarà Come Prima); ma il rischio di dire banalità è tale che forse è meglio sorteggiare un Vip a caso, telefonargli e chiedergli: Dov’Eri Tu l’11 Settembre?
Ecco, la mia sensazione è che oltre Atlantico questa fase sia abbondantemente superata. Nessuno si è dimenticato l’11/9 (anzi): ma l’autoreferenzialità sulla grande tragedia che ha inaugurato il secolo è finita – del resto i secoli, una volta inaugurati, devono andare avanti. E così, mentre in Italia continuiamo a tirar fuori i nostri vecchi album dell’11 settembre, negli Usa ci si interroga sulla più grande tragedia americana della storia recente: che non è più l’11/9, ma Katrina.
Qui non si tratta di stabilire quale delle due tragedie sia stata più grave, o più simbolica, o più luttuosa. Né di tifare per il documentario di Spike Lee contro il film di Oliver Stone. L’idea di un settembre 2001 e un settembre 2005 l’un contro l’altro armati, di una tragedia “di sinistra” (l’uragano) da contrapporre a una tragedia “di destra” (l’attentato più cruento e spettacolare della Storia), è una sciocchezza. Piuttosto val la pena di chiedersi: perché in Italia si continua a parlare così tanto di 11/9 (anche in mancanza di cose da dire) mentre Katrina ha forato così poco? È solo una questione di ritardo, come coi telefilm? Stiamo aspettando il doppiaggio? Due ipotesi.
Prima ipotesi: l’11/9 è semplice. Un grande vecchio cattivo decide di umiliare la nazione più potente del mondo con un diabolico piano. Il piano funziona, uccidendo migliaia di persone, ma la nazione attaccata reagisce compatta. Tutto qui. Qualunque storico o politologo potrebbe spiegarlo in modo più complesso, ma in sostanza l’11/9 si può ridurre a questo: una storia con buoni e cattivi che si può spiegare ai bambini. Pochi episodi della Storia si prestano a un’interpretazione così rassicurante. A me viene in mente soltanto la Seconda Guerra Mondiale: anche lì, gira che ti gira, buoni contro cattivi – coincidenza, di solito chi ha il pallino dell’11 settembre ha anche il pallino della guerra antinazista: buoni contro cattivi, e indovina un po’ da che parte stiamo noi.
Katrina, per contro, è la classica catastrofe postmoderna, con una lista di responsabili che non finisce più. Si va dal Padreterno – che poteva darci un pianeta meno turbolento – al Presidente Usa che misconosce il riscaldamento globale e taglia i fondi, al Governatore che non li investe in dighe, alla polizia che prima spara poi chiede, giù giù fino al singolo cittadino che, appena tagliano la luce, si sente autorizzato a rinnegare la civiltà e saccheggiare quanto può. Chi è il buono? Nessuno. Non è una storia che possa veramente piacere a noi bambini.
Seconda ipotesi: l’11/9 è chic. Mentre in fin dei conti, Katrina è solo un uragano. Sì, d’accordo, un uragano che affonda e getta nel caos una metropoli del Paese più potente del mondo ha qualcosa di eccezionale: ma un uragano per noi sarà sempre Terzo Mondo.
L’11 settembre rimane la nostra tragedia perché, alla fine dei conti, New York rimane la nostra città: l’orizzonte a cui aspiriamo. E questo spiegherebbe anche il nostro delirio autoreferenziale: perché continuiamo a raccontarci che eravamo in autostrada, o al lavoro, o dormivamo, e ci siamo fermati in un bar, o davanti a una vetrina di tv… chi se ne frega? Raccontarci serve a sentirci parte di una comunità ricca, affermata, improvvisamente minacciata nel suo simbolo più alto e prezioso. Eravamo sulla Tangenziale Ovest, ma ci sentivamo sulla West Side Highway; oppure eravamo in ufficio, ma in quel momento il nostro ufficio era la succursale del centro direzionale più alto del mondo: ci affacciavamo alla finestra e gli aerei che decollavano dal Marconi ci strappavano un brivido. Ci sentivamo tutti newyorkesi, era terribile ma anche fantastico.
Sentirsi neworleansiani, invece, fa schifo. La possibilità – nemmeno tanto remota – che anche il mediterraneo possa essere scosso da qui a qualche anno da catastrofi da Paese tropicale, non ha nulla di cool: è deprimente e basta. Per un disastro da Terzo Mondo possiamo commuoverci, perfino mobilitarci (basti pensare al diluvio di offerte che seguì lo Tsunami): ma immedesimarci, questo no. Abbiamo ancora un certo contegno.
(Eppure intanto l’America va, e noi arranchiamo).
- the kindest, bravest, warmest, most wonderful people
20-08-2006, 05:26Americana, cinema, tvPermalink Remote Manhattan
Remote ManhattanPer dirti che tipi sono i niuiorchesi: non si perdono uno show.
Oggettivamente, non possono.
Per prima cosa sono antennati, anche se non se lo ricordano più (quei bastoni di ferro sui tetti, ricordate? No). Poi sono tutti cablati. Il telecomando della tv via cavo è un affare in cui ti perdi, i canali non finiscono mai, se ti distrai c’è il rischio di non ritrovare mai più quello in cui ridanno la prima stagione dei Jefferson o le puntate della Casa nella Prateria inedite in Italia (ma se sei quel tipo di persona che riesce a vedere solo Law & Order, c’è anche il canale che dà solo Law & Order).
Volendo – e inserendo la carta di credito nella fessura – ci sono anche le donne nude, mi è parso di capire.
Se proprio va male, c’è Tivo: l’affare che salva i programmi su un disco rigido, cancellando automaticamente le pubblicità, si capisce.
E se malgrado tutto ciò non si trovasse niente di buono, c’è il DVD – perlomeno, credo che ci sia: non lo abbiamo chiesto, non volevamo sembrare retrogradi, ma qualche dvdnolleggio in giro s’è visto, quindi – ah, e poi c’è Internet. Wireless più o meno dappertutto. Mal che vada contenuti se ne trovano anche lì.
Se uno è proprio temerario, può persino andare al cinema. È un po’ più caro che da noi, ma c’è di tutto. Il festival del film brasiliano, la rassegna sul popolare cineasta madrileno, e qualsiasi film uscito negli Usa nell’ultimo semestre, direi. Compresi quelli che già trovi su cavo. Insomma, per perderti qualcosa devi impegnarti.
Così uno se li immagina un po’ scafati, questi niuiorchesi, salottari e selettivi. In fondo Manhattan è fatta a forma di telecomando, ogni block è un canale diverso e danno la sensazione di non finire mai. Finché non finisci a Bryant Park, tra la Quinta e la 42ma, la sera che proiettano all’aperto The Manchurian Candidate. Un film degli anni Sessanta, in bianco e nero, con Sinatra.
Secondo voi si fa vedere qualcuno? Un film in bianco e nero degli anni Sessanta, disponibile in ogni casa in vhs, dvd, cavo e tivo? Una cosa che persino in Italia svenderebbero in edicola con un quotidiano? Proiettato su un telone bianco stile Festa dell’Unità, con un’acustica impossibile (rimbalzante su grattacieli di 40 piani)?
Ebbene, i niuiorchesi sono fatti così. Per vedere the Manchurian Candidate con Sinatra, in bianco e nero e acustica pessima, proiettato alle nove di sera in Bryant Park, si appostano tra i cespugli sin dalle quattro del pomeriggio. Quando i poliziotti aprono i cancelletti, si gettano a occupare il verde coi tappeti. Dalle cinque alle nove, si inganna il tempo con chips e frappuccini. E quando finalmente parte la sigletta scema dell’iniziativa, ci si alza in piedi e ci si libera alla danza. I niuiorchesi sono fatti così.
Oppure erano tutti turisti. Comunque il parco era pieno, dalle cinque in poi.
- viaggiano i perdenti - piu' adatti ai mutamenti
04-08-2006, 16:08Americana, segnalazioniPermalink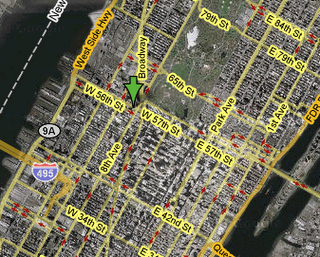 New York, NY
New York, NYIo (ma potrei anche dire, ed era ora, Noi) andiamo a stare li', per un paio di settimane.
Non possiamo ospitare nessuno - regolamento di condominio - ma se siete nei pressi, scrivete, si va a prendere un frappuccino al pomodoro frizzante, cose cosi'.
Aggiungo che a NY gli alberghi sono assai cari, ma per fortuna su internet c'e' la possibilita' di concludere affari interessantissimi con tutti gli niuiorchesi che subaffittano d'estate, su siti che non ho nessuna intenzione di consigliarvi - piu' tardi arriva la massa dei vacanzieri italiani meglio e', sorry.
- XXX hot girls inside
03-08-2006, 15:48Americana, pubblicità, sessoPermalink Sex lime
Sex limePer dirti come è strano il mondo: apri uno yogurt. Non è molto virile, lo so.
Ma non hai tempo di cucinare, hai solo 5 minuti per mangiare, gli snack ti fanno paura e nel frigo comunitario della biblioteca c’è spazio, appena, per uno yogurt. Al sapore di Lime Cake, torta al Lime. Voi avrete le vostre idee sul Lime: per me, è solo una variante gay del maschio limone. Comunque mi piace.
Apri lo yogurt e inizi a scucchiaiare, distratto, finché ti accorgi che stai cercando di leggere una cosa. (Deformazione professionale. Nulla di scritto resterà non letto).
Stai fissando la stagnola – la stagnola che funge dal coperchio agli yogurt, avete presente, quella che fino ai 16 anni è consentito leccare in società. Tu ne hai più del doppio, quindi mentre mangi fissi i resti di yogurt che colano dalla stagnola. Colando, lasciano intravedere una parola. girls.
No anzi, ggirls.
No, anzi, vu vu vu gggirls eccetera. Un sito. Un sito di donnine. La pubblicità di un sito di donnine. Stampigliata sul lato interno del coperchio di stagnola di uno yogurt. Al sapore di torta al Lime. Acquistato in Connecticut, USA, nel 2006 dC, Terzo pianeta dal Sole, braccio periferico della Via Lattea, universo.
In questo stesso universo, qualcuno (qualcuno che ha studiato), ha preso un sito di donnine nude, uno yogurt alla torta di lime, e ha pensato che poteva funzionare. Non un sacchetto di patatine. Non la linguetta di una lattina di birra light. Non un barattolo di ravioli. Uno yogurt alla torta di lime.
Ma non funziona, vero?
Scusate. Adesso che ci penso. Mi è venuto in mente che. Devo controllare una cosa su un sito. Ci sentiamo domani forse.
- f*** you, NY
02-08-2006, 15:08Americana, cinema, telefoniaPermalink Non dovrebbe essere un italiano a dirlo, tuttavia: coi cellulari, gli americani, si devono dare una regolata.
Non dovrebbe essere un italiano a dirlo, tuttavia: coi cellulari, gli americani, si devono dare una regolata.Io lo giuro, croce sul cuore che possa morire, in 20 giorni non c’è stata una che è una sola conversazione che non sia morta sullo squillo di cellulare. Non una.
Probabilmente non stavo dicendo nulla di importante, ma invece fossi per rivelare il Senso della Vita, eh? Ebbene Caroline, Eddie, Steve, Ju, Pablo, il Senso della vita consiste nel fatto che…
Drin.
No, macché Drin! Le polifoniche, ci hanno! Le polifoniche.
Uno cerca di razionalizzare. Non succederà la stessa cosa anche da noi? Solo che è meno facile accorgersene perché, appunto, a conversare ci abbiamo rinunciato da un pezzo. La novità non è tanto essere negli USA, ma aver lasciato a casa il cellulare.
Ma un momento. Le cassiere dei drugstore? Gli impiegati agli sportelli? E’ il quarto in due giorni che secco perché deve interrompere una comunicazione personale.
- Scusi, eh, volevo sapere quanto verrebbe un abbonamento dei treni per…
Ti sbatte il volantino in faccia e riprende a spiegare la ricetta degli spaghetti alle polpette dentro. Ma che ti vadano di traverso.
E' che da noi ogni novita' arriva sempre accompagnata da qualche sano anticorpo scettico. Appena arrivato, il cellulare produsse il suo stereotipo negativo, il truzzo da cellulare. Qui no. Non c'e' nessuna vergogna, nessun limite fissato dalla decenza, in effetti forse non c'e' il senso della decenza. Lo stereotipo e' positivo, e' Veronica Mars che con un cellulare riesce a farti i raggi X e li scansiona subito al laptop per forwardarli all'FBI.
Il rovescio della medaglia, è che i telefoni pubblici sono sprofondati nella più deregolata e disservizievole anarchia. Hai un quartino? Te lo mangio. Compri una tessera prepagata? Per usarla ti serve il quartino. Al quarto tentativo prende la linea uno stronzo del consumer care molto seccato perché l’ho interrotto al cellulare con la fidanzata.
“Il suo numero di Carta di Credito, please”.
“Eh? Sto solo cercando di telefonare…”
“Lo so. Per metterla in contatto col numero richiesto mi serve il suo numero di Carta di Credito, please”.
“Ma ho appena pagato una prep…”
“Ci-dispiace-questo-servizio-non-è-disponibile, ho bisogno del suo numero di Carta di Credito! Ha capito! La tua Carta di Credito! Voglio sapere che numero ha!!! Parla la mia lingua? Mi capisce?”
“No”.
Mette giù lui.
Sono in un Ed-Norton-allo-specchio-nella-25ma-Ora state of mind. Un giorno, con molta calma, amerò New York, ma non oggi.
Stasera sogno di un grattacielo che piano piano s’inclina, un difetto strutturale, si appoggia a un altro grattacielo e scatabreaaaaaang! Tutti giù a domino. E piangi, piangi, bambino del romanzo di J. S. Foer. Che la mamma ti compera un tamburino.
Quel tipo di fantasie che faceva il giovane Osama quando capì che le bionde ci stavano – e di malagrazia – solo per via dei petrodollari.
- it's wonderful
01-08-2006, 15:34AmericanaPermalink La questione della lingua
La questione della linguaE con la lingua, in America, come va con la lingua, eh? Eh?
Va molto bene.
Il mio inglese è wonderful. Me l’ha detto una insegnante di conversazione. Proprio così wonderful. Me lo confermano un po’ meno tutti. Chi dice very good, chi dice really good. Io ringrazio.
Poi si mettono a parlare e non ci capisco nulla.
Quando sei in Inghilterra, ti danno dell’Americano.
Sbarchi in America, e loro han quasi l’aria di scusarsi: bello il tuo inglese, ma noi parliamo così. Al massimo ti fanno il grande favore di parlarti espanol.
E’ inutile chiedergli di parlare più lentamente, perché non lo sanno fare. Come a chiedere a un cinese di non cantare mentre parla: ma se smette di cantare le parole perdono il significato.
Nella mia Scuola Media di paese ci si poteva permettere una sola prof di inglese, e quindi per andare in una classe di inglese serviva il sorteggio (i ricchi non si erano ancora accorti di quanto l’inglese fosse importante – o forse non c’erano ricchi, ancora).
Io fui sorteggiato, e ricordo, ero felice come una Pasqua. Avrei imparato l’inglese! Di lì a un anno, due anni, tre? avrei compreso i testi delle canzoni! Quando Sting cantava (in falsetto), io avrei capito quel che cantava. Era mai possibile?
Imparare un’altra lingua mi sembrava qualcosa di magico. Come un sesto senso, impossibile da spiegare a chi non lo ha. Come fai a spiegare a un cieco alla nascita cos’è la vista? Avrei capito cosa dicono gli americani. Sembrava impossibile, e invece era vero!
Invece era impossibile.
16 anni sono passati da allora: una licenza media, una maturità (linguistica) ottima, qualche viaggio, e adesso è tempo di rassegnarsi. Non li capirò mai.
Ho anche fatto il traduttore! Traducevo libri! Mi ero messo nel mercato come traduttore dal francese, salvo che quel mercato non esiste praticamente piu', i francesi hanno smesso di scrivere libri interessanti. E allora mi sono buttato sull'inglese, una scuola di umilta' incredibile. C'e' sempre una parola importantissima che tu non avevi mai sentito, c'e' sempre un modo di dire che ti spiazza.
Ma in fondo quando traduci non e' cosi' importante sapere l'inglese, l'importante e' saper scrivere in italiano. So che ci sono intere biblioteche accademiche sull'Ubersetzungtheorie che mi smentirebbero, ma si fottano.
Il problema, con gli americani, e' solo uno: cosa-c-stanno-dicendo-a-me-in-questo-preciso-momento?
L’unica cosa che mi riesce per ora è sommergerli io per primo di parole, prima che loro possano accorgersi che io non li capisco quando m’interrompono. Questo mi viene abbastanza bene. La mia coinquilina ha preso quest’abitudine, a tarda sera, di versarmi da bere e osservarmi parlare. Ogni tanto dice qualcosa e io dico yeah, yeah, e continuo. Si diverte.
Se non squilla il cellulare possiamo andare avanti fino alle due.
Di solito squilla.
- punk rock drives me crazzzz.......
30-07-2006, 06:26Americana, concerti, musicaPermalink- rice and fall
27-07-2006, 07:06Americana, migrantiPermalinkNel frattempo tutti non fanno che chiedermi: e nel futuro? Come saranno gli americani del futuro? Ebbene, io mi sono posto il problema, ho anche fatto delle proiezioni. E dunque. Dal mio punto di osservazione mi sembra indiscutibile che:

1. Gli americani del futuro avranno gli occhi a mandorla
2. E parleranno spagnolo.
1 + 2 = In pratica, un altro mezzo miliardo di filippini.
E segnatevi questo: voi forse no, ma i vostri figli prima o poi assisteranno alla trasmissione di un discorso di un presidente di cognome Mendoza o Cortes, faccia da Vietkong, che proclama la necessità di difendere lo stile di vita occidentale dalle minacce asiatiche, e quel che è peggio è che ci crederà davvero, e i vostri figli pure.
Poi ci sarà anche il drammatico summit, col presidente usa che guarda negli occhi il presidente comunista cinese, e a un certo punto gli dice: ma tu non è che vieni dalla manciuria, per caso? Sai, perché io ho ancora dei parenti laggiù. Ma no! Ma sì! Paisà! Spaghetti di riso! Melodie pentatoniche! Cani spariti in circostanze misteriose nei dintorni di friggitorie! Pacche sulle spalle, e poi si andrà con le delegazioni in un posticino all'angolo del Palazzo di Vetro a mangiare il pollo alle mandorle del Kentucky.
Ridete, ridete.
Il riso abbonda.
- piano americano
25-07-2006, 06:18AmericanaPermalink Se sei così furbo
Se sei così furbo"L'America è la più ricca nazione della Terra, ma i suoi abitanti sono per lo più poveri, e i poveri americani sono spinti a odiare sé stessi. Per dirla con l'umorista americano Kin Hubbard, "Non è una disgrazia essere poveri, ma aiuta". E in effetti essere poveri è un crimine, per loro; eppure l'America è una nazione di poveri. Ogni altra nazione vanta tradizioni popolari di uomini poveri, ma estremamente saggi e vortuosi, e pertanto più degni di stima dei ricchi e dei potenti. Nessuna fiaba del genere viene mai raccontata dai poveri americani. Essi si disprezzano tra loro, e glorificano chi sta meglio. La più umile delle mense, il più misero dei bar, gestito da un uomo che è egli stesso un povero, avrà probabilmente sulla parete un motto che dice: "Se sei così furbo, perché non sei ricco?" Ci sarà anche una bandiera americana, non più grande della mano di un bambino - incollata a un contenitore di lecca-lecca, che garrisce dal registratore di cassa.
L'autore della monografia, un nativo di Schenectady, New York, aveva secondo alcuni il Quoziente d'Intelligenza più alto mai registrato tra i criminali di guerra condannati all'impiccagione. Così va il mondo".
Kurt Vonnegut, Mattatoio n. 5; nella mia traduzione (brutta).
- se solo imparassi a pronunciare "espresso"
20-07-2006, 07:54AmericanaPermalinkNon lo avrei detto, ma per ora la cosa che mi piace di più in America è il caffè. Non dico la broda marrone.
Mi piace andare in un caffè, prendere qualcosa e sedermi. Coi muffin e coi cookie si va abbastanza sul sicuro. Non costano molto e c’è la rete wireless. C’è anche una climatizzazione bella gelida, ovviamente, che in altri giorni mi è sembrata pleonastica, ma ora no, ora è benedetta.
New Haven è una piccola città di contraddizioni, che dalla vetrina del caffè almeno si vedono. C’è la matricola di Yale che ciatta con la famiglia e l’operaio col casco dal cantiere qui di fianco. La mendicante che in teoria vende fiori. Un tavolo di colletti bianchi a riunione ed il barbone che è venuto a prendere il fresco. E una ciambella. C’è il PHdando in ingegneria che prepara un esame e ci sono io, con una cuffia da centralinista, che parlo italiano a qualcuno che non c’è.
Nessuno disturba nessuno, abbiamo tutti le nostre cuffie, il nostro monitor, la nostro daffare. Ma nemmeno ci ignoriamo.
(Sarà capitato a qualcuno, almeno una volta, di ciattare col dirimpettaio).
C’è il tizio tipo Hemingway, non è colpa sua se ha una barba simile (o forse sì?) che quando passa il cameriere portoricano con lo scopettone gli dice: sai da cosa si riconosce il Maestro in un tempio buddista? Il cameriere sorride, perché questa è la politica aziendale, e Hemingway riprende: è quello che ti viene incontro con lo scopettone, quindi vai avanti, fa il tuo lavoro! C’è un tizio con la kippah, del resto Dio è in ogni luogo e quindi anche al caffè.
Ma soprattutto ci sono i laptop. Un tavolino, un cliente, un laptop. Tutti a scriversi qualcosa. Tanti scrittori al caffè non li hai visti mai, neanche a Parigi (hai mai visto davvero uno scrittore in un caffè di Parigi?) Tanta scrittura mette soggezione.
C’è chi si porta il lavoro da casa. Ma c’è chi a casa ci potrebbe essere già, qui la giornata di lavoro è abbastanza corta. Si parte presto e si fanno sei ore filate, no pausa pranzo. E questo ci porta al grande problema di tutta la civiltà anglosassone: se alle due del pomeriggio non ti reggono le palpebre, dov’è che puoi schiacciare un sonnellino?
- in a big fat country
19-07-2006, 07:08AmericanaPermalink ...and the land of fat-free
...and the land of fat-freeLa maggior parte delle persone vive la propria vita in uno stato di tranquilla disperazione. È uno schifo.
Prendi il popolo più potente di tutti. Non dovrebbe godersela? Ha bandierine piantate in tutto il porco mondo. È il club in cui tutti vorrebbero entrare. Ti aspetteresti un ambiente rilassato, democratico, e insieme elegante.
E invece per strada c’è un sacco di gente per niente rilassata, per nulla elegante, che ti guarda dal basso in modo affatto democratico. Sotto la crosta del benessere c’è una polpa piena di poveri. Bianchi, neri, misti, li riconosci subito, i poveri. Da cosa li riconosci?
Sono grassi.
Il ventre molle dell’America è veramente molle.
Se ci pensi, è stata una trovata geniale, gonfiare i poveri. Cosa c’è di meno dinamico di un obeso? Cosa c’è di meno refrattario a una rivoluzione?
La povertà obesa è stabilizzante. Fa a pugni con tutto quello che sapevamo del mondo e di come cambiarlo. Se Marx avesse visto i poveri obesi, forse avrebbe riformulato qualcosa. Troppo tardi.
Vai a far la spesa. È tutto fat-free (la salsa di pomodoro?), è tutto light (la birra!), è tutto diet. Se non possono toglierci i grassi, ci tolgono il sodio. È tutto un gioco a sottrarre. E poi.
E poi volti l’angolo è c’è lo scaffale di junk. In confezioni così grandi, da noi, si vende solo la terra da giardino. Tutto fat-free, tutto light, come no. Nella nazione fat-free, si è grassi perché non ci si può permettere il prodotto dietetico. Da una parte i vincenti, light e affusolati. Sono quelli che vedete nei telefilm. Dall’altra il bestiame, nutrito a pastone. Non si ingrassano così da noi i maiali?
L’obesità è una forma di dipendenza, ma rifletti. C’è una dipendenza che dà meno problemi sociali? Gli alcolisti fanno troppi danni. Gli eroinomani rubano, e muoiono troppo presto. Un obeso ha un suo costo, ma: è in grado di lavorare – la sua stessa stazza lo protegge da atteggiamenti devianti (il furto, l’omicidio) – e last but not least, muore relativamente in fretta – la collettività non dovrà pagargli decenni di pensione. L’obeso non è il cittadino perfetto, ma per qualcuno può essere il cittadino ideale.
L’obeso ha bisogno di mangiare. Ha bisogno di muoversi in automobile. Ha bisogno dell’aria condizionata, seriamente, sennò schiatta. L’obeso ha un sacco di bisogni. Voterà per chi glieli difende.
Ed è questo che mi schifa del mondo: che è fatto male, brutto e senza redenzione. Da un Paese che brucia il 70% delle risorse, chiederesti almeno un po’ di bellezza, un po’ di classe. No, il 70% di tutto quel che c’è al mondo serve a ingrassare un enorme parco elettori.
È uno schifo ed è tutto quel che abbiamo.
- home is where
18-07-2006, 05:49Americana, autoreferenzialiPermalinkHo pensato a due cose, ieri, mentre cercavo di fotografare un bidone della spazzatura.
La prima cosa: posso capire gli scoiattoli, ma è possibile che nemmeno i bidoni mi stiano in posa? Cosa c’è che non va nelle mie mani? Perché il mondo mi sfugge via sempre in questo modo? Non è che prenda il volo: si sposta appena di un attimo: era lì, flash, non c’è più. Faust ci scommise qualcosa col diavolo.
La seconda cosa: che diavolo sto facendo? Una foto? A un bidone? Della spazzatura? E poi? La farò vedere ai miei amici? La posterò sul sito? Ci tengo così tanto a far vedere che anche in America producono spazzatura? Sì, ne producono, spesso in misura eccedente ai bidoni. Scoop!
Ma è sempre stato così, se ci penso. In Francia fotografavo solo i palazzoni (gli HLM), belle campiture grigie appena arrosate dai tramonti. Ce n’era uno annerito dal fumo di un incendio, ne andavo pazzo. Sullo sfondo massaie magrebine si recavano ad Auchan con carrelli arrugginiti. Fermati palazzone! Sei così bello! Sorridi! Ti mostrerò ai miei amici. Io non sono mica normale.
 Anche nel mio quartiere, tra tante case di legno, ce n’è una bruciacchiata. È stata la prima foto che ho provato a fare. Insieme al negozio di liquori all’angolo, che segna il punto di non ritorno: da lì in poi si incrociano solo facce scure.
Anche nel mio quartiere, tra tante case di legno, ce n’è una bruciacchiata. È stata la prima foto che ho provato a fare. Insieme al negozio di liquori all’angolo, che segna il punto di non ritorno: da lì in poi si incrociano solo facce scure.E i panzoni al concerto di Kenny Rogers.
E i bidoni della spazzatura.
Tutto questo credo che faccia parte di un training inconscio per autoconvincermi che sto bene dove sto di solito, a Modena cioè. È un fatto che appena viaggio un po’, inizio a notare che c’è un sacco di poveri in giro. Sul serio, ce n’è molti, dove non te li aspetteresti.
Ma è solo un modo polemico di porsi verso la nazione ospitante. I poveri ci sono anche nella mia città, ma io non è che ogni mattina vada a fotografarli in Viale Gramsci. Da cui questa mia nuova definizione di casa: Casa è dove i poveri non si fanno più notare.
 Stessa cosa per i negozi. È vero, non c’è modo di far la spesa se non si è motorizzati. Il drugstore più vicino è a 40 minuti di marcia. La civiltà della macchina, si sa, gli ampi parcheggi. Però. Provate a trovare un supermercato in centro storico a Modena, dai, provateci.
Stessa cosa per i negozi. È vero, non c’è modo di far la spesa se non si è motorizzati. Il drugstore più vicino è a 40 minuti di marcia. La civiltà della macchina, si sa, gli ampi parcheggi. Però. Provate a trovare un supermercato in centro storico a Modena, dai, provateci. E le persone. È un fatto che non ti si filano, ma in fondo, perché dovrebbero? Essere stranieri è all’ordine del giorno, qui; e metà dei commessi ha gli occhi a mandorla, tu che pretendi? Per strada, al caffè, chi non ha le cuffiette sta parlando al cellulare, non c’è proprio modo di attaccar bottone. Però.
Però, in due anni che sto a Carpi, ho mai attaccato discorso con qualcuno? Al bar, per strada, in fila alle poste? No. La differenza è che ero a casa mia, e gli estranei erano qualcosa da cui difendersi. Da cui un’ulteriore definizione di Casa: casa è quel posto dove non ti preoccupi più di essere solo.
Quasi non te ne accorgi.
- no pigeons
13-07-2006, 16:32Americana, animaliPermalinkInvece, sapete cosa non c’è, qui, di cui non si sente affatto la mancanza? Gli stramaledetti piccioni! Niente gugu, niente flapflap, niente odore di merda, niente! I Padri Pellegrini li hanno lasciati a casa! E han fatto bene.
Ci ho messo un po’ a rendermene conto. Di solito non guardo gli uccelli. Non li guardo perché sono sempre i soliti grassi e puzzolenti pennuti grigi che mai appresero ad atterrare sugli alberi, un particolare che Darwin si è guardato bene di approfondire. In confronto a loro i polli hanno un’aria intelligente.
Qui invece non smettevo di fare a caso ai volatili.
Ci sono i pettirossi. Una specie di merlo ma col petto rosso pure lui. I rondoni. I passeri di città, quelli con le macchie sul collo, che quando ero bambino c’erano in effetti anche nella mia città, ma poi li ho visti sempre meno, soppiantati immagino dai grossi bombardieri grigiopuzzolenti. Finché non mi sono reso conto che la differenza è tutta qui. No pigeons, ha-cha-cha-cha. Niente macchie bianche sulle cadillac (devo ancora vedere una cadillac).
Io sono uno storico abitatore di sottotetti, il mio odio per i piccioni è etnico, totalizzante. E magari per gli americani di qui si tratta di un pennuto raro e simpatico, da fissare con la stessa aria scema con cui io fisso gli scoiattoli. Non vedono l’ora di venire a Piazza San Marco e nutrirli di costoso granturco. Vagli a spiegare che sono loro i veri ratti alati, B52 del guano, vettori di quanto al mondo v’è di più fetuso.
Una volta ero a Edimburgo. Stavo accompagnando in vacanza una comitiva di ragazzini francesi quasi tutti musulmani, compreso uno che in realtà era vietnamita. Era il suo modo per farsi accettare (non funzionava). Era una bella giornata – ricorderò sempre Edimburgo come una città soleggiata – e picnicando nel parco, io mi misi a spiegare al vietnamita musulmano francese che provava ad acciuffare i piccioni che era impossibile riuscirci, perché lui ha gli occhi sui lati della testa, e quindi ti vede anche se gli arrivi da dietro, lo vedi? (gli dicevo), lo vedi? (e intanto inseguivo un pennuto rognoso), non li beccherai mai! E credevo in questo modo di assolvere un ruolo educativo.
Quando da un cespuglio spunta fuori una signora, e io non so come, ma capisco subito che lei è inglese, forse dall’accento? Davvero avevo un orecchio così buono? O forse semplicemente perché in due sillabe si era già precisata come una monumentale stronza?
“Ma non si vergogna! Ho visto tutto, sa!”
“Eh? Mi scusi, io stavo soltanto…”
“Ho visto bene cosa stava facendo! Ho visto bene! Lei stava insegnando a questo ragazzino come dare la caccia a queste amorose creature! E’ una vergogna!”
“Ma no, in effetti stavo solo spiegando che…”
“E magari lei si considera un educatore! Sono inorridita! Torturare questi graziosi pennuti!”
La signora non faceva che assecondare il suo zelo animalista. Non sapeva che in quel momento stava rappresentando un’intera nazione. Non sapeva che nel cervello, indubbiamente un po’ razzista, del suo interlocutore, in quel momento la cellula cerebrale che conteneva l’input “inglesi” stava per accogliere per sempre l’input “non sanno distinguere un bell’uccello da un contenitore alato di merda”.
D’altro canto, lei rincasando a Newcastle probabilmente ha concluso che gli italiani sono la feccia della terra. Importunano i piccioni nei parchi.
O mi ha preso per un francese. E magari non era neanche inglese, era di Cork.
L’Europa è così complicata, vista da qui.
- foto vere arriveranno
11-07-2006, 15:44AmericanaPermalinkFoto non fatte
Tutti hanno un lettore qui, ovviamente. Sui marciapiedi è tutto uno svolgere e riavvolgere di cuffiette. Ognuno è nella sua scaletta personale – ma agli incroci, invariabilmente, c’è un’autoradio che pompa hipop.
Foto non fatte: la scritta MAFIA sulla maglietta di una ragazza che fa jogging. Ragazza robusta. Magari non è colpa sua, si chiama proprio così.
Un cop. Un vero cop con pistolone e sfollagente e tutto. Ma in braghette corte e in bicicletta.
E siccome sono qui da dieci giorni, ormai, è tempo di rispondere alla domanda che tutti mi vorrebbero rivolgere, e cioè: li hai visti gli scoiattoli sgambettare sui marciapiede? Li ho visti dalle finestre arrampicarsi ai rami, se è per questo. Fotografarli è piuttosto dura, non stanno in posa.
(Ma quando te li trovi di fronte all’improvviso, che ti occhieggiano dal coperchio di un trashcan, non sono pittoreschi per niente. In quel momento ti rendi conto di conoscere già i loro cugini roditori, i sorci).
E quando viene sera, una sirena ogni mezz’ora. Non ci si annoia per le strade del Connecticut. Ma mi hanno consigliato di non uscire.
- italian stallions
06-07-2006, 16:51Americana, calcio, mondiali, società dell'avanspettacoloPermalinkMa insomma questa World Cup la guardano, gli americani. Perche'? Cosa ci trovano? E' l'unico sport in cui non sono obbligati a vincere: pure, si sciroppano partitacce di nazioni esotiche come Ucraina o Portogallo; mandano giu' serafici l'umiliazione di farsi buttare fuori da Ghana o Boemia; non si smuovono dal video, anche se nessuno segna per due ore, una cosa impensabile in qualsiasi altro sport. Perche'?
Ebbene, sentite un po' questa. Gli americani guardano il soccer perche' e' divertente. Proprio cosi'.
E' divertente - l'avreste mai detto? - addirittura fa ridere. Quando un CT disperato getta uno straccio nel secchio, loro si mettono a ridere. Quando l'ennesimo centrocampista si butta giu' dolorante per un contatto, il volto contorto in una maschera tragica (e il 90%, va detto, sono in maglia azzurra), loro si sganasciano. Quando Grosso si mette le mani nei capelli, disperato per un calcio in uno stinco, si sbudellano. Gattuso, poi, fa ridere solo a guardarlo.
Davvero, non si rendono affatto conto della gravita' della cosa. Quando infine Grosso segna, e la diretta per un attimo mostra un'immagine del Circo Massimo che s'infiamma, loro ridono a crepapelle. Non gli passa per la mente il fatto che da qualche parte nello stesso mondo ottanta milioni di tedeschi hanno cominciato a soffrire e cinquanta milioni di italiani hanno le palpitazioni. Non sanno quanti padri di famiglia tedesca stiano seriamente pensando di cambiare localita' balneare per l'agosto, onde evitare l'irridente bagnino romagnolo. Ne' concepiscono il dramma schizofrenico del bagnino romagnolo, che sogna da 24 anni l'umiliazione del crucco, ma nel frattempo teme di non rivederlo per un'intera estate. Non ne sanno niente, loro.
Per loro e' un gioco, in cui nessuno segna quasi mai, ma quando qualcuno segna poi e' finita. E' divertente questa cosa, che il pallone non si puo' toccare con le mani. Le strattonate, i fischi, i tuffi. I portieroni coi loro guantoni.
E l'Europa tutto intorno, che trattiene il sospiro, e' uno spasso.
- usa
02-07-2006, 19:22Americana, segnalazioniPermalinkSoliti problemi di adattamento e adattatori. Quando è tutto a posto vi scrivo.
- la guerra tiepida
03-03-2006, 04:57Americana, Berlusconi, Iraq, memoria del 900, missioni italiane, resistenzaPermalink Piccoli petulanti pizzaioli
Piccoli petulanti pizzaioli1. Un vecchio e un bambino si presero per mano, e andarono in un prato pieno di croci...
Belle queste croci bianche, disse il figlio.
Sono soldati che attraversarono l'oceano per difendere la nostra libertà, rispose il padre.
Come te, rispose il figlio?
No, figliolo, è diverso. Io ho attraversato i monti e mi sono imboscato in Isvizzera.
Ma papà, perché non sei rimasto anche tu a difendere la nostra libertà?, incalzò il figlio.
Per chi mi hai preso, per un comunista?, replicò sdegnato il padre.
Il figlio non chiese più niente.
2. È probabile che sui cimiteri del distretto elettorale di Ceppaloni sia imbattibile. Ma per il resto Mastella è una frana, non dovrebbero farlo parlare. Di cimiteri militari del Commonwealth è punteggiata la penisola. Ce n'è uno a Udine, uno a Bologna (bastava leggere 2025...), uno a Milano, dove non è troppo inverosimile che un giorno Luigi Berlusconi accompagnasse il figlioletto. E non importa che molti dei caduti a Bologna, ad esempio, fossero in realtà indiani o pachistani (abilissimi a strisciare nelle macchie dell'Appennino e accoltellare il tedesco in silenzio): sono pur sempre "soldati che attraversarono l'oceano per difendere la nostra libertà". Berlusconi è un bugiardo professionista, lo sappiamo. Sbugiardarlo richiede come minimo altrettanta professionalità.
3. I politici italiani che hanno avuto l'onore di parlare al Congresso americano sono stati: De Gasperi, Andreotti, Craxi e Berlusconi. Come dire che dopo il povero Alcide buonanima, gli americani non hanno più azzeccato un solo politico italiano di riferimento. Abbiamo avuto, nell'ordine: un colluso con la mafia; un corrotto morto latitante; un parolaio inconsistente. A questo punto tanto vale mandargli Panariello, tanto che importanza ha: era mattina e non l'ha visto nessuno (quando Aznar o Blair sono saliti in Campidoglio, c'era la diretta anche negli USA).
4. Sulla pronunciation, cerchiamo di essere equi. Pur senza quel magnifico "But no, but no" sfoggiato mi pare con Rasmussen, B. è comunque stato imbarazzante. Una lingua la sai parlare o non la sai parlare: se non la sai ti fai tradurre, come immagino faccia Chirac, e non credo che nessuno lo prenda per un provinciale. Sentire il mio rappresentante che parla di Europa e libertà nell'Assemblea più potente del mondo con l'accento di un pizzaiolo di Toronto m'intristisce, oggettivamente; m'intristirebbe anche se fosse Prodi (ma è B).
Detto questo, devo riconoscere che per essere un sixty-something, Berlusconi non se la cava neanche male. Insomma, non conosco nessun sessantenne italiano con una pronuncia migliore della sua. Allora forse il problema non è della pronuncia, ma dell'età. Già. Dovremmo eleggere rappresentanti più giovani (peccato che siano più fessi, in media).
5. Il discorso in sé era talmente vago che quasi quasi lo sottoscrivo in toto (a parte l'aperture a Putin, ovvio). Il fatto è che per quanto guitto, B. è sempre un po' ragionevole degli opinion-leader al suo seguito: al Congresso ha fatto presente che in breve ci saranno al mondo 6 miliardi di poveri e 2 miliardi di privilegiati. Naturalmente la ricetta proposta (il libero mercato) è una patacca: però almeno mette a fuoco la questione, negando esplicitamente il conflitto di civiltà. (A volte mi chiedo se questo spaventoso conflitto di civiltà contro il quale io polemizzo continuamente – e non solo io – non sia alla fine un mostro marginale, confinato su qualche blog e giornalino di opinione più o meno presentabile. Una comoda sponda per argomenti che comunque rimbalzano subito da un'altra parte).
6. L'atlantismo di Berlusconi è un grosso bluff, che nessuno gli vede per pietà. Quando si è trattato di mettere nero su bianco il proprio sostegno agli Usa, B. ha nicchiato per mesi. Al vertice delle Azzorre non c'eravamo: c'era il Portogallo (ospite), la Spagna, il Regno Unito; c'erano ovviamente gli USA; ma B. no.
Come dice Ciampi, il contingente italiano è arrivato in Iraq solo "a guerra finita" e "su invito dell'Onu", ecc. ecc.. Un malizioso potrebbe dire: siamo arrivati a guerra vinta (vecchia consuetudine italiana) e a pozzi aperti. In ogni caso, la presenza italiana è minuscola, e non ci fa onore: come m'imbarazza il pizzaiolo di Toronto al Congresso, così mi sento disturbato dall'idea che con soli tremila uomini noi ci riteniamo in diritto di mantenere un'opzione dell'Eni sui pozzi petroliferi di Nassiryia. È possibile non vedere la sproporzione enorme tra quello che abbiamo fatto noi e quello che hanno fatto gli angloamericani? Loro hanno, insomma, invaso tutto il Paese, esportato la democrazia in massa. Noi abbiamo addestrato un po' di poliziotti…
7. Eppure anche la nostra omeopatica presenza in Iraq, col tempo è diventata strategica. Dopo il ritiro spagnolo ci bastano tremila uomini per essere forse il terzo contingente in Iraq (di sicuro il secondo europeo). Perciò, anche se siamo in pochi (e abbiamo pretese forse esagerate), gli angloamericani hanno effettivamente bisogno di noi per evitare che l'Iraq sembri una nazione occupata militarmente da una sola potenza nemica. L'altra faccia della medaglia, è che ci bastano tremila uomini per esporre tutta l'Italia a ritorsioni terroristiche. Ora, pur essendo pavido di carattere, e lesto al panico, credo che al Terrore occorra reagire con fermezza. Ma non capisco che senso abbia esporsi al Terrore solo col piedino. Tanto il Terrore è Terrore, per definizione fanatico e integralista: se ha deciso di colpirci, ci colpirà. Ma allora tanto valeva spendersi di più, fare la guerra sul serio. Oppure non fare nulla, e non esporsi neppure. Quello che non sopporto è la guerra tiepida, tutta questa ipocrisia governativa "sì, siamo con gli americani, però non abbiamo partecipato alla guerra, però siamo loro alleati, però non combattiamo ma educhiamo la polizia, ecc.". Come se Al Zarqawi e compagnia s'interessassero dei dettagli. Se davvero avevamo paura di Al Zarqawi, ce ne stavamo a casa. E se non abbiamo paura di lui, dovremmo combatterlo a fronte alta.
8. In questi giorni sono molto impegnato e l'idea anche solo di scaricare e sfogliare l'enciclopedia programmatica dell'Unione mi butta giù. Da qualche parte nelle 200 pagine ci sarà anche l'exit strategy dall'Iraq. Immagino che abbia tempi più brevi di quella prevista da Berlusconi. Se fosse così mi sembrerebbe giusto: l'elettorato di riferimento dell'Unione non ha mai voluto la guerra. In realtà nessun elettorato la voleva, tranne forse quello di Capezzone. A proposito di Capezzone, anche il suo film sulla "Comunità delle democrazie" dovrebbe essere sospeso dalle sale diciamo fino al 9 aprile: non perché non sia immaginifico e ben girato, ma perché rischia di farci perdere voti, e i voti sono molto importanti, vero?
Quando parliamo di ritirarci dall'Iraq, diamo per scontato che l'Italia sia in Iraq. Non è proprio così. 2-3000 militari italiani da un Paese di 25 milioni di abitanti occupato da 140.000 militari USA non sono davvero una gran cosa. Ognuno può avere la sua opinione sulla Guerra in Iraq, ma non c'è dubbio che il nostro aiuto agli americani sia già oggi piuttosto esiguo. E interessato, per di più.
Capisco le ragioni di chi dice che non si può abbandonare l'Iraq nel caos. Nei fatti l'Iraq è nel caos: sciiti e sunniti continueranno a scontrarsi per anni. 3000 italiani, però, non cambiano di molto la situazione.
3000 italiani sono importanti come moneta di scambio tra Berlusconi e Bush (io mantengo formalmente la presenza italiana nella coalizione dei volonterosi, e tu mi fai una marchetta elettorale). 3000 italiani sono importanti perché ci espongono agli attacchi terroristici. 3000 italiani, secondo me, possono andarsene anche domani, e l'Iraq resterà il problema che era prima. Certo, gli USA avranno perso un altro piccolo petulante alleato.
Secondo me se ne faranno una ragione.
- even better than the real thing
17-02-2006, 03:58Americana, anglistica, Barthes, realities, tvPermalink L'isola che c'era, o forse no
L'isola che c'era, o forse noQuello che è successo con J.T. Leroy, o con James Frey, non è una novità (in breve: si è scoperto che le tragiche esperienze di vita raccontate nei loro libri di successo sono in parte o totalmente false: addirittura l'ermafrodito Leroy non esiste: nelle interviste era interpretato da una ragazza).
Non del tutto una novità, dicevo. Non sono sicuro che nel Settecento gli inglesi comprassero le Avventure di Robinson Crusoe come un romanzo d'invenzione. Parecchi ci sarebbero rimasti male, scoprendo che si trattava soltanto delle invenzioni di un tal Daniel Defoe, ex mercante di vini, bancarottiere.
Quei lettori non compravano fantasia. Compravano le memorie di un "vero" naufrago su un isola deserta. Peccato che i racconti dei "veri" naufraghi sulle isole deserte non andassero oltre le cinquanta paginette. Perché la vita di un "vero" naufrago del Settecento, probabilmente, era un incubo. La più parte impazziva e basta. Un olandese a Sant'Elena arrivò a disseppellire la bara di un compagno per usarla come imbarcazione. Defoe non aveva mai messo il naso fuori dalla Gran Bretagna, ma aveva una merce rara sul mercato: la fantasia. È stato uno dei primi autori di best-seller – come tale, snobbato da gran parte dei suoi contemporanei scrittori.
La letteratura ha un suo pubblico affezionato: chiamiamolo "zoccolo duro". Lo zoccolo gradisce le novità, ma su alcuni paletti non transige. Uno di questi è il cosiddetto patto finzionale: io lettore accetto, per tutta la durata della mia lettura, di fingere che quello che mi dici tu scrittore è vero. Non a caso è chiamata anche sospensione della credulità: puoi trasformare una ninfa in alloro e un uomo in scarafaggio, mettermi davanti paesi, isole, mondi immaginari, e io ti crederò – solo finché non chiuderò il libro. C'è qualcosa di rassicurante – e forse di regressivo – in tutto questo: il lettore in sostanza promette di stare zitto e buono per tutta la durata della favola. Si tende a pensare che chiunque sia dotato di una media istruzione e abbia tempo di leggere ami la narrativa; in realtà non è così. C'è gente a cui il patto finzionale semplicemente non piace. E infatti anche le biografie hanno sempre avuto un pubblico di tutto rispetto. Notare: gli autori di biografie stipulano coi loro lettori un accordo che è l'opposto del patto funzionale: io apprezzerò una biografia nella misura in cui mi dimostrerai che non è fiction.
Ecco, se cominciamo a usare l'inglese, le cose diventano più chiare: tutto si gioca tra fiction e reality. Sì, proprio come in tv: accanto a uno zoccolo duro che tradizionalmente apprezza le storie dei professionisti della fantasia, è cresciuto negli ultimi anni un pubblico che vuole situazioni sempre più "reali". Curiosamente, i due generi si danno ancora oggi battaglia sullo stesso campo di Defoe: L'isola dei famosi contro Lost. Ma naturalmente, sin dai tempi di Dafoe (che s'ispirò all'avventura di un naufrago vero) fiction e reality sono due astrazioni. Molto spesso noi crediamo di comprare fiction, e invece stiamo cercando reality: vale per tutti i testi di ventenni veri o presunti, da Porci con le Ali a Melissa P. Ciò che cerchiamo, tradizionalmente, in libri del genere, sono informazioni reali sugli usi e costumi della razza dei giovani: dove si trovano, come comunicano, se si riproducono o no. Pazienza se non sono scritti bene: l'importante è che raccontino qualcosa che (da qualche parte nel mondo) sta succedendo veramente.
Allo stesso tempo, gran parte del reality in commercio è pura fiction: vedi appunto JT Leroy. Sapere che non è mai esistito trasforma la sua biografia in qualcosa di diverso – che probabilmente piacerà meno.
Ma da un punto di vista politico cos'è peggio, la fiction o il reality? Se da una parte abbiamo un pubblico che se ne starà zitto e buono per tutta la durata dello spettacolo (ma alla fine potrebbe anche alzarsi e decidere di fare la rivoluzione; di solito però non succede), dall'altra abbiamo – oltre a un sospetto di voyeurismo – la più grande impostura della modernità: la Naturalezza, o Autenticità, o Spontaneità. Lo sanno bene i concorrenti televisivi, costretti a sforzi immani per simulare quella "spontaneità" che il pubblico richiede.
La Naturalezza (qui ci vorrebbe Barthes, siete fortunati che non l'ho in casa) è la fregatura ideologica per eccellenza. La Società nasconde i suoi rapporti di forza dietro la maschera della Natura.
(La società dovrebbe essere quella cosa che tutti possiamo e vogliamo cambiare in meglio; la natura è il mondo mitico, aspro e selvaggio, che nessuno si permette di toccare, a cui tutti aspireremmo segretamente a tornare).
Libri come quelli di JT o di Frey, che potrebbero apparire documenti di protesta, funzionano in realtà come reportages turistici dai mondi della perversione, della follia, dell'ambiguità sessuale, della dipendenza.
Il lettore-tipo di reality non vuole cambiare le cose: le osserva a una distanza ragionevole, si tiene aggiornato – e quando scopre che gli hanno venduto della fiction giustamente s'incazza. Se il libro gli è davvero piaciuto, potrete persino sentirlo sostenere che "comunque quello che non è successo a JT sarà senz'altro successo a qualcun altro": in una frase del genere emerge tutto il cinismo dell'appassionato di reality, che si ritrova a dover sperare che qualcuno sia stato veramente violentato come JT, per salvare la propria esperienza di lettura. Un turista del dolore 'autentico' non ha il minimo interesse alla sistematica riduzione del dolore sulla terra: viceversa ha qualche interesse che il dolore continui, si replichi, si perfezioni, si rinnovi: e ogni tanto qualche superstite la scampi e scriva un libro.
Già, perché un'altra cosa hanno in comune Robinson Crusoe, JT e Frey: il mito del superstite. Tutti e tre hanno patito grandi tribolazioni, ne sono scampati, e possono fare soldi a palate raccontandoceli. Se la Natura è un mondo aspro e selvaggio (ma avventuroso, e inconfessabilmente bello), la Società è quel salotto simpatico che ricompensa generosamente chi ha saputo trasformare le sue esperienze in un racconto glorioso. Devo già averlo letto da qualche parte: JT è l'ultima incarnazione del Sogno Americano. Il ragazzo/a che a furia di dolori e sacrifici s'innalza dalla strada all'empireo degli scrittori. Scoprire che questa puntata del Sogno è stata realizzata da una bella signora ricca in un lussuoso appartamento di San Francisco procura ai nemici dell'Autentico un sordo brivido di soddisfazione.
Rimane il caro vecchio interrogativo: che fare? Se i seguaci della fiction sono bambini educati che non disturberanno la proiezione, e i maniaci del reality sadici voyeur senza il minimo interesse a migliorare il mondo, esiste una terza via? Quesito interessante, pensateci nel week-end.
(Ciao Vale, se passi di qui)
- 2025
09-06-2005, 17:522025, Americana, religioni, universiade, vita e mortePermalinkCaro Leonardo,
ogni docente ha il suo intercalare preferito, che sarà senza dubbio rivelatore di qlcosa. Chi dice "è vero" ogni tre frasi ha paura di mentire (o di farsi scoprire?); chi dice: "se non vi dispiace" ha un gran bisogno di piacere a qlcuno.
Io credo di aver capito ql è il mio intercalare: "Come sapete". Simpatico modo di esorcizzare il fatto che i miei studenti non sanno un c.
"Come sapete, questo trimestre è dedicato a una delle opere di narrativa scritta più importanti del secolo scorso, Left Behind di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins. Solo di recente l'opera è entrata nei programmi didattici del Teopop, in parte a causa del lungo periodo di ostilità tra il nostro Sistema e gli usastri. Perdurava inoltre la secolare, cattiva abitudine di studiare soltanto le opere narrative lette e divulgate dalle élites culturali, con qualche concessione ai generi che le élites stesse amavano consumare nel dopocena divertimento: il pulp, la space opera di Lucas… Oggi il nostro approccio è molto cambiato, come sapete".
(Due sbadigliano, uno già dorme. La coppia sul fondo è interdetta, pensava che si proiettasse un video. Adesso non sanno se uscire o limonarmi davanti).
"Oggi, dopo le varie rivoluzioni perlopiù religiose che hanno profondam mutato le società sulle due sponde dell'atlantico, il ruolo di qste famose élites è stato molto ridimensionato, e gli studiosi preferiscono occuparsi delle opere che hanno maggiorm segnato l'immaginario popolare: il codice Da Vinci, la profezia di Celestino, l'Alchimista, eccetera. E Left Behind ovviam. Non per il loro intrinseco valore letterario (che in certi casi, come il nostro, è irrisorio), ma per l'importanza che hanno avuto nel modificare il comportamento di vaste moltitudini di persone. Un libro può essere bello o no: ma quando riesce a riformare una religione, provocare una rivoluzione e svariate guerre, è senza dubbio importante, e meritevole di essere studiato. Siete d'accordo?"
Silenzio-assenso. "Left Behind descrive – e in parte provoca – il radicale mutam religioso della fede protestante usastra a cavallo tra i sec. XX e XXI. Sapete come in quel periodo molte vecchie comunità protestanti chiudano i battenti, sostituite da chiese di concezione nuova. Ora, se voi due in fondo mi date una mano ad abbassare le tende, proietterò il mio visore a pag. 104:
Per anni aveva sopportato la chiesa. Ne frequentavano una che chiedeva poco e offriva molto. Avevano allacciato diverse amicizie; avevano trovato il loro medico, il loro dentista, il loro assicuratore e persino avuto accesso al circolo sportivo grazie a quella chiesa. Rayford era riverito, presentato con orgoglio come il comandante di un 747 ai neofiti e agli ospiti; aveva prestato persino servizio nel consigli pastorale per diversi anni.
Ecco, direi che qui si descrive in sintesi il senso di un'appartenenza religiosa di fine secolo. La parrocchia come mini-lobby: in una società che sta smantellando il welfare, la Chiesa consente ai nuovi arrivati in un quartiere di inserirsi in un proficuo circuito di conoscenze e di scambio dei saperi. Una chiesa di qsto tipo "chiede poco e offre molto": non in termini di vita ultraterrena, ma di benessere quotidiano. A un certo punto, però qsto modello entra in crisi ed è soppiantato da qlcosa di nuovo, che all'inizio è solo "una stazione radio".
Dopo la scoperta della stazione radio cristiana e di ciò che definiva "la vera predicazione, la vera dottrina, Irene si era definitivam disillusa nei riguardi della loro chiesa e aveva preso a cercarne un'altra. Rayford allora aveva colto l'opportunità per abbandonare del tutto le sue frequentazioni, assicurando la moglie che quando lei avrebbe trovaro una nuova chiesa che davvero le piacesse, lui l'avrebbe seguita. Irene ne trovò una e Rayford occasionalm si provò a seguirla; ma prendevano le cose troppo alla lettera da qlle parti, scendevano troppo sul piano personale; il che era troppo gravoso per lui. Non era riverito, aveva come la sensazione d'essere parte di un progetto e quindi prese a tenersene più o meno alla larga.
Si tratta evidentem di una chiesa born again. La prima reazione di Ray è tipica: alla larga, quelli fanno sul serio. Dopo qualche tempo inizia a temere per le "manie religiose" della moglie. Pag. 9:
La più grande paura di Rayford era che le manie religiose di Irene non si sarebbero dissolte nel nulla come il suo entusiasmo di venditrice porta a porta per la Amway o di propagandista per la Tupperware, e come la sua passione per la ginnastica aerobica. Se l'immaginava tutta intenta a suonare campanelli e a chiedere alla gente se poteva leggere un paio di versetti.
Amway, tupperware, aerobica: il triangolo usastro delle Casalinghe. È questo il primitivo brodo di coltura delle chiese Born Again. Il libro insiste su qsto punto: è la Casalinga che deve pregare per il Marito, e tentare di evangelizzarlo. Anche se c'è il concreto rischio di allontanarlo da sé, come succede nel caso di Ray. Domande?
"Che vuol dire born again?"
"Significa «rinati». Per i born again occorre rinascere alla fede, buttar via la vecchia religione e rinascere alla nuova. Non a caso in qsto periodo viene esaltato il bambino appena nato, come individuo perfetto perché senza peccato".
"E il peccato originale?"
"Non è più così importante. Tanto che, come sapete, si arriva all'esaltazione del super-bambino: l'embrione, il feto. Sono senza dubbio meritevoli della vita eterna. Durante la Rapture spariscono bambini appena nati, come a pag. 41:
La CNN ritrasmise il video al ralenti mostrando il ventre ingrossato della donna che diventava quasi piatto, come se avesse partorito in quello stesso istante. […] La sequenza si bloccà nel momento in cui il ventre della donna si afflosciava. «Il camice dell'infermiera sembra ancora gonfio, come se lo indossasse una persona invisibile. È sparita! Lì, lo vedete?
"Altre domande?"
"Cos'è Amway?"
- 2025
31-05-2005, 03:382025, Americana, religioni, universiadePermalinkCaro Leonardo,
giornate difficili. Taddei è depresso. Io soffro l'afa e un'ondata di polline micidiale, che mi ha spinto in piazza a cercare antistamina di contrabbando. E devo anche fare lezione.
E a lezione, come temevo, non c'è più lei.
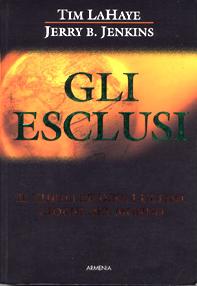
"I PENSIERI DI RAYFORD STEELE vagavano di continuo su una donna che non aveva mai neanche toccato. Il suo 747, a pieno carico e con il pilota automatico innestato, faceva rotta sopra l'Atlantico; ora prevista dell'atterraggio a Heathrow: le sei del mattino. Rayford aveva rimosso deliberatam ogni pensiero riguardo ai familiari".
"Qsto è l'incipit del romanzo che ha maggiorm segnato la cultura usastra nel ventunesimo secolo – benché sia uscito nel 1995. Ora, voi sapete che noi insegnanti amiamo fissarci sulle frasi iniziali dei romanzi, che sono spesso rivelatrici".
[In realtà noi insegnanti a volte arriviamo in Facoltà intorpiditi da dosi illegali di cortisone, abbiamo amnesie e crisi d'ispirazione, e ci fissiamo sulle prime righe di un libro in attesa che il buio passi o regni del tutto].
Ma in qsto caso, a dire il vero, l'incipit è depistante. Il lettore iper-occasionale, quello per intenderci che scorresse qste righe nel chiosco di un'edicola, s'immaginasse… che cosa? Voi cosa vi immaginate? Fingete di non aver letto le prime cento pagine per oggi.
[Fingono fin troppo bene, vedo].
"Prof…"
"No prof, ma dimmi".
"Sembra… un testo immorale".
"In che senso immorale?"
"L'apologia di un adulterio".
"Come il sessanta per cento di tutta la letteratura occidentale, esatto. Il caro vecchio adulterio. Ma il libro, come sapete, non ci racconterà nulla di tutto ciò. Rayford Steele non 'toccherà' mai la donna a cui sta pensando così intensam. Il lettore iper-occasionale non lo sa ancora, ma in ballo qui c'è molto di più di un banale adulterio con l'assistente di volo: in gioco c'è addirittura l'anima di Steele. Proprio all'inizio del libro, nel momento in cui in tutto il mondo i Prescelti sono assunti in cielo in anima e corpo, il pilota è sorpreso nel mezzo di un peccato di pensiero. La sua immaginazione corre liberam, come l'aereo in pilota automatico: Steele non pensa ai familiari che ha lasciato sulla terra, e qsti stanno volando in cielo. Passerà il resto del libro a pensare a loro. Altre considerazioni?"
"Mi stavo chiedendo… perché un aereo? Considerato che il libro poteva iniziare in qualsiasi punto del mondo, perché proprio un aereo?"
Tenera manina che spunti dalle ultime file, allora ci sei! Il cuore mi dà un colpo un po' più forte, un fiotto di sangue spazza via il cortisone soporifero e mi riporta in vita.
 "Ecco una buona domanda. L'aereo risolve in maniera economica alcuni problemi narrativi. Come sapete, il libro è il primo di un ciclo di testi che si pone il problema dei problemi: come descrivere la fine dei tempi in modo verisimile? Come calare le profezie del Vecchio e Nuovo Testamento nella contemporaneità, e in particolare nella vita quotidiana di un lettore del midwest usastro? Per fare un esempio: nella Bibbia si parla di Rapture, di salita al cielo degli eletti del Signore. Un evento miracoloso che non è facile da immaginare. I pittori di tutte le epoche lo hanno raffigurato in modi diversi. Nel 1995 tocca a Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins. Noto qui che è erroneo chiamarli profeti, loro non hanno mai preteso di avere qsto dono. In realtà le profezie esistevano già. Qllo che LaHaye e Jenkins hanno fatto con i testi Left behind è un'opera di illustrazione: hanno illustrato l'Apocalisse, il Libro di Daniele, le Epistole di San Paolo eccetera… in sintonia con i canoni estetici del Midwest, l'area di principale diffusione della fede born again. Niente aure new age, dunque – ma neanche fanfare cattoliche, niente angeli sulle nuvolette che l'usastro Mark Twain aveva deriso un secolo prima. La genialità degli autori sta nella semplicità delle loro scelte. L'ascesa dei puri è una sparizione. Un momento prima c'erano, il momento dopo non ci sono più. Spariscono dai loro letti, dagli stadi, dalle ecografie. Abbandonano le macchine in strada, i carrelli nei supermercati, il bagaglio a mano nell'aereo. Segno della loro scomparsa, i vestiti abbandonati: proprio come il sudario di Gesù dopo la Resurrezione. Ecco un'illustrazione dell'ascesa al cielo abbastanza verosimile.
"Ecco una buona domanda. L'aereo risolve in maniera economica alcuni problemi narrativi. Come sapete, il libro è il primo di un ciclo di testi che si pone il problema dei problemi: come descrivere la fine dei tempi in modo verisimile? Come calare le profezie del Vecchio e Nuovo Testamento nella contemporaneità, e in particolare nella vita quotidiana di un lettore del midwest usastro? Per fare un esempio: nella Bibbia si parla di Rapture, di salita al cielo degli eletti del Signore. Un evento miracoloso che non è facile da immaginare. I pittori di tutte le epoche lo hanno raffigurato in modi diversi. Nel 1995 tocca a Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins. Noto qui che è erroneo chiamarli profeti, loro non hanno mai preteso di avere qsto dono. In realtà le profezie esistevano già. Qllo che LaHaye e Jenkins hanno fatto con i testi Left behind è un'opera di illustrazione: hanno illustrato l'Apocalisse, il Libro di Daniele, le Epistole di San Paolo eccetera… in sintonia con i canoni estetici del Midwest, l'area di principale diffusione della fede born again. Niente aure new age, dunque – ma neanche fanfare cattoliche, niente angeli sulle nuvolette che l'usastro Mark Twain aveva deriso un secolo prima. La genialità degli autori sta nella semplicità delle loro scelte. L'ascesa dei puri è una sparizione. Un momento prima c'erano, il momento dopo non ci sono più. Spariscono dai loro letti, dagli stadi, dalle ecografie. Abbandonano le macchine in strada, i carrelli nei supermercati, il bagaglio a mano nell'aereo. Segno della loro scomparsa, i vestiti abbandonati: proprio come il sudario di Gesù dopo la Resurrezione. Ecco un'illustrazione dell'ascesa al cielo abbastanza verosimile.La verosimiglianza è ottenuta anche con riferimenti alle tecnologie più avanzate. Avrete notato che durante gran parte del libro i personaggi non fanno che chiamarsi in segreteria. Qsto può snervare il lettore contemporaneo, ma nel 1995 era il modo più moderno di comunicare. Il più 'sportivo' dei personaggi, Buck, riesce a connettersi a Internet sull'aereo; e pensate che il WWW era appena nato. E pensate all'aereo. Un non–luogo che li comprende tutti. La signorina si è in pratica risposta da sola. Proprio perché il libro deve cominciare in "tutto il mondo" (le sparizioni accadono nei cinque continenti), non può che iniziare su un aereo. Non c'è nulla come un Boeing per farti sentire che il mondo è piccolo rotondo. E Lahaye e Jenkins sono due scrittori apocalittici per un mondo piccolo e rotondo, così come San Giovanni era l'apocalittico di un mondo immenso e piatto.
Allo stesso tempo, il Boeing è anche un pezzo di Midwest semovente, che trascina con sé i suoi personaggi 100% usastri nel primo passo verso la fine dei tempi… toh, è già finita l'ora. Ci vediamo domani. Sì? Che altro c'è?"
"Prof, ma è successo davvero?"
"Sì, più o meno vent'anni dopo l'uscita del libro è successo qlcosa del genere. Molti usastri sono spariti dall'oggi al domani. Quelli che sono rimasti hanno rifondato la loro nazione su basi puritane e isolazioniste, come sapete".
"Allora l'apocalisse è già successa?"
"Tecnicam, è una cosa che è cominciata e che sta succedendo tuttora".
"E quando finisce?"
"Scusate, ora devo scappare. A domani".
[Mi piace lasciarli a fiato sospeso. Non so quanto sia pedagogico o didattico, ma mi piace.
Lo scrittore dovevo fare, mica il prof.]
- 2025
08-03-2005, 02:502025, Americana, crisi energeticaPermalink(In realtà sono nove e continuano da ieri)
Sei. Quali sono i nostri attuali rapporti con gli Stati Uniti d’America? Spero buoni.
"Ottimi. No, sul serio.
Dopo un periodo di, ehm, crisi , causata dal collasso del sistema economico neoliberale, i rapporti con gli Usastri sono andati via via migliorando, fino alla ratifica del trattato di San Gennaro da parte del Sommo Pontefice e dei Reverendissimi Padri Pellegrini, tre anni fa.
Il trattato (ancora uno sfrusciare di pergamena) sancisce che… uh, Teopop e Usa sono parti diverse di un solo grande sistema, fondato sul consumo di idrocarburi di origine fossile, così com’è prescritto nel Santo Vangelo di Gesù Cristo nostro Signore e Sovrano. Almeno fino all’anno prossimo, poi il trattato scade e si vedrà".
Sette. Mi è parso di capire che l’Italia, o come diavolo si chiama adesso, è attualmente coinvolta in operazioni militari contro la Libia. Potrei avere qualche ragguaglio sulle ragioni e l’andamento del conflitto? La Libia è forse una dittatura islamofascista? Gli USA partecipano al conflitto?
"Ehi ehi ehi, queste sarebbero tre domande in una. Nell’ordine:
a) l’Italia come lei l’intende non esiste più, in buona parte. Noi ci riferiamo al Paese-Sistema in cui viviamo col nome di Teopop, o al limite di “Bel Paese”, quando abbiamo bisogno di sinonimi.
b) Attualm la Libia è un piccolo emirato-cuscinetto incuneato tra il Califfato del Levante e l’Africa Bizantina, retta da un tiranno sanguinario e pessimo centrocampista, tal Gheddafi. Già da tempo egli rifiutava di pagarci
c) Gli usastri non partecipano al conflitto, anzi, più volte hanno cercato di dissuaderci: la sola idea di dislocare militari in un altro Paese per motivi umanitari o economici o quant’altro è assai lontana dalla loro mentalità isolazionista e monroviana. Inoltre, loro preferirebbero che noi acquistassimo il petrolio dell’Alaska o dell’Antartide da loro, più caro ma più theologically correct. In ogni caso, bizantini e gialli non gli permetterebbero mai di entrare nel mediterraneo".
Otto. Perché sono stato vestito così? Posso cambiarmi?
"Spero che il personale paramedico l’abbia già rifornita di un cambio. In realtà lei ci è stato consegnato dal personale diplomatico usastro in quegli abiti – abiti che corrispondono, se non sbaglio, al costume del supereroe Captain America, apparso in diverse pubblicazioni a fumetti usastre a partire dagli anni Quaranta del secolo scorso".
Nove. Qui sostengono che il caffè in Italia non si beve più perché “non piace più a nessuno”. Mi stanno prendendo in giro?
"Assolutam no. Nell’ultima decade il consumo di caffè nel Bel Paese è drasticam diminuito, fino a scomparire quasi del tutto. Gli studiosi hanno fornito diverse spiegazioni al fenomeno, ma la più convincente rimane quella culturale: il caffè oggi è associato allo stile di vita edonista, vizioso e depravato tipico delle culture materialiste dell’Estremo Oriente. Non a caso in questa stessa decade il consumo di caffè e derivati della caffeina da parte dei gialli è via via aumentato, determinando l’ascesa dei prezzi e l’esaurimento delle risorse mondiali. In pratica, se lo bevono tutto. Tanto peggio per loro. Noi siamo passati a bevande più salutari, e radicate nella nostra tradizione comunitaria e cattolica".
Dieci. Cosa c’è nella stanza 68?
"Oh, beh.
Non credo che valga la pena parlarne adesso.
Voglio dire, non dev’essere difficile da immaginare. Insomma, se ci pensa bene lei sa cosa c’è in quella stanza.
Deve solo sperare di non entrarci mai".
FINE DEL MESSAGGIO
--------------------------------
--------------------------------
Da: dott. Damaso, primario Ospedale Maggiore, San Petronio
a: sig. Immacolato, via Beato Giussani 12 San Pet. Nord
Oggetto: Re: Dieci risposte per Taddei
MESSAGGIO A CARICO DEL DESTINATARIO
"Immacolato, sono io, maledizione.
Vieni appena puoi. Il Capitano si è infuriato e non riusciamo a sedarlo. E se mi scappa siamo entrambi a culo a terra".
JONATHAN FRANZEN, Come stare soli, Einaudi, Torino, 2003 (How to be alone, 2002; traduzione di Silvia Pareschi).
Questo libro vuole essere, in parte, la testimonianza del passaggio da un isolamento rabbioso e spaventato a un’accettazione – persino una celebrazione – dell’essere lettore e scrittore. Non che oggi manchino i motivi per essere arrabbiati e spaventati. (dall’Introduzione).Da apocalittico a (parzialmente) integrato: è la traiettoria dell’intellettuale contemporaneo tracciata da Jonathan Franzen in questa sua scelta di saggi, comparsi su riviste tra il 1994 e il 2001 e raccolti in volume nel 2002. Una traiettoria che il lettore dei suoi romanzi troverà in qualche modo familiare: l’intellettuale Franzen la condivide con alcuni dei suoi personaggi romanzeschi più riusciti. In mezzo al guado, la palude della depressione, motivo esistenziale sul quale l’autore ritorna esplicitamente in più occasioni.
All’inizio degli anni Novanta Franzen sperimenta sulla sua pelle la crisi del progetto artistico su cui ha impostato la sua carriera sin dall’inizio (“Quando finii il college, nel 1981, non ero al corrente della morte del romanzo sociale”). I suoi primi due romanzi, pur riscotendo un discreto successo di critica e di pubblico, non suscitano nessuna reazione a parte “un’altra pagella di buoni voti da parte dei critici […] una discreta quantità di denaro; e il silenzio dell’irrilevanza”. Le statistiche sul calo dei lettori di narrativa, il trionfo della cultura dell’immagine, l’avvento dei profeti “cybervisionari” con le loro previsioni su un futuro interamente digitale: tutto sembra congiurare contro l’antica professione del romanziere. Più in profondità, l’opulenta società americana degli anni Novanta sembra non aspettarsi più nulla dalla narrativa e dall’arte.
Immaginiamo che l’esistenza umana sia definita da un Dolore. […] Se consideriamo la religione e l’arte come i metodi storicamente preferiti per venire a patti con questo Dolore, che ne è dell’arte quando i nostri sistemi tecnologici ed economici e persino le nostre religioni commercializzate sono ormai abbastanza sofisticati da collocare ognuno di noi al centro del proprio universo di scelte e gratificazioni?
La società non ha bisogno di letteratura, ma di narcotici: e ne produce in abbondanza, “sotto forma di Tv, cultura popolare e oggetti di ogni tipo”. Ciò che rende particolarmente efficace la descrizione dei “narcotici” è che l’autore non nasconde di averne fatto uso a più riprese, e di sentirne ancora il bisogno: è il caso, per esempio, della televisione. Come nella miglior tradizione apocalittica, l’apparecchio televisivo è considerato un oggetto diabolico, ma il rapporto che l’autore intrattiene col “vecchio aggeggio ingombrante” nascosto letteralmente nell’armadio, rasenta il grottesco.
Mi chiedo se possa esistere un’immagine più tetra della codipendenza delle centinaia di ore che ho passato con un pezzo di filo di rame tagliente stretto fra indice e pollice per migliorare la qualità dell’immagine del mio televisore.
Può darsi che le pagine apocalittiche di Franzen – quelle in cui l’autore indaga sulla sua depressione, e ne fornisce le coordinate storiche e sociali – siano le più intense: ma nei saggi in cui compaiono sono già rielaborate sotto un nuovo punto di vista. Esemplare sotto questo aspetto la sorte del saggio Perché scrivere romanzi, che ai tempi dalla sua apparizione su “Harper’s” nel 1996 col titolo Forse sognare era stato considerato (per un malinteso) un manifesto del romanzo sociale, da cui Franzen stava piuttosto prendendo congedo: rileggendolo sei anni dopo, l’autore si rende conto che
nei cinque anni trascorsi da quando avevo scritto il saggio, ero riuscito a dimenticare che a quell’epoca ero un individuo molto arrabbiato e con la testa piena di teorie. Il fatto che gli americani guardino tantissima Tv e leggano poco Henry James mi provocava un’angoscia apocalittica.
La “fuga di uno scrittore in crisi dalla prigione dei suoi pensieri rabbiosi” comincia con una scoperta fondamentale: la solitudine. Contattato da una studiosa di scienze sociali che sta conducendo una rigorosa ricerca scientifica sul “pubblico della narrativa seria in America”, l’autore scopre di appartenere sin dall’infanzia a una tipologia di lettore ben definita: l’isolato sociale, che sin dall’infanzia vive la sua esperienza di lettura come dialogo con un “essenziale mondo immaginario”. Questo mondo essenziale non è un rifugio, tutt’altro: nella opere narrative questi lettori riconoscono una sensazione d’imprevedibilità che è un tratto distintivo della loro esistenza (si tratta spesso di migranti, o persone che vivono comunque una realtà molto diversa da quella dei genitori). La buona narrativa descrive i conflitti rifuggendo le facili soluzioni, e tornando sempre sui “problemi fondamentali”.
In fondo, è sempre il vecchio tema del dialogo coi classici: ma Frenzen lo vive come una scoperta liberatoria.
Come potevo non sentirmi estraniato? Io ero un lettore. La mia essenza mi aspettava da sempre, e adesso mi dava il benvenuto. D’improvviso mi accorsi di quanto fossi ansioso di costruire e abitare un mondo immaginario.
Solo ora, deponendo parzialmente le ambizioni del suo progetto di romanzo sociale, Franzen può riscoprire il piacere di leggere e di scrivere dei personaggi e dei luoghi che ama. Il suo terzo romanzo, arenatosi da tempo sotto il peso “del mio presunto dovere nei confronti di una chimerica cultura di massa”, si rimette in moto: si tratta naturalmente di The Corrections, che uscirà nel 2001 (Le correzioni, Einaudi, 2002).
Che cos’è esattamente la solitudine di Franzen? Non sembra avere molto a che vedere con torri d’avorio o ritorni al privato. L’intellettuale non rinuncia a indagare la società in cui vive e a pronunciare sentenze anche molto critiche. Non rinuncia nemmeno, se invitato, a comparire in un talk show televisivo (perlomeno ci prova, com’è testimoniato dal bel racconto autobiografico Ci vediamo a St Louis, dove una troupe televisiva costringe l’autore a tornare nei luoghi dei suoi lutti familiari). Ma la scoperta di appartenere a una comunità extratemporale di lettori e scrittori lo riconcilia coi suoi contemporanei. Non è più costretto a fare concorrenza (una ben misera concorrenza) alla cultura di massa: in fondo l’elitarismo della letteratura è sempre esistito, anche se “si era fugacemente eclissato nel periodo d’oro del romanzo”.
Così il “sublime sdegno” dei tempi di Forse sognare lascia il posto a un tono più bonario nei confronti di una realtà nella quale l’intellettuale progressivamente accetta di vivere, rinunciando a molti eccessi ideologici. Molti saggi raccolti nel volume testimoniano questo mutato atteggiamento. Raccontando la malattia del padre, in quella che è quasi un’appendice alle pagine più autobiografiche delle Correzioni, Franzen ammette di aver rifiutato dapprima l’idea dell’Alzheimer (“mi sembrava un altro aspetto della medicalizzazione dell’esperienza umana”) nel tentativo di salvare un’individualità annullata dalla casistica medica
…mi dispiace vedere il significato personale staccarsi da certi errori di mio padre, come confondere la moglie con la suocera, una cosa che allora mi parve bizzarra e misteriosa e dalla quale racimolai ogni sorta di nuove e importanti intuizioni sul matrimonio dei miei genitori. A quanto pare, il mio senso della personalità individuale era illusorio.
Se nel suo ultimo romanzo Franzen aveva descritto impietosamente l’involuzione liberista della società attraverso lo smantellamento di una compagnia ferroviaria privata, in Lettere smarrite l’argomento è capovolto: si tratta di dar conto del crollo sistemico di una grande azienda pubblica, il servizio postale di Chicago, travolto dalla burocrazia, dalla corruzione e dall’ipocrisia del politically correct. Perfino il vero nemico numero uno della società americana, il “Grande Tabacco”, è affrontato da Franzen con insospettabile tolleranza in Setacciare le ceneri: fumatore pentito ma non redento, Franzen si scopre in un qualche modo solidale con le aziende fornitrici di sigarette, capri espiatori del risentimento popolare, e comunque colpevoli di aver “venduto l’anima ai consulenti legali” (il saggio documenta come la strategia suicida di negare la nocività del fumo fosse una scelta portata fino in fondo dagli avvocati dei produttori). In Unità di controllo Franzen documenta in presa diretta i paradossi di uno dei più fiorenti business americani: l’amministrazione carceraria. Da una parte del muro, i giovani “neri e latini” obbligati a svolgere “per un dollaro l’ora o anche meno, i lavori umili che da liberi si rifiutavano di svolgere per il minimo salariale”; dall’altra parte, gli abitanti della cittadina che ha deciso di ospitare un carcere di massimo rigore, illusi e poi frustrati da una struttura che promette sicurezza ma non dà occupazione.
In altri saggi il nucleo tematico della solitudine diventa riflessione sul concetto (problematico) di privacy: ma anche in questo caso, e in un momento in cui le libertà personali sembrano messe a dura prova dalla pervasività della tecnologia, Franzen spiazza il lettore invertendo i termini della questione: non è la privacy che manca agli statunitensi, anzi: nell’era dei forum elettronici e dell’esplosione dei quartieri residenziali la verità è che “siamo sommersi dalla privacy”. Quello che invece va scomparendo è uno spazio pubblico, “dove ogni cittadino è il benvenuto e dove la sfera puramente privata è esclusa o limitata”. Perciò, paradossalmente, il caso Clinton-Lewinsky, esploso nell’“ultimo grande, poderoso bastione della vita pubblica americana” è l’unica, e definitiva violazione della privacy, mentre l’espansione suburbana ha causato la fine delle “buone maniere”, dei “comportamenti adulti che si imparano meglio in luoghi pubblici come i marciapiedi”. Ma nonostante le spinte centrifughe, la grande città polifunzionale resiste, e rimane il luogo ideale dove imparare a stare soli. È qui che lo scrittore-lettore Franzen decide di restare. A costo di ridursi a razzolare nei rifiuti, come al termine di uno dei pezzi più autobiografici e divertenti, Materiale di recupero. Qui l’arte della riparazione dei vecchi utensili (una macchina da scrivere, una poltrona, un vecchio computer) diventa, più che una sfida al “tecnoconsumismo”, ma una vera e propria metafora della pratica letteraria.
L’obsolescenza è il prodotto principale della nostra passione nazionale per la tecnologia, e io sono ormai convinto che l’obsolescenza non sia un male ma una meraviglia: non la perdizione, ma la salvezza. Più il progresso tecnologico diventa precipitoso, più cresce il volume dei detriti obsoleti. E i detriti non sono soltanto materiali. Sono anche una religione arrabbiata, la rinascita di ideologie controculturali, i nuovi disoccupati, gli eterni disadattati. Tutto ciò garantisce che gli scrittori non saranno mai soli. L’ineluttabile obsolescenza è il nostro patrimonio.
(La versione on line di Forse sognare l'ho trovata grazie a FaM). Maestri di vita (12): Paul Newman siede al tavolo.
Maestri di vita (12): Paul Newman siede al tavolo.Ognuno di noi è figlio, oltre che di una madre e di un padre, anche di una talvolta complicata, talvolta banale serie di circostanze che hanno fatto incontrare queste due persone invece di chiunque altro. Io, per esempio, sento di dovere qualcosa a Paul Newman.
Questa verità l’avevo sempre sentita tenuta dentro di me, senza riconoscerla, fino al ritrovamento, in un cassetto, di una fototessera di mio padre del 1970. Era come la tessera mancante di un puzzle. La verità, banale e sconvolgente insieme, mi investì di colpo. Tante domeniche pomeriggio d’infanzia, passate a giocare ai lego sul tappeto, mentre in tv davano un film di quell’attore un po’ sbruffone. Perché mi ricordavo solo i suoi film? Perché solo il suo nome? Di colpo ogni tessera andava al suo posto.
Mia madre, da giovane, non si perdeva un film di Paul Newman. Mio padre, da giovane, era l’articolo più somigliante a Paul Newman che la bassa padana potesse offrire. Naturalmente la carnagione era un filo più scura e il formato era ridotto, perché l’altezza media di un popolo è proporzionale al benessere, e la bassa padana fu zona depressa fino al 1950.
Ora, prima che vi mettiate strane idee in testa, è giusto che lo sappiate: io assomiglio a mio padre, ma a Paul Newman, neanche un po’. Ingiusto, ma è così.
E tuttavia a volte mi chiedo se questa assurda, banale circostanza, non potrebbe spiegare qualche aspetto del mio carattere. Io in fin dei conti potrei essere definito una persona pacifica e conciliante, proprio come mio padre (che non mi ha mai detto quei famosi No che aiutano a crescere). D’altro canto, è evidente che io non sono davvero una persona pacifica e conciliante, bensì un egocentrico sbruffone. Da chi ho preso? Da mia madre no, da mio padre nemmeno. E allora?
Credo che Paul Newman sia il mio attore preferito. Di lui ricordo molto bene due film. Il secondo, in italiano, si chiamava Lo Spaccone (The Hustler, 1961). Il ruolo perfetto per lui, no? Ma era uno dei suoi primi, in bianco e nero.
Lo Spaccone, a memoria, mi sembra il film più alcolico che io abbia mai visto. Ci si ubriaca solo a guardarlo, ti alzi dalla poltrona che ti gira la testa. Peggio di così c’è solo Morire a Las Vegas, ma a Las Vegas Nicholas Cage sa benissimo che beve per uccidersi; invece nello Spaccone la gente beve senza neanche rendersi conto che nuoce gravemente alla salute. Si fuma anche molto. È un film di altri tempi (mi ricordo un dialogo pomeridiano tra lui e lei: “Cosa fai oggi?” “Niente”. “Ti va di bere?”)
Lo Spaccone sarebbe un film sul biliardo, ma, come si dice in questi casi, il biliardo non è che una metafora della vita. All’inizio Paul Newman è convinto di essere il più grande giocatore del mondo, e non smetterà di crederci per tutto il film. Ma gli va tutto male, perché? Perché è uno spaccone. A biliardo si gioca così: si gioca con un pollo e si finge di essere più polli di lui: si perde un po’, e quando il pollo è cotto a puntino lo si spenna. Ci vuole concentrazione, sangue freddo, killer instinct. Paul Newman non ha nulla di tutto questo. Invece di cercarsi polli giù al molo, va davanti al più grande giocatore di biliardo vivente e lo sfida a regolar tenzone. E per dimostrare che è sicuro del fatto suo, tra un colpo di stecca e l’altro beve bourbon come una spugna. E vince, stravince, e beve, perché è un genio. Finché dopo dodici ore di stecca non succede qualcosa. Il suo agente gli consiglia di ritirarsi, ma lui deve andare avanti. Non si è accorto che il vecchio maestro lo sta per spennare, da pollo che è.
Dodici ore dopo lo svegliano, abbracciato al termosifone, e lo avvertono che la partita è finita, e lui ha perso tutto. Ma tranquilli, questo è solo l’inizio del film.
Ora, però, visto che non siete degli sprovveduti, e film americani ne avete visti tanti, con un piccolo sforzo potete immaginarvi da soli come continua. È il solito canovaccio: all’inizio del film il giovane di belle speranze fa una brutta figura, cade in disgrazia, ma poi capisce quali sono stati i suoi errori, e verso la fine del film torna sui suoi passi e trionfa nel luogo dove era stato umiliato. In mezzo, di solito, incontra anche una bella ragazza.
Così vanno i film, in America, e così vorremmo che fosse la nostra vita: siamo persone eccezionali che hanno fatto degli errori, ma con qualche piccolo aggiustamento…
Lo Spaccone però non ce la fa. Resta Spaccone fino alla fine, e anche quando vince, in realtà perde tutto. Insomma, è un completo disastro. E un paio di volte alzandomi dalla poltrona coi postumi di una sbronza, mi sono chiesto: ma non avrò per caso preso da lui?
Per fortuna poi penso al primo film che mi ricordo di lui, che è La Stangata (The Sting,1973: abbiamo la stessa età). Per me non ci sono film più belli, ma è anche vero che sono anni che non vado a ricontrollare.
In questo film, se ci fate caso, Paul Newman assume un ruolo vagamente paterno nei confronti del vero protagonista, che sarebbe Robert Redford: lo spettatore tende a immedesimarsi in quest'ultimo. All’inizio del film, poi, Newman non sembra altro che un alcolizzato di mezza età, come se avessero chiuso Lo Spaccone in una cantina e lo avessero tirato fuori dopo quindici anni. Ma poi c’è la scena del poker sul treno.
Newman e Redford sono saliti su un treno per tendere un tranello a un gangster che gioca a poker in un vagone (ma che, ve lo devo raccontare?) È Newman che va a gettare l’esca. Prima però entra in una toilette e si mette a fare gargarismi col bourbon. Che fai, gli chiede Redford. Non lo vedi? Risponde lui. Ci metto un po’ d’acqua. Altrimenti non lo reggo.
Anche se so che non è vero, mi piace pensare che La Stangata sia il seguito dello Spaccone. Che il protagonista sia sempre lo stesso, solo che ora ha finalmente capito il trucco fondamentale della vita (lo stesso che ha salvato i Guns’n’Roses dalla cirrosi epatica): allungare il bourbon. Nella vita non bisogna essere sbronzi. Bisogna sembrare sbronzi. Chi non lo capisce è un fallito, anche se è il miglior giocatore di stecca del mondo. Chi lo capisce non ha più nient’altro da imparare.
Quando Paul Newman arriva nel vagone del poker, col colletto aperto e scravattato, la bottiglia di bourbon in mano e l’aria da imbecille, la partita è sua.
Nello stesso modo (occhi socchiusi, aria da scemo, vestiti spiegazzati: e riflessi pronti, sangue freddo, e lo stesso freddo nel cuore) vorrei sapermi sedere anch’io un giorno al tavolo della vita.
Il complesso di Fort Alamo
L’americanismo dei Neoconi è comunque un sentimento nobile. Apparentemente i Neoconi non farebbero altro che prolungare una celebrata tradizione italiana, che consiste nel mettersi sempre e comunque dalla parte del vincitore: eppure non sono affatto arroganti. Non si capisce il Neocone se non si entra un po’ nel suo immaginario. Certo, occorre fare un piccolo sforzo, perché noi e i Neoconi viviamo in due mondi diversi.
Noi pensiamo di vivere in una nazione vagamente destrorsa, vagamente razzista, che ha bisogno di immigrati ma non è ansiosa di riconoscerne i diritti civili: con una classe dirigente inadeguata e un po’ disonesta, ben rappresentata dal buffone in capo, con le sue eterne pendenze con la giustizia, il suo conflitto d’ìnteressi: una persona che non ci è simpatica per niente, e non ha mai fatto nessuno sforzo per diventarlo.
Il Neocone vive altrove: in un Paese che è stato ed è tuttora sotto il controllo dei… chiamiamoli “comunisti”, anche se il concetto non rende del tutto l’idea. Anche se incidentalmente i comunisti hanno perso le elezioni, non hanno mollato la loro presa sulla coscienza degli italiani. Controllano le aule di giustizia e le aule di scuola, l’ottanta per cento dei quotidiani e tutti i programmi televisivi che valga la pena vedere (i Neoconi, è buffo, non si perdevano una puntata di Santoro).
I comunisti sono i no global, i girotondini, l’ex sinistra di governo, i magistrati, i giornalisti; perfino Andreotti, quando faceva una politica cautamente filoaraba, era in qualche modo un comunista. Gli immigrati non sono comunisti, ma lo diventeranno, e a quel punto l’Italia sarà definitivamente perduta. I comunisti, l’11 settembre, andavano in giro a dire che l’america se l’era cercata. I comunisti hanno esposto le bandiere della pace, probabilmente lucrando sul prezzo. I comunisti vanno alle manifestazioni, vanno ai concerti, consumano droghe leggere, fanno casino fino a tardi e impediscono alla gente onesta di dormire. Ora, sto esagerando, mi rendo conto: la maggior parte dei Neoconi è sana di mente e non soffre di paranoie più di chiunque altro. Ma non c’è dubbio che il Neocone medio si senta assediato. Sventolare la bandiera stelle e strisce allegata a Panorama non è un gesto di vittoria, ma una disperata richiesta di aiuto. I Neoconi si sentono a Fort Alamo. Fuori, orde di pancabbestia, talebani, magistrati, filosofi, giornalisti italiani, giornalisti europei, europarlamentari. È il punto del film in cui di solito arrivano i Nostri.
Ora che sappiamo in che mondo vive il Neocone, non possiamo non provare un po’ di simpatia per lui. Ci vuole del coraggio a infilarsi in un fortino e resistere ad assalti da ogni parte, con abnegazione e sprezzo del buon senso. Prendiamo il caso Schulz, che in sé e per sé non era nulla di eccezionale: Berlusconi ha fatto una gaffe madornale e avrebbe dovuto scusarsi con più convinzione, tutto qui. Alcuni Neoconi se ne sono resi conto. Altri no. Altri si sono cimentati nella missione impossibile di difendere Berlusconi, brutalmente provocato da Schulz. Dibattiti sulla definizione di kapò. (“Ignoranti! Kapò non vuol mica dire nazista!”). Digressioni sulla storia del kapò nel cinema e nella televisione. Scottanti retroscena: Schulz era stato fomentato da Vattimo e Travaglio. Eccetera, eccetera. Fino all’apoteosi finale: Berlusconi è inviso ai tedeschi perché è l’inventore del nuovo asse portante europeo, con Blair e Aznar (lo dice un pezzo del Times, mica bruscolini). Avevamo lasciato Totò de Curtis, ci ritroviamo Winston Churchill. La mente vacilla. Ecco, dopo un po’ di frequentazione dei Neoconi bisogna fare uno sforzo per tornare al nostro mondo, per ricordarci che in Italia c’è un’ampia maggioranza di centrodestra e un leader che controlla più di metà dell’informazione.
 Nato l’undici settembre
Nato l’undici settembre
Un’altra cosa che mi rende simpatici i Neoconi (e che probabilmente mi rende antipatico ai loro occhi) è la loro giovinezza interiore. I Neoconi vedono il mondo con occhi nuovi. Si capisce che per loro è “la prima volta”. È la prima volta che s’interessano a un movimento popolare (in Iran). È la prima volta che si appassionano ai problemi dell’Africa (Bush sta facendo il consueto tour africano di metà mandato). È la prima volta che si scandalizzano per le torture in Iraq, per i diritti civili, per il caso Sofri e tante altre cose. Siccome è la prima volta, lo fanno con un’intensità invidiabile. Siccome è la prima volta, guardano con sospetto chiunque vanti dei trascorsi. E io, che arrivo da un’ondata appena appena precedente, mi ritrovo nei panni detestabili dell’attivista veterano, sempre pronto a dire: “Eh… anche noi, ai loro tempi abbiamo lottato per tante cose…” Come i sessantottini del riflusso, insopportabili.
Il paradosso è che tutto sommato abbiamo la stessa età. E vabbè, si sa, io ho lottato per varie cose, di solito mi è andata male, ecc.. Ma loro? Dove sono stati negli ultimi trent’anni? Quando Saddam Hussein gasava i curdi, quando gli studenti iraniani venivano giustiziati, quando Sofri entrava in galera?
C’erano. Senza dubbio c’erano, anche se non avevano i blog. E forse qualcuno di loro avrà anche partecipato a delle proteste, firmato petizioni, scritto ai giornali, eccetera. Ma tutto questo non ha molta importanza. Non ha molto senso rimproverare al Neocone il suo passato, perché il Neocone è un uomo nuovo, rinato all’improvviso l’11 settembre. Se vogliamo capire il Neocone, dobbiamo azzerare l’orologio e ripartire da lì.
Per i Neoconi l’11 settembre non è stata solo una spaventosa tragedia, ma l’inizio di una nuova era: l’era dell’incertezza endemica, della guerra al terrorismo, della Giustizia Infinita. Come diceva Casarini: “anno zero della guerra globale”… (Casarini è un punto di riferimento per i Neoconi, che ultimamente seguono le sue vicende forse con più attenzione degli stessi disobbedienti). È dall’11 settembre che il Neocone ha capito di essere americano. Nel rogo delle torri ha visto la caduta dell’Occidente sotto i colpi di un Islam infido e traditore. Le torri che crollano hanno colpito il suo immaginario: sono il simbolo di una civiltà razionale, quadrata, infinitamente superiore, ma anche fragile, proprio in virtù della sua superiorità: facile obiettivo dell’invidia del mondo. Proprio come il Neocone, che vive assediato nel suo appartamento. Lo stesso assedio, lo stesso scontro di civiltà. Il momento era grave: come ha detto il Neocone Berlusconi a Strasburgo, “le borse sono crollate l’11 settembre” (e questa è un’altra bella cazzata: l’economia era già in recessione da un anno, anche se Greenspan non aveva il coraggio di dircelo). I Neoconi si sono stretti intorno al Presidente degli Stati Uniti, un buffo figlio di papà eletto a minoranza, che di colpo si è trasformato in un grande statista, l’uomo del destino. La svolta in politica estera è stata spettacolare: due invasioni in due anni.
Ora, non importa tanto che sia l’Afganistan che l’Iraq siano due ferite ancora aperte, perché il Neocone non giudica i risultati: giudica le intenzioni. La guerra in Afganistan era Ok, perché bisognava fermare Bin Laden (Bin Laden è scomparso). La guerra in Iraq era Ok, perché bisognava importare la democrazia in Medio Oriente. Il resto (bombe a grappolo, uranio impoverito, petrolio, oppio, guerriglia endemica su entrambi i fronti, armi di distruzione di massa che non si trovano) sono dettagli, e al Neocone non piace parlarne. Preferisce parlare degli orrori del regime iracheno. E va bene, ognuno sceglie i dettagli che preferisce. I blog servono proprio a questo: isolare un dettaglio dal caos informe delle informazioni, trasformarlo in un argomento, uno slogan, un tormentone. I Neoconi sono bravissimi in questo.
Essendo giovani, e sotto assedio, i Neoconi hanno una dannatissima fretta. Cosa aspetta l’Iran a diventare una democrazia moderna? Cosa aspettano i palestinesi a ritirarsi ordinatamente nelle loro riserve? A voler consigliare prudenza, a spiegare che le cose sono un po’ complesse, che molti problemi vengono da prima dell’11 settembre e ci vorranno secoli a risolverli… si fa la figura che ci sto facendo io, e cioè del barbogio saccente.
D’altro canto i Neoconi non sono fondamentalmente cattivi, e anche se tollerano cose come Guantanamo o le cluster bombs, chi siamo noi per voler giudicare? Non abbiamo tutti tollerato tanti orrori del mondo?
Ma intanto il Neocone s’informa, è vorace di notizie, si dà da fare, cresce. Forse conviene sedersi sulla riva del fiume e vedere cosa succede. Le fedi sono come le scorie radioattive: sembrano incrollabili, in realtà hanno tempi di dimezzamento che si possono perfino calcolare. Certi Neoconi continueranno a essere Neoconi per centinaia d’anni: ma altri no. Il tempo s’incaricherà di corrodere le loro convinzioni, addolcirli, e alla fine verranno anche loro a sedersi qui di fianco. Che c’è posto.
First we take Bassora, then we take Berghèm (primo episodio)
I'm guided by a signal in the heavens
I'm guided by this birthmark on my skin
I'm guided by the beauty of our weapons
First we take Bassora...
Fu lunga, breve, giusta, sbagliata, preventiva, mal preventivata, disumana, umanitaria, fu tante cose, la Seconda Guerra del Golfo, finché un giorno finì: e mentre i soldati dell’Iperpotenza sgomberavano (sostituiti dagli effettivi degli Stati vassalli), l’attesa montava, di conoscere quale sarebbe stato il prossimo obiettivo della Libertà Infinita; quale altro Stato Canaglia avrebbe avuto il privilegio di assaggiare il dolce sapore della democrazia, con quel vago retrogusto di uranio. In Occidente si accettavano scommesse; nel Medio Oriente s’incrociavano le dita e le code di paglia, lunghe assai.
Perciò la sorpresa fu grande, quando si scoprì che il fortunato prescelto era un Paese mollemente sospeso tra Africa ed Europa, ma da millenni iscritto nel catasto Occidentale; un antico faro di Civiltà, anche se negli ultimi tempi sbirluccicava appena, e un amico di vecchia data dell’Iperpotenza (come l’Iraq, del resto). Cosa poteva giustificare una simile scelta? Il petrolio? No, petrolio non ce n’era. Appena appena un po’ di metano, ma chi farebbe una guerra per il metano? No, ormai le guerre non si facevano più per il profitto, ma per la democrazia, punto e basta. L’Iperpotenza riteneva che non ce ne fosse abbastanza, in quel Paese, e aveva deciso di rovesciargliene un po’, lei che non sapeva più dove metterla.
A chi obiettava che quel Paese era, ufficialmente, una Repubblica democratica fondata sul Lavoro, gli ideologi dell’Iperpotenza replicavano con franche risate. Una Democrazia, quella? Con un Presidente che possedeva in forma privata metà dell’etere televisivo e in forma pubblica l’altra metà? Con un Parlamento che varava riforme della giustizia ogni volta che un parlamentare veniva beccato con le mani nel sacco? Con intere regioni in mano a tribù e a clan della malavita organizzata? Forse che Saddam Hussein era un Presidente democratico perché vinceva le elezioni col 99%?
E poi c’erano alcuni diabolici dettagli, che alimentavano il sospetto – qualcosa di più di un sospetto – nel cuore della diffidente Iperpotenza. Già da tempo essa aveva imparato a dubitare degli amici ancor prima dei nemici, specie se erano amici grandi produttori e commercianti di armi.
Perché, proprio nel corso della guerra del Golfo, il Parlamento di quel Paese aveva sentito l’esigenza di consentire ai propri produttori di vendere armi ai Paesi che violavano i diritti civili? Pura coincidenza? E che dire di due anni prima, quendo ancora fumava Ground Zero e il mondo faceva la fila per esprimere le condoglianze all’Iperpotenza ferita al cuore? Non era stato forse lo stesso Parlamento *democratico* a votare una norma sulle rogatorie internazionali che era come un invito alle organizzazioni criminali e terroriste del mondo a nascondere i propri capitali in quel bel Paese? Insomma: si trattava di uno Stato amico o di uno Stato canaglia? Certe volte era difficile distinguere. Ma nel dubbio, si bombarda: era una prassi consolidata, ormai.
Certo, i governanti di quel Paese avevano avuto tante belle parole di solidarietà con l’Iperpotenza. E quanta retorica sulla Terra della Democrazia, sulla bellezza delle stelle e delle strisce… ma aiuti concreti? Pochini. Invio di truppe al fronte? Solo a guerra conclusa. Uso delle basi? Sì, ehm, no, solo per azioni umanitarie, solo se ci mettete davanti al fatto compiuto.
“Ma insomma”, sbottavano i diplomatici dell’Iperpotenza, “siete nostri alleati o no?”
“Ma sì. Ma no. Cioè, dipende dai sondaggi”.
E intanto la situazione degenerava, giorno per giorno. Nel Paese era scoppiata da anni una violentissima guerra civile, detta Guerra del Traffico. Ogni giorno (e ogni notte) su strade e autostrade i civili si scontravano in duelli suicidi, col tacito consenso dell'autorità, che incoraggiava le fazioni a rottamare e acquistare auto sempre più veloci e distruttive, in nome dell'interesse nazionale e del Prodotto Interno Lordo. Ogni anno il numero di morti superava di gran lunga quello dell’Intifada palestinese. Urgeva un’invasione, per ripristinare, se non la libertà e la democrazia, almeno il Codice Stradale. Sarebbe morto qualche innocente, certo. Ma non si poteva far finta di niente, nascondere la testa nella sabbia.
I don't like your fashion business, mister.
I don't like these drugs that keep you thin.
I don't like what happened to my sister.
First we take Bassora...
Furono così avviate le procedure d’invasione, i colloqui multilaterali, i siparietti con gli ispettori ONU, e tutto l’armamentario che serve a far rilassare il telespettatore tra una guerra e l’altra, e a stimolargli l’appetito (parla di guerra per sei mesi, e alla fine ti supplicheranno di cominciarla). Ma nel Paese in questione, pigramente sospeso tra Europa e Africa, la tensione cresceva. Non era cosa di tutti i giorni, diventare un target militare.
I cittadini, specialmente, erano un po’ perplessi. (Continua...)
 Domande più frequenti (2)
Domande più frequenti (2)Dov’eravate quando la NATO bombardava la Serbia?
Alcuni erano qui, altri erano via, alcuni erano contro i bombardamenti, altri pensavano che fossero giusti. Il dibattito fu feroce, ma è proprio il caso di riaprirlo adesso? La situazione in Iraq è molto diversa.
Ma anche se, per assurdo, avessimo sostenuto tutti la Nato in quell’occasione: e allora? Non ci sarebbe consentito cambiare idea? Molti che espongono bandiere ai balconi non l’avrebbero sicuramente esposta nel 1991 o nel 1999. Ma il pacifismo in Italia è cresciuto anche perché i Paesi Occidentali ultimamente viaggiano al ritmo di una guerra all’anno: una cosa mai vista sui libri di Storia.
E allora attenti, perché in democrazia sono proprio le persone che cambiano idea a far vincere o perdere le elezioni. Dov’eravamo ai tempi della Cecenia, della Bosnia, del Ruanda, del Congo, delle Falkland? Non sono fatti vostri. Adesso siamo qui, è questo il problema.
(Perché invece, voi dov’eravate ai tempi della Cecenia, della Bosnia, del Ruanda, del Congo, delle Falkland?)
Siete sicuri di non essere anti-americani?
E l’America è sicura di non peccare di arroganza? Sempre, davanti all’ostentazione del potere, qualcuno storce la bocca. Un grande potere dev’essere gestito con molta saggezza, per evitare di destare intorno a sé invidia e rancore. In passato, negli USA, ci sono state amministrazioni che hanno dato prova di questa saggezza. Non è il caso dell’amministrazione Bush jr.
L’opposizione all’America, in ogni caso, non è dettata dalla semplice invidia (così come il vostro filoamericanismo non è necessariamente servilismo). La politica estera dell’amministrazione Bush jr è tutt’uno con la politica interna e con il modello economico che sottende. La guerra è il modo in cui il gigante proclama al mondo che “il tenore di vita dei cittadini americani non è in discussione”. Noi, se ci permettete, non siamo d’accordo.
Poi, certo, finché siamo cittadini occidentali istruiti siamo anche in grado di distinguere tra un’amministrazione americana (che ci sta antipatica) e il popolo americano (che adoriamo, col suo cinema, la sua musica e la sua letteratura). I ragazzi nati nei campi profughi di Gaza non sono in grado di fare questa distinzione. E i ragazzi nascono nei campi profughi di Gaza da cinquant’anni.
E siete sicuri di essere meglio degli americani? Anche voi consumate petrolio. Non trovate che gli americani stiano combattendo anche per voi?
Il nostro stile di vita è molto simile a quello degli USA. Ma mentre cerchiamo di moderare i nostri consumi, non possiamo fingere di non vedere che gli americani si accaparrano il 60% delle risorse mondiali. La loro avidità crea un forte squilibrio nel mondo, e li rende impopolari presso una parte crescente della popolazione mondiale. Nei Paesi meno sviluppati questa impopolarità prende la forma dell’integralismo religioso; in Occidente dà vita ai movimenti di protesta. Gli USA (e i loro Paesi satellite) devono combattere contro gli uni e gli altri, e nel frattempo accaparrarsi le risorse necessarie a mantenere il proprio status di superpotenza. La guerra in Iraq non è che un fotogramma di questo lungo conflitto, che è iniziato anche prima dell’11 settembre.
Ma allora voi e Bin Laden siete dalla stessa parte…
No. Noi e Bin Laden non parliamo la stessa lingua e non saremmo in grado di capirci. Il fatto che anche lui attacchi l’egemonia USA non ce lo rende in nessun modo più vicino a noi. Dal nostro punto di vista c’è più distanza tra noi e lui che tra lui e Bush. Del resto sono stati gli USA a inventarlo, e non è escluso che in futuro tornino a usarlo contro di noi. Come fa ogni capetto locale quando grida all’intelligenza fra sinistra pacifista e terrorismo islamico: è una demonizzazione dell’avversario indegna di una democrazia, e di chi si sente così ricco di democrazia da volerne anche esportare.
Come ci si sente a essere la seconda superpotenza mondiale?
Hai letto troppi giornali. Noi non siamo la seconda superpotenza, siamo ancora una potenza di terzo o quart’ordine. Ma in questa fase storica siamo gli unici che possono diventare una superpotenza senza correre il rischio di essere bombardati preventivamente.
È per questo che facciamo un po’ paura ai nostri governi. Non tanta paura: appena un po’.
C’è altro?
L’anno scorso mi disse: “Vado in Palestina”, io gli risposi: “quasi quasi vengo anch’io”.
Quest’anno mi ha detto: “Vado in Iraq”, io gli ho risposto: “sei matto”.
Oggi dovrebbe essere a Bassora. Il suo 15 febbraio l’ha fatto a Bagdad.
... [la sintassi è quella che è, provateci voi con le tastiere del medioriente] Qui tutto ok, la manifestazione bellissima. Temevamo che si inserissero iracheni con le foto di S.H. ma cosi' non è stato. Però la gente, i bambini, le donne ci salutavamo dalla finestra con sorrisi e "thank you", gli operai dalla impalcature ci chiedevano le bandiere della pace per sventolarle. Bello. […]
Per il resto incontri, visita al suk, alla università, al rifugio della famosa strage del 92. La gente e la città sono molto più laiche di come pensavo. Rarissimi i burka e perfino i veli non tanti, molte donne vestite occidentali, la gente ti parla, accetta le foto perfino nella moschea. Certo niente alcool, ecc, la strada è lunga ma diversa da come ce la raccontano. La paura non si sente, viene esorcizzata con vita intensa e festosa, molti matrimoni, gente in strada, musica, ecc. Un po' sarà anche che non sanno tutto e un po' che sono fatalisti ma non del tutto, vedo la tv in camera e non parla quasi d'altro.
Em. non lo sa (e quando lo saprà s’incazzerà molto), ma è un porco fascista. Almeno stando a Fred Barnes, direttore del Weekly Standard (segnalato da Camillo). Come tanti altri opinionisti non solo americani, Barnes ha improvvisamente scoperto che in Iraq c’è una vergognosa dittatura da abbattere, altro che petrolio. E chi non lo ha ancora capito è un “porco fascista” (testuale: “Fascist pigs”). Compresi i milioni che hanno manifestato sabato.
 Siam tre (milioni di) piccoli porcellin
Siam tre (milioni di) piccoli porcellinMi scuserete per la traduzione casereccia.
“La corruzione della Sinistra si è aggravata negli ultimi anni. Questo non è mai stato tanto evidente come lo scorso Sabato, quando massicce manifestazioni contro la guerra si sono svolte a New York, San Francisco e altre città degli Stati Uniti e del mondo, tra cui Londra. Forse che i manifestanti hanno marciato contro il consolato iracheno di New York per chiedere di porre fine ai crimini di Saddam? No. Forse che lo hanno condannato nei loro slogan e nei loro striscioni? Macchè. Forse che hanno difeso le vittime di Saddam? No. La sinistra, oggi, sta sdoganando i dittatori fascisti. Il suo nemico sono gli Stati Uniti”.
“Mr. Barnes?
Mr. Barnes, la chiamo dall’Italia. È una nazione fuori dagli Stati Uniti. Ha presente Roma? Lì intorno. Roma, sì, il Colosseo, Ridley Scott ci ha fatto un film.
Anche a Roma c’è stata una manifestazione, un po’ più grande che a Londra. Eravamo tre milioni. Mancava praticamente solo il Papa, per motivi di salute. Chi è il Papa? È… un capo religioso, molto importante. Fascista anche lui, evidentemente.
Lo sa che il Fascismo lo abbiamo inventato noi? Poi, grazie a voi, lo abbiamo scacciato. Anche se a dire il vero, nell’inverno del ’44 potevate darvi una mossa, invece di lasciarci i tedeschi in casa … ma è inutile recriminare. Ci avete salvati. Vi saremo eternamente grati. Oddio, senza l’Armata Rossa ci avreste messo ancora più tempo, ma noi preferiamo essere grati a voi piuttosto che all’Armata Rossa. Voi siete più simpatici, anche se non avete mai brillato in Storia e Geografia.
Mr. Barnes, ho letto il suo ultimo editoriale. Secondo lei tutti quelli che danno una chance a Saddam Hussein sono porci fascisti. Beh, è un’idea coerente. E io apprezzo la coerenza.
Apprezzo la coerenza che la portò, negli anni Ottanta, a scrivere vibranti editoriali contro l’amministrazione Reagan che finanziava Saddam Hussein nella guerra contro l’Iran. A quel tempo scriveva che non è giusto finanziare una dittatura fascista per combattere una dittatura religiosa. Ed aveva perfettamente ragione.
Apprezzo la coerenza che la portò, nel ’91, a dare del porco fascista a George Bush Primo, quando ordinò al generale Schwarzkopf di ritirarsi invece di entrare a Bagdad. Aveva ragione: quale insulso calcolo geopolitico poteva valere più della libertà di un popolo? Forse che i cittadini iracheni non avevano lo stesso diritto alla libertà degli emiri del Kuwait?
Per tutti questi anni ha continuato a tenerci informato sugli abusi criminali di quel regime. Non ha mai distolto lo sguardo. Diede del porco fascista a Clinton, che a parte qualche bombardamento di routine non sembrava assolutamente intenzionato a cambiare nulla in Iraq. Spiegò con pazienza che anche l’embargo, che colpisce la popolazione e rafforza la classe dirigente (e quindi la dittatura) in realtà è solo una porcata fascista. E aveva ragione, Mr. Barnes. Lei è l’autentico paladino delle libertà irachene.
Mentre noi, poveri illusi pacifisti, per tutto questo tempo neanche sapevamo dove fosse sulla cartina, l’Iraq. Non ce n’è mai fregato niente. Lo abbiamo tirato fuori solo come scusa per parlar male dell’America.
Il fatto è che oltre a essere porci e fascisti, siamo anche schifosamente modaioli. Nel 2001 ce la menavamo tanto con l’Afganistan, dicevamo che era ingiusto bombardarlo: ma che ne sapevamo? Credevamo che i bombardamenti anglo-americani avessero lasciato diverse migliaia di vittime, ma a quanto pare ci sbagliavamo: le vittime civili sono solo poche centinaia, “few hundred”. Lo dice lei, che è un giornalista informato, noi non abbiamo motivo per dubitarne. Quest’anno c’è venuta la smania per Saddam Hussein. Ma ci passerà presto. Piuttosto c’è da chiedersi cosa ci verrà in mente dopo. L’Iran? Il Venezuela? Il mondo è pieno di dittatori da difendere. C’è solo l’imbarazzo della scelta, per dei piccoli porcellini fascisti come noi”.
(Se qualcuno mi dà una mano a tradurre, gliela spedisco pure.
Dite che capirà l’ironia?)
La stanchezza di Rosa Parks
There comes a time that people get tired (M. L. King)
La sera del primo dicembre 1955 Rosa Parks era stanca.
Tornava a casa dal lavoro (sarta in un grande magazzino a Montgomery, Alabama). Sull’autobus che aveva preso non c’erano posti a sedere per lei. Ma Rosa era molto stanca, e aveva deciso di sedersi ugualmente: sui sedili riservati ai bianchi.
Magari non era la prima volta. Magari aveva messo in conto qualche occhiataccia dei passeggeri. Ma alla fermata successiva, quando il conducente (una vecchia conoscenza) le chiese di alzarsi e lasciare il suo posto ai bianchi, Rosa rispose che era stanca, e che non si sarebbe alzata.
La stanchezza non le passò quando il conducente minacciò di fermare il bus e chiamare la polizia.
("Well, I'm going to have you arrested"
"You may go on and do so.")
Così Rosa Parks fu arrestata, il primo dicembre del 1955. Il resto è Storia. L’associazione nazionale per il progresso dei cittadini di colore organizzò un tipo di protesta del tutto nuova, destinata a un insperato successo: il boicottaggio dei trasporti pubblici di Montgomery, che per due terzi erano utilizzati dai neri.
Non fu una passeggiata: il boicottaggio durò 382 giorni. Uno dei promotori, il reverendo battista Martin Luther King, fu arrestato; la sua famiglia subì un attentato. Ma proprio nei giorni del processo la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò incostituzionali le leggi segregazioniste dell’Alabama. Così, a un anno dal suo arresto, il 21 dicembre 1956, Rosa Parks salì di nuovo su un autobus, ma dalla porta posteriore, fino a quel giorno riservata ai bianchi. Da quel giorno Rosa è diventata un’icona delle lotte per i diritti civili. E un simbolo di quanta forza ci possa essere nella stanchezza.
***
Se ho un rilievo da fare, a me, e in genere a tutto il Movimento, non è l’energia che mettiamo in quello che facciamo, che è benedetta, finché c’è.
Ma ho la sensazione che tanti di noi diano troppo affidamento alle proprie capacità. Ci dicono tutti: siete instancabili, voi attivisti. Ce lo diciamo anche noi. E – quel che è peggio – ci crediamo.
Finché un giorno non succede quello che non sarebbe mai dovuto succedere: ci stanchiamo. Prendiamo sonno alle assemblee. Marchiamo visita alle riunioni. Fin lì è ordinaria amministrazione. Poi cominciamo a dar buca agli appuntamenti, anche quelli fissati da noi: pessimo segno. Oppure nulla di tutto questo: continuiamo imperterriti finché non ci scontriamo coi limiti strutturali del nostro corpo: gastriti, emicranie, esaurimenti.
A quel punto, forse dovremmo chiedere scusa. E invece iniziamo a recriminare. Cominciamo a far pesare tutto il tempo che abbiamo investito nel Movimento, vorremmo riaverlo indietro (come se non avessimo sempre saputo che i patti non erano questi). Ci lamentiamo che tutti facciano affidamento su di noi, quando siamo stati noi i primi a voler fare tutto per gli altri. Perché degli altri non ci fidavamo. E adesso che siamo stanchi, non ci fidiamo più nemmeno di noi stessi.
Di lì a poco iniziamo a diventare scettici. Vediamo che il mondo va avanti anche durante i nostri periodi di stanchezza, e va male, naturalmente. Le cose vanno sempre peggio e nessuno riesce a farci niente. Certo, noi ai nostri tempi ci abbiamo provato, però… eravamo giovani e inesperti, e per giunta circondati da incapaci. Ci è andata male. Per consolarci impesteremo la generazione dei nostri figli con le nostre nostalgie deprimenti.
***
Io sono contento di aver ricevuto un’educazione cattolica. Ho assunto molti anticorpi in quel periodo.
Per esempio, ho maturato una grande diffidenza verso l’entusiasmo, verso le vocazioni troppo assolute, troppo rapide. Nella fede, come nell’amore, come nell’attivismo (che è quello di cui stiamo parlando), ho sempre avuto paura di essere un fuoco di paglia, lesto ad accendersi e a spegnersi subito dopo.
Certo, anche un fuoco di paglia ha la sua utilità, se vuoi accendere un falò. Ma quello che ti serve veramente è uno di quei ceppi grandi, secchi, che all’inizio non vuol saperne di prender fuoco. E non farà mai una fiamma alta. Ma brucerà e ti terrà caldo tutta la notte.
Così, certe sere che sono stanco, stanco anche di dar la colpa al lavoro, o al movimento, quando la colpa è soltanto mia, mi dico che anche la stanchezza ha i suoi vantaggi: basta accettarla per quello che è, farne il proprio Piave, puntare i piedi e mantenere la posizione. E cerco di pensare a chi è riuscito, in un determinato momento, per una determinata causa, a fare della sua stanchezza la sua forza. Non è che mi vengano in mente tanti esempi. Ma per fortuna c'è Rosa Parks.
Rosa Parks was physically tired, but no more than you or I after a long day's work…
Allora: secondo Marco Giusti, (L'Espresso) l'assegnazione degli Oscar è la prova che il cinema americano è in grande forma: Premiati gli effetti speciali e il cinema d’avventura. Ma anche pellicole “impegnate” di stampo europeo come “Traffic” e “Erin Brockovich”. Segno che Hollywood si è appropriata di tutto il cinema. Anche di quello che non era nelle sue corde.Invece per i critici del Manifesto, l'Oscar è l'orchestrina del Titanic, il 2001 è la "fine del cinema USA", come prova il successo senza precedenti delle pellicole non americane anche oltreoceano.
Chissà chi ha ragione… i pezzi del Manifesto mi sembrano più documentati e convincenti. Io non sono un critico, molto cinema l'ho guardato in tv, e il cinema americano è quello che mi è più familiare. Ultimamente ho notato che m'interessa sempre meno. S'avverte sempre più la sensazione che i plot siano studiati a tavolino da una commissione politico-scientifica. Ci dev'essere almeno un personaggio di colore, e non importa se ha un fisico di NBA, dev'essere più posato e ragionevole di un altro personaggio bianco, per evitare lo stereotipo. Il cattivo dev'essere punito, il cattivissimo salvato per il sequel. Ci devono essere tre grandi scene d'azione, una subito (così i ragazzini fanno silenzio in sala), una all'inizio del secondo tempo, una alla fine. Non discuto, penso anzi che sia un modo molto razionale di organizzare la sceneggiatura, ma quando inizi ad accorgertene ormai sei fuori gioco. Dopo venti minuti di Sesto senso sai già come va a finire, cosa resta?
Poi ci sono le cazzate belle e buone. Il gladiatore, per esempio, può vincere tutti gli Oscar che vuole, e Giusti può trovare Crowe "fantastico", ma resta una cazzata, di quelle che ogni tanto ti fanno dubitare di tutta la categoria dei critici, dei cinefili e dei lobbisti dell'Academy Awards (che avranno avuto le buone ragioni, ma nessuno si è alzato a dire che il re è nudo, che Ridley Scott si è bevuto il cervello, o forse è stato sostituito da un automa, come pare sia successo ad Harrison Ford in Blade Runner?).
I critici. Gente che non farebbe male a una mosca... ma una volta oltrepassata la soglia di velluto della sala, si trasformano in belve assetate di sangue. Picchia qua, taglia là, sangue a fiotti, che gran cinematografia.
Facesse almeno venire i brividi. Ma puoi portarci un bambino e vederlo sbadigliare. A un certo punto, prima di entrare nell'arena, un gladiatore si piscia addosso. Ecco, è l'unica scena in cui mi sono sentito un po' in pena. Per il resto, chi se ne frega di tutte quelle comparse mascherate a cui salta via la testa con tanta facilità. La trama, poi, è una sfida (persa) al senso del ridicolo. L'imperatore che si fa ammazzare al colosseo. Ma neanche in un cartone animato giapponese.
Sempre Il manifesto ci ricorda che a Hollywood siamo alla vigilia di un clamoroso sciopero, che dagli autori potrebbe contagiarsi agli attori. V'immaginate un anno senza cinema americano? Si starebbe davvero così male? Chi lo sa. Forse ci accorgeremmo che a vedere questi film ci andiamo più per inerzia che per altro, che alla fine delle nomination e delle sfide per gli oscar non ce ne frega niente. Come dei gladiatori di Scott. Hai un bel da vestirli alla moda, di scannarli con violenza ed eleganza. Non ci fanno neanche compassione. Sei un vecchio guerriero suonato, Hollywood. Pollice verso.
 Pseudo-cripto-ebrei
Pseudo-cripto-ebreiChi cerca un'identità guarda spesso al passato. Tutti noi, anche se poveri, ci crediamo almeno gli eredi di una tradizione, di una cultura. Se ci fosse richiesto di definirla ci troveremmo in difficoltà. Se ci fosse chiesto un documento scritto, citeremmo poderosi volumi che probabilmente non abbiamo mai letto. È possibile che i talebani, "studenti di teologia", non abbiano mai letto il Corano (del resto un lettore della Bibbia può mettere in difficoltà un sacerdote in pochi secondi).
Tutto questo nostro passato, ricco di cultura e tradizioni, forse è solo frutto della nostra immaginazione.
Questa è la strana storia dei finti cripto-ebrei del Nuovo Messico.
I cripto-ebrei sarebbero gli ebrei spagnoli che avevano conservato clandestinamente le tradizioni e la religione originaria anche dopo le conversioni forzate al cristianesimo, volute dalla corona di Spagna. Nessuno dubita che cripto-ebrei ce ne siano stati veramente, anche a prescindere dalle paranoiche 'cacce all'ebreo' scatenate dall'Inquisizione spagnola in tutti i territori del re cattolicissimo.
Tra questi territori c'era anche il Nuovo Messico, oggi uno dei 50 Stati Uniti d'America. È lì che all'inizio degli anni Ottanta lo storico Stanley Hordes, intrigato dalla presenza della stella di David su alcune lapidi, scopre le tracce di un'antica comunità cripto-ebraica, e individua addirittura gli eredi viventi dei cripto-ebrei. Come scrive Marco D'Eramo
Man mano che le sue ricerche si venivano a sapere, spontaneamente gli si presentavano persone che testimoniavano: "Quel tale è ebreo perché..." o altre che ricostruivano alcuni lati oscuri della propria infanzia e nell'ebraismo nascosto dei propri genitori scoprivano la ragione per cui da piccoli non erano stati mai a messa o non avevano mai mangiato maiale.
La cosa attira naturalmente l'attenzione della comunità ebraica statunitense (stavo per dire "della potente lobby ebraica statunitense", ma diavolo, sempre con questi luoghi comuni e anche un po' antisemiti…). Vengono raccolte testimonianze, girati documentari… nel frattempo gli eredi dei criptoebrei, riscoperta la loro cultura, iniziano a convertirsi, a circoncidersi, a compiere viaggi in Israele. In breve innalzano anche una sinagoga.
Nel frattempo la storia del cripto-ebraismo si sgonfia. Un'altra ricercatrice, Judith Neulander, esamina tutte le ingegnose prove escogitate da Hordes e le confuta, una ad una. La presunta antica comunità cripto-ebraica si rivela essere una non meno curiosa comunità protestante, di origine avventista, arrivata nel New Mexico dal Midwest. La stella di David e i nomi ebraici erano parte integrante del folklore di questa setta che si riteneva una delle tribù perse d'Israele.
La domanda che sorge spontanea è: cosa faranno quei poveri cripto-ebrei che nella scoperta del loro cripto-ebraismo avevano magari trovato un senso alla loro esistenza? Si convertiranno daccapo alla Chiesa del Settimo Giorno? Se, come pare, qualcuno ha già trovato la ragazza in Israele, è un po' troppo tardi per riconoscere che le proprie radici sono frutto di un malinteso.
La storia degli pseudo-cripto-ebrei c'insegna qualcosa? A non prendere troppo sul serio le identità culturali? A non sentirsi sulle spalle secoli di Storia? Invece di rimproverarci le frustrazioni di un'educazione cattolica bimillenaria, potremmo accorgerci che il nostro presunto retaggio culturale non va più indietro del Concilio Vaticano II, e che tutto quello che c'è stato prima ci è altrettanto estraneo dei misteriosi cripto-ebrei – ma forse dovremmo concludere che ne sappiamo veramente poco, sulla Storia e su di noi… l'articolo di marco D'Eramo sul caso dei cripto-ebrei è comparso mercoledì sul Manifesto. Una ricostruzione appassionante (ma in inglese), è sul numero del Dicembre 2000 di Atlantic on Line.


















































































