Adolescenti, non li spiamo mai abbastanza
04-04-2025, 01:26cinema, delitti e cronaca, forze dell'ordine, scuola, tvPermalinkHo visto Adolescence, ci ho messo i miei tempi. Non mi sembra dica nulla di troppo profondo sulla violenza di genere, anche se lo dice con espedienti che destano sempre ammirazione (i piani sequenza) e a volte rischiano di mettersi tra noi e il messaggio – ma immagino sia un problema soltanto per chi tiene molto a questa cosa del messaggio. Senz'altro viene incontro a un'esigenza di aggiornamento che ogni tanto assale il mondo degli adulti, la necessità di svecchiare il lessico; come dice il ragazzino, voi parlate sempre di bullismo, ecco, in effetti potremmo considerare il bullismo la punta di un iceberg, e avere la curiosità di cosa c'è sotto. Sotto ci sono i redpillati, i ragazzini che per rompere il ghiaccio prendono le dritte dagli youtuber e li senti dire sciocchezze terrificanti (ma almeno ci provano), i gamer con i loro limiti empatici e attentivi che sono onestamente quelli che mi inquietano di più, forse perché ho la sensazione che abbiano preso il potere, almeno a Washington. Mi inquieta però anche il modo in cui gli autori di Adolescence hanno pensato di impostare il discorso, ma non credo di essere oggettivo, in fondo si parla delle persone con cui lavoro.
La serie si aggira in un mondo in cui tutto è sempre accessibile e visibile: del resto gli inglesi oltre ad avere le migliori scuole di recitazione al mondo sono all'avanguardia anche nella diffusione delle videocamere di sorveglianza – qualcuno prima o poi metterà in correlazione le due cose; forse Adolescence è un tentativo di metterle in correlazione. I primi tre episodi potrebbe averli previsti Foucault, sono come tre piani del Panopticon: la Stazione di Polizia, la Scuola e l'Istituto Psichiatrico. La scelta del piano sequenza potrebbe alludere a questo: siccome tutto è sempre visibile, ci è consentito di aggirarci sulla scena tra i personaggi: ma non è vero, tutto è visibile solo a chi possiede i circuiti chiusi, e inoltre le videocamere non si aggirano così, avrebbe avuto più senso un montaggio di camere fisse. Questa disparità tra chi vede tutto e chi può solo sperare di non disgustare gli spettatori esplode nel terzo episodio, dove il ragazzino crede di essere il protagonista della sua tragedia e invece è sedotto, spiato, svuotato e respinto con un moto di genuino fastidio (quel mezzo conato di vomito della psicologa, quando sta per addentare il tramezzino, per me è il momento più notevole). Il quarto episodio spiazza un po' lo schema che mi stavo facendo, ma anche seguendo la famiglia, gli autori non smettono di dirci che tutto è visibile, tutto è videocamera, tutto è giudicabile e da questo giudizio costante e universale non si può più sfuggire. Va bene. Ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di instagram. Ma vorrei tornare ai primi due episodi, perché sono quelli che mi hanno lasciato le sensazioni peggiori.
Il primo comincia con un'irruzione della polizia che lì per lì ci sembra esagerata, ma tutto il resto della serie vorrà dimostrarci che non è vero, che la polizia ha fatto benissimo a irrompere così. Dopodiché seguiamo i personaggi in una Stazione di Polizia dove tutti sanno quello che stanno facendo, e lo fanno con professionalità e sollecitudine. È un procedurale nel senso letterale del termine, nel senso che per l'80% non fa che mostrare cosa succede passo dopo passo quando la polizia inglese ti arresta per sospetto omicidio. L'unica cosa che mi ha lasciato perplesso è che nessuno, per più di mezz'ora, chiede ai poliziotti chi sia morto: sinceramente sarebbe la prima cosa che domanderei, persino se l'avessi ucciso io. Ma forse gli inglesi hanno un più alto concetto della privacy, che ne so. In compenso il padre dice qualcosa come: ci avete sfasciato la casa, e il poliziotto gli risponde: Non è vero. Comunque ci sono i video e potrà sporgere reclamo. Se non avete un avvocato ve lo diamo noi ed è bravissimo. La polizia possiede i video e gestisce l'oggettività: può affermare in qualsiasi momento cosa è vero e cosa non lo è, e la cosa non ci preoccupa perché vediamo che i poliziotti sono esseri umani con debolezze standard, ma anche un buon livello di professionalità ed empatia. Fantastico.La seconda puntata è ambientata in una scuola media, e forse questo sta offuscando la mia oggettività, ma il confronto tra i due piani concentrazionari è impietoso. A scuola niente funziona. I professionisti non sono professionali, non riescono a controllare i ragazzi che si pestano ferocemente anche sotto i loro occhi, che comunque a volte nemmeno ci sono, perché come nelle scuole del cinema americano assistiamo a sequenze importanti dove gli adulti non si fanno vivi, per quanto sia irrealistico; forse semplicemente sono in ritardo, o in pausa caffè; non insegnano, non consolano, non risolvono, sanno solo dire "fermo lì" e: "guardate il video". Ci sono video dappertutto, dice il poliziotto disgustato (lo stesso poliziotto che senza le videocamere non avrebbe risolto il caso). Invece la poliziotta ci ricorda un paio di volte che la scuola puzza, di cavolo e masturbazione. (La Stazione di Polizia probabilmente sa di caffè e inchiostro per le impronte). La scuola è il luogo del delitto, che in effetti è avvenuto a qualche iarda di distanza, ma è a scuola che i ragazzi si sono conosciuti e si sono predisposti per odiarsi a morte. Ora, io non so se le scuole inglesi siano davvero così – e a tal proposito comincio a capire la saggezza dei nostri antenati, che decise di isolare le Medie Inferiori sia dalle Elementari sia dalle Superiori, perché è davvero una fase critica che è meglio sia guardata a vista, da professionisti abituati alla stupidità così peculiare di quella fascia di età. Quel che mi disturba davvero è vedere un contrasto così netto tra forze dell'ordine e scuola del caos. Un contrasto che il terzo episodio non fa che fortificare: anche stavolta il contrasto è tra una psicologa superprofessionale e un ragazzino cresciuto in una jungla finta che crede che fare "buh" lo renderà più interessante. È difficile assistere alla sequenza senza provare un compiacimento sadico per il modo in cui il Caos viene interpretato e definitivamente represso.
Infine, se proprio vogliamo unire i puntini, nella quarta puntata il padre ricorda che non ha mai picchiato suo figlio, perché? Perché suo padre lo cinghiava troppo. E qui forse c'è il vero gap culturale, perché gli inglesi in effetti sono stati gli ultimi europei a togliere le punizioni corporali a scuola, laddove in Italia la generazione che si era ripromessa di non toccare i figli tutto sommato era quella dei miei genitori (i boomer, sì). È il momento in cui i genitori si stanno lambiccando per capire dove hanno sbagliato, se hanno sbagliato: forse il padre non doveva voltarsi dall'altra parte mentre il figlio portiere prendeva tutti quei goal (nella società delle videocamere, voltare lo sguardo è l'offesa estrema). Oppure, chi lo sa, gli autori non lo dicono, ma unendo i puntini uno potrebbe anche giungere alla conclusione che la cinghia ogni tanto va usata; che la scuola era più seria al tempo dei frustini e dei righelli; che l'unica istituzione che funziona davvero – la Polizia – funziona perché non si fa scrupolo di puntare un fucile su un adolescente nel suo letto durante un'irruzione, o di inseguirne un altro tra i marciapiedi anche se a conti fatti è inutile, dove vuoi che scappi, hai l'indirizzo, hai il telefono, lo riacciuffi tra tre ore al Macdonald, a Carpi i tizi che entrarono con un autobus in una scuola li presero lì. Insomma ci ho messo i miei tempi, ma ho concluso che Adolescence è una serie reazionaria che ti spaventa coi ragazzini omicidi per suggerirti che ci vuole più repressione. L'estremo opposto dei 400 colpi: se li lasci un po' liberi sapranno solo farsi male, l'unica è sequestrargli le lame e spiarli in modo più capillare: mai distogliere lo sguardo, mai. Onestamente mi dispiace pensarla così, non mi sembrava così terribile guardandola, ma rileggendomi purtroppo mi ritrovo d'accordo.
Due film che non c'entrano nulla
20-03-2025, 19:42Americana, cinema, governo Meloni, memoria del 900, scuolaPermalinkForse perché non ho mai avuto molte illusioni sulla statura politica e morale di Giorgia Meloni, che mi ritrovo sempre meno in sintonia con chi la rimprovera. È un po' come Berlusconi, ai tempi in cui i suoi detrattori sbagliavano costantemente obiettivo: quello corrompeva la guardia di finanza, e loro gli davano del nano pelato. Aa Meloni invece l'altrieri ha osato non riconoscersi nel Manifesto di Ventotene, il che non può essere una sorpresa per chiunque conosca un po' sia lei sia il Manifesto: ma improvvisamente questo diventa un delitto di lesa maestà, all'improvviso una mattina il Manifesto di Ventotene diventa una specie di carta costituzionale benché nessun parlamento l'abbia approvata, e la maggior parte di noi l'abbia nemmeno letta. Però Repubblica la pubblica in edicola, e Benigni ci farà la sua predica annuale, quindi aa Meloni come si permette. Ora, quand'è successa questa cosa? Quand'è che Spinelli e Rossi, la cui eredità politica sembrava essersi perduta nell'immediato dopoguerra, sono diventati i nostri Padri Fondatori?
Non ne ho idea, è un caso che sinceramente non ho seguito. L'idea che la carta sia l'atto di concezione dell'Unione Europea mi è sempre sembrata una forzatura: Spinelli e Rossi avevano qualche buona idea (ma anche qualche abbaglio, inevitabile vista la situazione in cui scrivevano), ma non credo che senza le loro idee non avremmo avuto i trattati di Roma e poi di Maastricht. Così come è una forzatura affermare che l'europeismo sia nato a Ventotene, quando ne parlava ed esempio Mazzini già un secolo prima. A Ventotene la sinistra italiana arriva tardi, credo a metà degli anni Novanta: non ho argomenti per dimostrarlo, soltanto labili suggestioni (una Festa Nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, più di vent'anni fa, con un padiglione che ricostruiva scala 1:1 la camera di Spinelli).
Ad esempio l'anno scorso è uscito Un altro ferragosto di Virzì, che essendo il sequel di Ferie d'agosto è ambientato a Ventotene. Nel film Sandro, che già in Ferie era l'archetipo dell'intellettuale di sinistra declassato, ha sviluppato un'ossessione per una specie di pollaio che avrebbero costruito i confinati, e se ricordo bene ha chiesto l'intervento della Sovraintendenza ai beni culturali per preservare il monumento antifascista. Nel frattempo sta sempre peggio di salute e ha allucinazioni in cui vede Spinelli, Rossi, le rispettive mogli, e ovviamente Pertini: tutto un Walhalla laico di eroi che lo attende al di là della malattia. Mentre lo guardavo trovavo tutto molto appropriato, e allo stesso tempo cercavo di ricordarmi se nel film di un quarto di secolo prima Sandro avesse mai anche solo accennato agli antifascisti al confino sull'isola.
L'ho voluto riguardare e ho avuto conferma che no del 1996, Sandro dei confinati non parlava mai, e sì che non teneva molto spesso la bocca chiusa. Rivista con gli occhi di oggi, una dimenticanza del genere è inspiegabile: insomma, il primo film che mette in luce la nuova lotta di classe tra ceto riflessivo impoverito e borghesia berlusconiana abbruttita è ambientato nell'isola che fu il simbolo dell'antifascismo: una metafora cotta e servita, eppure gli sceneggiatori non ne approfittano mai, come mai? Forse nel '96 gli sceneggiatori non sentivano la necessità di sottolineare quanto fosse importante Ventotene per l'antifascismo e l'europeismo perché, come tutti noi, al tempo il manifesto lo ignoravano, dei confinati avevano sentito parlare molto vagamente, e Ventotene l'avevano scelta magari perché era più facile girare lì che, poniamo, a Ponza. Tutti questi Grandi Padri che Sandro si crea nel secondo film, circondandosi di figure serie e sorridenti un po' come Fazio quando sceglie gli ospiti di riguardo, sono adozioni molto tardive, di gente che si è ritrovata orfana di Gramsci e Che Guevara a quaranta o cinquant'anni. Può darsi che gli autori del secondo film l'abbiano ammesso, quando a un certo punto ci fanno scoprire (spoiler) che il pollaio è un falso storico, l'ha rimesso assieme il figlio di Sandro da bambino. È un retroterra culturale postumo, non necessariamente posticcio, perché ai manifesti si può aderire a qualsiasi età. Bisogna però leggerli. Aa Meloni un po' lo ha letto – anche solo un paragrafo – e ovviamente non le è piaciuto, il che è abbastanza in linea col personaggio e la sua storia. Chi invece se la prende con lei, lo ha letto davvero? Non necessariamente. È una generazione cresciuta riempiendo gli scaffali dei soggiorni di supplementi editoriali (libri, vhs, cd, dvd, album di figurine) senza sentire l'esigenza di aprirli troppo, a rischio di consumarli.
***
E ora qualcosa che non c'entra davvero nulla, ma siccome si parla di film, segnalo che su Raiplay c'è ancora non so per quanto The Fabelmans in versione originale coi sottotitoli: un altro film in cui a un certo punto ci sono lunghe scene in una scuola dove ragazzi e ragazze interagiscono, si parlano, si innamorano, ma soprattutto si bullizzano come belve e si pestano a sangue. Queste scene, che sono familiari alla mia generazione più dei Promessi Sposi, forse non le avrei mai trovate così strane se poi nella vita mi fossi ritrovato di nuovo nella scuola media, un posto dove ovunque vada il preadolescente devono esserci in media 1-2 adulti a guardarlo, tranne in bagno; e ciononostante colluttazioni se ne verificano ogni giorno, senza gli eccessi delle scuole americane, per il semplice motivo che appunto: adulti ce ne sono dappertutto, e per quanto non sempre siano svelti di riflessi, sono comunque un grosso deterrente che impedisce al cervello del preadolescente di anche solo concepire pestaggi organizzati o assalti alla baionetta nei corridoi.
Insomma se mi chiedete perché la società USA sembra subito più violenta della nostra, senz'altro sono convinto che un certa disponibilità di armi c'entri per qualcosa; ma poi l'idea forse cattolica che i ragazzini van guardati. Senonché.
Senonché in molte scuole adesso va di moda questa DADA, ovvero "Didattiche per Ambienti Di Apprendimento", che significa in soldoni che invece di spostare gli insegnanti dall'aula della classe A all'aula della classe B, sposti le classi dall'aula dell'insegnante A all'aula dell'insegnante B. Come tutte le didattiche, ha una sua funzionalità: ad esempio negli USA diverse materie sono opzionali, per cui è normale che gli studenti cambino non soltanto aula, ma proprio classe, ovvero trovino altri studenti, a seconda della materia. Da noi però succede questa cosa, che molte novità vengono accettate un po' alla svelta perché bisogna semplicemente mostrare ai genitori che stiamo innovando, e a parte questo non è che possiamo permetterci più elasticità di tanto, perché l'organico è quello che è (anzi lo tagliano), quindi le classi rimangono le stesse, però... cambiano aula. Se lo chiedete a me, spostare classi di 25 ragazzi invece che insegnanti singoli è un'autoevidente assurdità logistica, che serve semplicemente per limare altri minuti di intervallo tra una lezione e l'altra: è normale che gli studenti se ne dicano entusiasti, così come molti genitori che appunto, come me sono cresciuti più coi telefilm americani che con Leopardi. Poi in questo modo servono gli armadietti, vi immaginate? Proprio come nelle highschool, ma quanto sarà figo? Quindi qual è il problema?
Mah, ditemi voi. Se l'insegnante A resta fermo nella sua aula A, e l'insegnante B nella sua aula B, cosa succede nei corridoi compresi tra A e B? Esatto, un sacco di ragazzi di tutte le classi liberamente in giro. Capite che ci sono le premesse per cominciare anche noi a scrivere film e serie in cui ci si accoltella sui pianerottoli, è finalmente un gap con la scuola anglosassone che stiamo per colmare, vi immagino entusiasti, e poi tra vent'anni da tutto questo bullismo chissà che geni incompresi verranno fuori, che Spielberg, che Watterson, finalmente.
Nessuno è stato stronzo come Dylan (ma Chalamet s'impegna)
29-01-2025, 22:41Bob Dylan, cinema, musicaPermalink(Premessa che non c'entra quasi nulla con A Complete Unknown e quindi si può allegramente saltare)
Qualche tempo fa, non sapendo cosa guardare ho visto The King, un film del 2019 in cui Chalamet, non sapendo chi interpretare, interpreta Enrico V d'Inghilterra. È un film curioso perché Shakespeare ha fornito il materiale per una saga in tre stagioni, mentre gli sceneggiatori hanno deciso di tenere soltanto qualche suggestione (l'idea che Enrico da principe passasse il tempo nelle bettole con Falstaff), e raccontare un'altra storia, che sostanzialmente è... Dune. E notate che è un film del 2019. Ma c'è quasi tutto: un erede un po' recalcitrante ma che a un certo punto accetta l'idea di essere l'Eletto, onde per cui si fa convincere a guidare un esercito nella battaglia definitiva, senonché verso la fine (spoiler) una donna gli fa venire il sospetto di essere stato manovrato come un pupazzo, e di non essere l'eletto di un bel niente. È un canovaccio che davvero somiglia più a Herbert che a Shakespeare, e non mi pare che fosse molto diffuso prima di Herbert; anzi ho la sensazione che stia diventando popolare adesso, un altro film che ha un canovaccio simile ad esempio è il Blade Runner di Villeneuve; anche gli ultimi capitoli di Matrix e Joker se ho capito bene giocano sulla demistificazione dell'Eroe, insomma è una storia che fino a qualche anno fa non ci raccontavamo e di colpo ce la stiamo raccontando sempre più spesso. Forse ci dice qualcosa di noi, ma cosa? Che dovremmo smetterla di considerarci gli Eletti; che questa convinzione ci rende infelici oltre che pericolosi a noi e agli altri. Finirla con un certo calvinismo, finirla con un certo messianesimo troppo autoriferito. Se è la storia giusta al momento giusto, forse questo spiega il successo di Timothée Chalamet, un attore bravo e persino versatile, eppure sempre con l'aria di essere lì perché è l'amico di uno importante, una combinazione di ingenuità e arroganza che ti fa sempre istintivamente prendere le distanze. Chissà cosa avrebbe fatto con Dylan, mi sono domandato. E appena ho potuto sono andato a vedere A Complete Unknown.
(Se volete potete cominciare qui).
Forse davvero Bob Dylan contiene più moltitudini di ciascuno di noi. A questo punto Scorsese gli ha già dedicato due documentari, mentre di biopic ne abbiamo avuti altri due: fatevi venire in mente un altro artista vivente ispiratore di tanta produzione audiovisiva. E malgrado questo, ci sembra ancora di essere in superficie: i due film sembra che lo facciano apposta, uno si chiama Non sono qui e l'altro Un completo sconosciuto. Quest'ultimo si limita a inquadrare una brevissima stagione (il quinquennio 1961-1965), ma come ha osservato Alessandro Carrera (che su Dylan è autorità definitiva) lascia fuori talmente tante cose interessanti che potremmo farci un altro film. Sul serio: potremmo lasciar fuori Pete Seeger – tanto nessuno riuscirà mai a interpretarlo come Ed Norton – e metterci Dave Van Ronk, che in A Complete fa da tappezzeria: ma è stato lui a lasciare a Dylan uno spazio sul divano del suo appartamento nel Village, e uno slot di dieci minuti sul palco del Gaslight Café; è stato Van Ronk il primo a farsi fregare un pezzo da Dylan, il suo arrangiamento di The House of the Rising Sun. Potremmo mostrare un Dylan sconosciuto che guarda la Baez in tv cantare Silver Dagger, con i canini che brillano ai riflettori, cercando di restituire quel misto di invidia, di senso del pericolo e di attrazione che deve aver provato. La scena in cui finalmente la incontra di persona ma non se ne accorge perché ci sta provando con la sorellina Mimi, mentre Joan si domanda chi è quel campagnolo e perché puzza così tanto. Potremmo inserire il viaggio a Roma per fare una sorpresa a Suzie Rotolo che forse non lo voleva tra i piedi. Potremmo mostrare tutte le volte che è stata Suzie a dire no, non ci andiamo a vedere il solito film romantico in bianco e nero, invece andiamo a una mostra o a teatro perché è ora che impari due cose sul mondo. Potremmo mostrare un Bob terrorizzato dall'idea di passare due ore su una poltrona a guardare una cosa di Brecht, e poi rimane folgorato da Jenny dei Pirati e decide che questo bisogna fare: canzoni che avvisino il gentile pubblico che sarà giustiziato prima dell'alba. Potremmo mostrare un Dylan molto più sardonico, a patto di trovare un interprete che sappia cantare i talkin' blues che facevano scoppiare a ridere gli avventori del Gaslight: apparentemente Chalamet non ci è riuscito, ma chissà se gli hanno chiesto di provarci. Potremmo soffermarci un attimo su quanto fosse una iena Grossman, il suo agente, col quale poi sarebbe rimasto in causa per vent'anni. Potremmo mostrare Dylan in sala di registrazione che cerca subito di fare qualcosa di elettrico con Mixed Up Confusion, ma deve rinunciarci perché non è capace, non riesce a suonare a tempo, per cui da subito il folk è un ripiego.
Potremmo togliere una Blowin' in the Wind, che nel film si sente tre volte, e aggiungere una Hattie Carrol. Potremmo mostrare davvero la scena del perfido Zantziger, sudista ubriaco che si mette a bastonare una povera cameriera afroamericana che muore di spavento, e se la cava col minimo della pena: e tutto questo all'indomani della Marcia su Washington, proprio quando Dylan ha deciso che è ora di cantare la rivoluzione sul serio. Potremmo mostrare Dylan coi capelli corti sul Mall di Washington, davanti a centinaia di migliaia di afroamericani che non giocano alla rivoluzione, che stanno davvero rischiando la vita (i razzisti li aspettavano agli incroci, tiravano alle corriere) – Dylan che sceglie con cura le canzoni meno adatte all'occasione, e anche in quel caso la Baez che ci mette una pezza. Potremmo inserire qualche pantera nera, Malcolm X, o anche solo Emmett Till (come in Ali di Michael Mann), perché a quel bambino linciato per un saluto Dylan dedicò delle sue canzoni più barricadere, e poi per qualche motivo si vergognò di avergliela dedicata. Sicuramente non dimenticheremmo quella volta che doveva ritirare un premio a una cena di liberal americani, ma arrivò ubriaco e si mise a raccontare che aveva tanti amici che andavano a Cuba, e che a volte si sentiva un po' l'assassino di Kennedy. E l'incontro coi Beatles, o quella volta che ascoltò The House of the Rising Sun rifatta dagli Animals e saltò sulla sedia: qualcuno aveva rubato la stessa canzone di Van Ronk e aveva cambiato la storia della musica, e non era lui, fuck fuck, fuck. Mostrare qualche seminterrato in cui "mescolavano le medicine" – affrontare con meno censure gli aspetti più sordidi del sottobosco di Manhattan, o almeno qualche canna ogni tanto, per il realismo. Perché questa cosa che fumassero tutti continuamente ma solo roba legale, come dire.
Potremmo mostrare Phil Ochs, anche solo per allontanare il sospetto di una congiura del silenzio: nessuno parla mai di Phil Ochs (e Love Me I'm a Liberal sembra scritta ieri): potremmo mettere la scena in cui Dylan lo caccia dalla limousine, anche se forse era un semplice taxi. Forse non faremmo in tempo a mostrarlo scambiare frecciatine con Andy Warhol, forse nel 1965 ancora non aveva incrociato né la modella Edie Sedgwick né l'ex coniglietta Sara Lownds (dal 1966 Sara Dylan). Ma insomma il senso è che potremmo raccontare una storia completamente diversa. Potremmo addirittura evitare la battaglia di Newport, che sembra a tutti così fondamentale, ma in sostanza fu un set di venti minuti in cui qualcuno fischiò Dylan, forse perché si aspettava ancora canzoni folk e Dylan era stanco di suonarle: o forse perché il sound system non era adatto e quindi il pubblico sentiva soltanto un gran frastuono. Qualche fan se la prese male, ma non così tanti: e nel frattempo Like a Rolling Stone stava uscendo nei negozi e avrebbe venduto più di tutto quello che aveva pubblicato fino a quel momento, quindi davvero: perché ogni volta bisogna descrivere Newport come una battaglia campale? Cioè, sul serio Mangold ha girato un film su Dylan in cui il nemico numero uno di Dylan è... Alan Lomax?
 |
| Trovatevi qualcuno che vi guardo come Suzie, sul serio. |
Mi dispiace doverlo scrivere, perché il film è ben fatto come sa ben farli Mangold, ma temo che questo Dylan Cacciato dal Tempio sia una pagina di vangelo calvinista: l'unico Dylan che può interessare alla sensibilità del tardo capitalismo. Non un rivoluzionario, non un un artista che cerca di evolversi, ma più concretamente un furbastro del Midwest che si prende gioco di tutti questi liberal newyorkesi, questi hobo-chic che giocano alla rivoluzione; Dylan fa il nido nei loro club, copia tutto quello che può servirgli, ma il suo destino è un altro: lui è un Predestinato al Successo. Tutti i comprimari esistono in relazione a lui, e soltanto finché servono a lui: Woody Guthrie è il profeta da cui ereditare la missione, Pete Seeger il padre da tradire, Lomax il censore da abbattere, Joan la rivale da sconfiggere e "Sylvie" la damigella che lo attende alla finestra, e che lo molla per una banale forma di gelosia – almeno hanno avuto il buon gusto di non chiamarla Suze, dato che non lo è.
Ma insomma, esiste solo Dylan. Gli amici sono come le chitarre acustiche: utili e maneggevoli, finché non diventano ostacoli. Il prezzo della fama è scoprire negli occhi ammirati degli altri il verde dell'invidia. E basta, a parte il Successo non c'è nient'altro: l'amore è una parola di quattro lettere, le canzoni non fanno le rivoluzioni ma a dimostrare chi è il migliore: a quel punto si poteva davvero far partire i titoli di coda con Positively 4th Street, la canzone in cui Dylan di alta classifica non ha più niente da dire se non: ce l'ho fatta, sono il meglio, e chi non è con me è contro di me. È più o meno quello che ogni rapper deve ripetere oggi un paio di volte ad album; sono il migliore, sono l'Eletto, mangiate la polvere, voi non mi state criticando; mi state solo invidiando. Dylan non si è mai concesso un dissing ma con Positively ci è andato abbastanza vicino.
Nel mio film (per fortuna non so scriverli), Dylan è un ragazzo in balia degli eventi, che vive in un mondo che può finire da un momento all'altro: nel suo Midwest i contadini costruiscono rifugi antinucleari. Anche la rivoluzione è un'opzione, e per qualche mese del 1963-1964 può veramente aver creduto di esserne l'araldo. Il suo terzo disco, The Times They Are A-Changin', è un monumento di realismo folk; la canzone che gli dà nome è un inno che dà i brividi – li avete sentiti al cinema, ed era la seconda volta, se avete già visto Watchmen. È l'annuncio di un mondo nuovo che farà a meno di tante persone inutili, proprio come Jenny dei Pirati. Dopodiché è successo qualcosa che nessuno ci ha raccontato. Forse, banalmente, Dylan ha avuto paura. Era solo un ragazzo, di mestiere scriveva canzoni e le cantava nei teatri, la rivoluzione avrebbe richiesto un impegno e un'attenzione che non erano alla sua portata. Signore, risparmiami questo calice. Nel giro di pochi giorni Kennedy è morto e negli USA sono arrivati i Beatles: una coincidenza che lo stesso Dylan ha ricordato in una delle sue ultime canzoni inedite, l'incredibile Murder Most Foul. Imbracciando una chitarra elettrica, Dylan ha scelto tra pop e Movimento per i diritti civili. Non se ne è mai pentito. Negli anni successivi, mentre i suoi connazionali scoprivano di essere impegnati direttamente in una sanguinosa guerra in Vietnam, Dylan non ha mai voluto scrivere una canzone sull'argomento. Nel mio film insomma Dylan sarebbe uno dei tanti che per un attimo crede di essere l'Eletto, ma poi cambia idea per un soprassalto di paura o di ragionevolezza. E a recitarlo chiamerei Timothée Chalamet, tra l'altro ho visto che se la cava anche a cantare. E per questi ruoli un po' stronzi è l'uomo giusto.
Berlinguer (non l'eroe di cui abbiamo bisogno)
20-11-2024, 19:40Br, cinema, memoria del 900PermalinkPrima di andare a vedere Berlinguer – la grande ambizione mi chiedevo come fossero riusciti a trovare materiale per due ore di film su un personaggio senza dubbio interessante ma, diciamolo, non esattamente cinegenico (un "grigio funzionario", anche in famiglia dunque lo chiamavano così). Quando è finito Berlinguer mi sono guardato intorno smarrito: ma come, tutto qui? E la marcia dei quarantamila, il referendum sulla scala mobile, la questione morale? Avete tagliato tantissime cose!
Più che degli sceneggiatori potrebbe essere colpa delle piattaforme, con la loro serialità televisiva, che col tempo ci toglie il gusto per la sintesi. La serialità è una droga; con il trucco della reiterazione fa sì che ci affezioniamo a qualsiasi personaggio, purché ben recitato. Due ore di Germano nei panni di Berlinguer mi sono sembrate poche, ne avrei volute almeno altre due; e pazienza se si sarebbe trattato di vederlo ingrigire, tossire e agonizzare, ne sentivo la necessità. Anche perché così la storia è veramente troppo schematica: giunto al vertice del suo partito (ma come ci è arrivato?), nel momento in cui rischia di vincere le elezioni (ma perché va così forte?) il Segretario Enrico Berlinguer teme che un simile successo possa stimolare una risposta autoritaria. L'esempio del golpe cileno lo spinge a tentare una strada diversa: un "compromesso storico" col principale partito di governo, la Democrazia Cristiana. Siamo nel momento più inerte della Guerra Fredda: la mossa di Berlinguer è allo stesso tempo obbligata e imprevista. Osteggiato sia da Est sia da Ovest, poco compreso dalla base operaia del partito, il progetto trova una sponda nel segretario DC Aldo Moro: ma proprio quando tra mille cautele ed esitazioni la trattativa sembra finalmente portare a qualcosa, Aldo Moro viene sequestrato e ucciso. Fine, e scusate gli spoiler.
Ora proviamo a dire cosa poteva esserci nel film, e non c'è. Alcune cose sono riassunte veramente per sommi capi: i movimenti extraparlamentari, di sinistra (una kefiah) e di destra (la bomba in piazza della Loggia). Gli industriali (un'intervista all'Agnelli vero, che sarebbe stato molto più intrigante se interpretato da un attore: ma gli autori non se la sono sentita). Altri personaggi sono completamente rimossi: i socialisti, ad esempio; in effetti avrebbero complicato il quadro. Ogni biografia è una semplificazione, lo sappiamo. Si tratta di capire se la semplificazione funziona, se fa di Berlinguer l'eroe di una tragedia che ci interessa e ci dice qualcosa. Gli sceneggiatori non si erano dati un compito facile: c'è qualcosa, nella figura di Berlinguer che respinge tuttora le semplificazioni, gli schematismi, le agiografie. I comunisti non credevano troppo nelle figure degli eroi, e Berlinguer non riteneva necessario diventarne uno. Persino i suoi discorsi, per quanto ben scritti, non ci hanno lasciato frasi particolarmente memorabili: erano tempi diversi, non era necessario conquistarsi i titoli di giornale con battute icastiche o spiritose. Si potrebbe dire più o meno lo stesso per Moro, riscattato però da una fine tragica che a Berlinguer non è stata concessa. Berlinguer si è spento gradualmente – ucciso forse dalla nicotina che s'insinua velenosa in tutte le sequenze – nel mentre che l'Italia cominciava un processo di deindustrializzazione che ha tolto al suo partito una delle principali ragioni d'essere. Questo il film non lo racconta, anzi lo riassume in una didascalia finale in cui viene spiegato che anche negli Ottanta, gli "anni del liberismo" [???] il partito di Berlinguer continuava a tener duro. Che è proprio un errore di prospettiva storica, ma a quel punto il film è finito. Prendiamo atto che agli autori la fine del PCI non interessava. Cosa gli interessava.
 |
| Manca anche questa vignetta, che fu importante |
Il compromesso storico. La "grande ambizione" del titolo è il compromesso storico. Un'idea che Berlinguer ha formulato nel 1973 e ha abbandonato nel 1979. Una grande occasione mancata? Forse: ma soprattutto la dimostrazione più evidente del fatto che l'Italia sia uno Stato a sovranità limitata. Alla fine non importa nemmeno se Moro sia stato sequestrato e ucciso per conto dei sovietici, degli americani o da schegge impazzite come (forse) erano le BR. Né importa più di tanto la famosa "linea della fermezza" che Berlinguer scelse di adottare nell'occasione e che il film non problematizza affatto. Era un problema di equilibrio mondiale: l'Italia non poteva uscire da un blocco (Berlinguer lo sapeva), il PCI non poteva uscire da un altro blocco (Berlinguer ci provò, rischiando molto), e in questo consisterebbe la tragedia rappresentata nel film. Che oltre a raccontarci qualche anno della vita di un leader politico, come sempre ci parla di noi: della nostra sovranità limitata (possiamo assumere posizioni che non siano atlantiche?), e delle nostre nostalgie: per un partito di massa e per un leader un po' carismatico. Ecco, la nostalgia.
Quando è finito il film, mi sono appunto chiesto cosa avevo visto per tutto il tempo. Non avevo visto gli attentati, non avevo visto i movimenti, non avevo visto né Saragat né Craxi, né Leone, né i confindustriali, né un vero dibattito sul caso Moro: e quindi? Avevo visto un congresso del PCUS, qualche frammento tratto da discorsi ben più lunghi e complessi e un po' di intimità famigliare nella casa di un leader di partito, ma a parte questo come hanno fatto a tenermi in sala per due ore? Temo che la risposta abbia troppo a che vedere con la nostalgia. Che forse è una molla che porta più spettatori nelle sale, ma da un punto di vista storico è davvero la sensazione meno utile in assoluto. Sempre questa idea che da qualche parte nel nostro passato ci sia stata un'età dell'oro a cui è seguita una caduta, a causa di un qualche errore commesso da un incauto mortale. Se Togliatti avesse criticato l'invasione in Ungheria. Se le BR non avessero ucciso Moro... Se, se, se.
Benigni e la Shoahsploitation
29-01-2024, 01:46antisemitismo, cinema, giorno della memoria, memoria del 900PermalinkUn giorno o l'altro, non necessariamente un Giorno del Ricordo, dovrei mettere per iscritto la mia annosa diffidenza nei confronti di La vita è bella. Ha a che vedere col concetto di Shoahsploitation, parola che mi sono inventato e non ne vado fiero, anche perché alla fine è inutile prendersela: se imponi un momento di approfondimento tutti gli anni in tutte le scuole è inevitabile che nascano prodotti che servono esattamente a questo – magari si può rimarcare che Benigni/Cerami sono stati tra i primi a capire che razza di mercato si stava aprendo. Cruciale fu l'incontro con Mihăileanu, che aveva già in mente il concept di Train de vie e pensava a Benigni un protagonista: forse non capiva di avere davanti anche un produttore abbastanza scafato che poteva copiargli l'idea.
La mia diffidenza ha a che vedere con l'equivoco per cui quello che chiediamo a questi prodotti 'leggeri' a tema Shoah è uno spunto per parlare di Shoah a un'età in cui rischiamo di scioccare i bambini. Servono a questo. Il problema è che forse li scambiamo per punti d'accesso all'argomento, laddove manco ci provano: La vita è bella non "spiega" la Shoah, non introduce alla Shoah (neanche Train de vie, neanche Jojo Rabbit). Sono film che rimangono nei dintorni, raccontano episodi quasi sempre inventati intorno all'argomento, cercano di non risultare troppo depressivi o disturbanti e ti danno la sensazione che hai passato un paio d'ore a ricordare la Shoah. Nel frattempo i ragazzi crescono, un 27 gennaio dopo l'altro hanno effettivamente il tempo per imparare qualcosa, per cui alla fine qualcosa passa: è più liturgia che didattica, comunque.
Di tutti questi film La vita è bella è il più pervasivo, al punto che alla fine della scuola dell'obbligo i ragazzi rischiano di averlo già visto due o tre volte, di associare per sempre la faccia grulla di Benigni all'ebraismo, che già tante offese ha patito e sopravvivrà indubbiamente anche a questa, però forse il mio fastidio parte proprio da Benigni, e dal concetto del film, che non riesco ad accettare (non da un punto di vista morale, è proprio la sospensione dell'incredulità che non mi scatta): un padre che convince un bambino che Auschwitz è un gioco a premi. Questo pone tutta una serie di problemi.
a) Non si ingannano i bambini – cioè, succede spesso, ma costruirci sopra un film è discutibile. Proporre poi questo film ai bambini è proprio un corto circuito che m'infastidisce.
b) I bambini non sono mica deficienti, cioè come fai a credere che Auschwitz sia Takeshi's Castle (se tra l'altro non hai mai visto Takeshi's Castle). Davvero quel bambino non può crederci davvero, l'unica strategia che trovo per reggere la visione è immaginare che sia lui che sta prendendo suo padre per scemo, gli regga la candela perché altrimenti suo padre non potrebbe fare più il pagliaccio, e a quel punto gli prenderebbe la depressione.
c) Questa finzione dipende tutta appunto dalla capacità di Benigni di fare il pagliaccio. Tutto il film posa sulle spalle di questo tizio che manco fosse Charlie Chaplin, cioè se chiedevano a Charlie Chaplin lui probabilmente gli avrebbe detto no, guardate, neanche io riuscirei a rendere credibile una situazione del genere, e sono il più grande pagliaccio del mondo, ma se potessi fare un film del genere l'avrei fatto, e se non l'ho fatto c'è un motivo (anche Jerry Lewis all'ultimo momento ha bloccato tutto, vi ricordo). Benigni osa dove non ha osato Jerry Lewis, e il problema è che non è nemmeno il Benigni al top della forma, cioè per gran parte del film è il Benigni al minimo sindacale che ti ride in faccia e si aspetta che ridi anche tu per simpatia.
d) L'idea del campo come concorso a premi mi sembra anacronistica, anche se capisco che in epoca di Squid Game possa ritornare interessante (e qui potremmo aprire una digressione su quanto sia disumano il concetto di concorso a premi, e in generale la gamification della realtà che proprio nei Paesi dove è più avanzata ha prodotto fiction come Battle Royale o Squid Game).
Beh alla fine forse ce l'ho fatta, ho messo per iscritto quasi tutti i problemi che ho con la Vita è bella, senza nemmeno toccare l'annoso problema dei carri armati, che quando finalmente arrivano, sono quelli americani. Ma davvero mi sembra l'ultimo dei problemi, anche gli americani qualche campo l'hanno liberato. Ne approfitto per dire che per quanto m'infastidisca La vita è bella, forse funziona meglio di altri prodotti pensati per la scuola e più nobili, come La tregua di Rosi che in teoria non ha niente che non va e in pratica non gira, non saprei dire il perché, io alla fine quando vedo che un film non gira non lo guardo più e dopo un po' mi dimentico il perché.
I cattivi cinematografi
24-08-2023, 10:43cinema, italianistica, poesiaPermalink |
| f4 |
Un mese fa su Raiplay era disponibile, solo per un 48 ore, Il cattivo poeta e probabilmente ve lo siete persi. Sarò sincero, anch'io non sono riuscito a finirlo, e dire che non era esattamente il periodo dell'anno più oberato di impegni. Ricordo di aver messo pausa su un fotogramma in cui il protagonista, per la quinta od ottava volta, ci dava la sua interpretazione personale e senza dubbio convincente dell'espressione f4 basito. In sostanza è un giovane gerarca che dopo una fulminea carriera scopre, tipo nel 1936, che i fascisti sono però parecchio cattivi e torturano la gente, immaginate se succedesse a voi di aver pensato fino al giorno prima che erano tutti bravi e buonissimi e poi, così, passavo per caso nei sotterranei della sezione federale che dirigo e ma come, ci sono camerati che torturano gente, sconvolgente nevvero. Nel frattempo Castellitto interpreta il vecchio D'Annunzio ed è bravissimo, ovviamente, ma mi domando se non sia parte del problema, e il problema è: perché facciamo dei film così?
Uso la prima persona plurale perché l'industria cinematografica italiana campa anche dei miei contributi, e quindi perché invece di fare un film su D'Annunzio interessante (cioè parliamo di un poeta aviatore cocainomane, sessuomane che scappa dall'Italia per debiti, poi torna, conquista una città da solo e la gestisce per due anni finché non lo tirano via a cannonate, certo non è batman ma a occhio non è impossibile fare un film interessante su un personaggio così)... decidiamo scientemente di spendere dei nostri soldi per farne uno dove il protagonista per metà tempo attraversa corridoi, esattamente quel tipo di cose che il primo giorno di un corso di sceneggiatura dovrebbero insegnarti a tagliare, cioè il cinema dovrebbe isolare le cose interessanti della vita di una persona, che al 99% non sono traversate di corridoi. Ma ecco, in Italia succede questo, che abbiamo corridoi molto belli da mostrare, il film è girato al Vittoriale e ne è, in sostanza, una cartolina. Questa è un'altra parte del problema.
Poi abbiamo questi attori molto bravi che li metti lì e fanno qualsiasi cosa, per cui non è così indispensabile inventarsi un contesto in cui farli brillare, Castellitto è un D'Annunzio credibilissimo che però non ha niente da dire tranne devo incontrare Mussolini e convincerlo a non far scoppiare la seconda guerra mondiale, presto! presto! che è una buona idea per un soggetto, però da qui a farci un'ora e mezza di film qualcosa deve succedere, qualche altra idea di contorno ti deve venire, e ribadisco, parliamo di un poeta aviatore cocainomane sessuomane e conquistatore di città, potremmo non lo so, mostrare degli aeroplani che sorvolano Vienna? eh ma costano. Delle orge a Fiume? No, la proloco di Fiume non sgancia un euro, dobbiamo stare a Gardone, ci hai messo la penisola di Sirmione al tramonto? ah, tramonta dall'altra parte? Sticazzi, metti un altro quarto d'ora di Sirmione. E tutto quello che ha fatto D'Annunzio di interessante nella vita a parte aggirarsi per i corridoi del Vittoriale, amori guerre letteratura teatro? eh, tutto quello che ha fatto... ò dimo. A me dispiace, non tanto per il film che alla fine è un prodotto dignitoso (non l'ho finito, magari la seconda metà riscatta) ma per un'industria che funziona così, con una mentalità da ristorante per turisti che se la mena con il pitoresco e intanto risparmia pure sulla pummarola.
Nanni Moretti nel multiverso della follia
23-04-2023, 10:05cinema, Moretti (Nanni)Permalink– È almeno dai tempi di Aprile (più di un quarto di secolo) che Nanni Moretti ha qualche difficoltà a fare il Nanni Moretti, sia pubblico che privato. Ce lo ha detto in tanti modi, in qualche caso ce lo ha praticamente urlato nelle orecchie: non voleva più fare il papa (Habemus Papam), non voleva più fare nemmeno il regista (Mia madre); di sicuro non voleva più fare il classico film di Nanni Moretti con la vespa, le scenate, le canzoni, i tic nervosi. Forse ripetere che non voleva era un modo per nascondere che non ci riusciva: in ogni caso era un rifiuto comprensibile, nemmeno Chaplin ha fatto il Vagabondo per così tanto tempo. Così alla fine Nanni Moretti ha fatto un film diverso e... chi l'ha visto? Io no; quindi con che faccia potrei rimproverare Nanni Moretti che si rimette a fare esattamente il film che vogliamo da lui – un film che praticamente ha già fatto (la sinossi potrebbe essere la stessa del Caimano). A un certo livello diventa una questione di sopravvivenza: se è l'unica cosa che vogliamo da lui, lui che altro può venderci? Ma è faticoso per lui e pure per noi.
– C'è un elefante sempre più grande nella sala, che non viene né dalla Francia né dalla Germania ma ha un naso sempre più ingombrante (e anche le orecchie fanno una certa impressione): Nanni Moretti non è più un efficace interprete di sé stesso. Scandisce ogni battuta con una lentezza estenuante, come se si preoccupasse soprattutto di farsi capire dai francesi – di evitare che si concentrino sui sottotitoli e si perdano la sapienza compositiva delle inquadrature? O magari è il risultato di quella decennale dipendenza da antidepressivi che butta lì a un certo punto e non sai se crederci? (non è vero, ci credi immediatamente). In ogni caso fa paura, c'è chi invecchiando appassisce o si ingobbisce o si ingiallisce: Nanni Moretti rallenta, rallenta sempre più, sembrava già un po' lento in Habemus ma adesso non è più una sensazione, adesso sembra un androide che ripete le frasi che direbbe Nanni Moretti. Non è che alla cosa non potremmo assegnare una funzionalità espressiva: è sin dal fulminante finale di Sogni d'oro che Moretti ci suggerisce che lui non è l'eroe dei suoi film, ma l'antagonista, se non proprio il mostro: che mogli e figli hanno tutti i buoni motivi per abbandonarlo, e che forse anche noi spettatori dovremmo. È una prospettiva che ci sorprende molto più oggi che negli anni Ottanta – oggi i registi ci tengono a spiegare di essere diventati protagonisti del loro cinema attraverso un apprendistato costellato di figure indimenticabili, frequentazioni eroiche – Moretti no, Moretti assume sempre più spesso lo sguardo spiritato del padre della Stanza del figlio che voleva riavvolgere il tempo, uno sguardo che urla Spettro Autistico. Moretti ci sta dicendo che i suoi tic, le sue scaramanzie, sconfinano nel morboso e dovremmo smetterla di incoraggiarlo, Moretti è almeno da Bianca che ci propone di leggere in senso maniacale le piccole ossessioni che abbiamo sempre preferito considerare stravaganze dell'amico geniale. Moretti però con questo amico geniale ci convive tutti i giorni da una vita e probabilmente è il primo a non poterne più: se fosse sua moglie avrebbe già affittato una appartamento per andarsene. Già in generale invecchiare non è il massimo, non fai che ripetere le stesse cose sempre più lentamente. Ma immagina che il tuo mestiere coincida nel ripetere le stesse cose davanti alle cineprese. Non è una cosa atroce? Non fa venir voglia di farla finita?
Un po' sì.
Ma poi passa.
Bisogna variare il dosaggio.
 |
| Il momento whathafuck |
– Certo che lo Zeitgeist è incredibile. In teoria questo film non ha nulla di attuale, Moretti avrebbe potuto girarlo oggi o ai tempi di Aprile, più o meno con la stessa trama. Non c'è nessuna velleità di dire qualcosa di nuovo o qualcosa di sinistra o qualcosa in generale sull'attuale governo – Moretti e i suoi sceneggiatori, si capisce, sono molto più preoccupati dell'avvento delle piattaforme di streaming, descritto qui come Boris 4 come una catastrofe culturale che terrorizza molto più dei postfascisti al governo e vabbe', sono le ansietà di una categoria, vanno accettate in quanto tali. Poi ci si mette il caso, come ai tempi di Habemus Papam che era già un film assolutamente privato e fuori dall'attualità, salvo che pochi mesi dopo un papa si dimise davvero e Moretti passò per un profeta. Anche stavolta, c'è chi ha trovato nelle immagini dell'invasione sovietica dell'Ungheria un riferimento all'invasione russa dell'Ucraina: è un'interpretazione possibile, ma potrebbe anche trattarsi di una coincidenza, la questione ungherese è sempre stata una ferita aperta per militanti e fiancheggiatori del PCI. Ma addirittura a un certo punto, credo per una pura coincidenza, si menziona un orso in fuga in Trentino e la necessità contagiosa di parlarne per restare sulla cresta dell'onda. Cosa che da blogger capisco benissimo: anch'io ogni tanto mi sorprendo a pensare se per caso non ho un'opinione originale sugli orsi del Trentino, qualcosa che si possa non dico monetizzare ma socializzare. A quanto pare non ce l'ho, ma posso sempre rifarmi col nuovo film di Nanni Moretti.
– Dicevo infatti che lo Zeitgeist è incredibile, non perché esca un film in cui si parla di un orso in Trentino proprio due settimane dopo la prima vittima trentina di un orso in 150 anni, ma per esempio perché proprio il film in cui Moretti prende le distanze più che mai dal cinema 'violento', di matrice potremmo dire tarantiniana, finisce esattamente come due o tre degli ultimi film di Tarantino, ovvero con una fuga nell'ucronia: Hitler massacra gli ebrei? E allora gli ebrei sparano a Hitler. La Manson Family ammazza Sharon Tate? E noi massacriamo la Family, li sbraniamo, gli diamo fuoco. I sovietici invadono l'Ungheria? E noi strappiamo coi sovietici. Il cinema ha descritto la Storia, ma si trattava di cambiarla: non c'è riuscito, e adesso semplicemente prova a immaginarne una più bella. È il momento in cui la gente piange, l'ho notato. Non so nemmeno se Moretti li abbia guardati, i film di Tarantino (immagino di sì, con qualche fastidio), ma l'effetti è molto simile: è commovente immaginare Sharon Tate che si sveglia nel suo letto il 9 agosto, è commovente immaginare che Togliatti battezzi la via italiana al comunismo. È un po' come resuscitare Spiderman dopo che Thanos l'ha polverizzato, per dire quanto è incredibile lo Zeitgeist: persino i registi italiani di una certa età all'improvviso si mettono a ragionare in termini di multiverso, un concetto sul quale sappiamo ancora spaventosamente poco.
– Gli spettatori si commuovono oppure, nel mio caso, cercano di calcolare cosa sarebbe successo davvero se nel '56 Togliatti fosse stato forzato dalla base del partito a una svolta trotskista. Naturalmente chi è di formazione materialista tende a minimizzare questo tipo di svolte: così come tornare indietro nel tempo per sparare a Hitler non salverebbe la Germania dal nazismo (si sarebbero trovati un altro fuehrer, lo stesso Adolf Hitler sembra già raccattato tra le seconde scelte), così uno strappo nel '56 forse non avrebbe cambiato più di tanto le cose. Magari Togliatti sarebbe morto un po' prima, magari qualche membro del suo entourage gli avrebbe aperto il cranio con una piccozza o qualche altro strumento tascabile. Molti intellettuali sarebbero rimasti nel PCI, tra cui Calvino: sarebbe stato un bene per il partito, ma anche per gli intellettuali? Può persino darsi che a quel punto il Comintern avrebbe riversato le sue risorse sul PSI, dove c'era ancora una forte corrente filo-URSS, dopodiché i ruoli si sarebbero invertiti, Moro avrebbe fatto il centrosinistra con un PCI un po' più piccolo e qualche anno più tardi Craxi si sarebbe trovato leader di un partito sovietista – non dico che non sarebbe interessante riscrivere una storia così, ma insomma la Jugoslavia stava lì per mostrarci che queste terze vie non è che andassero più di tanto in là. È comunque piacevole sognarle, e il cinema serve anche a quello. E a non impiccarci, almeno non oggi: poi domani è un altro giorno, vedremo.
La macarena sulle vostre tombe
26-01-2023, 21:06cinema, film italiani bruttini, generazione di fenomeni, scuola, tvPermalinkVi vedo tutti immotivatamente entusiasti per un monologhetto sull'entusiasmo immotivato, un pezzo appiccicato alla benemeglio in un prodotto seriale per far contenta la guest star che se l'è scritto. Non c'entra niente con lo sviluppo della trama, è uno sbrego diegetico, è un attore che esce dal personaggio e ci intrattiene sui fatti suoi che secondo lui sono divertenti. Anche secondo voi sono divertenti – del resto sembra fatto apposta per essere trasformato in story e girare sui vostri smartofoni. È una variazione sul tema delle chat scolastiche, nel 2023, ci vuole coraggio, no? Non sono mica tutti pronti all'ironia contro un avversario potente come le chat scolastiche. È un pezzo che si crede Mattia Torre, come probabilmente capita a tanti cartocci nel cestino della writing room della Littizzetto. È un pezzo che se la prende con l'entusiasmo dei genitori che vogliono fare qualcosa per migliorare l'offerta educativa del loro istituto. Hanno tutti una passione (la batteria, la danza, il ciclismo) e vogliono comunicarla, con tanto entusiasmo, che secondo il regista (appollaiato su una terrazza che dà su Piazza del Popolo) è "il sentimento più orrendo dell'essere umano". Non l'odio, non l'intolleranza, non l'impulso dell'audista che ti sorpassa a destra sull'A1: no, per il regista italiano il sentimento più orrendo è la voglia di insegnare qualcosa ai propri piccoli, e già che ci siamo ai piccoli degli altri. Capace che poi crescono più socievoli, ciò è sbagliato! Il regista italiano nel 2023 vuole stare in un angolo imbronciato, perché in questo consiste la sua coolness, in sostanza il regista italiano è una Mercoledì cinquantenne che si crede Nanni Moretti, e voi siete entusiasti di questa cosa.
I genitori,per una volta che invece di lamentarsi dei compiti, dell'insegnante, del bullo o dell'insegnante bullo, provano a proporre cose, magari con un po' di ingenuità ma un minimo di buona volontà; i genitori che vedono i figli passare i pomeriggi senza staccare l'occhio dallo smartofono e la cosa li spaventa; i genitori si domandano se non c'è qualcosa di non scrollabile che potrebbe coinvolgere questi benedetti ragazzi; e invece di scrivere accorati appelli a Gramellini fanno un'assemblea con tante proposte, ognuno porta la sua cosa, a me sembra quasi commovente – ma al regista no.
I genitori sono anche preoccupati per il traffico, in una città così complicata come Roma il ciclismo è ancora una scelta difficile (gli audisti ti menano se provi a usare le ciclabili) ma presto o tardi ineludibile, bisogna preparare i ragazzi a un mondo che sarà per forza diverso dal nostro, ma il regista dal terrazzo su Piazza del Popolo tutto questo traffico mica lo vede, e poi lui al pomeriggio giocava per i fatti suoi ed è cresciuto bene, i suoi figli idem, e questo chiude la questione: tutto è già come dev'essere, anche questi smartofoni prima o poi passeranno. Di questo, siete entusiasti.
Se i vostri figli lo sapessero vi soffocherebbero nel sonno – ah, ma lo sanno, vi leggono sullo smartofono. La macarena verranno a ballare: sulle vostre tombe.
Non è più tempo per i Rashomon
25-12-2021, 02:33cinema, essere donna oggi, Il PostPermalinkThe Last Duel, (Ridley Scott, 2021).
Normandia, 1386: si disputa l'ultimo duello giudiziario della storia francese. Il cavaliere Jean de Carrouges accusa l'ex compagno d'armi, Jacques Le Gris, di aver violentato sua moglie, Marguerite. Le Gris sostiene di avere avuto con la moglie di Carrouges un rapporto consensuale. La moglie invece sostiene... no, la moglie non 'sostiene': la moglie dice il vero. Fine. Non è che possiamo metterci lì a mettere in dubbio quel che dice una donna. Non siamo mica nel Medioevo...
 |
| Ma che ci vedono le donne in Adam Driver, bisognerebbe fare una ricerca seria su questa cosa |
Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei la pace del mondo, la salute per tutti e un film sul Medioevo decente da proiettare in seconda media – prima di sbuffare, prova a dirmene uno. Visto? No, i draghi non valgono, no, nemmeno i cicli arturiani. Un film per mostrare ai ragazzi un mondo vero, che è esistito e che sicuramente era molto diverso dal nostro, ma in un qualche modo funzionava, coerente, verosimile: castelli, armature, servi della gleba, vorrei solo conservare in un angolo del loro immaginario un po' di arnesi medievali perché – non lo so neanche io il perché, ma in un qualche modo non mi sembra onesto lasciare che crescano senza. Non chiedo un capolavoro; anche solo un film a colori che abbia più senso delle Crociate di Ridley Scott, perché davvero lo so anch'io che fa acqua da tutte le parti: ma trovami qualcosa di meglio nella filmografia degli ultimi trent'anni. E lo so bene che Scott si intende poco di Medioevo – come d'altronde di qualsiasi evo: alla fine per lui è quasi sempre tutto un grande western con la Frontiera e i pistoleri che si vede che patiscono di non poter estrarre il revolver, di doversi vestire di ferro e sguainare ancora scomode spade – ma almeno sa mettere insieme uno spettacolo. Come dici?
Sì Babbo, lo so che ci ha riprovato anche quest'anno, l'ho visto l'Ultimo duello e mi dispiace che sia andato così male, in un qualche modo il Medioevo a Sir Scott porta sfiga ed è strano: di tanti posti dove ambientare un western sembra uno dei più congeniali al suo gusto per la meraviglia. L'abbiamo sempre saputo che per Hollywood la Storia è un fondale per mettere in scena in modo pittoresco i problemi di oggi: non è esattamente l'approccio storico che mi servirebbe, ma ha il pregio di tenere svegli anche gli spettatori che non siano patiti di cavalli e armature. Scott non dà l'aria di interessarsi di politica, eppure più i suoi film sono in costume, più le sceneggiature si ingombrano di ideologie. Il Gladiatore era il film perfetto per l'America imperiale post 11 settembre (è stupefacente che sia uscito l'anno prima); le Crociate per reazione s'intestardivano a immaginare un Regno dei Cieli multietnico e multiconfessionale. The Last Duel, vent'anni dopo, è un film su #meetoo e la rape culture così concentrato sul suo essere un film su #metoo e la rape culture che in certi punti lo spettatore esigente è portato a domandarsi: ma sul serio? Cioè mi stai davvero raccontando questo, in senso non ironico? Ecco: è un film senza ironia, una qualità che a Hollywood sta diventando merce sempre più rara e pericolosa.
The Last Duel vuole dire qualcosa di molto vero e attuale e vuole dirlo senza il minimo rischio di essere frainteso. Lo fa scomodando vicende di un secolo diverso, vissute da persone i cui valori erano molto diversi dai nostri – e pazienza: Hollywood si è sempre comportata così e forse è l'unico modo per portare nel Medioevo un po' di spettatori che non si farebbero attirare da un caso di cronaca medievale. Alla fine chiunque avrà imparato qualcosa: anche solo il fatto che a un certo punto del Medioevo i medici ritenessero l'orgasmo femminile necessario al concepimento ("It's science!": e tutto questo diversi secoli prima che altri medici, tra Sette e Ottocento, negassero la stessa esistenza dell'orgasmo femminile).
Dopodiché, caro Babbo, capisci anche tu che un film sullo stupro con un dibattito processuale sull'orgasmo, in seconda media, non lo posso mostrare. Ma sarei comunque contento di averlo visto. Il problema è un altro e te lo dico, caro Babbo, sir Scott stavolta non c'entra niente. Sì è più cupo del solito, certi tagli sono evidenti, il ritmo non è il massimo, ma gli perdonerei questo e altro. I colpevoli che non riesco a perdonare sono Ben Affleck e Matt Damon, che non paghi di aver voluto tirar fuori da un saggio di Eric Jager un blockbuster militante, hanno anche deciso di scomodare Rashomon. Proprio così, hanno voluto consegnarci il loro Rashomon, e magari sono persino convinti di esserci riusciti: il loro film problematico con tre versioni inconciliabili della stessa storia secondo i punti di vista di tre personaggi in conflitto. E i critici non si sono fatti sfuggire la cosa – anche perché ci sono persino le didascalie prima di ogni versione, insomma basta saper leggere le scritte grosse e alcuni sembra ne siano ancora in grado, sicché abbiamo veramente delle recensioni in cui The Last Duel è paragonato a Rashomon.
 |
| Lui però si ritaglia sempre la parte giusta |
Ora Babbo capiscimi, non si tratta di snobismo. Non ne faccio una questione tecnica, ma insomma Rashomon è un film che ci vuole dire che la realtà oggettiva non esiste, che ognuno ha la sua e che lo spettatore non necessariamente riuscirà a ricomporne una. È l'esatto contrario di quel che succede nell'Ultimo Duello, dove dopo aver sentito la campana del cavaliere Carrouges e quello di Jacques Le Gris, la didascalia ci avverte che tocca alla signora, e che la sua verità è "La Verità". Non lo dico io, Babbo, c'è proprio scritto così sullo schermo, affinché nessuno possa confondersi sulla morale del film: e la morale è che gli uomini si raccontano tante palle, per orgoglio o per invidia o persino per amore (ma più spesso per orgoglio e per invidia); le donne invece no, le donne dicono sempre la verità, tranne ovviamente quando non mentono per non finire sul rogo arrostite a fuoco lento. Dopodiché Scott può filmare castelli e armature con tutta la maestria che gli compete, ma l'impianto non funziona, e qui suggerisco a chi vuol vedere il film di non leggere oltre, perché... non so prendiamo Le Gris.
Il film ci spiega, con la sua manina leggera, che Le Gris è cresciuto in un sistema di valori che non gli consente di riconoscere uno stupro, nemmeno quando lo commette. Quando nella sua versione Marguerite fa resistenza, Le Gris è convinto che stia recitando un rituale di corteggiamento. E siccome in quel momento stiamo guardando la scena con gli occhi di Le Gris, dovremmo appunto vedere una Marguerite che vuole e non vuole, che civetta un po', una Marguerite cedevole che infine si concede all'amplesso. Se questo film fosse un vero Rashomon, dovremmo appunto assistere a questo: ma la vera notizia che porta al mondo il nuovo film di Ridley Scott è che i Rashomon in America non si possono più fare – e dire che fino a qualche anno fa erano quasi un tropo, molti telefilm avevano la loro puntata-Rashomon, House MD sicuramente ne ha una e persino Saranno Famosi – ma adesso no, adesso se vedessimo Marguerite concedersi e gioire potremmo equivocare. Qualche spettatore/trice sicuramente equivocherebbe, voglio dire, è statistica, e poi i Rashomon implicano appunto questo, che ognuno possa scegliere la versione che preferisce: ma ciò oggi è intollerabile, qualcuno twitterebbe che Ridley Scott ha girato un film che esalta la cultura dello stupro; che Affleck e Damon l'hanno scritto, che Driver l'ha recitato: insomma no, non si può fare, non è più tempo per i Rashomon, e così ci tocca guardare questa scena molto imbarazzante dove Le Gris vive il vertice della sua storia d'amore mentre ansima sulla schiena di una poveretta che nemmeno è riuscito a svestire. Non c'è nulla di veramente problematico qui, non c'è spazio per il dubbio che anzi va scacciato e al massimo individuato nei personaggi come una debolezza da debellare: le vittime sono serie, integerrime e sofferenti, i rei sono patetici. Alla fine il vero colpevole è il Medioevo: e la sua colpa è di non voler credere alle donne. E Babbo io non è che voglia difendere il Medioevo a ogni costo, lo so che era un periodo terribile per le donne, ma i film che condannano il passato in quanto passato ho sempre paura che servano a distogliere dalle responsabilità del presente.
Rashomon ci chiedeva di accettare che ogni Verità è parziale; l'Ultimo Duello ci nomina giudici onniscienti, davanti a due uomini che hanno deciso di scannarsi per contendersela. Alla fine, caro Babbo, quel che mi lascia è un po' di freddo amaro in bocca, per aver voluto controllare se davvero il cattivo viene punito come nel mio cuore avevo già desiderato. Ci sono anch'io sugli spalti, col sadico re di Francia. Mi dispiace Babbo, perché non è nemmeno un brutto film. Ma non è quello che mi serve.
La fine dell'autocritica
24-07-2021, 19:19autoreferenziali, blog, cinema, internet, Moretti (Nanni), Woody AllenPermalink
Questa immagine, ma soprattutto questa didascalia, divide l'internet italiana in due parti, e sospetto che la divisione azzecchi l'età mentale meglio dei documenti anagrafici. Non saprei tracciare un discrimine (nati nel 1980? 1985?) ma da un certo punto in poi è un'immagine imbarazzante: Ritratto di regista boomer che non capisce dove va il cinema. Probabilmente i giovani non fanno nemmeno caso ai capelli bianchi, che erano il punctum della composizione: Moretti era arrivato a Cannes con la chioma nera di ordinanza, il contrasto sempre più insostenibile col grigio cenere della barba. Quando sei un personaggio pubblico a un certo punto devi fare questa cosa di ammettere che ti tingevi i capelli, per quanto al di fuori possa sembrare ridicolo per alcuni è più traumatico di un coming out. In una botta sola devi ammettere che sei vecchio e che cercavi di nasconderlo. Se poi quasi nessuno ci fa caso è peggio ancora, significa che loro ti vedevano già vecchio: sei tu che ti aggrappavi al tuo autoritratto mentale, gli altri le tue rughe le danno per scontate, le vedono anche nei film dove ancora non le avevi.
 |
| Pochi giorni prima |
Per quelli nati prima del discrimine, questo è il caro vecchio Moretti che si prende in giro da solo, con quella spietatezza che negli ultimi film si è un po' attenuata (ma solo un po'). È il Moretti-regista-isterico di Sogni d'oro (ma anche di Mia madre), quello che vuole vincere a costo di rendersi ridicolo, e che non vuole morire. Più del Moretti che non si capacita del successo di Henry, pioggia di sangue, è quello che si fa una canna davanti alla tv mentre Berlusconi trionfa. Certo che è patetico, ma lo fa apposta. Al che i più giovani possono ovviamente rispondere: certo che lo fa apposta, ma è patetico, e il discrimine è tutto qui.
Per i vecchi quel che importa è l'intenzione; per i giovani il risultato. Moretti non ha fatto tantissimi film, così che non capita poi così spesso l'esperienza rivelatoria di riguardarli per caso senza averne l'intenzione: quella situazione in cui ogni volta mi stupisco di quanto era perfido con sé stesso e con il sociotipo che interpretava. Moretti picchiava sua madre, spintonava il padre, stalkerava sue ex, scenate dappertutto. Questa perfidia era un valore in sé, ma se i giovani non la capiscono forse il suo cinema in breve non interesserà più a nessuno. Questo mi dispiace più di altre cose, e sento che sto per rimettermi a parlare di Woody Allen, scusatemi.
Woody Allen di film ne ha fatti molti di più, diciamo anche troppi di più, diciamo che anche se gli impedissero di farne altri non sarebbe una catastrofe culturale; la vera catastrofe culturale è che non sono più in grado di apprezzare quelli vecchi. Prendono Manhattan per una prova indiziaria, non è che non capiscano che Allen in un film del genere stava denunciando sé stesso e i suoi simili, ma ne approfittano, Allen si autoaccusa e loro si autonominano giudici e lo condannano. Ammettiamo che nei trent'anni dell'abbondanza era diventato a un certo punto un topos prendere in giro la figura del borghese intellettuale sempre sull'orlo della crisi di nervi, ormai una maschera di una postmoderna commedia dell'arte. Poi a un certo punto cambia il paradigma, all'improvviso e con una certa violenza: chi ancora indugiava nel topos autocritico (ad esempio Louis CK) viene stritolato da un meccanismo che si rivela molto più spietato di lui. Si è all'improvviso convocato un nuovo tribunale e ci si rende conto che tutto questo autocriticarsi non funzionerà come attenuante, anzi, tutti questi artisti non hanno fatto che facilitare il lavoro ai nuovi accusatori. Woody Allen, ci spiegano, è ossessionato dal sesso, e dalle giovinette. Certo, rispondiamo, Allen non fa che esprimere in modo grottesco queste ossessioni che sono comuni a tutti, ehm, noi: ma a questo punto gli accusatori alzano un sopracciglio e noi siamo nei guai. Meglio cominciare a scrivere che Allen ha fatto il suo tempo, forse qualche giovinetta tornerà a metterci un like.
Com'è successa questa cosa, di chi è la colpa. Siete seduti? Perché sto per dare la colpa a internet, ai social network, ebbene sì, sto invecchiando molto più rapidamente di Moretti. Ma mi ricordo che fino a un certo punto anche su questo blog trovavo normalissimo esprimere le mie frustrazioni, la percezione del mio essere ridicolo, i miei guai e le mie colpe, e cosa cercavo? Se non assoluzioni, certo attenuanti da un giudice bonario che al di là di tutto il materiale probante avrebbe valutato le mie intenzioni. Un approccio, starei per dire, molto cattolico: non fosse che né Allen né Moretti mi sembrano particolarmente cattolici. Comunque a un certo punto ho dovuto smetterla: non potevo più mettere in mostra le mie debolezze perché c'era gente cattiva lì fuori che le avrebbe riprese, linkate, taggate, esagerate, additate, e vi giuro questa gente esiste davvero, non me la sogno, magari saranno appena una manciata di persone ma sono fastidiosi come zanzare e per evitarle ho smesso di denudarmi in pubblico. È stato un processo graduale, non saprei neanche dire quando è iniziato, fatto sta che mi sono costruito questa specie di Io pubblico che magari è pessimista ma non si dispera mai, non piange mai, non ti racconta più i suoi traumi infantili e quanto era patetico da adolescente – tutto questo fino a metà '00 si poteva fare, ora ti prenderebbero per pazzo, non c'è più nessuna gloria nel sapersi mettere in berlina. Ora devi imparare a sanguinare per i fatti tuoi, con tutti gli squali in giro. È un mondo diverso. Ipocrita in un modo diverso. Forse preferivo l'ipocrisia di Moretti che cercava la nostra simpatia comportandosi in modo insopportabile. Era paradossale, probabilmente preferisco i paradossi.
Chi ha cancellato i cancellatori di Woody Allen
14-05-2021, 01:53cinema, pedofilie, tv, Woody AllenPermalinkAl termine di una settimana – non questa, la precedente – che la mia bolla sociale ha trascorso a discutere sulla Cancel Culture, e in particolare se esista o no (cioè non ne siamo ancora sicuri), domenica scorsa è apparso da Fazio nientemeno che Woody Allen, in carne e ossa e videochiamata, e... non è successo niente.
Ma proprio niente, mi sembra che non ne abbia parlato nessuno. E stiamo parlando di Woody Allen, ovvero non solo uno dei registi americani più conosciuti e affermati in Italia, ma anche del caso più esemplare di questa benedetta Cancel Culture, tanto da essere citato credo in qualsiasi articolo che ne parli e che cerchi di spiegare cos'è (questo è l'ultimo che ho trovato). Woody Allen che malgrado il suo prestigio negli USA non è ancora riuscito a trovare un distributore per il suo ultimo film – forse proprio a causa della Cancel Culture. Woody Allen la cui autobiografia è uscita prima in Italia che negli USA, dove un editore addirittura ha rinunciato a pubblicarla a causa delle proteste degli stessi dipendenti. Woody Allen che tuttora è accusato da sua figlia di molestie, e a cui molte attiviste e attivisti non perdonano la relazione con la figlia (adulta) dell'ex compagna. Woody Allen che è talmente al centro del dibattito che la stessa Scarlett Johansson, nelle stesse ore, mentre accusava l'organizzazione che assegna i Golden Globe di pratiche discutibili ai limiti dell'abuso, è stata criticata da molti guerrieri social per avere lei stessa in passato difeso Woody Allen. Woody Allen insomma di cui sembra impossibile poter parlare senza accennare a tutto il dibattito sulla Cancellazione, e invece in Italia domenica scorsa ci siamo riusciti, grazie a Fazio, grazie alla Rai: abbiamo cancellato la Cancel Culture. È una cosa buona, è una cosa sbagliata? Non lo so. È comunque una cosa interessante, ne vorrei parlare.
I’m sorry... Scarlett ‘I should be able to play a tree’ Johansson? The woman who still openly supports Woody Allen? https://t.co/tQUHL9BvXY
— jstoobs (@thejstoobs) May 10, 2021
Immagino che la richiesta di non toccare nemmeno di sguincio l'argomento sia arrivato dal management di Allen. Se una richiesta del genere fosse stata fatta a una redazione giornalistica, il caso si porrebbe. Può un giornalista accettare di intervistare un personaggio senza toccare un argomento così importante – diciamo pure l'unico argomento relativo ad Allen che ormai può interessare a uno spettatore sotto i quarant'anni? Può farlo senza venir meno alla sua etica professionale e senza perdere la faccia? Secondo me no. Fazio infatti non è un giornalista, o per lo meno non ha mai tentato di accreditarsi come tale. Fa promozione culturale, mettiamola così, e dopo tanti anni sappiamo anche come funziona e cosa produce. Si selezionano prodotti quasi sempre già rinomati, già ormai ridottisi in feticci, e li si usa per arredare il salotto ideale di un ceto medio riflessivo che vuole sentirsi culturalmente aggiornato, prima di ridacchiare per le battutacce della Littizzetto. Anni fa mi permettevo di prenderlo un po' in giro per la sua gerontofilia, la sua tendenza a circondarsi di vecchi nonni saggi: dopodiché è invecchiato pure lui, siamo invecchiati tutti – Allen un po' prima degli altri e Fazio domenica non vedeva l'ora di incorniciarlo nella posa dell'amabile vecchietto che non sa usare il tablet e nemmeno il telecomando.
L'intervista non si è scostata da un canovaccio che Allen ha perfezionato da decenni: tutti gli danno del genio, lui si schermisce, tutti gli danno del falso modesto, lui continua a schermirsi (incidentalmente, è la stessa strategia che adopererebbe un mostro criminale, un Kaiser Soze). La sua autobiografia, se gli avete dato un'occhiata, è un'interminabile rivendicazione di mediocrità che alla fine si trasforma in una specie di autodifesa: sono una persona qualunque molto fortunata, continua a dirci, e le persone qualunque non fanno le cose orribili che ad Allen sono state attribuite.
Per una scenetta del genere, Fazio era la spalla ideale: nessuno più di lui sa sintonizzarsi sulla falsa modestia dei suoi Grandi Vecchi. Lo fa benissimo perché ci crede: Fazio era sinceramente orgoglioso di intervistare Woody Allen in quanto monumento di una generazione, e del tutto indifferente al fatto che un'altra generazione lo consideri un mostro. È una generazione che non guarda la tv, quindi perché preoccuparsi.
Viene il sospetto che il problema sia tutto generazionale: la Cancel Culture esiste soltanto da una certa classe in poi. Per i nati prima del 1970, azzardo, il caso Dylan-Farrow è un fatto di cronaca di più di vent'anni fa. Per i nati dopo il 1980 è l'unica cosa interessante, benché mostruosa, che il tizio abbia fatto. Io sto in mezzo a queste due generazioni che vorrei definire l'una contro l'altra armate, ma non è vero: ormai non si frequentano più, e le rare volte che si parlano non si capiscono. Per chi ha amato almeno qualche film di Allen, il tiro al piccione su Twitter è un'esperienza mortificante: la maggior parte di chi getta sassi, si capisce, non ne ha mai visto uno. Alcuni lo ammettono pure. Vien da pensare che un certo tipo di attivismo sia un modo economico di risolvere l'aggiornamento culturale: il tizio ha girato più di 40 film, se vuoi parlarne senza perderti i riferimenti dovresti averne visti almeno una metà. Se invece decidi che il tizio è un mostro, puoi sparare immediatamente il tuo giudizio tranciante e ti resta anche tutto il pomeriggio libero per guardarti una serie. Non è che il contrappasso non abbia una sua logica: Woody Allen per tanti anni ha potuto contare sulla benevolenza di un pubblico e di una critica pronti a degustare qualsiasi suo prodotto come un'eccellenza artistica. Nel frattempo è cresciuta una generazione che le rare volte che prova a guardarne uno, non capisce cosa ci sia di divertente e/o tragico. Lui d'altro canto ha sempre detto che il giudizio dei posteri non lo interessava, anche se forse non immaginava che i posteri piuttosto di perder tempo a capire e contestualizzare avrebbero scambiato Manhattan per un'apologia della pedofilia.
Quindi alla fine questa Cancel Culture esiste o no? Non saprei. Di sicuro esiste una generazione che non ha timori reverenziali per i feticci del passato – il che è un bene – ma che tende a confondere questa naturale irruenza con un dispositivo morale. Col risultato che molte cose che comunque starebbero per finire nel dimenticatoio rimbalzano un po' più in là, nell'Indice dei Manufatti Culturali Proibiti e Quindi Interessanti. Un posto dove le generazioni successive potrebbero più facimente riuscire a recuperarli... e allora, se mi piace il cinema di Woody Allen, chi devo temere di più? Il mellifluo Fazio che troverebbe geniale anche un suo assolo jazz di peti con le ascelle, o i giovani aspiranti inquisitori che non sopportano la vista di un quarantenne a letto con una diciassettenne? Quale dei due atteggiamenti, nel medio-lungo termine, consentirà ai lungometraggi di Woody Allen di rimanere culturalmente rilevanti, anche se invece di trovarli su Netflix dovremo cercarli su Pornhub?
L'incredibile storia di un piccolo film (in acque internazionali)
16-12-2020, 17:46cinema, epidemia 2020, film italiani bruttiniPermalinkChiunque da studente abbia provato a costruirsi una piccola realtà, un circolo o un centro sociale, conosce bene l'obiezione e la sensazione. L'utopia ti porta a condividere idee ed emozioni, a incontrare un gruppetto di sodali con i quali magari si riesce anche a combinare qualcosa, qualcosa che da un inavvertibile momento in poi diventa sempre più simile a un bar. La cultura, la libertà, senz'altro, ma alla fine tutto si traduce fatalmente in consumo. Chi critica Sibilia per aver trasformato un quarantenne con trascorsi repubblichini nel solito sessantottino copre soltanto una metà del fenomeno: il Sessantotto di Sibilia è un oggetto di scena, ormai depauperato da qualsiasi nostalgia, ripreso da altri prodotti che hanno avuto successo internazionale (La meglio gioventù) e rimesso a nuovo perché da un punto di vista narrativo funziona sempre, come una volta funzionava il far west o il proibizionismo dei gangster: lo spettatore sa già cosa aspettarsi, democristiani oscurantisti e impomatati e giovani coi blue jeans che ballano il geke ge'. Il fatto che più che di parlare di rivoluzione abbiano voglia di ballare e bere drink discutibili graffia lo spettatore come il pizzicotto di qualcuno che cerca di svegliarti: altro che '68, è di noi che si parla.
 |
| Altri modelli inconfessati e inarrivabili. |
Siamo tutti Francesco? (No, ma ci piacerebbe)
04-10-2020, 13:34cinema, repliche, santiPermalink4 ottobre - San Francesco d'Assisi (1182-1226)
 |
| Il culo era proprio un selling point. |
Che dire di San Francesco, patrono degli italiani e (coincidenza inquietante) degli animali? Primo grandissimo poeta della letteratura italiana, con quel Cantico delle creature pieno di k che piacciono ai giovani? Ce ne sarebbe da scriverci un libro. Ma lo hanno già fatto in tanti. E anche a proposito dei libri su San Francesco si potrebbe scrivere un libro. Ma hanno già fatto anche questo. Quindi a questo punto che si fa?
In San Francesco al massimo ci si può specchiare. Nel senso che è uno di quei personaggi così popolari che ormai mille narrazioni diverse ne hanno levigato l'immagine fino a farla diventare una superficie specchiante. Per esempio io, se penso al mio San Francesco, lo vedo ormai un po' datato; ma non datato al dodicesimo secolo; piuttosto agli anni Settanta, che sono quelli in cui sono cresciuto leggendo anche la bio a fumetti di San Francesco sul Piccolo Missionario; guardando il film di Zeffirelli (la cosa più gay che si poteva proiettare in un cinema parrocchiale); cantando le canzoni di Forza Venite Gente, il più fortunato musical da oratorio della storia (brevissima) dei musical da oratorio.
Insomma che Francesco era il mio Francesco'70? Un fricchettone. Però di buona famiglia. Zeffirelli lo aveva capito benissimo, e la parte più interessante del suo film probabilmente è quella in cui la famiglia lo tratta un po' come si trattavano i figli da disintossicare, che fanno il gioco del silenzio e ti abbracciano, poi un mattino te li trovi sul tetto, “guarda mamma adesso volo”
E prima o poi – come tutti gli eroi medievali di Zeffirelli – ti mostra angelico il culo. Erano tempi così. La colonna sonora, tutti lo sanno, la canta Baglioni. Invece non tutti sanno che in originale era di Donovan, esatto, sì, Dolce Sentire è Baglioni che canta su Donovan, e finì nei canzonieri liturgici, avete presente, quelli posati sui banchi di chiesa, con Noi vogliam Dio e Symbolum '77 (Tu sei la mia vita / altro io non ho). Si cantava di regola durante la comunione. Non che nessuna autorità ecclesiastica l'abbia mai omologata, ma i preti facevano finta di niente, erano anni così. Pur di avere giovani in chiesa avrebbero aperto le porte anche ai Black Sabbath.
Questo insomma era il mio Francesco '70-80: l'unico Santo che ci fosse vicino in quel periodo in cui volevamo stare in parrocchia ma anche farci crescere la barba, azzuffarci nei fienili e magari farci le canne. E i soldi di papà ci pesavano un po' in tasca. Fossi nato giusto qualche anno prima probabilmente sarebbe stato un tizio più tosto, come quello che fa la morale a Totò e Ninetto in Uccellacci: un estremista intransigente che rifiuta il concetto di proprietà privata (perché in fondo il pauperismo medievale consisteva in questo), occupa chiese diroccate e insieme ad altri giovani disadattati fonda comuni maoiste sul filo dell'eresia. Ma ormai gli anni Ottanta incalzavano. I tempi erano maturi per un Francesco diverso, un Francesco rockstar. In realtà in questo blog io vorrei trattarli un po' tutti da popstar, i Santi; ma nel caso di Francesco l'approccio è perfino banale, voglio dire, la Cavani per il suo film francescano a colori scelse Mickey Rourke. Mickey Rourke! Che abbraccia un crocefisso di Cimabue buttato lì per caso e ci si struscia sensuale! Mickey Rourke nudo coi tatuaggi che si masturba nella neve! Ma vediamo il filmato.Cioè, capite, Mickey Rourke. Agli altri santi, quando va bene, affibbiano Castellitto (quando va male Beppe Fiorello).
Però è finita anche quella fase – e pensando a Mickey, oserei dire che non è finita bene. A questo punto mi domando con che Francesco stiano crescendo i ragazzini di oggi. Esce ancora il Piccolo Missionario? Ok, il Francesco ambientalista funzionerà sempre, ma è plausibile, mi chiedo, un Francesco teocon? Perché no, dopotutto aveva la fissa per le crociate (a proposito, una delle molle per la conversione potrebbe essere stato un attacco di panico: partiva per la guerra, ma c'era già stato e non gli era piaciuta affatto, soprattutto l'esperienza della prigionia: mettersi addosso un sacco e fare il mendicante poteva essere un'exit strategy, ma il senso di colpa per essersi ritirato dalla lotta alla fine potrebbe avere prevalso e averlo portato in Terrasanta; è un'ipotesi come un'altra, ma Francesco ormai uno specchio, per cui l'ipotesi probabilmente somiglia meno a Francesco che a me).
Che altro potrebbe essere tornato di moda in questo momento? Di sicuro non il pauperismo, uno stile di vita che in fin dei conti consiste nell'elemosina: è un fenomeno tipico dei periodi di boom economico, ma quando il ciclo finisce la gente sbarra le case e comincia ad aver paura dei lebbrosi e degli zingari. Invece dovrebbero andare forte le stimmate: per molti secoli ne è stato l'unico portatore ufficiale. E in generale la sua sensibilità nazionalpopolare (ha inventato il Presepe vivente).
Sotto la superficie dello specchio, Francesco resta lì, aspetta le generazioni che verranno e lo vedranno in un modo diverso. Inutile ormai domandarsi chi fosse veramente - nel suo ritratto più antico e verosimile (quello di Cimabue nella Basilica inferiore di Assisi) è semplicemente un uomo che conosce il dolore e la povertà, e che da otto secoli, senza abbassare lo sguardo, sembra fissare proprio noi.
Scuola di ballo al sole
06-07-2020, 09:48cinema, coccodrilli, musica, PasoliniPermalinkEnnio Morricone (10/11/1928, 6/7/2020).
Siamo pari
31-01-2020, 23:11cinema, famiglie, generazione di fenomeniPermalinkNon siamo riusciti a ridurre le emissioni, non ci siamo rivoltati contro chi ci avvelenava, non abbiamo nemmeno protestato, cioè ci abbiamo provato ma ci siamo ritirati alle prime mazzate. Da chi ci ha preceduto non abbiamo imparato nulla, ma ve l'abbiamo insegnato lo stesso.
Abbiamo esaurito le risorse, esaurito gli antibiotici, esaurito l'ossigeno, il che non significa che non abbiamo smesso di parlare, di solito per farvi la predica. Vi stiamo per lasciare un mondo in macerie e tantissime armi per litigarvele. D'altro canto.
D'altro canto voi ci avete portato a vedere Me Contro Te La Vendetta Del Signor S, quindi direi che adesso siamo pari.
Lo sai che si dice dei cattolici
23-01-2020, 00:21cantare, cinema, coccodrilli, cristianesimo, traduzioniPermalinkmormoni, islamici e sikh.
Ci son Testimoni e battisti,
ma io... io non sono così.
Son tra i cristiani cattolici,
ci sono da sempre, e lo sai
che c'è di bello a esser cattolici?
Vai bene così come sei.
Non serve essere alto e prestante,
o un nobile o un genio, perché
cattolico sei dall'istante
in cui tuo padre è venuto per te.
Infatti...
Ogni sperma è sacro,
ogni sperma è santo.
Se sprechi lo sperma
Dio si altera alquanto.
Lascia gli infedeli
tristi a sgocciolare:
ogni goccia persa
Dio la sta a contare.
Ogni sperma è santo,
ogni sperma è sacro.
Se sprechi lo sperma,
Dio sa che è un massacro.
Indù, ebrei, taoisti
spruzzano qua e là,
ma Dio salva soltanto
chi si conterrà.
Ogni sperma è santo,
Dio ce l'ha donato.
Ogni sperma è una risorsa
per il vicinato.
Ogni sperma è santo,
ogni sperma è buono.
Ogni sperma è utile,
ogni sperma è un dono.
Lascia che i pagani
innaffin monti e mare:
ogni goccia persa
Dio la fa pagare
Ogni sperma è sacro,
ogni sperma è santo.
Se getti lo sperma,
Dio si arrabbia,
tanto.
Every Sperm Is Sacred, musica di André Jacquemin e David Howman, testo di Michael Palin e Terry Jones (1942-2020).
(Ho sempre pensato che sarebbe stato giusto averne una traduzione cantabile in italiano, non importa quanto inferiore all'originale).
Tradurre in cattività: il caso Neon Genesis Evangelion
09-07-2019, 19:06animazione, cinema, fumetti, TheVision, traduzioniPermalinkNon è responsabilità di Gualtiero Cannarsi se, fino a qualche giorno fa, i personaggi di Neon dicevano cose come “È col tentare di abbatterlo in fretta che la cosa si è fatta dura”, o “L’autoespulsione è entrata in attività”. Non è responsabilità sua se i doppiatori sono stati costretti a recitare battute che non capivano. Se a Cannarsi è stata data sempre più fiducia, malgrado i problemi fossero evidenti (e il pubblico non mancasse di notarli), la responsabilità è di chi questa fiducia per tutto questo tempo l’ha concessa. Ora Cannarsi pagherà anche per loro, ma quel che è successo è che un sincero cultore della materia è stato lasciato solo, per anni, al tavolo di lavoro, da committenti la cui negligenza a un certo punto deve aver interpretato come un attestato di fiducia. Magari sarebbe bastato poco: un editore, un distributore, un collaboratore che in tutti questi anni gli stesse accanto, gli rileggesse a voce alta le frasi che scriveva, lo aiutasse a non allontanarsi dall’italiano parlato e scritto. Qualcuno che smorzasse sul nascere certe velleità ermeneutiche che sono il tipico mostro che nasce dal sonno breve e agitato dei traduttori quando la scadenza comincia a essere troppo vicina (e la scadenza è sempre troppo vicina). Cannarsi invece è stato lasciato solo, e ha fatto quel che facciamo tutti quando siamo soli: ha iniziato a parlare con sé stesso, in una lingua tutta sua.
Tradurre è molto difficile. Bisogna avere due lingue in testa, e non è detto che nella nostra ci stiano davvero. Nelle orecchie, soprattutto, perché a volte è come ascoltare due musiche contemporaneamente. Magari non è impossibile, ma senz’altro non è una passeggiata, e il traduttore non fa altro tutto il giorno. Eppure ci basta leggere due o tre pagine in un’altra lingua, o anche solo ascoltare due o tre episodi in versione sottotitolata, per ritrovarci già in bocca qualche espressione che in italiano non esiste, qualche calco che un buon traduttore dovrebbe sempre saper aggirare, con leggerezza, mentre saltabecca da una lingua all’altra. Questo dovrebbe fare il traduttore ideale.
È una vittima designata, in un certo senso. L’uomo giusto nel momento sbagliato... (Continua su TheVision).
Per qualche anno Cannarsi si è ritrovato confinato in una confortevole nicchia di mercato: un limpido acquario lontano dall’oceano, dove le sue mostruosità erano ritenute inoffensive – forse persino decorative. I film dello studio Ghibli, in Italia, sono un prodotto per appassionati. Il fatto che per molti appassionati il doppiaggio sia un errore a prescindere ha fatto sì che alcune critiche siano passate inosservate agli addetti ai lavori. Ma il sospetto è che alcuni di questi addetti abbiano lasciato Cannarsi libero di fare scempio di lessico e sintassi perché il risultato sembrava aggiungere qualcosa alla versione italiana di quei film: un senso di straniamento, di esotismo che li proteggeva dalle critiche, rassicurando i fan sul fatto di trovarsi davanti a vere opere d’arte dai contenuti preziosi (e a volte enigmatici) e non a banali cartoni-animati-giapponesi per bambini. Un classico equivoco interculturale: i film di Miyazaki in effetti sono cartoni animati, e non hanno alcun bisogno di un registro aulico o pretenzioso per imporsi allo stesso pubblico trasversale che in Occidente si gode i film della Disney. Ma in Italia li si è proposti a un pubblico diverso, più adulto, che andava in un qualche modo confortato sul contenuto artistico dell’opera (quella che Walter Benjamin chiamava aura). Un pubblico del genere non poteva accontentarsi di pagare il biglietto per vedere belle favole: doveva anche avere la sensazione di immergersi in una cultura diversa.
In questo senso Cannarsi era l’uomo giusto. Quel che ha fatto ai film di Miyazaki ricorda in qualche modo l’operazione condotta sui testi omerici da una delle traduttrici italiane più celebrate del secolo scorso, Rosa Calzecchi Onesti. L’aedo omerico si rivolgeva a un pubblico eterogeneo di contadini, guerrieri, casalinghe, bambini: Rosa Calzecchi Onesti pensava essenzialmente ai laureandi in lettere che pur non avendo il tempo di leggere Omero in lingua originale, dovevano conservare l’illusione di esserne capaci. Da cui l’idea di riprodurre in italiano soluzioni sintattiche che l’italiano non consente, che rendono il testo più faticoso ma più ‘autentico’ per l’ex liceale che conservi qualche vaga nozione di grammatica greca. L'Omero calzecchizzato ha perso la sua universalità (non lo puoi più leggere ai bambini), ma ha acquisito l’aura necessaria per apparire un prodotto colto, adatto a un preciso segmento del mercato. Qualcosa di simile Cannarsi ha fatto con Miyazaki. Non c’era una semplice riga di dialogo che non riuscisse a complicare e a rendere esotica, straniante, sempre all’inseguimento di una fantomatica fedeltà “all’opera” che non si accorgeva di tradire. Il risultato è uno strano ibrido che senza suonare né italiano né particolarmente giapponese, ci fa capire che quello che vediamo non è il solito prodotto audiovisivo, ma qualcosa di più profondo che richiede uno sforzo supplementare. Qualcuno se ne lamentava, ma i puristi comunque preferivano i sottotitoli, e forse tutto sarebbe continuato così ancora a lungo, se a un certo punto Netflix non avesse ripreso la pratica di Neon Genesis Evangelion.
Anche qui c’è un equivoco, o forse più d’uno. NGE in Giappone è uno degli anime più popolari di tutti i tempi, mentre in Italia è rimasto un prodotto di nicchia, poco conosciuto al di fuori del bacino degli appassionati. Un bacino di dimensioni comunque rilevanti, ma tant’è; in Italia gli unici mecha a essere già entrati nell’immaginario collettivo sono quelli degli anni della tv dei ragazzi e delle prime emittenti private: Goldrake, Mazinga, eccetera. Quando finalmente il Corriere si è accorto del caso Cannarsi, ha ritenuto necessario spiegare ai propri lettori che Neon Genesis è una “nuova serie che si ispira a Goldrake” (per il lettore medio del Corriere tutto quello che è successo dopo il 1994 è “nuovo”). Segregati a lungo in una nicchia, i fan italiani dell’anime di Hideaki Anno hanno avuto tutto il tempo e l’agio per radicalizzarsi e sviluppare la convinzione che NGE sia molto più di un cartone di robottoni: un’opera profonda e complessa, intrisa di riferimenti culturali da decifrare con cautela. Il fatto che i personaggi non parlino tutto sommato una lingua molto diversa da quella degli altri anime a base di robottoni rischiava, anche stavolta, di danneggiare l’aura del capolavoro. Si veda l’estenuante dibattito sulla opportunità di tradurre shito come angelo o come apostolo, dando per scontato che Anno si ponesse davvero il problema della precisione nei rimandi biblici, e non stesse semplicemente pescando riferimenti colti un po’ a caso, confondendo Nuovo e Vecchio Testamento così come un autore italiano confonde serenamente Buddha e Budai. Un dibattito del genere è esattamente il mangime adatto per un pesce come Cannarsi, che può dimostrare il suo acume di filologo e rassicurare il pubblico adulto italiano sulla profondità di NGE: non il solito anime di robottoni, ma un’opera d’arte, dunque degna di un linguaggio aulico e accessibile solo agli iniziati.
E però Netflix non è la Lucky Red: il bacino di utenza è ormai molto più vasto e in particolare Netflix Italia in un primo momento potrebbe avere sottostimato la popolarità di NGE. Dal suo confortevole acquario, Cannarsi si è ritrovato sbalzato nell’oceano da un momento all’altro, senza avere gli strumenti per accorgersene. Ma ancora: com’è stato possibile che nessuno gli abbia impedito di consegnare ai doppiatori un testo che conteneva espressioni come “senza nessuna recalcitranza” o “hanno già completato di prendere rifugio”? Cannarsi scrive strano, ormai è il suo mestiere, anche se non è sempre consapevole. È abbastanza inutile pretendere che si renda conto di quel che ha fatto o che addirittura chieda scusa. Lui ha fatto esattamente quello che fa in questi casi, senza reagire alle critiche, anzi senza nemmeno capirle. Chi però in tutti questi anni lo ha lasciato lavorare indisturbato, qualche domanda dovrebbe porsela.
Giornata della memoria, appunti sulla
30-01-2019, 17:22cinema, ebraismo, giorno della memoria, memoria del 900, rifiutati, scuola, StoriaPermalinkMetti sull'Uno c'è un maestro che urla
18-01-2019, 18:215Stelle, Beppe Grillo, cinema, Il Post, santi, scuola, tvPermalinkIl primo successo del 2019 per la Rai è Alessio Boni che urla ai ragazzini. Certo, La Compagnia del Cigno è molto altro: c’è musica in abbondanza, classica e moderna, e poi ogni ragazzo ha il suo arco narrativo, l’ingresso nell’età adulta eccetera – sì sì però se lunedì sera mettete sull’Uno all’improvviso, in tre casi su tre si materializzerà Alessio Boni che a stento controlla l’impulso di rompervi la bacchetta in testa.
La Compagnia ha battuto il Titanic restaurato, ha battuto la Coppa Italia; il maestro che urla è il primo grande spettacolo italiano del 2019. Quasi un italiano su dieci ha assistito alle sfuriate del maestro Boni senza cambiare canale. Anzi dev’essersi in qualche modo affezionato, e non so se questa è una buona notizia per il mondo della scuola. In gran parte si tratta degli stessi italiani che non esiterebbero a denunciare un maestro del genere se invece che in tv sbraitasse in quel modo davanti ai propri figli, in un’aula scolastica – andiamo, persino io lo avrei mandato a quel paese a un certo punto: e faccio il suo mestiere. Che ci è successo?
Che fine ha fatto il modello di insegnante che andava di moda quando studiavo, quello super-empatico che non castigava mai nessuno, anzi riusciva a entrare in sintonia con tutti senza alzare la voce? Il Robin Williams dell’Attimo fuggente: molti di noi insegnanti vorrebbero ancora assomigliargli, anche se alla fine ci scappa la pazienza e gli studenti piangono e poi i genitori protestano. Genitori che, diciamolo, non hanno sempre tutti i torti, forse dovremmo essere ancora più pazienti – sì, però gli stessi genitori quando tornano a casa si bevono due ore di fiction con Alessio Boni che urla e strepita, c’è qualcosa di paradossale in tutto questo.
D’altro canto è pur sempre televisione. Quello specchio piuttosto distorto che non mostra quasi mai il mondo intorno a noi; il più delle volte ci mette davanti il mondo dentro di noi. Nessuno vorrebbe un maestro severo per i suoi figli, ma tutti segretamente lo vorremmo per i figli degli altri, e forse una fiction assolve questa funzione (“Guarda questo professore asfaltare sette adolescenti!”)

Come ogni modello che funziona i critici si sono subito affrettati a farci notare il prestito evidente nei confronti di un prodotto d’importazione. Lo ha prontamente ammesso anche lo sceneggiatore Ivan Cotroneo: il maestro interpretato da Alessio Boni deve molto a quello impersonato da J. K. Simmons in Whiplash, il primo film di Damien Chazelle. È il ruolo che finalmente ha fruttato un Oscar a Simmons, il classico caratterista che tutti abbiamo la sensazione di conoscere come un familiare, tante volte lo abbiamo visto in tv. E però in Whiplash il maestro urlatore è il cattivo del film, non l’eroe che aiuta a sbloccare le potenzialità del protagonista. A parte la sua ossessione per la musica (ossessione omicida) non conosciamo quasi nulla di lui. Non c’è tempo per spiegare cosa lo ha trasformato nella belva che è; non ci sono flashback che ci facciano scoprire i suoi dolori, i suoi lutti, non ci sono siparietti ricattatori che ci facciano piangere insieme a lui. Non è insomma come il maestro di Boni, che tra una scenata e l’altra lascia intravedere un animo sensibile, empatico, in grado di entrare in sintonia con il delicato mondo interiore dei ragazzi; se anche il personaggio di Simmons sembrava trapelare qualcosa del genere, era soltanto per rivelarsi fino alla fine un subdolo manipolatore.
Whiplash fu criticato, anche in Italia, per la visione del mondo che tradiva: una giungla dove conta soltanto la lotta per la sopravvivenza, l’autoaffermazione e il successo. Il film si presta in realtà a un’interpretazione più problematica: il protagonista è più vittima che eroe. Il maestro della Compagnia del Cigno, all’apparenza più sfaccettato, alla fine è soltanto il classico burbero dal cuore d’oro. Ma Whiplash è un grande film anche perché mette in guardia da quel modello di maestro carismatico, denunciandone la tossicità.

Sia Whiplash che La Compagnia, poi, traggono spunto da un discorso così universalmente condiviso ormai che rischiamo di non vederlo intorno a noi, come l’aria che respiriamo. In un certo senso è l’aria che respiriamo. È il talent-show. Whiplash è strutturato come una caricatura di talent-show: un maestro severo, un allievo che deve seguirlo ma anche sconfiggerlo. La Compagnia è un succedaneo di talent-show – quasi un placebo per i telespettatori in crisi d’astinenza, tra la fine di X Factor e l’inizio di Sanremo. Lo stesso Sanremo assomiglia anch’esso sempre più a un talent-show, al punto di essersi dotato di un maestro talentuoso, magari non sbraitante ma più severo di quanto ci saremmo aspettati: Claudio Baglioni.
Il 2019 è l’ultimo anno degli anni Dieci. Forse non è più troppo presto per un bilancio: è stato il decennio dei Talent. È vero, esistevano anche prima (più negli USA che in Italia). Ma fino a X Factor non eravamo abituati a chiamarli così, e soprattutto non li consideravamo molto di più che una forma di intrattenimento, una sottospecie dei Reality. Poi è successo qualcosa, fuori e dentro la tv. Non è ancora chiaro cosa – forse ha a che vedere con la caduta delle élite di cui in questi giorni stanno parlando sui giornali di carta. Insomma altri punti di riferimento sembrano essere crollati: i politici hanno smesso di essere attendibili (non che lo fossero dieci anni fa), medici e insegnanti hanno perso ogni autorevolezza. L’unico punto fermo, l’ultimo baluardo della meritocrazia, è il Talent.
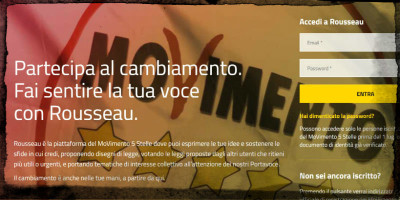
A questo punto naturalmente occorre obiettare che una meritocrazia del genere non può funzionare: tanto per cominciare gli strumenti sono farraginosi (Rousseau non funziona), ma anche se fossero efficienti, ci sarebbe il problema che il popolo è un pessimo giudice, non ha le competenze ecc. ecc.. Tutto probabilmente vero. Ma non è così strano che la società dello spettacolo si affidi al codice del Talent. Scuole e università non è chiaro se funzionino o no; perlomeno le ultime classi dirigenti che hanno formato lasciavano molto a desiderare. I Talent non è detto che creino più competenza, ma sicuramente fanno spettacolo, e quella è una cosa che sappiamo apprezzare.

Nei Talent scorre ancora, neanche tanto sotterranea, quella vena di sadismo e crudeltà che abbiamo bandito dalle scuole (e che forse inconsciamente rimpiangiamo). Solo nei Talent è ancora concesso umiliare l’incapace, e mettere apertamente l’uno contro l’altro gli apprendisti. Che parlino di cucina o di musica, il motivo per cui li guardiamo è il motivo per cui ci lasciamo ipnotizzare dalle sfuriate di Alessio Boni: i maestri sadici sono sexy. Vederli tormentare le loro vittime è uno spettacolo per cui paghiamo abbonamenti e biglietti al cinema. Forse ci piacciono proprio perché non assomigliano affatto ai nostri ex professori, empatici e condiscendenti, sempre pronti ad applaudire ogni nostro minimo sforzo. Se non siamo diventati quegli uomini e donne di successo che loro vedevano in noi, magari è colpa loro: troppo buoni, troppo permissivi. Se ci avessero preso a ceffoni, invece, chissà… vabbe’, è troppo tardi per recriminare. Ma si fa ancora in tempo ad accendere la tv. Sull’Uno c’è un prof che strepita, su Sky quattro cuochi infieriscono su dilettanti allo sbaraglio, l’Attimo fuggente almeno stasera non c’è (anche perché a modo suo va in scena in tutte le scuole d’Italia, da lunedì a sabato, da settembre a giugno: e dopo un po’ viene a noia, non ditelo a me).
"Mai ci fu una storia più scorretta..."
11-01-2019, 00:35anglistica, autoreferenziali, cinema, invecchiare, ragazzini, scuola, sessoPermalinkDa allora non c'è una classe in cui non l'ho mostrato, in versioni sempre un po' più nitide: e non c'è una volta in cui non abbia fatto il suo porco lavoro. A volte, se c'è tempo (una supplenza improvvisa, una nevicata) ci concediamo anche un confronto col Romeo+Juliet di Luhrmann, che li sconvolge perché Di Caprio così giovane non lo immaginano. Ma sulla distanza non c'è gara, Zeffirelli vince tutto, Zeffirelli ci penetra in luoghi che non sappiamo nemmeno di avere, o ce lo siamo dimenticati. Poi passa un anno, a volte anche due, e mi domando se non mi ricordo male, se non tendo a sopravvalutare l'effetto – in fondo è solo un film, ormai vecchissimo, probabilmente dovrei cercare cose più moderne, più pensate per i teen di adesso. E ogni volta boom, lo stesso incantesimo. Del resto, perché non dovrebbe funzionare una volta in più? Shakespeare è sempre quello, Zeffirelli pure, i preadolescenti sono sempre preadolescenti litigiosi acerbi disperati. C'è una sola cosa che cambia, nel quadro complessivo.
Sono io.
E me ne accorgo in modi curiosi – la musica di Rota, ad esempio, che all'inizio mi era molesta e ora è quasi parte del paesaggio. Ma soprattutto: faccio sempre più fatica a guardarlo. All'inizio era un film, soltanto un film, probabilmente lo consideravo kitsch o camp o middlebrow, non mi ricordo (però funzionava, quindi lo usavo: al massimo cercavo di smontarlo dopo la visione). Ma ricordo che alla ricerca di informazioni incocciai in un forum in cui un cinefilo americano lo definiva "horny", e scrollai mentalmente la testa: che bacchettoni questi americani, voglio dire chi è che negli anni Zero ancora si eccita per due chiappe di Romeo in un fotogramma.
Ecco, sono passati gli anni Zero e pure i Dieci: Shakespeare è sempre Shakespeare, Zeffirelli è sempre Zeffirelli, i fotogrammi con le chiappe non sono aumentati, e io sono sempre più turbato da quel film. Cioè, è pur vero che funziona, ma accidenti se è horny. Direi pure che è barely legal. E prima o poi non sarà più legal, prima o poi con una classe mi metto nei guai, a mostrare sulla lavagna interattiva quei due minorenni che amoreggiano. Spero che non sia stavolta.
Fatemi un bocca al lupo, è per stamattina.
Ai giochi addio...
E anche questo coccodrillo
10-07-2018, 09:19cinema, coccodrilli, OttantaPermalink
Non credo che fosse una scelta autoriale; probabilmente erano i pezzi in classifica nel momento in cui avevano girato il film. Ancora più probabilmente se ne fregavano, i Vanzina, come doveva essersene fregato il padre e tutti i registi della generazione precedente. Mi vengono in mente un paio di capolavori in bianco e nero che sono anche caroselli frastornanti di canzoni da classifica – Il sorpasso, Io la conoscevo bene, ma era un periodo diverso, forse le canzoni avevano tempi di decadimento più lunghi. Invece un gap di sei mesi, negli anni Ottanta, sembrava un secolo. Dopo sei mesi Moonlight Shadow era preistoria, Sunshine Reggae a Natale causava dolore fisico. Troppo presto per provarne nostalgia, in compenso ti suggerivano una tristezza sconfinata. Lo spleen delle vacanze finite, delle feste di compleanno quando gli amici se ne vanno e la mamma non sparecchierà da sola. Una sensazione che gli stessi Vanzina non temevano di evocare alla fine dei loro film migliori ("E anche questo Natale se lo semo levato da le palle"). Il cinema stava perdendo la presa sull'attualità e ovviamente il colpevole era l'elettrodomestico a colori che tenevamo in casa. Quando il Drive In di Ricci divenne egemone, i Vanzina tentarono di ripeterlo al cinema. Ma i tormentoni di Ezio Greggio erano ancora più effimeri del pop da classifica, sei mesi dopo non è che non facessero semplicemente più ridere: sapevano di morte.
Chi è cresciuto negli anni Ottanta non è che avesse accesso a molte opzioni: poteva amarli o poteva odiarli. Non c'erano terze vie, sono state tracciate dopo. A chi sceglieva la seconda, a chi necessitava quotidianamente di oggetti esemplari su cui esercitare il proprio disprezzo, i Vanzina offrivano un bersaglio così comodo, così evidente che avrebbe dovuto insospettirci, ma eravamo scemi. I Vanzina a modo loro erano nostri compagni di strada; disprezzavano le maschere che mettevano in scena tanto quanto le odiavamo noi, ma eravamo troppo piccoli per capire, troppo orgogliosi. A loro non potevamo perdonare nulla. Consideravamo la sola esistenza di Christian De Sica una bestemmia, un'offesa al nobile regista di film neorealisti che dovevamo ancora guardare; ci avremmo messo trent'anni a capire che per la maggior parte della sua carriera Vittorio De Sica aveva interpretato cialtroni squallidi quanto quelli che erano toccati al figlio. Magari nel frattempo ci stavamo facendo una cultura sul segmento aureo della commedia all'italiana (quella che arrivava su Rete4 in seconda serata), in confronto al quale le farse vanziniane ci sembravano una degenerazione intollerabile; senza accorgerci che i Vanzina erano gli unici eredi di quelle formule che tentavano di svecchiare procedendo per tentativi, senza lasciare nulla di intentato e senza menarsela mai. Ecco, se la fossero menata un po' di più forse oggi sarebbe più facile salutare un grande artista e scopritore di talenti. Invece i Vanzina erano una macchina: lavoravano tanto, incassavano tanto e non avevano pietà di nessuno. Senz'altro non di sé stessi.
Nel film italiano più celebrato dell'ultimo decennio, un film che rielabora echi felliniani, scoliani e morettiani in un gran pastone per turisti, a un certo punto una tizia ci informa che "l’unica scena jazz interessante è quella etiope". Quel pezzettino lì non è Fellini, non è Scola e non è Moretti: potrebbe essere uno scarto di lavorazione dei Vanzina, qualcosa che all'ultimo momento De Sica non avrebbe detto perché gli sarebbe venuta in mente una frase più divertente.
L'epico, persino un po' brechtiano, Fantozzi
03-07-2018, 23:44cinema, coccodrilli, tvPermalinkPer Mattia Feltri era soprattutto un atto di denuncia contro l’ipocrisia dei dirigenti che si atteggiano a rivoluzionari, come il dottor Ricciardelli che la sera di Italia-Inghilterra convoca i suoi dipendenti e li costringe alla visione del capolavoro muto e in bianco e nero; il vecchio Feltri li avrebbe definiti radical chic, il giovane ci risparmia almeno la definizione. Aldo Grasso invece non riuscì nell'occasione a controllare l’impulso di scrivere “superiorità antropologica della sinistra”, contro cui Fantozzi si ribellerebbe; la sua sarebbe la “resistenza che l’impiegato oppone a chi vuole colonizzare il suo tempo libero”.
Dall’amaca Michele Serra tentava l’impossibile compromesso tra gli orfani di Villaggio e gli estimatori di Ėjzenštejn: “Lo stesso spettatore poteva benissimo amare la Potëmkin e Fantozzi, il cinema d’essai e il cinema popolare. Ma in sale diverse, in momenti diversi e con animo diverso”. È un veltronismo che Villaggio non avrebbe condiviso: anche l’ultima volta che ebbe occasione di parlarne – invitato dalla Cineteca di Bologna nel 2003 in occasione del restauro della Corazzata – ribadì la sentenza fantozziana: altro che capolavoro, era una “cagata” che avrebbe potuto interessare solo “vecchi e insonni”.
E però la necessità di salvare capra e cavoli, Fantozzi e Corazzata, è troppo forte e produce torsioni interessanti, come quella di WuMing1 che dopo la commossa rievocazione di un’epica proiezione della Potemkin in piazza Maggiore propone di leggere l’episodio come una “vertiginosa mise en abime” dei cinque atti del film: “il cineforum è la corazzata; Fantozzi è il marinaio Vakulenčuk che per primo grida la verità su quel che sta accadendo; gli spettatori sono i marinai insorti; l’odioso Riccardelli è gli ufficiali spodestati; la sala occupata è Odessa; la polizia che «s’incazza davvero» ha il ruolo dei cosacchi che reprimono”.
Villaggio novello Ėjzenštejn, e proprio perché si permette di sfottere Ėjzenštejn (...nel momento in cui la borghesia finto-rivoluzionaria se ne impossessa e lo trasforma in un feticcio). A corroborare una lettura tanto epica, WuMing1 riconosce nella saga di Fantozzi un unico personaggio positivo: il marxista Folagra, che dal sottoscala in cui è confinato non rinuncia a spargere il seme della rivolta - un po’ come i WuMing, fedeli al loro personaggio di rivoluzionario in servizio permanente. Folagra però nel film sembra una macchietta, appena in grado di farfugliare quattro slogan autonomisti; la fiaccola rivoluzionaria che passa a Fantozzi si smorza subito nel Grande Acquario dei Dipendenti. Del resto non è che ai personaggi di WuMing la rivoluzione di solito riesca: sin dai tempi di Q non hanno fatto che raccontare storie di rivoluzionari magari più strutturati di Fantozzi, ma ugualmente destinati alla sconfitta. Paolo Villaggio in questo senso è un marxista più ortodosso (o più novecentesco): quando scriveva e sceneggiava Fantozzi, sembrava avere in mente una concezione meno vicina alla New Italian Epic che all’epica brechtiana: come Madre Coraggio, Fantozzi non acquisisce mai una vera consapevolezza della propria condizione di sfruttato. Non è lui che doveva svegliarsi, ma lo spettatore.
Non è esattamente andata così. Il secondo tragico Fantozzi è un film del 1976, un’epoca pre-tv-color in cui i cineforum impegnati erano ancora una realtà non solo nelle grandi città – e in effetti lo sketch era nato in tv come una satira di quell’ambiente, che Villaggio conosceva bene; solo in un secondo momento era stato riadattato all’universo fantozziano. Il successo dei primi Fantozzi di Salce e Villaggio fu notevole, ma la vera penetrazione nell’inconscio collettivo avviene nel decennio successivo, quando la Mediaset ne acquisì i diritti e cominciò a riprogrammarli intensivamente – al punto da risorgere anche il personaggio cinematografico, in una serie di sequel sempre più deprimenti.
È solo in quel momento che “è una cagata pazzesca” diventa un modo di dire della lingua italiana (70.700 risultati su google); una specie di versione adulta e sboccata dell’andersoniano “il re è nudo” (anche “92 minuti di applausi” era già un meme prima delle GIF: nell’era pre-facebookiana di internet la citazione fantozziana era un buon surrogato del tasto “Mi Piace”). Nel frattempo però il paesaggio che Villaggio irrideva – quel mondo scalcagnato di cineforum fumosi coi seggiolini di legno – era completamente scomparso; e Ėjzenštejn dimenticato, anche dal palinsesto notturno di Rai3. La tv commerciale stava crescendo una nuova generazione di cinefili, forse non meno fanatici del dottor Ricciardelli, ma dai gusti completamente diversi: completamente digiuni dei maestri russi e degli espressionisti tedeschi, ma in grado di riconoscere un film di Bombolo o Lino Banfi dal singolo fotogramma.
Chi cresceva in quegli anni poteva condividere la sensazione di ritrovarsi bloccato nella scena dell’assedio fantozziano, e costretto come Ricciardelli a vedere a ripetizione “Giovannona Coscialunga, L’esorciccio e La polizia s’incazza”. Tra questi titoli ormai imprescindibili della storia del cinema italiano, non mancavano i film di Fantozzi. La rassegna integrale, sempre più lunga e ridondante (e triste, nel suo lungo percorso verso il trash), veniva riprogrammata una volta a semestre. I megadirettori delle emittenti ci convocavano per sentirci ridere – ridere stava diventando obbligatorio, come una volta partecipare al dibattito. Invece dell’“occhio della madre”, era obbligatorio menzionare il "radical-chic" e la “superiorità-antropologica-della-sinistra”; al posto del “montaggio analogico”, c’era lo sberleffo obbligatorio verso un modello di cinema e di società che non avevamo nemmeno fatto in tempo a conoscere. È andata così e non è certo responsabilità di Paolo Villaggio; comunque è finita. Vero?
I 1001 pianeti di Valérian
23-10-2017, 23:56cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, Francia, fumetti, futurismiPermalinkDa qualche parte al centro di questa città quadrimensionale, vivono i superstiti di un antico e nobile popolo che abbiamo sterminato un giorno senza volere - cose che càpitano quando si esplora la galassia. Non vivono in armonia con la natura: la natura non c'è più. Hanno la loro tecnologia, sviluppata un po' in autonomia un po' rubacchiando quello che passava ai piani superiori. Non è incomprensibile, ma ha le sue stranezze - comunicano col Minitel, hanno le tastiere con la A al posto della Q. Un giorno spiccheranno il volo, verso un nuovo pianeta dove vivere in pace e stagionare altri ottocento formaggi diversi. E ci mancheranno. Sì, proprio i francesi. Lo so, sembra impossibile.
 |
| Ma tingerle i capelli proprio non si poteva? Anche in CGI... |
 |
| L'idea - molto europea - che la convivenza sia un caos, però un caos che tutto sommato funziona. |
Si potesse fare a meno di lui, ne sarei contento. Ci fosse in circolazione qualche altro visionario regista francese in grado di attingere a quell'immaginario autoctono che negli anni Sessanta dava i punti agli americani - ma non c'è. Quel momento in cui il pianeta Francia e il suo satellite Belgio erano gli astri più fiammanti del firmamento, e Mézières e Moebius plasmavano il nostro immaginario, con situazioni più problematiche di quelle che arrivavano da oltre oceano, ma immagini altrettanto suggestive - alzi la mano chi ha trovato l'astronave di Valérian un po' troppo simile al Millenium Falcon, beh, è ovviamente il contrario. Besson non sarà il miglior difensore del patrimonio culturale che rappresenta, ma al momento è l'unico, e quindi viva Luc Besson e i suoi pupazzoni digitali (che comunque reggono il confronto di Avatar). Per quanto sia difficile volergli bene, una volta su dieci ne vale la pena. A volte gli riescono cose impossibili, ad esempio rendere simpatica Cara Delevigne. Mentre Dane DeHaan ha esattamente la faccia da schiaffi che serve a un avventuriero dello spazio. Valerian e la città dei mille pianeti resiste indomito al Monviso di Cuneo, almeno fino a stasera 24 ottobre alle ore 21.
I replicanti sognano Blade Runner analogici?
15-10-2017, 15:16cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, futurismi, OttantaPermalinkIl passato non esiste. I tuoi ricordi sono solo un innesto. Non è sempre stato così, ma un giorno c'è stato un black out e tutti i ricordi che avevi - le foto da bambino, i tuoi film preferiti - puf, è sparito, come lacrime nella pioggia. Non ci credi. Vuoi che facciamo un test?
Ho appena citato un film famoso. Ti ricordi quale?
Bene.
Ti ricordi quando l'hai visto per la prima volta?
Vedi?
Il primo a rompere l'omertà è stato Zerocalcare. Nei giorni successivi, qualcun altro ha trovato il coraggio di ammetterlo: uno dei problemi di Blade Runner 2049 è che è il seguito di un film che siamo tutti convinti di conoscere, ma non ci ricordiamo di aver visto. C'è senz'altro una spiegazione razionale al fenomeno. Quando uscì al cinema eravamo troppo giovani - e comunque floppò. Era stato messo insieme da Ridley Scott con tanta ambizione e pochi soldi. La storia faceva acqua, alcuni dialoghi non avevano senso, l'atmosfera era azzeccatissima ed ebbe un effetto dirompente sul nostro immaginario - uno stacco netto dai futuri postatomici degli anni precedenti - per cui negli anni Novanta anche se non guardavi Blade Runner te lo ritrovavi replicato in tutto il cyberpunk, persino nei fumetti della Bonelli: dappertutto pioggia, inquinamento, grattacieli, androidi tristi. Nel frattempo uscirono varie riedizioni, una director's cut che non piacque al director, cui seguì la director's cut della director's cut - a quel punto forse noi vedemmo per la prima volta Blade Runner, ma eravamo già in quell'età in cui ci vergognavamo a dire di non averlo già visto, e così programmammo noi stessi per dire: "l'altra sera ho rivisto Blade Runner". E si sa come va con l'autoprogrammazione, no? Convinci più te stesso che gli altri. Ormai era il 2000 e la gente si era messa a scrivere su forum e blog, e ogni tre righe citava "Ho visto cose che voi mortali". Tutti sembravano conoscerlo a memoria, Blade Runner. Ma più che la storia tutti citavano quel monologo senza senso improvvisato dal grande Rutger Hauer che sembra arrivato all'ultimo momento da qualche altro set di fantascienza ("navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione"?), e poi l'atmosfera, eh, l'atmosfera. La pioggia, le pubblicità luminose, il sushi. Ok. È un innesto.
Non è successo. Non hai mai visto veramente Blade Runner. E forse è meglio così. Ora sei libero di guardarti un ambizioso film di fantascienza di Denis Villeneuve, e di amarlo od odiarlo per quello che è. Un ambizioso film di fantascienza di Denis Villeneuve. Meglio di quello di Scott? E che ne so?
(Spoiler: in una delle scene più apparentemente gratuite, il grande demiurgo (che è Jared Leto, ma anche un po' Villeneuve) gioca a resuscitare il passato. È un gioco che ultimamente abbiamo già visto in tutti i film di fantascienza ad alto budget, quindi l'effetto sorpresa ormai è andato. Salvo che stavolta il demiurgo resuscita il passato, lo trova insoddisfacente e lo uccide. Ed ecco che una scena che sembrava poco interessante diventa il senso del film).
C'è stato un blackout, davvero. Tutto quello che ci ricordiamo è andato perso, perché anche se non siamo replicanti (e chi dice che non lo siamo?) la nostra memoria funziona come quella dei computer - la nostra memoria è quella dei computer: o è condivisa, o scompare. Nel 2049 di Villeneuve, il Blade Runner originale non esiste più. Solo qualche frammento audio. Per quanto tu possa cercare di riprodurre fedelmente qualche dettaglio, commetterai sempre un errore fondamentale: sbaglierai il tono di voce, o il colore degli occhi. Tanto vale buttare via anche i frammenti e ricominciare da zero. Restano i sogni - brandelli di ricordi incontrollabili - ma anche di quelli come ti puoi fidare? Lascia perdere. Il passato non esiste, guarda avanti. Una volta forse il mondo era molto migliore, ma è stato tanti anni fa e non ti riguarda.
Villeneuve ha una padronanza dei mezzi che ti fa dubitare della sua umanità... (continua su +eventi!) Il suo futuro è ammuffito e arrugginito come dovrebbe essere. Anche gli ologrammi smaglianti a volte vanno in crash. Il casting è perfetto - se Ryan Gosling era nato per interpretare un replicante, strappa l'applauso il modo in cui Leto, Ana de Armas o Dave Bautista vengono adoperati sempre al meglio delle loro capacità (quando l'ex wrestler Bautista inforca quegli occhialini, ti sembra il più umano di tutti).

A Villeneuve non interessa se il tal personaggio è replicante o no - siamo tutti replicanti a modo nostro. Ci crediamo speciali perché abbiamo dei ricordi che lui sa fabbricare in serie. Villeneuve non si preoccupa troppo di mantenere l'atmosfera del primo film ed è forse questo il motivo per cui in alcune sequenza, con naturalezza, ci riesce. A Villeneuve interessava fare un film di fantascienza cupo, nebbioso, imbastito su un'idea di futuro coerente, e c'è riuscito. A Villeneuve interessava un certo ritmo lento, e la cosa infastidisce soltanto nell'ultimo terzo, quando lo sforzo di reintrodurre sul set Harrison Ford allunga i tempi a dismisura. Si poteva fare diversamente? Secondo me no. A questo punto sono portato a fidarmi di Villeneuve come di un'intelligenza artificiale: se il film è troppo lungo, si vede che non c'era modo di accorciarlo senza ottenere un prodotto inferiore. Sta floppando? È un Blade Runner, che ti aspettavi? Gente che fa la fila per vedere un futuro prossimo dove mangeremo millepiedi e flirteremo coi sistemi operativi? (Eppure dopo una settimana l'ho visto in una sala ancora piena, ero il primo sorpreso a vedere che la gente non uscisse a metà).
Anche ammesso che Villeneuve sia un umano, ormai è certo che non è americano. Il suo Blade Runner è la storia di una creatura che non si crede speciale; che lentamente cede alla tentazione auto-indotta di credersi speciale; ma non lo è: ed è qui che Villeneuve fallisce clamorosamente il suo test di americanità. Il che non significa che non possa ancora rendersi utile, e provare riconoscenza per chi lo creato e ha creato i suoi ricordi. Saranno anche innesti, ma restano le cose più belle che abbiamo. Forse non abbiamo mai visto Blade Runner, ma è lo stesso dentro di noi. Oggi più che vent'anni fa. Blade Runner 2049 è al Cityplex di Alba (15:30, 18:30, 21:30), al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo) (14:45, 17:10, 20:30, 21:30), al Vittoria multisala di Bra (17:30, 21:00), al Fiamma di Cuneo) (14:50, 18:05, 21:15), al Multilanghe di Dogliani (17:40, 20:45), ai Portici di Fossano (15:30, 18:30, 21:30), al Baretti di Mondovì, (21:00), al Cinemà di Savigliano (16:00, 18:45, 21:30).
Nel giardino delle attrici castratrici
06-10-2017, 08:48cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, essere donna oggiPermalinkAl di là del bosco c'è la guerra. È lontana e in ogni dove, brontola tutti i giorni come un temporale che non riesce a sfogarsi. Un giorno ci troverà e sarà finita - in fondo siamo soltanto un collegio di signorine, o quel che resta di. Un giorno la guerra busserà ai nostri cancelli. O forse arretrerà sgomenta?
 |
| Niente All Star stavolta |
Dopo aver rinunciato e esprimersi in una grande produzione, la Coppola ha ripiegato sul remake di uno sfortunato film di Don Siegel in cui Clint Eastwood durante la Guerra di Secessione si nascondeva in un convitto di signorine - in Italia provarono a smerciarlo come un prodotto sexy, La notte brava del soldato Jonathan, ma era un film molto inquietante per l'epoca, in cui Eastwood metteva in discussione il suo machismo: un film che metteva in scena incesti e castrazioni, e che al botteghino andò male (pochi mesi dopo Siegel e Eastwood si inventarono l'ispettore Callaghan, riconquistando machismo e botteghino). Al posto di Clint c'è Colin Farrell; nel cast femminile la Coppola ha convocato Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning e altre ragazze più giovani e assai promettenti. Tutte bianche, il che difficilmente le sarebbe stato perdonato nel 2017, ma lei lo ha fatto lo stesso (non se ne è resa conto o se ne infischia proprio? Continua su +eventi!)
Nel film di Siegel uno dei personaggi più importanti era una schiava, ma la Coppola una schiava afroamericana non sapeva come gestirla, così ne ha fatto a meno. Mentre critici e femministe la facevano a pezzi, riscoprendo stereotipi razziali in Lost In Translation, lei difendeva la sua scelta spiegando che aveva eliminato la schiava proprio perché aderiva a uno stereotipo razziale; in effetti era la classica schiava subdola e impicciona e - al contrario delle collegiali bianche - non parlava un buon inglese. D'altro canto perché una schiava non avrebbe dovuto essere subdola e impicciona, e perché mai avrebbe dovuto parlare un buon inglese? Così per evitare di essere accusata di razzismo, la Coppola ha diretto il primo film ambientato nel Sud secessionista in cui non viene mai, assolutamente mai, inquadrato un personaggio afroamericano. Come t'insegnano al collegio: delle cose scabrose non si parla, non esistono. Le donne di Siegel avevano scheletri negli armadi, quelle della Coppola ci tengono gli abiti da sera (e sono tutti perfetti). Le donne di Siegel tramavano per conquistarsi l'unico uomo, manipolandosi a vicenda; quelle della Coppola al massimo si rubano gli orecchini. Il punto è sempre lo stesso: non è che la Coppola rifiuti l'approfondimento psicologico, è proprio che non le interessa. Le piace mettere in scena signore di tante età e farle splendere a turno. Hanno tutte qualcosa di magico che solo un grande fotografo sa catturare, anche se di solito lavora per Vogue più che a Hollywood. C'è un momento per la Kidman, un momento per la Dunst, e se in un attimo di debolezza finisci per preferire la Fanning, è scontato che un po' ti meriti le disgrazie che ne deriveranno. Ma se cerchi il dramma ti sei proprio sbagliato, e dopo tanti anni è imperdonabile: dovresti saperlo che lei gira così. E vince pure dei premi, quindi insomma hai solo sbagliato sala. Di fianco fanno Valerian, fanno It, Blade Runner, ce n'è per tutti i gusti. La Coppola può essere irritante, ma ha un suo stile, un suo prodotto e un suo pubblico. Eppure.
Eppure a me dispiace che non riesca a uscire dalla sua comfort zone festivaliera, perché una regista con una visione così personale, una cura per il dettaglio inconfondibile e un'arroganza da autrice, mi sembra un po' sprecata per i servizi di moda. Se un giorno qualcuno riuscisse a convincerla, per esempio, a fare un horror, secondo me ne salterebbe fuori un capolavoro. I suoi film sono una specie di bolla sempre sul punto di scoppiare, immersi in una sensazione di sciagura imminente che non ti accorgi nemmeno di sentire, che dai scontata come quel costante rumore di fondo. A differenza di Bling Ring e Marie Antoniette, stavolta la Catastrofe non entra in scena. Forse non entrerà proprio nessuno. Forse la guerra è finita da secoli e quei rumori sono basi registrate. Forse quel bosco è in una bolla di vetro in fondo al mare. L'inganno è ancora per una settimana al Fiamma di Cuneo alle 21:15.
Tom Cruise spaccia (ma non aspira)
25-09-2017, 21:11cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, drogarsiPermalink |
| Una volta ero un pilota. In una vita precedente. |
"L'avevamo già visto in Collateral".
Beh, ma quello era un killer, questo... questo è un simpatico cialtrone!
"Edge of Tomorrow".
No, no, questo è più manigoldo, questo...
"La mummia".
Questo fa sul serio, capite? Questo spaccia la droga!
"La droga? Tom Cruise?"
Non ve l'aspettavate, eh? "Tom Cruise" e "droga" nella stessa frase sono un colpo basso, non dite di no.
"Si drogava già in Minority Report".
Sì, no, ma stavolta non è che si droghi. La spaccia soltanto.
"Cosa vuol dire che la spaccia soltanto?"
Beh è colombiana di Medellin, dai, cosa pretendi, che la sniffi sul grande schermo? È pur sempre Tom Cruise.
 |
| È il caso di dire: che botta. |
Se anche non andrete a vedere Barry Seal, c'è una scena che vi ricorderete perché compare in tutti i trailer, anche nelle pubblicità. C'è Tom Cruise che fa un atterraggio di fortuna in un sobborgo; c'è Tom Cruise che smonta dall'aeroplano tutto infarinato di cocaina con una valigia ricolma di dollari. È davvero il nocciolo di tutto il film: c'è l'aeroplano, ci sono i soldi, c'è la coca, c'è Tom Cruise che in un qualche modo ci salta fuori sempre (quasi). È anche l'unica scena che suggerisce che qualche granello di cocaina potrebbe essere stato inavvertitamente inspirato dal narcotrafficante interpretato da Tom Cruise. L'unica. E allora, signori, magari di narcotraffico non siamo così esperti, ma ormai di film ne abbiamo visti tanti. Anche prima dell'attuale inflazione di Escobar al cinema, c'era stato Blow, lo Scarface di De Palma, c'era stato Goodfellas con quella scena in cui Liotta se la prende con l'amante perché quando confeziona le dosi lascia polvere dappertutto. È cocaina, è bianca e granulosa, se soffi fa una nuvola, è quasi impossibile viverci in mezzo e non tirarne mai. Neanche un po'. Capita solo nelle fiabe - quelle che probabilmente i vecchi narcos raccontano ai bambini - il nonno era un capocartello, ma era pulito come appena nato - nelle fiabe e nei film con Tom Cruise.
Ci ho messo un po' a capire cosa non mi stesse convincendo in Barry Seal. Negli USA - dove deve ancora uscire - magari farà un po' di rumore perché... (continua su +eventi!) perché sostiene papale papale che la cocaina di Medellin entrasse in America grazie a una ditta basata in Arkansas che conosceva le rotte della DEA e della FBI dal momento che faceva lavoretti sporchi per la CIA e la CIA le aveva passato i tracciati. Che mentre Reagan dichiarava la Guerra alle Droghe, qualcuno forse nello stesso edificio considerasse l'invasione di colombiana purissima il prezzo da pagare per reprimere i sandinisti in Nicaragua. I sandinisti sono rimasti al potere, la cocaina è diventata un consumo di massa, la CIA si è allontanata fischiettando, e in tutto questo Barry Seal cosa rappresenta? Una pedina che si credeva furba ma che alla fine ha lavorato per tutti e non è riuscito a portarsi dietro nulla. Un tipo di personaggio che non è poi così nuovo per Tom Cruise - e allora perché stavolta manca qualcosa alla classica parabola del bravo-ragazzo-che-scopre-il-malaffare? Perché Barry Seal non raggiunge non dico i livelli di Wolf of Wall Street, ma a un certo punto fatica a mantenere il passo non certo da fuoriclasse di War Dogs?
Potrei tagliare corto e dire: Scorsese. Scorsese questi film li sa fare, gli altri no. Ma credo di averlo già scritto quattro o cinque volte, temo sia l'ora di approfondire. C'è che Scorsese è un tossico. Oddio spero non mi denunci. Magari ha smesso da anni, ma dentro di sé c'è un meccanismo che continua a girare. Gira a vuoto, ma gira. Tom Cruise ha altre stravaganze, ma quel meccanismo non ce l'ha. O non vuole mostrarlo, il che per un attore è imperdonabile. Magari gli piaceva il soggetto - un fattorino dei cieli che frega la Cia per conto dei colombiani e poi viceversa - magari voleva il suo Wolf of Wall Street personale. Però non voleva abbassarsi a tirare coca per tutto il film, ed è qui che casca l'asino. Il suo personaggio resta un'amabile faccia da schiaffi che passa la vita a mettersi nei guai senza un perché. Per un biplano ultraveloce? Una cadillac da regalare alla moglie? una villa con piscina a Mena, Arkansas? Non sembra davvero valerne la pena. La canonica scena "aiuto non so più dove mettere i soldi", che in Wolf varcava le soglie del grottesco, qui finisce per sottolineare l'assurdità della situazione: quanti ripostigli deve trovare Barry per le sue mazzette prima di capire che non potrà mai spenderle? La droga serve anche a questo: a bruciare i surplus in una nuvola gaia di euforia, a creare in individui non apparentemente cattivi quell'abisso da cui poi nascono le idee più disperate e geniali. Ma Barry non si droga. L'unico buon motivo per cui insiste a schivare l'artiglieria sandinista e gli elicotteri della DEA è che si diverte un casino. E naturalmente ha moglie e figli da mantenere - eh già, la famiglia, quanti crimini in tuo nome. Ma sul serio non c'è altro, nemmeno una scappatella con una hostess, niente. Cruise voleva fare il narcotrafficante ma anche il buon padre di famiglia.
Alla fine Barry Seal resta una pagina di storia interessante (anche se un po' fabbricata a posteriori: del resto quando c'è di mezzo la CIA l'unica verità è nel tritadocumenti). Non è però il film promesso, quello in cui finalmente Cruise si toglie la maschera da bravo ragazzo e ci mostra le turpitudini di cui è capace. Tutto il contrario: la maschera è più stretta del solito, non passa neanche un granello di polvere. Barry Seal è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo alle 20:00 e 22:40; al Vittoria di Bra alle 21:00; al Fiamma di Cuneo alle 21:10; al Multilanghe di Dogliani alle 21:30; ai Portici di Fossano alle 18:30 e alle 21:15; al Cinema Italia di Saluzzo alle 22:15.
La sublime arte del lobbying
19-09-2017, 14:17cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkSai perché i buoni perdono sempre (no, non al cinema, nella realtà)? Perché non sono abbastanza cinici. Non solo hanno quelle cose fastidiose che si chiamano "sentimenti", ma non sanno nemmeno sfruttarli: li nascondono, ricacciano le lacrime e cercano di sembrare razionali. Si aspettano che qualcuno gliene riconosca un merito. Sono sempre un passo indietro, sempre affannati nel tentativo di svelare l'ennesima trappola dei malvagi, invece di mettersi a elaborare trappole in cui qualche malvagio per una volta possa cadere. Per dirlo con una parola: sai perché i buoni perdono sempre nella realtà? Perché sono buoni. Ma se fossero i più cinici del mazzo, se vendessero i sentimenti propri e altrui a un tanto al chilo, se giocassero d'anticipo, che spettacolo sarebbe. Purtroppo nella realtà non può succedere. Al cinema, però...
Sai perché l'Europacorps di Luc Besson non sbaglia quasi un colpo al botteghino? Perché parte sempre da modelli collaudati - perlopiù americani - e li carica all'inverosimile, come neanche gli autoctoni osano. La loro America è sostanzialmente un sogno - un sogno nutrito di film americani, storie americane, serie americane. Ma se un giorno, invece di scopiazzare gli action per pensionati o i cinecomics o le commediole a base di animali parlanti, volessero cimentarsi con cose più cervellotiche, come quelle serie politiche ambientate a Washington dove tutti i politici e i lobbisti parlano a cento all'ora, che il pubblico raffinato si scarica coi sottotitoli e poi passa il tempo a leggere i sottotitoli? Se invece di fare il verso a Star Wars per una volta tentassero di fare il verso ad Aaron Sorkin o a House of Cards: cosa succederebbe? Che razza di film super-cerebrale, straparlato, implausibile ma irresistibile ci salterebbe fuori? Un film come Miss Sloane, diretto imprevedibilmente da John Madden (Shakespeare in Love, i Marigold Hotel) scritto da un esordiente e imbottito di intrighi e scene madri, ambientato in quell'America dirigenziale che si vede sempre nelle serie tv, quei palazzi tutti ascensori enormi e uffici a vetro. Una storia che parla del lobbysmo americano come se fosse l'epica Greca, un mondo che forse da qualche parte è esistito ma ormai è solo una metafora, un'iperbole, una scena trasparente dove mettere a galleggiare personaggi tragici. Un film che dopo cinque minuti ha già infilato un'interrogazione al Congresso e un dialogo tra due personaggi sulla via del gabinetto in cui si citano, tra le altre cose, Socrate, la Nutella e l'olio di palma. I debiti sorkiniani si saldano anche in sede casting, dove rivediamo almeno due volti di Newsroom, la dolce Alison Pill e li grande Sam Waterson: quest'ultimo in particolare piazzato in modo strategico, una specie di garanzia di genuinità di un prodotto (che tanto genuino magari non è, ma come si fa a non cedere davanti alla faccia del buon vecchio Waterson? Continua su +eventi!)

Ma Miss Sloane è soprattutto il film in cui Jessica Chastain può finalmente recitare a ruota libera, nel ruolo paradossale di lobbysta stronza che decide di passare dalla parte dei buoni - senza smettere di essere stronza, semplicemente trovando un fine nobile a i suoi stronzissimi mezzi. In fondo il suo ruolo non è molto diverso da quello già interpretato in Zero Dark Thirty - una donna super-determinata che fa di una singola missione lo scopo della vita - ma quello era un film realistico, o meglio le tentava tutte per presentarsi come tale. Miss Sloane è ambientato nella magica America sognata a un oceano di distanza, malgrado molti ingredienti della trama siano presi da scandali realmente avvenuti e documentati. L'eroina del film della Bigelow, in confronto a Miss Sloane, è statica come un'icona: qui la Chastain parla e straparla, teoricamente è dura come un diamante ma poi s'infrange come un cristallo, ogni tanto si fa un pianto o una crisi di rabbia ma poi si scopre che tutti gli apparenti fallimenti erano previsti. Miss Sloane è un surrogato europeo di Sorkin che coi tempi che corrono non possiamo permetterci di snobbare. Ovviamente non scorre bene come l'originale, ma è comunque uno spasso. Purtroppo il pubblico non ha gradito: Sloane è costato 13 milioni di dollari e fin qui ne ha raccolti solo nove. Nel frattempo Luc Besson sta per fare uscire il suo nuovo cinecomic fantascientifico. Sarà un baraccone pazzesco e sì, forse ho più voglia di vederlo che il prossimo Star Wars. Miss Sloane è all'Aurora di Savigliano alle 21.
Ballare al volante, ballare al cinema
13-09-2017, 16:40cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, musicaPermalinkC'è gente che balla là in strada. Lo fanno di nascosto, non li riconosci - se non dalle cuffiette, e da come tamburellano sul volante al semaforo. Non lo fanno per esprimersi o per esporsi o per piacere a sé stessi: lo fanno e basta, sono nati così, non smetteranno finché gli batte un cuore. Non sono più allegri di te, tutt'altro: c'è chi ha un fischio nella testa, o un dolore che non passa, o un grido che gli urla in testa, una canzone da dimenticare suonandoci sopra migliaia di altre canzoni. C'è gente che balla al volante, e non sono gli autisti peggiori.
Già ai tempi di Hot Fuzz era abbastanza chiaro quanto Edgar Wright fosse affezionato a quei luoghi comuni del cinema d'azione che apparentemente stava parodiando. Come quello di Tarantino il suo è un cinema al cubo, che vive di riferimenti di riferimenti, e della gioia di saperli rimettere in scena. Baby Driver è una variazione d'autore su un tema rigoroso: man mano che la storia va avanti i margini d'azione si restringono, certi snodi della trama sono quasi tappe obbligate e Wright non fa nulla per occultarcele, anzi è come se le sottolineasse (continua su +eventi!)
La svolta probabilmente è una strana scena in un parcheggio, dove un personaggio che non rivedremo più fa un lungo e discorso sulla carne di maiale, che non ha altro senso che farti pensare a certe vecchie messe in scena di Guy Ritchie - forse è una parodia, forse un omaggio (c'è differenza?) È il momento in cui Jamie Foxx, fino a quel momento quasi un cameo, prende in mano il film e apparentemente lo deraglia. Da lì in poi qualcosa si inceppa, ma non è forse quello che succede in tutti i film sulle rapine? C'è un piano perfetto e a un certo punto qualcosa che va storto. Anche Baby, che nella prima mezz'ora sembrava infallibile, di lì a poco non riuscirà più a far partire una macchina. Ci sarà ancora molta azione, e le canzoni continueranno a ritmarla, ma la freschezza iniziale è andata persa e non poteva che finire così. Baby Driver non è un film sulla perdita dell'innocenza - il personaggio di Ansel Elgort rimane immacolato anche quando si macchia di sangue - ma su un altro sintomo della crescita: la fine del senso di onnipotenza. Il musical si interrompe, le macchine non seguono più il groove, tutto crolla e chi ha deciso di seguirti, o in un momento di debolezza, di coprirti, forse ha commesso il suo più grande errore.
Baby Driver ha una trama molto semplice, portata avanti da personaggi la cui biografia si potrebbe scrivere su un tovagliolo. Questo lo aggiungo per chi nei giorni scorsi si è lamentato, per esempio, della scarsa profondità dei personaggi di Dunkirk - allora, forse è meglio rammentare che al cinema le storie durano in media due ore, nelle quali l'approfondimento dei personaggi non è sempre la priorità. Se davvero è quel che vi interessa, forse è meglio se restate a casa e vi leggete un libro - oppure vi sparate una stagione di una serie in venti puntate dove di sicuro ci sarà tanto spazio per approfondire i personaggi, sviscerarli, ribaltarli e ricomporli a piacere - viene il sospetto che chi trova il cinema superficiale, oggi, si stia aspettando qualcosa che al cinema più di tanto non si può trovare. E che da parte sua lo stesso cinema di intrattenimento stia prendendo un'altra direzione - che poi è una banale strategia di sopravvivenza: visto che non si può rivaleggiare con la serialità, si tende all'estremo opposto: alla rapidità, alla stilizzazione. Baby Driver e Dunkirk sono due film diversissimi, ma accomunati dalla volontà esibita di essere oggetti cinematografici. In entrambi i casi la colonna sonora è fondamentale. Nel caso di Baby Driver, Wright mette a frutto la vecchia lezione di Tarantino: se c'è una cosa che piace agli spettatori in sala, è scoprire o riscoprire qualche vecchia canzone. Perché è vero che c'è gente che balla ai semafori: ma anche in sala, quando si spengono le luci. Baby Driver è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:10, 22:40); ai Portici di Fossano (21:15); al Cinemà di Savigliano (20:20, 22:30).
Giù al tappeto negli anni Ottanta
09-09-2017, 03:04Bob Dylan, cinema, concerti, Il Post, musica, OttantaPermalink |
| Il film andò male ai botteghini, secondo gli esperti anche a causa dei baffi di Gregory Peck. "I tuoi baffi ci sono costati milioni", gli avrebbe detto un produttore. |
Mi è venuta in mente questa cosa mentre ridavo un'occhiata a uno dei documenti più penosi che un dylanita possa reperire su Youtube - qualcuno avrà già indovinato. Mettiamola così: qual è l'evento più glorioso nella storia del rock degli anni Ottanta, quello che segna uno spartiacque che è ancora visibile da qui, oggi? Senza dubbio il Live Aid, proprio nel bel mezzo del decennio: estate 1985. È la fine ufficiale del cinismo punk e post-punk; l'apparizione abbastanza improvvisa di una nuova sensibilità più filantropica che politica. I nuovi eroi da palcoscenico non vogliono soltanto vendere dischi ed essere adorati dal pubblico pagante: vogliono essere buoni. Salvare il mondo. Proprio lo sporco mondo che fino a qualche anno fa andava bruciato, improvvisamente nel 1985 diventa cosa sacra e degna di essere salvata. Bob Geldof è il profeta, Bono il Messia, Freddy Mercury il ladrone pentito eccetera eccetera. Ma chi è che fino all'ultimo momento cercò di rovinare la festa? Senza cattiveria, ma con l'intuitiva ostinazione di chi sembra essere nato per mettere a disagio la gente alle cerimonie? Un aiutino: in fondo alla scaletta, nel set di Philadelphia, c'era il grande Bob Dylan.
Anche se forse non se ne rendeva conto. Non era il solo: il ive Aid esplose in maniera abbastanza imprevista. Fino a pochi giorni prima ne parlavano soltanto gli addetti ai lavori e il giorno dopo sui quotidiani era diventato lo show del secolo. Dylan arrivò sul set senza una band, con una vaghissima idea di cosa fosse stato organizzato e perché, in uno dei periodi più confusi della sua carriera; ma invece di fare la cosa più semplice (portarsi una chitarra, un'armonica, suonare la fottuta Blowing in the Wind e buonanotte - magari con Peter, Paul e Mary che si erano riuniti per l'occasione) decise di accollarsi Keith Richards e Ron Wood, in un momento in cui i Rolling Stones sembravano separati in casa: Mick Jagger aveva appena duettato con Tina Turner sullo stesso palco. L'approccio è quello di tre amici che dopo l'ammazzacaffè si fanno prestare le chitarre e strimpellano la prima cosa che gli viene in mente. Il problema è che i tre amici sono Bob-Coscienza-della-Sua-Generazione e i due chitarristi della band più famosa del mondo: a presentarli c'è Jack Nicholson e a guardarli strimpellare il mondo intero. Insomma forse presero la cosa un po' sottogamba. A causa del peso dei loro nomi erano stati inseriti in scaletta verso la fine: non solo il pubblico era esausto, ma dietro le quinte c'era già chi brindava e festeggiava (oppure il coro di USA For Africa che stava facendo le prove: ognuno la racconta diversa e ritiene che gli ubriachi fossero gli altri). Wood e Richards sono abituati a capirsi al volo, ma dovrebbero prima capire cosa vuol fare Dylan, che sta in mezzo, non riesce a sentirsi in spia e rompe addirittura una corda - al che Wood gli presta la sua chitarra e in attesa del rimpiazzo resta sul palco a gesticolare come un ragazzino. Dietro c'è un gran baccano. Blowing in the Wind stavolta è veramente fottuta, chitarre scordate, uno strazio.
 |
| Gregory Peck, negli anni di KO Loaded, faceva Lincoln nella serie TV "Il buio e il grigio" (e com'è ovvio ricordava terribilmente il capitano Achab). |
Dicevo che in quel film Gregory Peck fa il pistolero che non ne può più - attraversa il deserto perché dall'altra parte c'è una donna che amava, addirittura un figlio che non ha mai visto. Tutto quello che vorrebbe è sistemarsi in qualche fattoria. Ma i ragazzini, i ragazzini non lo lasciano in pace. Lo sfidano, si fanno ammazzare, e a quel punto naturalmente salta fuori qualche altro ragazzino che deve vendicare l'amico, il fratello, il cognato: non finisce mai.
La breve apparizione di Dylan al Live Aid si potrebbe anche liquidare così: credeva di essere a una festicciola, si fidava di amici in realtà confusi quasi quanto lui, nessuno gli aveva spiegato che era la vedette finale di un Grande Evento Storico. Insomma un equivoco spiacevole. E però la scaletta suggerisce che non fosse del tutto inconsapevole. Come al solito la cambiò fino all'ultimo momento. Ron Wood racconta che mentre saliva sul palcoscenico lo mandò nel panico proponendo all'improvviso di intonare All I Really Want to Do: una filastrocca che forse i due Stones si erano dimenticati, ma che per Dylan vent'anni prima aveva rappresentato il primo dei tanti disimpegni: quello dal movimento politico. Al Live Aid alla fine Dylan non cantò "voglio solo essere vostro amico", ma la storia di Hollis Brown, il contadino del Midwest che stermina la famiglia e si suicida per la fame. Una scelta non banale e apparentemente appropriata a una sera in cui si raccoglievano fondi per l'Etiopia, senonché al termine Dylan buttò lì che magari un paio di milioni dell'incasso si sarebbero potuti stornare "per pagare l'ipoteca su alcune fattorie che i contadini di qui devono alle banche". Tirava aria di crisi anche nel Midwest rurale: il pubblico della mondovisione magari non ci aveva fatto caso, Dylan sì. Qualche mese dopo Neil Young organizzò addirittura un Farm Aid, che molti considerano direttamente ispirato dalle parole di Dylan: quest'ultimo in quell'occasione si preparò per bene con gli Heartbreakers e fece uno show di ottimo livello. Invece, nella sera in cui si teneva a battesimo il Rock Buono, Dylan arrivò ubriaco come una vecchia rockstar (con una scorta di vecchie rockstar altrettanto ubriache); non urlò "America First!" ma ci andò vicino, e prima di massacrare Blowin' in the Wind inflisse ai due Stones e al pubblico un altro brano del passato remoto, When the Ship Comes In - vi ricordate in quale altra occasione, a dispetto di ogni ragionevolezza, aveva cercato di rovinare una festa con la stessa canzone? La marcia di Washington, esatto. E ora non c'era più Joan Baez a metterci una pezza, ma Ron Wood a fare air guitar. Magari è solo una coincidenza. Ma dopo Washington l'aveva cantata dal vivo soltanto altre due volte; non la tentava da vent'anni e dopo il Live Aid l'avrebbe accantonata per sempre. È un pezzo antipatizzante, che dice che la Salvezza arriva all'improvviso e non fa prigionieri: non è un pranzo di gala né un concertone benefico. Chi ne è degno sarà salvato, gli altri affogheranno. Amen.
E così Gregory Peck attraversava il deserto e arrivava in questa città di compensato - sai quelle cittadine western montate negli studios - e ovviamente la sua vecchia fiamma non voleva parlargli, e il figlio non sapeva chi fosse: e qualcuno aveva un conto in sospeso, o voleva soltanto farsi un nome. Ma forse sarebbe meglio che cominciassi a parlare di Knocked Out Loaded, il disco che Dylan pubblicò un anno dopo il Live Aid, ma che aveva già iniziato a registrare un anno prima, sempre un po' qua e un po' là senza un'idea chiara. Ai tempi pensavo che "knocked out loaded" significasse "carico di knocked out", come un pugile pronto a mandare al tappeto l'avversario: insomma un bel titolo combattivo, ecco un disco che se non state attenti vi prende a pugni! Invece significa l'esatto contrario: allude a un KO ricevuto, si può tradurre "suonato", "al tappeto". Forse non avevo mai fatto caso che verso la fine Dylan canta proprio "I was knocked out and loaded in the naked night". È che forse non ci ero mai arrivato, verso la fine. E dire che è un disco abbastanza breve. È il suo miglior pregio. Stiamo del resto parlando di un disco costruito attorno agli scarti di Empire Burlesque, le canzoni che non era riuscito a terminare in tempo per la scadenza del 1985, integrate con altri esperimenti per lo più infruttuosi del 1986. Siamo insomma al raschio del barile: qualcosa di buono ancora vien su, ma che fatica.
E infatti Gregory Peck, quando alla fine riesce a parlare alla sua ex, cala la maschera e le dice che ha finito con le pistole e i duelli e tutto quanto, e che vuole soltanto sistemarsi. Lei ovviamente è un po' scettica; magari non è la prima volta che lo sente dire: poi nemmeno nei vecchi western in bianco e nero funzionava così, che se dopo dieci anni il pistolero fa un fischio, l'ex ragazza madre è già pronta a perdonargli tutto. Lui se ne rende perfettamente conto, e chiede un anno di tempo. Se tra un anno tornassi, e avessi rigato dritto tutto il tempo, tu me la daresti una possibilità? Capisco che non puoi darmela adesso, e nemmeno promettermela, ma prometti almeno che ci penserai? Messa in questi termini è una proposta che si può dignitosamente accettare - specie se te la propone un pur baffuto Gregory Peck...
Un altro relativo pregio di KO Loaded è la disarmante sincerità. Infidels e Empire erano due dischi carichi di ambizioni, in parte giustificate in parte no. C'erano tentativi di suonare professionale, di suonare sofisticato, di suonare moderno. KO suona soltanto... suonato. È il disco di un tizio che di mestiere vende dischi e fa concerti, e prima di cominciare la stagione dei concerti deve fare uscire un disco: che sia ispirato o no. Voi andate tutti i giorni al lavoro ispirati? Dylan nel 1985/86 quasi mai. Il che non significa che non ci andasse: se uno mette in fila tutte le collaborazioni e le incisioni del periodo scopre che non stava fermo un attimo. Gli USA For Africa, il Live Aid, il Farm Aid, gli Artists United Against Apartheid fondati da "Little" Steven Van Zandt e prodotti da Arthur Baker (Dylan per la verità canta soltanto due versi, ma è stato carino da parte sua partecipare. C'era Miles Davis, i Run DMC, e nel disco c'era anche il primo vero pezzo blues degli U2, Silver and Gold, ma cantato da Bono con due amici d'eccezione tirati a lucido: Keith Richards e Ron Wood!) E poi sessioni con Dave Stewart degli Eurythmics, sessioni con gli Heartbreakers, con Al Kooper e T-Bone Burnett, sessioni con chiunque. A Cameron Crowe che lo intervistava per il libretto di Biograph aveva rivelato, con un certo sprezzo del pericolo, che stava accarezzando l'idea di pubblicare un disco di cover. È un'idea che lo aveva già portato al disastro nel 1970, ma forse chissà, col tempo aveva imparato a concentrarsi anche nel compito di interprete da studio, no?
No (continua sul Post).
A Dunkerque il cinema resiste
06-09-2017, 12:50cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, guerra, memoria del 900Permalink |
| Bon voyage. |
 |
| Nell'ultimo momento c'è chi si tappa le orecchie e chi prende la mira. |
Ogni sconfitta può sembrare una vittoria, se la inquadri nel modo giusto. Il desiderio condiviso, e comprensibile, di salutare in Dunkirk il film dell'anno, è il rovescio di una constatazione amara: non è che ci siano tutti questi capolavori in giro per le sale ultimamente... (continua su +eventi!) Sia Hollywood che il cinema d'autore europeo sembrano navigare a vista, mentre le corazzate della serialità televisiva dilagano nel bacino dei giovani spettatori (quelli che se non si fanno una sensibilità cinematografica adesso, tra cinque anni in sala non verranno più: o al massimo per vedere la maxipuntata di un prodotto seriale come un cinecomic). Dunkirk è, tra le altre cose, un disperato manifesto di vitalità del cinema: non tanto per il feticismo della pellicola 70mm, ma per la sintassi così orgogliosamente antitelevisiva. In questo ricorda un film apparentemente diversissimo, Gravity: si tratta di due film brevi, senza tempi morti, che chiedono allo spettatore una specie di apnea: fai un bel respiro e ci risentiamo tra un'ora e mezza. Nolan ci promette lacrime, sudore e sangue (in realtà pochissimo), ma ci dice che la tv non è invincibile, che il cinema resisterà, perché c'è qualcosa che soltanto il cinema può fare.
 |
| Sangue e nafta |
Aspettando il re, trovando una mamma
30-08-2017, 02:18cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkUn giorno potresti ritrovarti a vivere in una baracca dall'altra parte del mondo.
Un giorno potresti ritrovarti dietro il volante di un'enorme automobile, in una bella casa, con una bella moglie.
Un giorno potresti chiederti: ma come ci sono arrivato?
Certi film - li riconoscevi dalla locandina - servivano soprattutto a viaggiare. Per il pubblico si trattava di un'alternativa low budget a viaggi veri che non si poteva permettere: film-safari con zebre e rinoceronti e selvaggi. Certi film funzionavano così. Aspettando il re sembra voler perpetuare la tradizione, individuando in Tom Hanks l'Homo Occidentalis per eccellenza, in perenne crisi esistenziale ed economica, e calandolo in una delle mete turistiche tuttora più difficili per gli occidentali: l'Arabia Saudita (ricostruita in Egitto). La prima scena dice tutto: unico non-musulmano su un aereo di linea, mentre gli altri pregano il loro Dio Hanks sogna di vivere nel video di Once in a Lifetime, Talking Heads. Lo seguiremo in un albergo, nel fatiscente cantiere di un nuovo polo tecnologico che è ovviamente un luogo di smarrimento metafisico oltre che una metafora delle vacue velleità delle dinastie dei petrodollari. Insieme a lui cercheremo di capire come si può passare anche solo qualche giorno in un Paese in cui in teoria è vietato bere alcool; grazie a lui daremo una sbirciatina alle festicciole delle ambasciate europee e addirittura riusciremo per qualche istante a intrufolarci alla Mecca, città proibita agli infedeli. Non ci capiremo un granché, proprio come succede ai turisti veri, ma alla fine ci sentiremo comunque arricchiti. Non troveremo Dio ma magari l'amore (caccia via), proprio come in quei vecchi film con gli esploratori biondi e le dive un po' esotiche. Quest'ultima cosa magari non era prevista nell'omonimo libro di Dave Eggers, ma evidentemente lo sceneggiatore e regista Tom Tykwer ne sentiva l'esigenza.
 |
| Vogliamo anche ricordare come avevano conciato Tom Hanks in Cloud Atlas. |
La storia del manager in trasferta, oberato dai sensi di colpa per aver collaborato alla delocalizzazione e allo smantellamento del Made in USA, sembrava già un po' datata quando uscì il libro - cinque anni fa: ora, con la disoccupazione statunitense in costante calo, suona sinistramente affine a certe tirate elettorali di Trump. All'angoscia vagamente beckettiana evocata da Eggers, Tykwer sovrappone la sensibilità paranoide che ha mutuato dalle sorelle Wachowski; in un paesaggio che è già surreale di suo, tra deserti e grattacieli, non serve molto per suggerire che il venditore di ologrammi Hanks sia vittima di un gigantesco scherzo, un meta-ologramma. Ma chi si aspetta un finale sconvolgente e rivelatore si prepara a una delusione: a un certo punto è come se sulla sceneggiatura fosse caduto un po' di zucchero, se non un'intera zuccheriera. Tykwer sembra sinceramente preoccupato non soltanto per il suo protagonista stanco e disperato, ma per tutti i cinquantenni che lo hanno seguito per più di un'ora, condividendone ansie e disagi a dire la verità più americani che universali (il college della figlia, status irrinunciabile!)
Alla fine non si tratta più di portare in viaggio gli spettatori, ma di confortarli: quella cisti non è necessariamente un tumore, quell'affanno è più panico che infarto; gli affari possono andare male, non è la fine del mondo: e anche i matrimoni, ma se guardi bene da qualche parte c'è già qualcuno disposto a medicarti e consolarti. È un film che in sostanza smette di guardarsi intorno e comincia a cercare la mamma: ma almeno la trova incarnata nelle forme antihollywoodiane di Sarita Choudhury. Vent'anni fa era la Tara di Kamasutra: oggi ne ha cinquanta, è una bellissima signora e non è affatto difficile capire perché l'uomo-Tom Hanks si senta attratto da lei. Quello che alla fine della visione rimane non spiegato è cosa possa aver trovato lei in un americano spaurito e senza direzione. Nei film di una volta sarebbe stata una domanda inutile: l'uomo bianco era affascinante in quanto bianco. Aspettando il re è al cinema Monviso di Cuneo da giovedì 31 agosto a martedì 5 settembre alle 21.
Charlize Theron pesta Berlino
22-08-2017, 00:37cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, nostalgia, OttantaPermalink |
| Che cast però. |
 |
| Speriamo sia make up. |
L'ufficio stampa ci aveva preventivamente spiegato che la Theron, mentre si allenava a incassare sul set, "vomitava praticamente tutti i giorni", che a un certo punto ha perso un dente. Atomica Bionda è un progetto suo: è stata la sua società di produzione a scegliere la graphic novel, a farla riscrivere su misura (la protagonista del fumetto non era nemmeno bionda), a convincere il secondo regista di John Wick ad abbandonare John Wick 2 per girare un film non così diverso. Atomica Bionda è un film voluto, interpretato e scolpito a mani nude sulla carne viva da Charlize Theron, e la cosa non avrebbe dovuto stupirmi così tanto - se solo riuscissi a liberarmi dalla mia prediletta immagine mentale della Theron, che è ancora quella della bambolona riccioluta che sta con Keanu Reeves all'inizio dell'Avvocato del diavolo; se almeno riuscissi a ricordare che la stessa bambolona, in quello stesso film, si trasformava in qualcosa di totalmente diverso, un corpo già slavato e dolente - allora potrei rendermi conto che Atomica Bionda non è semplicemente il film dell'ennesimo divo/a che passata la soglia dei 40 anni (50 per i maschi) si mette a cercare nei ruoli action una seconda giovinezza: che è anche il punto di arrivo coerente di un'attrice che ha sempre lavorato sul proprio corpo, riempiendolo e svuotandolo, rompendolo e riparandolo (continua su +eventi!)
 |
| Queste cose nei miei anni Ottanta non si vedevano! (maledizione). |
Ignoranti e felici, il film
14-08-2017, 03:05blog, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, film italiani bruttini, internetPermalinkRiuscireste a vivere due mesi senza connessioni internet? Sì, ma sarebbe un po' scomodo. Se non aveste mai usato internet, riuscireste a diventarne dipendenti nel giro di una settimana? È abbastanza improbabile. Ve li immaginate Giallini e Gassman professori di liceo, uno tecnopatico e l'altro entusiasta digitale, che si scambiano i ruoli? Uhm, in realtà no. Ecco, beh, non ci sono riusciti neanche gli sceneggiatori di Beata ignoranza: non esattamente gli ultimi arrivati, eppure.
In questi giorni sulla mia bacheca Facebook non fanno che parlare di Sarahah. Da quel che ho capito si tratta di un social network che ti consente di ricevere e mandare messaggi anonimi agli altri utenti. Lo ripeto perché secondo me è fortissimo: in questi giorni stanno tutti provando un nuovo servizio on line che - straordinaria novità! - ti fa sentire l'ebrezza di ricevere e mandare messaggi anonimi. Sono quelle cose che mi fanno sentire decrepito, perché mi ricordo ancora bene quando tutta internet era così, un posto di anonimi che si mandavano messaggi (l'anno scorso Facebook mi ha sospeso perché il mio secondo nome non gli risultava) (in effetti il mio secondo nome, tra Leonardo e il mio cognome, era Blogspot, e finché non l'ho cancellato non mi ha riaperto l'account, che evidentemente deve combaciare con quello che risulta all'anagrafe, il che è abbastanza inquietante: avrei potuto sbattere la porta e andarmene, ma la verità è che senza il mio account Facebook ormai farei persino fatica a lavorare) (sì, a lavorare a scuola).
 |
| La vignetta più riprodotta del New Yorker è del 1993. Dice: "Su internet, nessuno sa che sei un cane". |
È un film veramente strano. Sembra essere stato masticato, risputato e rimesso nel vassoio da un cameriere impassibile - che purtroppo è Massimiliano Bruno, da cui sembra ovvio aspettarsi di più. Per dire: tutto comincia con una scena in cui Gassman e Giallini litigano in classe - davanti ai loro studenti! che riprendono tutto col cellulare! Dovrebbe essere lo snodo fondamentale, la crisi da cui scaturisce tutta la storia, epperò in quel momento i due attori principali non sono credibili. Si prendono a male parole, ma c'è qualcosa che stona ed è strano, è chiaro che nessuno dei due è Lawrence Olivier, ma qui sono davvero al di sotto dei loro standard professionali. Più tardi scopriremo che l'effetto era voluto: non stanno litigando davvero, bensì stanno rimettendo in scena un loro litigio precedente; cioè stanno recitando nel ruolo di due attori. Ma non sono bravi attori - cioè, no, Giallini e Gassman sono ottimi attori, ma i loro personaggi no, sono due ex filodrammatici, insomma se uno ha la pazienza di aspettare 80 minuti scopre che all'inizio stavano recitando bene il ruolo di chi recita male. Il problema è che al cinema è anche una questione di imprinting: se tu all'inizio vedi dei cani, ci resti male, e la tua voglia di dare una chance al film ne risente.
Da quel litigio parte la scommessa: Gassman deve rinunciare a smartphone e adsl, Giallini deve cominciare a usarli. Ora non importa tanto che lo sforzo degli autori di rendere una sfida del genere credibile porti viceversa il film nel Reame del Più Contorto Inverosimile (la figlia di uno dei due, non è chiaro di quale, fa la regista! e decide di fare un documentario sulla sfida! Appassionante, no?) Il guaio è che appunto il film sembra scritto da qualcuno che si è disintossicato da internet una decina di anni fa e da allora lo guarda un po' da lontano, con sospetto, come i vegani trascinati in un ristorante di pesce. C'è un preside tutto orgoglioso perché il suo liceo è diventato "smart" grazie all'adozione del registro elettronico! Che roba, eh? Peccato che il registro elettronico sia obbligatorio in tutte le scuole pubbliche da un paio d'anni. Ma più in generale: quali sono le cose che facciamo quotidianamente, oggi, grazie a internet? Le prime che mi vengono in mente: usiamo le mappe stradali. Recensiamo qualsiasi cosa. Manteniamo i contatti con gente che avremmo perso di vista da un pezzo. Incontriamo gente che non avremmo mai potuto conoscere, con la quale condividiamo interessi. Possiamo lavorare a Ferragosto, anche se siamo al mare, come sto facendo io. E i giovani, mi dicono, guardano molto più porno (continua su +eventi...)
Giallini non consulta mappe, porno men che meno, non compra né vende né scrive recensioni (si prende solo venti secondi per stroncare Tripadvisor in toto), non riallaccia nessun contatto, non si pone neanche il problema di come usare internet nel suo ambito professionale. Però si mette a giocare con un suo allievo ripetente a uno sparatutto per playstation. Da professore a gamer in punto in bianco... e va bene, le commedie esagerano. Che altro fa? Corteggia una sua collega... con un nick anonimo. Nel 2017. Non so. È come usare la macchina per attraversare la strada. Se non avessi mai usato facebook, qual è la prima cosa che farei? Storicamente, un sacco di gente cercava gli ex compagni del liceo, e poi è restata perché ha trovato vecchi amici e se ne fa di nuovi. Non sarebbe stato più credibile che Giallini si mettesse a cercare vecchie fiamme, o scoprisse anime gemelle a migliaia di chilometri di distanza? Devi usare facebook per scrivere i bigliettini? Qualcuno lo usa ancora così?
Secondo me no, ma forse non ha nemmeno così senso discuterne. Credo che i primi ad aver capito che la premessa non funzionava sono stati gli stessi autori, che probabilmente hanno riprovato a riscriverlo, a ritagliarlo, a rimontarlo, e poi forse c'era una scadenza in ballo e semplicemente hanno lasciato che Giallini e Gassman gigionassero a piacere, in barba a qualsiasi vaga pretesa di verosimiglianza (si odiano da una vita, non si vedono da 25 anni e al primo problema uno ospita l'altro in casa). Il risultato è un film molto più borisiano di Boris - o magari dello stesso genere del film nel film di Boris, Natale con la Casta: ci sono sequenze quasi surreali, a volte anche molto sofisticate, che portano avanti una trama risibile; situazioni drammatiche ai limiti della tragedia e oltre buttate lì come se fossero gag da cartone animato (a un certo punto esplode una casa); siparietti scolastici che in qualsiasi scuola vera provocherebbero ispezioni e licenziamenti (nella scuola di Beata ignoranza è prassi comune schiaffeggiare gli studenti); c'è persino lo spettro di una defunta moglie amante e madre interpretata proprio da Carolina Crescentini, icona di Boris. Ci sono, soprattutto, un paio di caratteristi che si fanno le canne dall'inizio alla fine del film, il che non è affatto inverosimile, anzi, ma assume un senso preciso nel momento in cui ci rendiamo conto che in realtà sono i due personaggi più lucidi: come se il film fosse visto secondo il loro punto di vista e probabilmente è andata davvero così. Probabilmente c'era un'idea interessante che stava evolvendosi in un film inutile, una scadenza importante che cominciava a mettere ansia, qualcuno che aveva parecchia maria in casa e ha iniziato a distribuirne, e così insomma alla fine ne è uscito un film un po' così. Però simpatico. Gli attori sono molto simpatici. Non si capisce nemmeno chi vince la scommessa, cioè si capisce che la scommessa non era così importante, l'importante è voler bene a chi ami anche se non fa sempre figli con te. Inoltre farsi le canne è meglio che andare su facebook, e vabbe', non è il messaggio più reazionario del mondo in fin dei conti. Dai dai dai.
Beata ignoranza si può vedere gratis a Bra il 17 agosto in via Sobrero, alle 21:30, in occasione della Rassegna itinerante di cinema d'autore. Altrimenti il 25 agosto a Limone Piemonte (ore 21:15). Oppure su Youtube a partire da €3,99.
Uno psicanalista a Roma (un altro)
08-08-2017, 18:05cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, ebraismoPermalinkLasciati andare (Woody Allen, 2016)
Elia Venezia (Toni Servillo) è uno psicanalista che ha bisogno di perdere chili. Claudia (Verónica Echegui) è una personal trainer che ha bisogno di mettere ordine nella propria vita, ma che non può evitare di sconvolgere quelle di chi incontra. Se fosse un film, non potrebbero che incrociarsi. Ah, ma è davvero un film! E di Woody Allen! Di nuovo a Roma, stavolta nella magica cornice del Ghetto! Una commedia che è una sarabanda di trovate, dove si riflette ma si ride anche a crepapelle, e finalmente si rivede in forma il Maestro! Magari, in realtà no.
Lasciati andare (Francesco Amato, 2016)
Francesco Amato ha diretto tre film in dieci anni. Il primo (Ma che ci faccio qui!) era la storia fresca, sorprendente, di un ragazzo che scappa da Roma per fare il giro del mondo ma si ferma alla prima spiaggia; il secondo (Cosimo e Nicole) è la storia fresca, sorprendente, di due ragazzi che si incontrano al G8 di Genova e di quel che combinano in seguito. Lasciati andare è il suo terzo film ed è una delle commedie italiane migliori dell'anno. Però non è fresca, né sorprendente.
Francesco Bruni è lo sceneggiatore storico di Calopresti e soprattutto di Paolo Virzì, passato alla regia con Scialla, Noi 4 e Tutto quello che vuoi. Nel 2016 ha scritto, con Francesco Amato e Davide Lantieri, Lasciati andare. È esagerato affermare che da una squadra di autori del genere potevamo aspettarci di più di una commedia che, in effetti, gira che è un piacere ed è divertente il giusto, ma sembra approfittare di qualsiasi luogo comune cinematografico e narrativo che incontri sulla strada? Non bastava trasformare Servillo in un sosia di Freud che consiglia best-seller e ipnotizza i pazienti; bisognava anche affiancargli la pur brava Verónica Echegui nel ruolo della classica Manic Pixie Dream Girl, quel personaggio femminile che esiste soltanto nelle sceneggiature e ha il preciso scopo di dare una scossa al personaggio maschile? E se la scelta di ambientare la storia nel Ghetto era almeno qualcosa di originale, valeva proprio la pena caratterizzare il protagonista come uno spilorcio? Ma in generale: oltre allo psicanalista freudiano-quindi-ebreo-quindi-avaro, abbiamo una personal trainer solare e un po' pazza, e infatti spagnola; un capoverdiano che vende il fumo, un brutto ceffo dal coltello facile e l'accento balcanico, un lombardo carrierista e antipatico (Giacomo di Aldo Giovanni e Giacomo) e... un centravanti un po' scugnizzo e criptogay - questo a ben vedere è un luogo comune invertito, ormai banale quanto il luogo comune normale. L'unica scelta un po' originale è il rapinatore balbuziente di Luca Marinelli, che compare soltanto nel terzo atto e non a caso si porta a casa il film. E tuttavia.
Tuttavia alla fine Lasciati andare è un film divertente; Servillo è in forma (e non è meno macchietta che in altri prodotti più blasonati), la Echegui è davvero in parte, la storia è un po' prevedibile ma funziona. Forse il vero test per una commedia del genere sarebbe quello di Woody Allen: ovvero immaginare che cosa direbbero i critici di un film come Lasciati Andare se lo avesse girato lui. Secondo me sarebbero entusiasti. È vero, psicanalista e pazienti sembrerebbero quelli delle vignette, ma non è sempre stato così con Allen? È vero, più che spiazzare gli spettatori la storia sembra andare incontro alle loro attese, ma non è il tratto tipico di tanti film dell'ultimo Allen? La principale differenza è che Lasciati Andare si sarebbe visto in molte più sale e avrebbe incassato assai di più. Lo si può rivedere comunque a Cherasco venerdì 11 agosto, al cortile di Palazzo Gotti di Salerano (ore 21:30); l'ingresso è gratuito e il regista sarà ospite! Altrimenti venerdì 18 e venerdì 25 agosto alle 21:00 al cinema Sangiacomo di Roburent.
Spiderman è tornato alla Casa
01-08-2017, 14:02cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fumetti, mitiPermalinkSpider-Man: Homecoming (Jon Watts, 2017)
C'era una volta un supereroe così smagliante, così perfetto, che volle sfidare Atena: vediamo chi tesse la storia più avvincente. Invano Atena cercò di ricordargli i precedenti: guarda che chi sfida gli Dei casca malissimo. Eh ma io non casco mai! disse il supereroe, è impossibile! E fu proprio così. Quando vide la sua storia, Atena strabuzzò i suoi larghi occhi: era la migliore mai tessuta, persino le Parche in tanti eoni non avevano mai concepito roba del genere. E tuttavia chi sfida gli Dei va punito: pertanto Atena condannò il supereroe a rivivere quella storia per sempre. Ogni cinque, massimo ogni dieci anni, un narratore o una major cinematografica lo avrebbero fatto ricominciare da zero: di nuovo si sarebbe trovato in quel laboratorio di chimica e sarebbe stato morsicato da un ragno radioattivo, e suo zio sarebbe morto assassinato eccetera eccetera, nei secoli dei secoli dei secoli. Hai scritto la storia migliore? Non te ne libererai mai.
Non è Octopus e non è Venom; non è nessuno dei trentadue goblin. Non è J. J. Jameson (che ci manca tantissimo, torna JJJ). Il peggior nemico dell'Uomo Ragno, da sempre, è sé stesso. No, non il suo clone (ma è indicativo che nessun altro supereroe abbia avuto tanti problemi coi cloni). Proprio sé stesso. Il suo essere, banalmente, il miglior supereroe possibile. Quello che salta tra i grattacieli e schizza ragnatele: non ce n'è uno più spettacolare di lui, né sulla carta né sullo schermo. Se ci fosse lo sapremmo, perché è da mezzo secolo che ci provano. Spidey piace perché è un insetto? Hanno provato con qualsiasi altro insetto. O forse piace perché è un ragazzino? Hanno provato con tanti altri ragazzini. Sarà l'ironia? Abbiamo avuto ondate di supereroi ironici, ma niente da fare. Abbiamo avuto anche un milione di variazioni sul tema: dozzine di Donne Ragno e Uomini Ragno potenziati. Ultimamente va forte uno Spiderman nero - per dire, la gente che si lamenta che Zia May nel film è troppo giovane, li legge i fumetti? Lo sa che nei fumetti esistono Zie May giovani, Spidermen neri, Peter Parker in pensione? Per dire che le hanno provate veramente tutte. Niente.
Non riescono a cambiare nemmeno il costume. Steve Ditko lo inventò nel 1963, e in capo a un anno si era già stancato di disegnarci le ragnatele. Hanno provato a semplificarlo, a renderlo più d'impatto: niente da fare. Alcuni costumi di Spiderman sono diventati dei personaggi a sé, ma Spidey resta rosso e blu. Ormai quando prova a cambiare costume lo sai già, che è solo una finta per far impazzire i lettori.
 |
| The Amazing Spider Man, #1 Annual |
Il peggior nemico di Peter Parker non è Elektro e non è senz'altro l'Avvoltoio, quel poveraccio. Il peggior nemico di Spiderman è il suo successo. Il suo creatore pensava a un supereroe con superproblemi, ma come fai a essere credibile se qualsiasi tua versione va a ruba, il tuo merchandising è una solida certezza, e al cinema vorrebbero farti un film all'anno? Come fai a sembrare fresco come un teenager, dopo cinquant'anni di produzione industriale? Come fai a ripresentarti dopo 15 anni e cinque film e dire, ehi, azzeriamo tutto per la terza volta, sono di nuovo un semplice liceale che scopre di restare attaccato ai muri?
Ma soprattutto: come fa la Marvel a non sbagliare un colpo? A riprendere un eroe oggettivamente un po’ consumato – gli ultimi due episodi Sony non erano andati benissimo – e a ridargli vita come se fosse un concetto appena inventato? Come fa a inserirlo in una saga cinematografica già pesante e sfaccettata come quella degli Avengers, riuscendo però a suggerire forte e chiaro il messaggio che Spiderman sarà sempre un’altra cosa, una cosa un po’ a parte (una dinamica non troppo diversa da quella dello Spidey originale coi Fantastici Quattro)? Ammettiamolo, è un po’ irritante il modo in cui la Marvel sembra sempre arrivare al risultato – e senza darci nemmeno la consolazione di gridare al colpo di genio, perché non c’è niente di geniale in Homecoming: c’è solo il lavoro di squadra di un pool di sceneggiatori che sa fare il suo mestiere e non disprezza il suo pubblico. Uno degli aspetti più appariscenti dell’operazione – il ringiovanimento di Zia May – sembra alla fine più un trucco per attirare un po’ di polemica fine a sé stessa: Marisa Tomei è ovviamente perfetta, ma è dosata con il contagocce. Una trovata brillante è quella di riassumere la puntata precedente (il siparietto di Spidey in Civil War) con la sintassi di Youtube. Nota l’abissale differenza con Suicide Squad e la sua mezz’ora di preambolo in formato trailer: mentre la Warner tratta gli adolescenti come bimbominchia a cui somministrare riassuntini, Homecoming si pone il problema di capire come si raccontano, oggi, i liceali: con quali mezzi, con quali risultati. Perché ogni generazione ha le sue differenze, anche se a una certa distanza non sembrano un po’ granché, se lavori per loro queste differenze sono importanti. La Marvel lo sa, ma non si dimentica nemmeno tutti i quaranta-cinquantenni che continuano imperterriti a entrare al cinema a vedersi i suoi film. Quelli che forse non avevano più voglia di vedere per l’ennesima volta lo zio Ben morire, ma a tante altre cose non saprebbero rinunciare.
E la Marvel gliele dà. C’è una breve scena – quella dell’ascensore – che dà le vertigini per la quantità di riferimenti che contiene in pochi secondi. Quando vediamo l’inesperto Spiderman tentare il salvataggio della sua bella che precipita, non possiamo non pensare a Gwen Stacy. Quando un attimo dopo si trovano tête-à-tête – lui ovviamente in posizione invertita – qualcuno sussurra “baciala” e non possiamo non pensare a Tobey Maguire e Kirsten Dunst. Non sono inutili strizzate d’occhio: la scena è spettacolare e funziona, probabilmente, anche per chi tutti questi precedenti non li conosce; ma chi ha già qualche dimestichezza con Spidey si sentirà più in ansia quando Liz cade; e sta già dicendo “baciala” prima che si senta forte e chiaro. Se Spidey è condannato a rivivere la stessa storia ogni tot anni, noi possiamo ogni volta trovarci a nostro agio e scoprire qualcosa di più, qualcosa di meglio. È questa semplice, banale cosa che alla Marvel hanno capito. Forse perché a cucinare gli stessi personaggi da cinquant’anni ci sono abituati. Homecoming non è un capolavoro – nemmeno ci prova: si ferma di fronte a certi punti fermi quasi con riverenza: costruisce una scena notevole come quella del traghetto che sembra fatta apposta per farti pensare: non sono ancora lo Spiderman di Raimi che salvava quel treno sul binario sospeso e poi veniva salvato dai passeggeri; ma sto crescendo, dammi il tempo di fare i miei disastri e vedrai.
Anche se la trovata migliore del film resta il riscatto dell’Avvoltoio. Michael Keaton trasforma uno dei personaggi più patetici dell’universo Marvel – la tipica invenzione che Stan Lee poteva buttar giù in cinque minuti al gabinetto – un antieroe spaventosamente simpatico, che ha quasi il compito di mettersi tra noi genitori e Spidey: non provateci neanche, dice Keaton, i giorni in cui vi potevate immedesimarvi in un Tobey Maguire sono finiti. Oggi voi somigliate a me. Vi sentite presi a pugni dal sistema e fareste qualsiasi crimine per garantire ai vostri figli un futuro migliore. Keaton non ruba il film al suo eroe – la Marvel è troppo sgamata per commettere un errore del genere – ma è il primo villain della Casa che avremmo voglia di rivedere in un sequel. E se le cose vanno così non dovremo nemmeno aspettare molto. Nel frattempo Spiderman: Homecoming è ancora al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:30, 22:00), al Fiamma di Cuneo (21:10) e al Multilanghe di Dogliani (21:30).
Ultimo treno per il '96
24-07-2017, 15:39cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, drogarsi, nostalgiaPermalinkT2: Trainspotting (Danny Boyle, 2017).
Se stai leggendo questo, è perché circa 20 anni fa hai scelto la vita, dopotutto. Hai scelto un lavoro. Una carriera. La famiglia. Il televisore full hd 42 pollici. Hai scelto la lavatrice, la macchina, lo smartphone e l'apriscatole elettrico. La buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Hai scelto il mutuo a interessi fissi. La prima casa. Gli amici. Già, gli amici.
Magari quando hai sentito che usciva il seguito di Trainspotting ti è venuto voglia di risentirli, gli amici (a parte quello che sta in galera, certo). (E quello che non ti perdona un pacco da vent'anni). (Poi c'è quello che sta morendo, quello che si è trovato la fidanzata bulgara ed è il destino più pericoloso di tutti - a questo punto forse ti era passata la voglia di andare a vedere il seguito di Trainspotting 2).
 |
| Anch'io d'altronde punterei tutto su Anjela Nedyalkova |
Se stai leggendo questo, forse hai anche tu una cameretta dove non torni dagli anni Novanta. Un disco che non oseresti mettere sul piatto - hai paura che ne moriresti. E un po' di voglia di drogarti, ma hai perso tutti i contatti - i cosiddetti amici. E poi lo sai anche tu, che più che voglia di drogarsi è... nostalgia. Quella che ti prende alle spalle, certe volte, davanti a uno scorcio di città o a due foto ingiallite.
Cosa ha riportato insieme Ewan McGregor, Danny Boyle (che per anni non si sono parlati), con lo sceneggiatore John Hodge e l'autore Irvin Welsh (che non ha scritto niente ma fa un cameo)? A parte i soldi, intendo. Anche se i soldi, in effetti, non sono mai stati irrilevanti. Cioè parliamoci chiaro, Trainspotting non era Amici Miei. Le bravate consistevano nel rompere la testa a una ragazza con un bicchiere senza un motivo, il cameratismo serviva a dividere la siringa e si fermava davanti al primo vero mucchio di soldi da dividere. Quindi cosa c'era da rimpiangere? Trainspotting era un film sull'eroina. I personaggi erano esili, intercambiabili, il film non pretendeva di farteli piacere e infatti non ti erano piaciuti; T2 vent'anni dopo li rianima, ma al posto dell'eroina pretende di ravvivarli con la nostalgia. Ma certo.
Chi non ha nostalgia per il 1996? (Continua su +eventi!) Quel momento in cui qualsiasi cosa venisse dalla Gran Bretagna sembrava oro, e con due trucchi da videoclip Boyle sembrava la punta di diamante del cinema giovane mondiale. Ovviamente adesso siamo tutti più sgamati e non ci incanta più, Danny Boyle. Così come i tuoi amici del paese, ora che hai girato la tua parte di mondo, non sei così sicuro di volerli rivedere. C'è stato un momento in cui erano tutto per te: lo yin, lo yang, i punti cardinali. Ma è stato vent'anni fa, cosa ne sapevi in fondo. T2 è un film realizzato senza troppe pretese di verosimiglianza (Begbie evade e nessuno lo va a cercare a casa sua) da un gruppo di persone che non si stimano e che stanno già immaginando dove scapperanno con l'incasso. È un film di truffatori senza truffe - come nel primo episodio, verso la fine i soldi piovono un po' dal cielo (e prendono direzioni inaspettate, ma logiche). È un film molto cinico, ovviamente: ma anche il cinismo che era merce così preziosa nel '96 ormai te lo regalano al discount.
È un film che in mancanza d'altri argomenti si mette a fare il moralista, come se volesse porgerti il conto per tutta la gioiosa amoralità del primo episodio, il che sottopone i personaggi già non troppo spessi a torsioni incomprensibili: Begbie deve diventare un buon padre, ma è anche un assassino; Spud non farebbe male a una mosca ma continua a fottere tutti, e così via. T2 è un film che si atteggia a vecchio duro; che ti guarda di sbieco e ti dice: non sei meglio di me, anche tu non hai avuto più niente di meglio del 1996. Ma si sbaglia: io ho avuto tante cose in seguito e le rimpiango tutte più volentieri di Trainspotting. Un bel lavoro, una carriera, la famiglia, il televisore, eccetera. Non sono neanche andato a vederlo al cinema, figurati. Ma lo fanno giovedì 27 luglio all'Arena di Alba alle 21:45 (e si noleggia già su Youtube a €3,99). Here comes Johnny Yen again...
Il destino è già scritto (ma è comunque un casino)
18-07-2017, 12:33cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink2:22 - Il destino è già scritto (2:22, Paul Currie, 2017).
Quanti aeroplani atterrano e decollano da New York in un giorno? Quanti incidenti avvengono negli incroci di Manhattan? Quanta gente si è sparata alla stazione Grand Central, se non dal vero almeno nei film? Quante stelle esplodono ogni giorno nella galassia? E se dietro tutti questi avvenimenti ci fosse uno schema? Non sarebbe comunque uno schema troppo complicato?
Dylan Boyd (Michiel Huisman) è un controllore di volo al JFK, con la mania dei pattern. Dietro a ogni avvenimento quotidiano ha sempre la sensazione di intravedere un pattern. Non uno schema, non un disegno; la versione doppiata dice proprio così: pattern. Si vede che era intraducibile, boh. Boyd li vede dappertutto. Infatti a un certo punto un suo collega gli ricorda: ehi, lo sai come chiamano quelli che vedono i pattern?
 |
| Grand Central ha già qualcosa di metafisico. |
Al che Boyd sbuffa, cambia argomento, ma l'interrogativo rimane: come si chiamano? Googlando poi a casa ho scoperto che si tratta di Apofenia; che è un'ossessione assai affine alla Pareidolia (questa la conoscevo), e che è tipica di chi è portato a notare le coincidenze ma non a considerarle davvero coincidenze, bensì parte di uno schema, un disegno, insomma un pattern. E dunque, così come ogni buon thriller sin dai tempi di Hitchcock è incentrato su una psicosi; se per dire Babadook era un film sulla depressione post-partum (e in generale sulla sindrome dell'impostore di molte madri), Get Out sull'invidia etnica... 2:22 è un film sull'apofenia. La stessa sindrome che a mezza estate mi fa andare per cinema a cercare qualche film un po' irregolare, qualcosa che mi dia un certo tipo di brivido ma che mi faccia anche pensare, alla Predestination: film che assomiglino a puntate lunghe di Ai confini della realtà: ma ho la sensazione che si stiano facendo sempre più rari. È un peccato, perché io in questo periodo dell'anno ho proprio bisogno di vedere cose del genere. Non so perché, sarà un pattern...
 |
| Lei si chiama Teresa Palmer e spero di rivederla in film più interessanti. |
2:22 è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:30, 22:40), al Fiamma di Cuneo (21:10) e all'Italia di Saluzzo (20:00): sconsigliato a chi ha paura di volare.
Ammazzarsi in Amazzonia (ma di noia)
12-07-2017, 02:44cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkMa mettetevi per una volta anche nei panni dei Guarani. Ve ne state andando a raccogliere qualcosa da mangiare per la vostra famiglia, quando vi imbattete non in un boa di un quintale, non in un ragno gigante, non in un cane a due nasi, ma in qualcosa di peggio: un esploratore europeo. Allora non è una questione di razzismo, davvero, però non è esagerato dire che il più pulito degli esploratori europei come minimo ci ha la rogna. Anche quello che non intende disboscare il quadrante di foresta e venderti al mercato degli schiavi più vicino, anche quello che più che ai soldi pensa all'avventura, alla gloria, a lasciare un nome minuscolo su una carta geografica che fin lì è rimasta bianca, anche lui, diciamolo: puzza.
Hanno quest'abitudine ad andare sempre in giro coperti di tessuti, sudarci dentro e lamentarsi; e con la scusa dei barracuda, non si lavano mai. Nel posto più umido al mondo. Mio cugino una volta ha dato la mano a un esploratore inglese e nel giro di tre anni tutta la loro civiltà si era estinta, oh, sono cose successe davvero. Dunque quando vi ritrovate davanti un esploratore - non importa quanto piccolo, e simpatico, lo so, certi son proprio carini, verrebbe voglia di portarteli a casa e rosicchiarseli con calma - la cosa più sensata da fare sarebbe farli secchi, una freccia al collo e via: è anche una cosa pietosa, più rapida della malaria o del veleno dello scorpione. E però certe volte come fai? Te ne arrivano di talmente buffi, con quei baffi biondi e quei gingilli lucenti. È come prendere a calci un cucciolo.
 |
| A un certo punto si sente anche una nota di flauto. |
A un certo punto del film, il leggendario e sfortunato esploratore Percy Fawcett si ritrova coi suoi fidi compagni su una zattera alla deriva del fiume. È proprio alla deriva. Non sta remando nessuno. Eppure fin qui era stato ripetuto fino alla noia che l'obiettivo di Fawcett era trovare la sorgente di un fiume. Ora io non vorrei millantare tutta queste esperienza di cose amazzoniche, ma per quel che ne so, anche laggiù i fiumi scorrono dalla sorgente alla foce, e quindi insomma, come fa Percy Fawcett a trovare la sorgente - alla fine della stessa scena - senza mai remare controcorrente? Dici vabbe', è solo un blooper, la troupe ha passato mesi in Amazzonia ma forse questa cosa delle correnti non l'ha abbastanza interiorizzata. E però è indicativo di quel che Grey ha capito della foresta. Con le riprese en plein air cercava il realismo, ha ottenuto l'esatto contrario (continua su +eventi!)
 |
| Fawcett ha ispirato film più ispirati, diciamo. |
Similmente a Iñárritu, che con Revenant voleva darci il ritratto epico di un uomo immerso nella natura, e dopo mesi di riprese ad alta quota con la sola luce naturale ci ha soltanto mostrato di non aver capito né cosa ci sia di davvero disumano nella natura, né quali siano i veri limiti dell'uomo (il suo Di Caprio sembra un supereroe perduto nel salvaschermo di un pc aziendale). Grey commette lo stesso errore: disbosca un pezzo di foresta per farci passare la troupe, poi inquadra i suoi attori e li costringe a dare due colpi di machete ai bordi di un sentiero un cui passerebbe un fuoristrada - probabilmente c'è appena passato. Poi appena può fa un omaggio a Herzog - magari gli stessi errori li faceva anche Herzog (non ho voglia di controllare). Ma erano tempi diversi, il cinema di avventura era un genere ancora abbastanza codificato, un certo tasso di ingenuità necessario. Nessuno si lamenta se in un western le pistole a tamburo sono anacronistiche. Nessuno si lamenta se in un buon vecchio filmone di esploratori in technicolor i fiumi vanno a rovescio. Se queste cose tornano di moda - l'anno scorso Tarzan è andato abbastanza bene - perché non profittarne?
 |
| Eh però loro il fiume lo stavano discendendo. |
Alla fine The Lost City of Z non è né un rigoroso resoconto dell'ultimo esploratore romantico, né quel filmone avventuroso che meritava di essere. Quel che è peggio è che Grey sembra esserne accorto già a metà script: il film dura due ore e la seconda sembra non finire mai. Riesce ad addormentarti con una battaglia di trincea; riesce a essere prevedibile mentre descrive i luoghi più sconosciuti della terra. Hunnam ce la mette tutta ma per lui è il secondo flop in un anno (dopo King Arthur): che peccato, che spreco. Civiltà perduta è al Vittoria di Bra (21:00), al Fiamma di Cuneo (21:10) e all'Italia di Saluzzo (21:30).
La mummia contro Tom Cruise
05-07-2017, 03:54cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, invecchiare, mitiPermalink |
| "Tom Cruise, la MUMMIA" (ma solo io ci sento l'ironia?) |
"Salute a te, divino Mapother Quarto".
"Chiamami pure Tom, come butta?"
"Senti, io rappresento l'Universal, sai, quelli che hanno i diritti dei mostri classici".
"Volevate fare un film su di me?"
"...non proprio, no, volevamo fare un film in cui tu affronti un mostro classico".
"Perché, io non sono un mostro classico?"
"N-non ancora".
---
Alex Kurtzman ha detto di aver scelto Sofia Boutella per gli occhi; che non importa quanti effetti e computergrafica ci sarebbe stata intorno: il pubblico l'avrebbe guardata negli occhi. È una cosa molto bella da dire ed è persino un po' vera. La Boutella è una mummia struggente; per quanto crudele, riesce in un qualche modo a farti empatizzare - in pratica, riesce a soggiogarti. Tinta di blu, avvolta in cartapecora, truccata da cadavere, sembra comunque più umana di Thomas Cruise Mapother IV, Tom Cruise per i mortali.
---
"Hai ucciso tuo padre!"
"Sì però lo amavo. Volevo che mi ammirasse".
"Hai ucciso sua moglie... e il bambino!"
"Erano tempi diversi".
(Come fate a riconoscere un vero mostro? A uccidere i bambini sono tutti buoni, ma il vero mostro si giustifica col relativismo culturale).
---
No, adesso, sinceramente: secondo voi come andrà a finire con Tom Cruise? Perché un giorno o l'altro dovrà finire. Come la civiltà. Spero un po' prima. Cioè non ho niente contro Tom Cruise, davvero, grande attore e personaggio - però a un certo punto bisognerà porsi il problema: può invecchiare? Ne è in grado? E noi possiamo accettarlo? Internet dice che ha 55 anni (non mi fido. Se c'è qualcuno che potrebbe davvero mandare in giro un esercito di zombie a levargli gli anni su tutti i siti internet del mondo, costui è Tom Cruise). In questo film interpreta un tizio che potrebbe averne al massimo 35. Al massimo. E mi chiedo: è mai successo? che un attore interpretasse un tizio di 20 anni più giovane? Sì, ovviamente. In un altro film di Tom Cruise. Ma a parte lui? C'è Brad Pitt. Anche Brad Pitt, in Allied, sembrava un po' troppo tirato (che era poi il suo modo di sembrare la cosa più umana di Allied). Però ormai Pitt il massimo che fa è sparare ai nazisti - una cosa che è già un po' old-fashioned di suo; Cruise continua a fare lo stuntman di sé stesso e in questo film, per esempio, ha voluto una scena in cui recita in assenza di gravità. Galleggia in un aereo che precipita. Non è una scena incredibile, se non sai che l'hanno girata veramente in quel modo. Ormai col digitale si può fare di tutto e così non è che ti si cada la mascella, mentre Tom e la Bella in Pericolo rotolano dentro la fusoliera. C'era senz'altro un modo meno pericoloso di girarla, ma a Tom piaceva così. È il suo modo di dirci Sono Immortale?
---
---
Se la civiltà non finisce (e spero proprio di no, non vedo alternative interessanti) a un certo punto gli storici del cinema si troveranno davanti, ci pensate? trecento, quattrocento anni di immaginario sedimentato(continua su +eventi!). Chissà se degneranno di qualche interesse Guerre Stellari, chissà in quanti riterranno interessante scavare sul fondo per cercare tutti i resti del Marvel Cinematic Universe. La Mummia ha più chance. Lo so che sembra intollerabile e ingiusto, ma parliamo di un concetto che al cinema ha già 80 anni; parliamo di Boris Karloff. Di saghe sulla Mummia la Universal ne ha prodotte già tre o quattro e non c'è motivo per cui non debba continuare finché al pubblico continueranno a interessare i cadaveri male imbalsamati nelle tombe egizie, cioè... per sempre. Anche i cross-over non sono questa novità. La Mummia contro Dr Jeckyll? Al cinema queste cose si son sempre fatte. Gli Zombie della Mummia contro Gli Uomini in Nero del Dr Jeckyll? Perché no. Gli Zombie della Mummia contro Tom Cruise? Interessante, diranno i cinefili del futuro. Quando uscì, la Mummia era una specie di archetipo dell'inconscio collettivo, mentre Tom Cruise era ancora considerato un attore in carne e ossa. Secondo alcuni era davvero in carne e ossa; abbiamo persino i video in cui fa gli stunt più pericolosi; ma c'è da dire che nello stesso periodo cominciava ad andare in voga il ringiovanimento digitale dei divi di Hollywood, e quindi è difficile capire quanto ci fosse ancora del vero Tom Cruise in quello che poi è diventato a tutti gli effetti un franchise a sé (nel 2317 al cinema c'è Tom Cruise contro Gozzilla) (Gozzilla è animato da un algoritmo sofisticato che riproduce i passi dell'automa gigante del mitico film del 2287 il quale a sua volta era animato da un software che imitava le mosse dei vecchi pupazzi in stop-motion) (Tom Cruise invece è davvero lui in carne e ossa, anche se nessuno ci crede: da decenni sono tutti convinti che si tratti di un clone-bot e nessuno fa caso ai casi di vergini morsicate sul collo nei dintorni del set).
---
Non dico che valga il biglietto, ma a un certo punto Tom Cruise e Russell Crowe si menano. Per dire quanto ci credeva l'Universal nel progetto.
---
La Mummia somiglia un po' alla Lega degli Uomini Straordinari: prendiamo i vecchi mostri gotici dell'Ottocento e li rimontiamo con le logiche della continuity dei fumetti contemporanei. Purtroppo di Alan Moore ce n'è uno solo (e neanche tutto). Moore è un folle, un visionario, ma è anche uno sceneggiatore di buon senso, ad esempio: ok, mettiamoci pure la continuity contemporanea: ma se sono mostri dell'Ottocento devono restare nell'Ottocento. Il loro fascino sta lì. Il fantastico ha bisogno di un Altrove, di un orizzonte diverso dal nostro per svilupparsi, e l'Ottocento è un Altrove perfetto. Ma Kurtzman la sa lunga. Ti piazza un dottor Jeckyll contemporaneo. Ma se togli l'Ottocento al dottor Jeckyll ti rimane un bipolare qualsiasi - non proprio la persona che dovrebbe dirigere l'Agenzia contro il Male Universale. In effetti basta che il primo arrivato gli levi la siringona di mano e patatrac, tutto a carte e quarantotto.
---
A proposito di Guerre Stellari: la lavorazione del prequel sul giovane Han Solo ha riaperto il dibattito: ma esiste un giovane erede di Harrison Ford? Uno che potrebbe mangiarsi la scena sia in un'astronave-cargo, sia in un tempio maledetto, un figlio di buona donna col grilletto facile e la battuta pronta? Io! (sussurra la Creatura nella cripta). Io sono l'Erede di Harrison Ford! Datemi un frustino, mortali, e tremate!
---
La Mummia somiglia ovviamente ai cinefumetti, che invece ambientano il fantastico in un setting contemporaneo (tranne alcune eccezioni suggestive, come Wonder Woman). Questo spesso causa corti circuiti interessanti: ad esempio è sempre più difficile commettere disastri nei cinefumetti. Prendi un grattacielo: hai presente quanti grattacieli finti cascavano nei vecchi film di mostri? Ordinaria amministrazione. Il pubblico andava in sollucchero, non è che si mettessero a pensare a tutte le vittime - tanto si sa che è un grattacielo di cartone. Ma il grattacielo del cinefumetto contemporaneo sembra un grattacielo vero. Non è solo una questione di effetti speciali; è che i cinefumetti spingono sul realismo, vogliono stupirti portando uomini incredibili nel nostro mondo - ma nel mostro mondo se casca un grattacielo ci sono migliaia di vittime, è una cosa orribile. La Mummia ha rinunciato alla confortevole ambientazione ottocentesca per ottenere gli stessi effetti di un cinecomic, ma il risultato è che abbiamo un primo atto in cui l'Iraq odierno viene descritto come un allegro far west dove se i pistoleri locali esagerano nell'assediarti puoi sempre chiedere un intervento aereo. Poi arriviamo a Londra, dove per fortuna c'è un po' di bruma e, i grattacieli e... non ce ne frega niente. Sul serio. C'è una tempesta di sabbia davvero ben congegnata e assolutamente scenografica, ma non ti viene nemmeno per un attimo il pensiero per i poveri londinesi soffocati. È una Londra completamente finta, minacciata da un Male che non riesci a prendere sul serio nemmeno per un istante. La Mummia somiglia anche a un altro sfortunato blackbuster estivo di qualche anno fa, War World Z: in entrambi i film si registra il tentativo di ripulire un po' gli zombie, di renderli meno spaventosi, più pop, meno vietati ai minori. Forse quelli della Mummia sono un filo più paurosi di quelli di WWZ, ma la vera differenza sta nell'angoscia. Per quanto ripulito dal sangue e dalle cervella, WWZ restava un film apocalittico, eccessivamente cupo per le famiglie in cerca di aria condizionata (il finale fu modificato proprio per questo motivo). Nella Mummia tutta questa angoscia manca completamente. Il dark universe comincia ben poco dark.
---
La Mummia somiglia un po' a Suicide Squad, un film che brucia le tappe, che ha fretta di buttare sul fuoco più storie possibile, magari già intrecciate. Per cui ok, qui abbiamo la Mummia, gli zombie, il dottor Jeckyll e... non posso dire che altro. Non era meglio andare per gradi; dedicare alle origini di ogni mostro un film? Eh, ma ci avevano già provato (Dracula Untold) e non è andata bene. E così beccatevi la macedonia, pubblico estivo. Qualcosa di buono c'è, ma anche molti scarti che non ti saresti mangiato mai, toh, se lo fa la Warner perché la Universal non dovrebbe permetterselo?
---
La Mummia è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo, alle 20:20 e 22:40.
Wonder Woman nel Paese dei Mansplainers
26-06-2017, 12:06cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, essere donna oggi, fumetti, mitiPermalinkOltre il grande mare, figlia mia, vivono i Maschi. Un giorno li incontrerai. Da cosa li riconoscerai? Dalla barba, se va ancora di moda; da come si sbracano sui sedili dei mezzi pubblici - ma molto più probabilmente da come ti interromperanno mentre parli. Ti giuro. Non è una leggenda: magari stai raccontando la tua ultima battaglia, e loro, senza aspettare che tu finisca la frase, cominciano a spiegarti che le cose sono molto più complesse di quel che credevi; che non è tutto bianco o nero; pensa, esiste anche il grigio!; che certe volte un male è un bene, un armistizio serve a prolungare la guerra e un'arma chimica può servire a fare la pace. Figlia mia, il giorno che li incontrerai, tu magari ascoltali.
Poi menali tutti - neri, bianchi, grigi - non importa. Dagliene tante, figlia mia. Anche se non sai il perché: loro senz'altro lo sanno. Magari - se sopravvivono - te lo spiegheranno.
Il 2017 è un anno storico per l'uguaglianza di generi ed etnie al cinema. Dopo tanti cinecomics, finalmente ne abbiamo avuto uno al femminile, Wonder Woman - e in breve la Marvel ci darà il suo primo film concentrato su un supereroe nero, Black Panther! Non è incredibile, però, che ci sia voluto tanto? Mentre tutto intorno il nostro immaginario si faceva sempre più multicolore e multigenere; mentre i cast dei film d'azione riservavano sempre più posti alle minoranze, e sempre più spesso il ruolo della protagonista a una donna, non è curioso che i cinecomics siano arrivati a un risultato del genere così lentamente?
 |
| È incredibile come facesse ridere già dal poster (quelle orecchie, dio), |
Non è incredibile e non è nemmeno così vero, visto che 13 anni prima di Panther e Wonder Woman, Halle Berry era già Catwoman in un film che nessuno ricorda volentieri; soprattutto a casa Warner. E può darsi che quel flop, neanche il primo (Elektra, Supergirl) sia in un qualche modo responsabile del ritardo con cui la principessa amazzone arriva sul grande schermo: buona ultima dopo personaggi molto meno iconici e meno popolari (Ant-Man...), in un momento di iper-inflazione del genere a cui sempre più gli studios reagiscono proponendo personaggi collaterali e bizzarri: il supereroe che dice le parolacce, i supercattivi tuttitatuati, i procioni parlanti. Ecco il primo cinecomic al femminile arriva nell'anno del secondo film su un procione parlante. Furries 2 - Femministe 1, palla al centro.
La cosa sarebbe molto meno rilevante di quel che sembra, visto che grazie al cielo al cinema non ci sono soltanto supereroi, e nemmeno quel segmento molto chiassoso, cialtrone e culturalmente rilevante che sono i film d'azione. Prendi una qualsiasi saga young adult, da Hunger Games in poi; prendi Jennifer Lawrence, prendi Charlize Theron in Mad Max 4. Prendi Scarlett Johansson, a cui la Marvel non ha voluto dedicare un film solista, forse perché sarebbe costato troppo, e nel frattempo è diventata protagonista di una saga giapponese e di una francese. Prendi Angelina Jolie e Milla Jovovich che nel 2004 (13 anni fa!) mentre Gal Gadot diventava Miss Israele ed entrava nell'esercito, erano già protagoniste di saghe sparatutto. Persino in Fast and Furious le donne sono sempre più rilevanti: persino nei Transformers. Eppure c'è davvero chi ha aspettato il 2017, e l'arrivo di Wonder Woman, per festeggiare un traguardo nelle pari opportunità. Non è solo la storia a rendere omaggio alla bella semplicità dei tempi andati (c'è un'eroina buona ma ingenua che deve sconfiggere un cattivo astuto): anche il dibattito critico sembra arrivare da un tempo lontano in cui poteva sembrare incredibile che una donna prendesse al lazo i nemici anziché rammendar loro i calzini.
A questo punto però devo rammentare che sono un maschio eterosessuale, e forse la mia posizione non mi permette di capire che enorme salto in avanti sia, un film su Wonder Woman, per tutte le ragazze e bambine del mondo: soprattutto nei mercati emergenti, dove forse la Jolie e la Jovovich non sono arrivate così presto e così bene. Forse tutto quello che ho scritto fin qui è un lungo e ponderato mansplaining. Forse.
Ma anche in quel caso che altro posso fare, a parte recitare fino in fondo la mia parte di noioso maschio che spiega l'ovvio? Per me parlare di femminismo per questo film è fare un torto sia al femminismo sia al film. Quest'ultimo è divertente: probabilmente il migliore prodotto fin qui dall'universo cinematico Warner - dopo due mostri senza capo né coda né senso come BvS e Suicide Squad. È una storia dedicata all'origine di un singolo eroe, e per quanto la formula sia inflazionata è comunque più fresca dei polpettoni a più personaggi che la Warner ci doveva assolutamente propinare.
C'è una periodizzazione un po' più originale del solito (la Prima Guerra Mondiale, in tutto il suo orrore che a un secolo di distanza sembra ancora fantascienza apocalittica); c'è un prologo mitologico un po' kitsch ma che si riscatta con una delle cose più assurde e divertenti che ho mai visto sul grande schermo: Robin Wright che guida un assalto di amazzoni a cavallo contro delle truppe di sbarco tedesche.
 |
| La profezia si sta realizzando. |
L'amore illegale
19-06-2017, 10:14cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, famiglie, razzismiPermalink Loving (Jeff Nichols, 2016)
Loving (Jeff Nichols, 2016)Hai 18 anni, e quando sei rimasta incinta, il tuo ragazzo ha solo detto: Ok. È un uomo di poche parole, un muratore, ma "ok" è una parola bellissima. Poi è andato a comprare il terreno per costruirti una casa. Per sposarti ti ha portato fuori dallo Stato perché, dice, la burocrazia è più semplice. Nella camera dove a volte dormite assieme ha appeso il certificato di matrimonio; è una cosa carina.
 Una notte, mentre dormite, qualcuno vi entra in casa con le torce. C'è anche lo sceriffo. Vi ammanettano. Tuo marito indica il certificato - ecco perché l'ha appeso, allora - lo sceriffo scuote la testa e dice che quel pezzo di carta non vale niente, e che voi due dormendo assieme state commettendo un reato. Perché tu sei nera, lui è bianco, e questo è lo Stato della Virginia. Siccome dormite assieme, vi condannano a cinque anni di prigione (se vi avessero colto durante un atto sessuale, il reato e la pena sarebbero stati più gravi); vi rilasciano a condizione che non torniate più in Virginia per 25 anni. È il 1958 e il matrimonio interrazziale diventerà legale in tutti gli Stati Uniti soltanto tra nove anni. Grazie a voi. Mildred e Richard Loving.
Una notte, mentre dormite, qualcuno vi entra in casa con le torce. C'è anche lo sceriffo. Vi ammanettano. Tuo marito indica il certificato - ecco perché l'ha appeso, allora - lo sceriffo scuote la testa e dice che quel pezzo di carta non vale niente, e che voi due dormendo assieme state commettendo un reato. Perché tu sei nera, lui è bianco, e questo è lo Stato della Virginia. Siccome dormite assieme, vi condannano a cinque anni di prigione (se vi avessero colto durante un atto sessuale, il reato e la pena sarebbero stati più gravi); vi rilasciano a condizione che non torniate più in Virginia per 25 anni. È il 1958 e il matrimonio interrazziale diventerà legale in tutti gli Stati Uniti soltanto tra nove anni. Grazie a voi. Mildred e Richard Loving.La storia della coppia che ha cambiato la Costituzione degli Stati Uniti si meritava un film che non fosse un semplice temino edificante di educazione civica. Jeff Nichols, che fin qua aveva girato solo thriller angosciosi, psicologici o apocalittici, gioca la carta dell'iperrealismo, girando in 35 mm. e curando alla perfezione ogni dettaglio, dagli oggetti di scena alla pronuncia degli attori, affidandosi soprattutto a questi ultimi. Ruth Negga e Joel Edgerton danno vita a due protagonisti straordinariamente credibili, malgrado gli esigui margini di manovra: i Loving parlavano poco, e non amavano esibire i loro sentimenti. In particolare Edgerton riesce a nascondere sotto un ceffo da galera un personaggio mite e glorioso, uno che in due ore di film (e di prepotenze subite) avrebbe tutto il diritto di commettere una o due cazzate, e invece continua a ingoiare rospi fino a una vittoria che è così tanto più grande di lui che quasi non gli interessa (continua su +eventi!) Nel suo vocabolario di cento parole c'è spazio per frasi potentissime: quando lo arrestano, lo rilasciano e gli impediscono di pagare la cauzione per la moglie incinta: "Questo non può essere giusto". Quando l'avvocato gli spiega che lo Stato di Virginia ha intenzione di difendersi presso la Corte Suprema: "Come possono difendersi da quello che mi hanno fatto?" E quando sempre l'avvocato gli chiede se ha qualcosa da dire alla Corte Suprema: "Dica che amo mia moglie".
 |
| I tentativi di imbruttire Ruth Negga si sono rivelati abbastanza vani. |
Loving si rivede solo martedì 20 giugno, al Cinema Italia di Saluzzo (ore 17:00 e 21:15).
D'amore e d'ombra
12-06-2017, 23:35cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, ebraismo, Israele-PalestinaPermalinkQuand'ero piccolo, da grande volevo diventare un libro. Non uno scrittore, un libro: perché le persone le si può uccidere come formiche. Anche uno scrittore, non è difficile ucciderlo. Mentre un libro, quand'anche lo si distrugga con metodo, è probabile che un esemplare comunque si salvi e preservi la sua vita di scaffale, una vita eterna, muta, su un ripiano dimenticato in qualche sperduta biblioteca a Reykjavik, Valladolid, Vancouver...
Nel cinquantenario della guerra dei Sei Giorni, nelle sale italiane si celebra una specie di mini-festival israeliano, tutto al femminile: oltre a Un appuntamento per la sposa di Rama Burshtein (presentato a Venezia lo scorso settembre) è saltato fuori A Tale of Love and Darkness, girato e recitato in ebraico da Natalie Portman che era a Cannes due anni fa (e poi naturalmente c'è Gal Gadot, riservista dell'esercito israeliano, che fa Wonder Woman, e pare che sia molto brava). Dei tre film Love and Darkness è il più ambizioso: trasformare in cinema la monumentale autobiografia di Amos Oz richiedeva una dose di incoscienza che Natalie Portman fortunatamente ha conservato per dieci anni di lavorazione.
Come dimostrazione di serietà e perizia dietro la macchina da presa, A Tale of Love è sorprendente, forse anche troppo manierato: luci, ricostruzioni di esterni, montaggio, non puoi dirle niente. La Portman sa persino dirigere i bambini! (non solo il protagonista: c'è una ragazzina che sta in scena cinque minuti e riesce a comunicare con gli sguardi più di molti attori professionisti). Come trasposizione cinematografica, il film deve fare scelte inevitabili e in certi casi interessanti (ad esempio lo sfondo politico della storia è riassunto dalle chiacchiere dei passanti o dei passeggeri di un autobus, tra cui già onnipresenti nel 1948 i fanatici del complotto). Soprattutto la Portman sembra essere riuscita a cogliere un nucleo cinematografico in un libro disperatamente libresco, così concentrato sulla magia e sulla dannazione delle parole, sul fascino dei libri e sul desiderio degli uomini di partorirli e trasformarsi in loro. Di solito tutta questa letterarietà a Hollywood si risolve mettendo in scena tanti libri, possibilmente polverosi. La Portman non si sottrae, ma ti piazza ogni tanto qualche correlativo oggettivo di precisione spaventosa: l'utopia sionista di "far fiorire il deserto" trasformata in un orticello di cortile che non attecchisce, o il momento in cui il padre annuncia commosso al figlio: ora che è nato lo Stato di Israele nessuno farà più il prepotente con lui a scuola! e in capo a cinque minuti, ovviamente, il piccolo Amos deve cedere la merenda ai bulli (però israeliani).
Purtroppo il film ha un problema di ritmo (continua su +eventi!). In novanta minuti succedono parecchie cose, eppure sembra che non succeda quasi niente. Il disincanto che Amos Oz può permettersi, dopo aver partecipato alla guerra e alla stagione dei kibbutz, nelle mani volonterose ma affannate della Portman si trasforma in un pessimismo fin troppo cupo. Proprio quando ti aspetti che gli eventi precipitino (dalla dichiarazione d'indipendenza in poi) e la Storia irrompa sulla scena, la Portman decide di liquidare i combattimenti in un paio di scene e boati fuori campo, e concentrarsi sulla vicenda della madre: ovvero sul ruolo interpretato da lei stessa, ancora una volta nei panni di una depressa cronica.
Il problema è che i depressi sono i malati meno cinegenici al mondo. Piangono, prendono pillole, si scusano, prendono altre pillole, un po' d'euforia poi il crollo, altre pillole, chi non c'è passato difficilmente riesce a provare empatia. La voce narrante interverrà a collegare il crollo di Fania con l'inevitabile disillusione storica legata alla nascita di Israele: ogni sogno realizzato è un sogno deludente, voleva spiegarci Oz, e Israele non è più un sogno. Forse lo avremmo capito anche senza la didascalia, ma che fatica arrivarci. Alla fine anche questo film è un buon correlato oggettivo: un sogno cullato per lunghi anni, realizzato con grande fatica e serietà, che alla fine della visione lascia ammirati ma un po' freddi, stanchi: e i soldi del budget (perlopiù americani) non sono ancora stati recuperati. Come in altri film importanti prodotti in Israele (Kippur, Va' e vedrai), i palestinesi sono quasi del tutto assenti: compaiono soltanto in un paio di scene. Come se anche la Portman, per rispettarli e riconoscere i loro diritti, avesse bisogno di tenerli a una prudente distanza: quella distanza che a Gerusalemme forse non c'è mai stata. Sognare è vivere (un titolo italiano più sbagliato del solito, per un film che racconta la fatica di sopravvivere ai sogni) fino a mercoledì è all'Impero di Bra (20:20, 22:30) e ai Portici di Fossano (21:15).
C'è un giudice a Sana'a
07-06-2017, 02:52cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, essere donna oggi, IslamPermalinkUna bambina di dieci anni entra in un taxi. Chiede al conducente di portarla da un giudice. Quale giudice? La bambina non ne ha idea. Il giudice. Ce ne sarà almeno uno a Sana'a, Yemen. La bambina non può dirlo al tassista, ma sta andando a chiedere il divorzio.
La sposa bambina è il primo film di Khadija al-Salami, regista yemenita nata nel 1966 e data in sposa dalla sua famiglia nel 1977; ripetutamente violentata dal marito, riuscì a separarsene e alla fine vinse una borsa di studio negli USA. Trent'anni dopo, in Yemen ci sono ancora spose bambine: tra queste Nojoom Ali è diventata suo malgrado famosa in tutto il mondo per essere riuscita a divorziare a dieci anni. I Am Nojoom, Age 10 and Divorced è la storia agghiacciante del suo matrimonio, descritto da Nojoom stessa e dalla giornalista francese Delphine Minoui nel libro omonimo. La regista si trova insomma di fronte a una storia vera, tragica, necessaria, che è anche molto simile alla storia della sua vita: è un'occasione unica e non la spreca.
La sposa bambina è un film talvolta ingenuo, ma tutt'altro che banale... (continua su +eventi!) Paga senz'altro la scelta coraggiosa di girarlo completamente in Yemen - uno dei paesi più cinegenici del mondo - e di non lesinare in quanto a esterni. Sana'a è una metropoli infida e polverosa; le montagne terrazzate un mondo a parte dove ogni pietra, se spostata, può originare una disgrazia. Una gestione originale dei piani temporali scongiura il rischio (altissimo) di trasformare una storia tanto potente in una semplice didascalia: per quanto la distanza tra buoni e cattivi non possa che essere enorme e chiara sin da subito, il film riesce ugualmente a spiegarci che le cose sono più complesse di quel che sembrano, e addirittura si permette di dosare un po' di suspense. Allo stesso tempo, La sposa bambina è un film che non si vergogna di volerci indignare e commuovere con tutti i mezzi che ha - e il più potente forse è il volto così disarmante della sua protagonista, Reham Mohammed: una bambina qualsiasi che potremmo aver incrociato su qualsiasi marciapiede, anche davanti a casa nostra.
Femministe e islamofobi potrebbero restare delusi da un film sulla carta così promettente: ci sono donne che partecipano attivamente al meccanismo della violenza, e giudici apparentemente illuminati che però ci tengono a far notare che stanno semplicemente applicando i dettami della Sharia. La cosa più curiosa è il rilievo modesto dato ai personaggi positivi, un giudice tranquillissimo che non alza mai la voce nemmeno di fronte all'ingiustizia più palese, e un'avvocata esperta di diritti civili che dice dieci parole in tutto il dibattimento (gli imputati non riescono nemmeno a capire chi sia, e perché non si faccia i fatti suoi). Come se la giustizia non avesse poi bisogno di tutte queste parole o lacrime per affermarsi. Il film termina con una nota di speranza che purtroppo la cronaca si è incaricata di deludere: la guerra in Yemen ha di fatto bloccato l'approvazione di una legge che proibisca le nozze tra minorenni; coi soldi dell'autobiografia della figlia, il vero papà di Nojoom si è comprato altre spose.
La sposa bambina è all'Aurora di Savigliano mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, sempre alle ore 21:00.
L'uomo che si spogliò per rivestirci
30-05-2017, 03:02cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, internet, privacyPermalinkQuando dopo un quarto d'ora di film improvvisamente compare - sulla poltrona di quell'anonima stanza d'albergo che abbandonerà soltanto negli ultimi minuti - non possiamo che identificarlo: a distanza di appena tre anni il suo volto è diventato un'icona inconfondibile. Ma questo Edward Snowden ancora non lo sa. Su quella poltrona, è ancora semplicemente Citizenfour: un tizio affabile, dalle idee chiare e dalla parlantina sciolta che ha appena disertato, tradendo la fiducia del suo Paese e del suo datore di lavoro. Sa che non tornerà mai più a casa. Sospetta che verrà arrestato e rinchiuso a tempo indeterminato, come Chelsea Manning. Ci parleresti di te?, gli chiede Glenn Greenwald. Snowden all'inizio nicchia: non vorrebbe attirare l'attenzione su sé stesso. Quel che importa davvero è nei file, e nell'enorme significato che quell'enorme raccolta di dati sensibili ha per tutti i cittadini del mondo. Bisognerebbe parlare di questo. Ma la Poitras continua a stringere l'obiettivo su di lui.
Citizenfour è un documento e un paradosso: la regista invitata a documentare l'eroico atto di ribellione di uno dei più grandi paladini della privacy, per fare bene il suo lavoro non può che lederne la privacy. È lo stesso Greenwald, in una scena successiva, a difendere l'approccio: solo la trasparenza assoluta può togliere argomenti a chi accuserà Snowden di spionaggio, di complotti, di intelligenza col nemico. Dichiarare subito il nome, il cognome, raccontare la storia, spiegare le motivazioni: Snowden non vorrebbe, ma da semplice tramite di informazioni preziose deve trasformarsi in contenuto. Può essersi giocato la carriera e la libertà per difendere la nostra privacy, ma la sua è finita per sempre. La Poitras lo mostra a letto, in bagno, lo spia mentre si veste; documenta gli istanti esatti in cui il mondo si accorge di lui, attraverso i telegiornali che lo stesso Snowden ispeziona dal televisore di quell'anonima stanza d'albergo che è diventata da un momento all'altro il luogo più caldo al mondo. Nessun documentario su un divo musicale o televisivo è mai stato così vicino al suo soggetto nel momento in cui dall'anonimato viene assunto nell'empireo dei personaggi globali, quelli il cui volto viene proiettato sugli schermi dei grattacieli (continua su +eventi!)
Tutto questo succede unicamente perché lui l'ha voluto: e mentre succede Snowden è nervoso, rassegnato, stanco, perplesso, spaventato, euforico. Comunica meglio dei giornalisti che lo intervistano, sembra aver passato la vita al microfono più che davanti a un terminale: quasi più sciolto di Gordon-Levitt che lo interpretava nel film di Oliver Stone. Aveva previsto tutto, tranne forse che gli sospendessero il mutuo sulla casa. Snowden conserva ricordi (idealizzati) di un tempo in cui la Rete era libera davvero, i bambini anonimi dialogavano con gli scienziati e a nessuno veniva in mente di autocensurarsi mentre usava un motore di ricerca. Per regalarci una speranza di riottenere quell'innocenza, quell'anonimato, Snowden deve spogliarsi davanti alla Poitras (la quale invece esclude la sua immagine dal quadro). L'ultima scena, in cui da una ripresa esterna si intravede l'immagine sgranata della sua compagna che lo ha finalmente raggiunto a Mosca, e sta assaggiando la pasta in cucina, è voyerismo puro, temo inconsapevole: Citizenfour, la storia di come la privacy di ognuno di noi sia a rischio, finisce con una ripresa da paparazzo. Citizenfour si rivede a Bra mercoledì 31 maggio in occasione della rassegna Cinema e valori 2017.
Pat Dylan e Bobby the Kid
26-05-2017, 19:35Americana, Bob Dylan, cinema, Il Post, musicaPermalinklo sceriffo è già sulla tua pista.
I bounty killer ti hanno sulla lista.
Non gli gusta la tua libertà.
È un film imbottito di scene madri, ma la più famosa non è stata girata: nel buio della sala di proiezione, mentre guarda i giornalieri, il grande Sam Peckinpah, (ubriaco, una pistola carica in tasca), si rende conto che una lente è difettosa, che il lavoro di un'altra giornata va sbattuto via. Furioso, si alza, si sbottona e lascia sul telo dello schermo il suo segno - una "S" di urina. Dietro di lui, Bob Dylan si volta verso Kris Kristofferson: non dice niente, ma quello sguardo Kristofferson non lo dimentica più. Kris, ma in che pasticcio mi hai portato?
Passi notti intere, giù in Berenda,
a smazzare carte in un'hacienda,
finché trovi uno che ti stenda,
Billy, se hai bisogno, sono qua.
Un pasticcio che non si sarebbe perso per niente al mondo. Un film sul più famoso fuorilegge del west. Girato dal regista del Mucchio Selvaggio. Nei panni del protagonista l'amico Kristofferson, quel bel cantante country che qualche anno prima aveva retto i bonghi durante la registrazione di Lay Lady Lay. Talmente ghiotta era l'occasione di recitare e scrivere una colonna sonora western, che Dylan, per una volta nella sua vita, si presentò coi compiti fatti. Peckinpah, per dirla con Kristofferson, "non s'intendeva molto di musica", insomma non aveva la minima idea di chi fosse quel trentenne ricciolino che Kristofferson gli stava presentando. Ma il tizio aveva già Billy in canna. Gliela fece sentire. Scritturato. A Billy non si resiste.

Fai la festa a qualche señorita,
nell'ombra di una camera ti invita,
nel buio solitario lei ti guida...
Billy, a casa non ci torni più.
Voi fischiettate ogni tanto? Se vi capita, e se amate Dylan, ci siamo già capiti. Billy è l'abc, il pezzo dylaniano più fischiettabile. Si può andare avanti per giorni interi, e per milioni di variazioni sullo stesso tema triste. "Billy, you're so far away from home". Che ti è successo, Billy? Quale ingiustizia, quale imprudenza, ti ha portato così lontano? Quando i redattori di Mojo stilarono la classifica delle cento canzoni di Dylan, si scordarono di Billy. Sarà gente che non fischietta. Forse è un dono di natura, c'è chi ci nasce e c'è chi per capire Dylan è costretto a cercare barlumi di genio in dozzine di dischi opachi, quando basterebbe saper fischiettare Billy. Una delle melodie più semplici che abbia usato: una di quelle canzoni per cui vale la pena citare Robertson a proposito delle canzoni della Cantina: "non si capiva se fossero sue o no".
Nessuno, che io sappia, contesta a Dylan la paternità della melodia di Billy. Allo stesso tempo, è così basica che sarebbe veramente strano se l'avesse scoperta proprio lui. La incide in tre versioni diverse, come se non sapesse come riempire il disco (e invece parecchio materiale restò fuori). La maneggia come se fosse un interprete, anzi tre interpreti diversi: come se non fosse sua, ma un brano tradizionale che si può leggere in tanti modi e stravolgere a piacere. Come se la stesse cercando, per tentativi: è in cerca di Billy, come in Self Portrait era in cerca di Little Sadie. Se quel disco era l'autoritratto di un cantautore attraverso cover di altri artisti, Pat Garrett è il disco meno personale di Dylan (il primo che non ha la sua faccia in copertina), malgrado non ci sia una nota, una sola parola che non abbia scritto lui.
C'è chi prende mira dietro a specchi,
fori di pallottola sui tetti,
se non muori presto o tardi, invecchi:
Billy, sei rimasto solo tu.
Oggi Billy sembra fatta apposta per un western - il tema ideale qualsiasi panoramica in cui su un tramonto si stagli il profilo di un cowboy dal destino segnato - ma è un errore di prospettiva: prima di Billy le canzoni del film western erano diverse. Le scrivevano i migliori compositori sul mercato. Liberty Valance è di Bacharach (ha anche scritto Rain Keeps Falling On My Head per Butch Cassidy, ma non credo che si possa considerare un brano western). Ci mettevano un sacco di stilemi riconoscibili a colpo sicuro - chitarre country, violini, voci virili, qualche messicanismo - e ritornelli orecchiabili. Dylan i violini ce li ha, di chitarre quante ne vuoi (c'è Roger McGuinn alla 12corde, è la prima volta che incidono assieme); per la voce virile può fare un tentativo, ma Billy è tutta un'altra idea del west. Più elegiaca, più minimale. Può piacere o non piacere, ma finalmente è un'idea - da quand'è che non gliene veniva una?
Billy è il punto di arrivo di un sentiero accidentato che partiva dal 1967, dalla Cantina e da John Wesley Harding - un percorso ascetico, a ben vedere. Via il ritornello, via gli orpelli inutili: un tema solo, insistente come il blues, e in grado di sopportare centinaia di strofe. Quel tipo di ballate che secondo lui una volta la gente ascoltava per ore e ore, prima dell'avvento della radio e del cinema. Billy è già a suo modo un film. La storia che racconta non è molto più oscura ed episodica del copione che Peckinpah si era riscritto. C'è un bandito che dovrebbe fuggire, e invece gira in tondo. C'è uno sceriffo che (spoiler) lo ucciderà, ma un tempo era un suo amico. Le strofe che seguono non sono che variazioni sul tema del conflitto a fuoco. Due canaglie giocano a nascondino in una prateria senza senso, chi non è sceriffo è ladro di bestiame. Entri in saloon da assassino, ne esci con la stella di latta sul petto. In che pasticcio mi hai portato, amico?
Dormi con un occhio mezzo aperto
se con Garrett hai quel conto aperto.
Ogni suono è il La per il concerto
che la sua pistola suonerà.
In che pasticcio mi hai portato, Kris? Mettetevi nei panni di Bob Dylan, per una volta. Ce l'ha fatta: finalmente è sul carrozzone di Hollywood. Gente seria, valori solidi, mica quella bolla di sapone che è il mondo musicale, schiavo dei capricci di ascoltatori teen-ager e critici ventenni. Qui c'è gente che ha fatto la guerra, gente che ha già il suo nome scolpito sul marmo della Storia, James Coburn con tutte le sue meravigliose rughe (non le fanno più delle facce così), e Sam Peckinpah. Questo è il mondo degli adulti: Coburn e Peckinpah. Insieme per lavorare a qualcosa che andrebbe a vedere anche Abram Zimmerman, se fosse ancora al mondo - e sui titoli avrebbe visto il nome finto di suo figlio accanto a quello di quei grandi. Ce l'hai fatta, Robert "Bob Dylan" Zimmerman. Non sei più il ridicolo 'portavoce' di un evanescente 'generazione'. Sei un musicista dal talento riconosciuto e un caratterista di buon livello. Sennonché.
Sennonché siamo nel 1973, e anche il mondo degli adulti sta andato a puttane. Il grande Sam Peckinpah è un alcolizzato furioso che tutte le notti spara alla sua immagine nello specchio. Litiga coi produttori, litiga coi collaboratori, col cast, prima o poi se la prenderà anche con Dylan. Il copione è un casino, sul set a Durango gira di tutto, compreso il virus dell'influenza. Perderanno un sacco di tempo, e alla fine il regista abbandonerà il film al suo destino. Montato alla benemeglio, stroncato anche dai fan di Peckinpah, il disastro eclisserà il valore della colonna sonora - sapete chi ha vinto l'Oscar alla migliore canzone del 1973? Barbra Streisand, The Way We Were. Ora non dico che Billy avrebbe avuto una chance (in lizza c'erano anche Jesus Christ Superstar e Live and Let Die, fu un anno durissimo), ma Knockin' on Heaven's Door non si meritava una nomination? Il fatto è che per qualche tempo nessuno si accorse che per quel film sfortunato Dylan aveva scritto uno o due capolavori.
Viene il sospetto che il vecchio Sam avesse capito prima di tutti, e meglio di tutti... (continua sul Post).
Black is the New Barbablù
22-05-2017, 18:03cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, razzismiPermalinkIndovina chi viene a cena - in una bella villa bianca sul lato deserto del lago, tutto intorno chilometri di boschi, non un'anima a parte i cervi e i bianchi ricchi e progressisti. Rose vuole presentare Chris ai suoi genitori. Li ha almeno avvisati che Chris, oltre a essere un bravo fotografo, è... nero? No, ma non importa, anzi forse è meglio perché... è gente aperta, avrebbero votato Obama anche una terza volta, e poi chi non vorrebbe avere un bel ragazzo nero da sfoggiare al rinfresco?
Indovina chi ha azzeccato un altro thriller in una casa nei boschi: la Blumhouse, esatto. Ma stavolta ha esagerato. Con un regista esordiente e non pratico del genere (veniva dalle commedie); con la sua formula antica e austera, 10% azione e 90% suspense; con la sua produzione parsimoniosa, per non dire taccagna, ha portato in sala un film che è costato quattro milioni e mezzo di dollari e ne ha fatti duecentotrenta. Per intenderci: il King Arthur della Warner non ha ancora superato i cento - ce la farà, ma è costato centosettanta, per via dei mega-elefanti in computer-grafica che evidentemente erano necessari. La Blumhouse non usa computer-grafica (o se c'è davvero non si vede). Per emozionare lo spettatore - spaventarlo, divertirlo, consolarlo - non ha altre risorse che il montaggio, la recitazione, la storia: per farla breve: la Blumhouse fa il cinema. E funziona. Forse un cinema così classico è ormai merce talmente rara che fa notizia. Non spende tanto ma spende bene: luci e musiche ti danno l'impressione che il film giochi in serie A. Get Out cattura con cose semplici - occhi sgranati, occhi piangenti, porte chiuse e all'improvviso aperte, e qualche rumore semplicissimo e fantastico. Chi proprio vuole il sangue alla fine avrà il suo sangue, ma a Get Out per catturarti basta il suono di un cucchiaino (continua su +eventi!)
 |
| L'orrore è una lacrima. |
Get Out forse esagera a prendersela coi liberal bianchi, un avversario forse un po' troppo facile e sgonfio, proprio mentre una nuova ondata di razzismo tutt'altro che ipocrita e liberal manda un suo uomo alla Casa Bianca. Ma la storia funziona molto meglio così, e quindi tanto peggio per i liberal. Get Out non salverà l'America dal razzismo, ma intanto sta salvando il cinema: perché le cose che ha da dire, giuste o o meno giuste che siano (o persino sbagliate), le dice coi mezzi antichi e potenti del cinema. Al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:20, 22:40); al Vittoria di Bra (20:15, 22:20); all'Italia di Saluzzo (20:00, 22:15) e al Cinecittà di Savigliano (20:20, 22:30).
L'ingloriosa caduta dell'Excaliburino
16-05-2017, 13:44cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkA Camelot qualcosa non va, la tavola rotonda è in fermento: da indiscrezioni sembra che qualche Valoroso Cavaliere sia scappato con la cassa. Il valoroso sir Ritchie non si trova, nelle sue stanze il re Artù si tormenta: è colpa sua. Non doveva dar retta a quella banda di disperati, pur riunita sotto lo stemma di un nobile blasone, la Compagnia dei Fratelli Warner. Ma loro si erano fatti avanti con suadenti lingue biforcute... una saga in sei film promettevano, sei film! Roba da Guerre Stellari, come dire di no? Finalmente la fama di Excalibur avrebbe raggiunto i quattro angoli del mondo, rivaleggiando con quella dei supereroi e dei robottoni componibili. E mentre già volava con l'immaginazione, mentre già visualizzava il suo pupazzetto barbuto spuntare da un happy meal sudcoreano, il nobile Artù forse non si accorgeva che gli stavano rubando l'anima?
"Che avete detto? Devo passare la giovinezza in un bordello? Ma non ero un maniscalco?"
"Maestà, abbia pazienza, è per attualizzare il personaggio".
"Ah perché i bordelli sono attuali?"
"Ehm".
"Cioè io ogni tanto ci vado al cinema, nei blockbuster di adesso vedo un sacco di donne guerriere, qui c'è solo qualche strega repellente e un po' di prostitute di contorno, tutta questa attualità, scusate..."
"Àstrid Bergès-Frisbey dà comunque vita a un personaggio femminile cool e non scontato, ammetterà..."
"Potrei anche ammetterlo, ma... neanche un bacetto, niente... poi a un certo punto la rapiscono, e mi potrebbe anche stare bene, la Damigella in Pericolo è proprio materia bretone, l'abbiamo inventata noi, praticamente".
"Perfetto, maestà".
"Poi però nella scena d'azione successiva serve un deus ex machina e quindi la liberano. Il malvagio re Vortigern la libera senza un plissé. Aveva chiesto in cambio Artù, e invece la libera prima che arrivi Artù. Ora io di buchi narrativi un po' me ne intendo, e questo..."
"La liberano perché gli hanno promesso che Artù sta arrivando!"
"Dunque io Vortigern me lo ricordo, e così imbecille proprio no. Ha in ostaggio una maga e un bambino e libera la maga. Ma chi ha scritto questo copione, si può sapere?"
"I nostri migliori artigiani, maestà"
"Ovvero?"
"Ehm... Joby Harold".
"Ovvero?"
"Sta lavorando alla nostra versione di Flash e di Robin Hood".
"Sta lavorando. Ma un film intero lo ha già scritto?"
"Certo, ehm, Awake..."
"Mai visto".
"Un buon successo del... del... 2007".
"E poi non ne ha più scritti?"
"Ha fatto altro, e proprio per questo gli abbiamo affiancato un altro valentissimo professionista e coproduttore, Lionel Wigram".
"Ovvero?"
"Ehm..."
"L'avrà mai scritto un film questo qui".
"The... The Man from UNKLE".
"Ma ha floppato!"
"No, non ha floppato, no... diciamo che non ha raggiunto i risultati previsti. Ma mica per colpa sua, lo script era buono".
"È stato più un problema di regia, dice?"
"Ehm...."
"Mi aiuti a ricordare, io faccio il re nella materia bretone non è che mi intendo così tanto... chi stava dietro la macchina da presa quando avete prodotto The Man from UNKLE?"
"Guy Ritchie".
"Signori, aiutate un povero monarca altomedievale a capire... volete fare una saga sulla materia bretone in sei episodi, solo per il primo quanto avete intenzione di spendere?
"175 milioni di dollari".
"È una cifra spaventosa, epperò... si tratta di rivaleggiare coi draghi dello Hobbit, immagino..."
"No, veramente niente draghi per ora".
"Come niente draghi?"
"Dopo lo Hobbit pensavamo appunto di cambiare un po', pensavamo a degli elefanti".
"Elefanti? Ma io sono re Artù".
"Elefanti enormi!" (continua su +eventi!)
"Sentite, io sono un po' fuori dal giro grosso... l'ultimo con cui ho lavorato è stato De Laurentiis, lui aveva in mente queste cose un po' fantastoriche... è andata com'è andata. Diciamo che la fantarcheologia ha fatto il suo tempo. Ma voi mi state dicendo che intendete buttare quasi duecento milioni di dollari in un film su di me scritto da due novellini, senza un personaggio femminile forte, senza attori di prima linea (la cosa più importante che ha fatto il mio interprete al cinema è Pacific Rim) senza draghi e con gli elefanti. Confesso una certa perplessità".
"Ma c'è Guy Ritchie! Ha visto cos'ha fatto Guy Ritchie con Sherlock Holmes?"
 |
"Sentite. Ci è piaciuto immensamente lo Sherlock Holmes di sir Ritchie, ma il trucco che ha funzionato con la Londra dell'Ottocento - chiamiamolo choc anacronistico, un blockbuster d'azione in costume - non necessariamente funzionerà con Camelot. Primo perché Sir Robert Downey il Giovane non è più della partita - e anche Sir Jude il Bello soffre l'ingiuria del tempo; secondo, perché un buon trucco non funziona che una volta, al massimo due; terzo, perché Camelot è qualcosa di molto diverso, è un mondo di oscurità e misteri, e sir Ritchie e i suoi scrittorucoli questa cosa non l'hanno capita. È gente nata e cresciuta in città, non capiscono che esistano altri mondi, ficcano nel quinto secolo una Londinum metropolitana che neanche nel Milletré era grossa così, ma ammettiamo pure che ai paggi e alle pulzelle che affollano i multisala tutto questo non interessi. Siete convinti che si interesseranno comunque ai vecchi sortilegi di sir Ritchie? Quegli stacchi violenti, quei montaggi diegetici, quelle zummate improvvise, quei dialoghi esagerati da fumetto, così anni Novanta del Ventesimo Secolo..."
"È quel che piace ai giovani, maestà!"
"Non credo. Temo che sia quello che piaceva a voi quando eravate giovani. Ma i blockbuster di adesso non si fanno più così, c'è tutta un'arte che altre compagnie hanno interiorizzato, e voi no. Andate di selva narrativa in selva narrativa, cercando materiale quale che sia da sfruttare commercialmente, imponendo le vostre saghe raffazzonate alla benemeglio con la pura forza bruta del vostro nobile Stemma e del battage pubblicitario... non so se dovrei fidarmi di voi. Certo, la vostra proposta è allettante".
"Sei film in dieci anni, Maestà..."
"Ma rischio di perdere l'anima".
"Pupazzetti della tavola rotonda in tutti gli Happy Meal".
"Oh, va bene, dopotutto sono sopravvissuto anche a De Laurentiis e Valerio Massimo Manfredi, cosa ho da perdere? Portatemi il sigillo reale".
Da qualche parte ai piani alti della Warner Bros dev'esserci un gruppo di, come definirli, diversamente umani. Qualche figlio di, qualche ragazza di, qualcuno che passava di lì e aveva bamba per tutti, una squadra di iperattivi ipodotati che se hanno mai sfogliato un fumetto non riuscivano a decifrare le scritte nelle nuvolette; se mai sono entrati in un cinema, si sono addormentati dopo i trailer. Una gang di deficienti con una missione suicida: salvare il cinema da sé stesso. Lo scrivevo l'estate scorsa, di fronte a quell'empia catastrofe che fu Suicide Squad. Non è che ci credessi davvero, ero solo scandalizzato da un film. Ma ora che King Arthur è sotto di centotrenta milioni di dollari, comincio a domandarmi se per caso ci avessi azzeccato: se la WB non abbia dichiarato guerra ai blockbuster e se non sia tempo di decidere da che parte stare. Nel frattempo, chi è curioso può trovare King Arthur al Cinelandia Borgo San Dalmazzo (20:00, 22:40), al Fiamma di Cuneo (21:00) e al Cinecittà di Savigliano (21:30).
Gold, il grande spoiler
08-05-2017, 23:53cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkPer quanti anni l'ho cercato. Ormai avevo perso le speranze, quando mi arrivò una dritta: nella suite di un grande hotel della capitale sopravviveva a sé stesso uno degli ultimi Titolisti del Cinema Italiano. Aspettava che qualcuno salisse ad ammazzarlo o scendesse a pagargli il conto. Entrambe le cose erano al di fuori della mia portata, ma provai ugualmente a salire con una bottiglia di scotch. Si sciolse subito. In fondo moriva dalla voglia di raccontare, di difendersi.
"Quando ha capito che voleva fare il Titolista?"
"Non c'è stato un momento preciso... ho sempre saputo che l'avrei fatto, lo faceva mio padre, e il padre di mio padre, il cinema italiano è così".
"Anche suo padre cambiava i titoli dei film stranieri?"
"È stato uno dei più grandi. Ha presente Non drammatizziamo... è solo questione di corna?"
"Domicile conjugale, di François Truffaut".
"Ahah, sì".
"È stato suo padre a cercare di far passare un film di Truffaut per una commedia sexy con Lando Buzzanca?"
"Ci siamo comprati un'Alfa Giulia con quel titolo".
"Lei invece è quello che ha tradotto Eternal Sunshine of the Spotless Mind con..."
"No, non sono io quello..."
"Se mi lasci ti cancello".
"...purtroppo. Che invidia. Grandissimo titolo".
"Crede che in qualche modo abbia giovato alla fruizione del film?"
"Non lo so. Ma lo ha portato in un centinaio di sale in più. Migliaia di biglietti in più. Il nostro mestiere serve a questo".
"A vendere illusioni".
"Non è l'essenza stessa del cinema?"
"Non pensa che un titolo così sia in qualche misura truffaldino? A che è servito riempire centinaia di sale in più, se la gente che entrava credeva di vedere una commedia con Jim Carrey..."
"È servito a vendere loro biglietti, ecco a cosa. E magari a uno su dieci il film sarà pure piaciuto. Come dovevano tradurlo?"
"Non so, per esempio L'eterna luce di una mente pura".
"Wow".
"Grazie".
"Forse un centinaio di biglietti in tutt'Italia riusciva a venderli anche lei. L'eterna luce di una mente pura, ma certo. Che razza di ipocriti".
"Prego?"
"Mi ha sentito benissimo. Voi, voi tutti che ci odiate, siete solo ipocriti. Per mille euro in più cambiereste il nome anche ai vostri figli".
"No, non credo".
"E per diecimila?"
"N-no, direi di no".
"E qual è il problema? Mi dica, qual è il problema se un film invece di avere un titolo noioso ne ha uno un po' più accattivante? Ha paura di trovare più gente quando entra in una sala?"
"Mi dica soltanto una cosa. Lei si ricorda un film del 2017, di Stephen Gaghan..."
"Buio assoluto".
"Con Matthew McConaughey, che fa il cercatore d'oro..."
"Ah, quello! Non male dopotutto".
"È lei che ha deciso di sottotitolare la versione italiana "La grande truffa"?"
"Sì, è successo".
"Mi può spiegare il perché?"
"Non c'è già arrivato da solo?"
"Ma..."
"Senta, il nostro non era un lavoro da dilettanti (continua su +eventi!). Non è che ci sedevamo in un angolo e tiravamo fuori bigliettini da un sacchetto. C'erano indagini di mercato precise. Le commissionavamo, le analizzavamo, e ne ricavavamo delle indicazioni preziose. Se le dicessi - e non lo confermo - ma se le dicessi che la parola "truffa" in un titolo italiano valeva da sola seimila biglietti in più..."
"Aveva almeno visto il film?"
"Crede che fosse un gioco? Crede che non li amassimo, noi, i film? Mio padre era un appassionato di nouvelle vague, lo sa?"
"Si è reso conto di aver rivelato il finale del film nel sottotitolo?"
"Beh, adesso, poi, il finale del film..."
"Se n'è reso conto o no?"
"Senta, lei non può capire certe volte la pressione. Me lo ricordo bene quel film, e le attese che aveva generato - era una storia pazzesca. Lo sa che lo doveva fare Michael Mann, a un certo punto? E poi è passato..."
"...a Spike Lee".
"Ed era un veicolo per McConaughey, che in quel momento andava fortissimo. Sembrava un colpo sicuro. Ci avevamo investito. Ma poi... a un certo punto si scopre che il regista è cambiato di nuovo, ed è questo... come ha detto che si chiama?"
"Gaghan. Ha scritto e diretto Syriana".
"Ecco, basta dirlo. Syriana. Fosse stato per me, l'avrei chiamato 40 Notti di Petrolio. Ma avrebbe floppato lo stesso. Ci facciamo dare un copia per farci un'idea, e scopriamo che ovviamente è un casino. Il tizio ci stava fottendo".
"In che senso?"
"Andava alla cieca, sapeva che sottoterra da qualche parte aveva una storia, ma non capiva dove cercarla. Ogni tanto tirava fuori qualche idea, ma non era roba del suo sacco. Qualche idea da David O. Russell, qualche pezzo fregato a Scorsese - come se Scorsese facesse materiale che si camuffa facilmente".
"Ma c'era pur sempre McConaughey".
"Altroché se c'era. Fin troppo. Spalmato in ogni fotogramma. Come a dire: pensaci tu. Una palese dichiarazione di inadeguatezza dietro la macchina da presa".
"Però il personaggio serafico di Édgar Ramírez è perfettamente complementare a quello del protagonista".
"Sì, vabbe', resta il problema di due ore di primi piani di McConaughey, che se fossero i primi anni Zero andrebbe benissimo, ma è un McConaughey con la pelata e i denti storti. Recensioni perplesse. Box office americano in picchiata. Dovevamo inventarci qualcosa, capisci?"
"Ma è una storia fantastica".
"Che ti posso dire, si vede che non bastava".
"Era un buon motivo per... per..."
"Avanti, dillo".
"Per spoilerarla?"
"Seimila biglietti in più, figliolo. Seimila biglietti".
"...di gente che si sarà sentita presa in giro e avrà pensato: non ci torno mai più al cinema".
"Lo crede davvero? Ma no, tornavano sempre. Quella era gente che al cinema ci andava, era qualcosa di più forte di loro. La fame di illusioni".
"Se è così, perché la ritrovo in bolletta e senza un mestiere?"
"È finita la gente".
"Ovvero..."
"Finita. Invecchiati o morti. I giovani guardano serie in tv, la fine era segnata. Abbiamo solo cercato di viverci finché abbiamo potuto. Non è quello che facevano tutti?"
"Cosa facevano tutti?"
"Non saprei, ero quasi sempre al cinema. Ma mi ero fatto questa idea che scavassero buche".
"Buche? E perché?"
"Per riempirle".
"Non capisco".
"Per sentirsi impegnati, professionali, indaffarati, e magari qualche volte per caso trovavate un po' d'oro e vi ripagavate la spesa. Ma il più delle volte l'oro lo gettavate voi. Non andava così con tutto, in quegli anni?"
"Si è fatto tardi, può tenere la bottiglia".
"Non buttavate un sacco di soldi dei genitori in startup che servivano sostanzialmente a percepire fondi per le startup? Non passavate anche voi il tempo a inventarvi titoli fantasiosi per i vostri progetti, per i vostri curricula?"
"È stato un piacere, addio".
"Cosa si aspettava di trovare salendo quassù, l'uomo che ha ucciso il cinema? Il cinema non muore, il cinema è tutto intorno, basta trovare qualcuno disposto a farsi..."
"Fregare".
"...raccontare una bella storia"
"Non è una bella storia se sveli il finale".
"Non mi sono mai piaciuti i finali. La vera magia del cinema è quando si spengono le luci, e la gente spegne il telefono, e al botteghino ti dicono quanti biglietti hanno venduto..."
Gold è al Cine4 di Alba alle 19:30 e 21:00; al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo alle 20:10 e 22:40; al Vittoria di Bra alle 20:00, 22:30; al Cinecittà di Savigliano alle 20:15 e alle 22:30. Non fate troppo caso al sottotitolo italiano.
La galassia si salva ballando
01-05-2017, 01:17cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkDa qualche parte in una galassia meno lontana del solito, i Guardiani aspettano un mostro litigando su chi deve combattere e chi mettere su i dischi. Alla fine ci pensa il piccolo Groot. E siccome di combattimenti con i mostri galattici al cinema se ne vedono tutte le settimane, ormai, James Gunn decide di stringere l'obiettivo su Groot. È una scena che dura i quattro minuti di Mr Blue Sky, ma è più che sufficiente. Se non vi è piaciuta, potevate già alzarvi dalle poltroncine, perché i Guardiani Due è tutto qui. And if you don't love me now you will never love me again...
È un film su un bambino e sui suoi tanti padri. Il bambino si mette nei spesso nei guai e i padri non sono sempre attenti e presenti come dovrebbero essere. Se vi aspettate colossali scene d'azione resterete interdetti, se credevate che tra un combattimento e l'altro i Guardiani facessero dialoghi brillanti ci resterete male: si ride, sì, ma di battute abbastanza innocue e reiterate a uso degli spettatori più giovani. I Guardiani 2 è, come i migliori film Marvel, un film particolarmente fluido, senza vere soluzioni di continuità tra azione e commedia. Non ci sono personaggi seri e personaggi buffi; non ci sono scene madri, recitativi e siparietti buffi.
Come nei fumetti della casa madre, i personaggi scherzano mentre lottano, spiegano mentre uccidono, si confessano a degli sconosciuti perché non c'è una sola vignetta, una sola scena che non debba mandare avanti la storia, far ridere e stordirti con forme e colori. È quel groviglio di tensioni e di affetti, di forme ed effetti e di nuvolette fitte che raramente al cinema funziona, ma alla Marvel più spesso che agli altri. I Guardiani 2 è uno dei cinecomic più divertenti di sempre non per gli sfondi o gli effetti (computergrafica abbastanza standard, con qualche ricercatezza cromatica); non per le scene d'azione, e nemmeno per i dialoghi: ma perché riesce ad amalgamarli a puntino e alla fine non sapresti davvero cosa togliere e cosa aggiungere, un film così o ti piace tutto o dovevi andartene subito.
Anche l'ossessione per gli anni Ottanta è un mezzo più che un fine. I nonni che portano i nipotini al cinema almeno avranno qualche bella canzone da ascoltare; i padri si ricorderanno di qualche pomeriggio in sala giochi; i figli e i nipoti si immedesimeranno in Rocket e Drax, che non hanno ancora capito come funzionano le strizzate d'occhio, ma ci stanno lavorando. Fan di Guerre Stellari e Avengers non lo ammetteranno mai, ma i Guardiani stanno dando punti a entrambi... (continua su +eventi!) Sono arrivati dopo, con meno pretese - e questo forse è un vantaggio; si muovono in una delle province meno conosciute dell'immaginario Marvel (lo spazio profondo), cannibalizzando personaggi storici senza la minima preoccupazione filologica. Nessuno si aspettava un granché da Starlord e dai suoi amici alberi e procioni, e guarda cosa ti combinano ogni volta. Non ci provano nemmeno a sembrare profondi, ed è forse il motivo per cui qualche volta ci riescono. Nei Guardiani Due a un certo punto c'è quel tipo di scena commovente che Il risveglio della forza cercava affannosamente di allestire - salvo che qui ci si commuove davvero, senza avere a disposizione nessun vecchio eroe da sacrificare. Ogni personaggio ha un problema, una battuta e un momento di gloria: ogni guardiano a turno è mostro, eroe e clown. Tre anni dopo I guardiani sono di nuovo esattamente il film che volevamo vedere da ragazzini quando riuscivamo a conquistare il telecomando e a tenerlo fermo sul Ritorno dello Jedi o Flash Gordon o Star Games. Più che una parodia degli anni Ottanta, è la riscossa di un decennio che sapeva di averci lasciati delusi. È tornato a salvarci, sa che ci meritavamo di meglio, non ha troppe giustificazioni, ma una tuta spaziale tascabile. E anche stavolta siamo tutti Groot.
Storia di un panino deludente
25-04-2017, 09:48cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink |
| L'arca dell'alleanza. |
Ray Kroc non ha inventato il fast food: quello lo hanno messo a punto i geniali gemelli Dick e Mac MacDonald, nel loro ristorante di San Bernardino (CA), sfidando tutte le convenzioni degli anni Cinquanta (niente tavoli, niente cameriere, niente juke box) per concentrarsi su un solo obiettivo: servire istantaneamente hamburger e patatine. Kroc non ha inventato il franchising più efficace del mondo, anzi finché lo gestì lui direttamente non riusciva a rientrare nei costi di gestione. Kroc non ha nemmeno trovato un modo per risparmiare sulle celle frigorifere: l'idea arrivò dalla sua futura seconda moglie. Nell'impresa più epica della ristorazione moderna, Ray Kroc non ha messo il nome, non ha messo la faccia, non ha messo le idee: e allora perché è lui, e non un altro, il Fondatore? Perseveranza.
 |
| La terra promessa |
A quattro mesi dall'uscita nelle sale, il film non ha ancora coperto le spese di produzione (continua su +eventi!) Ai critici è piaciuto; i giurati dell'Academy hanno fatto finta di non vederlo; il pubblico non si è fatto vedere. Cosa non ha funzionato? Difficile dirlo. Da fuori il prodotto si presenta bene. Il primo morso è davvero stuzzicante - l'odissea di Kroc attraverso l'America, alla ricerca del solo messaggio di speranza in un futuro usa-e-getta: il piccolo ristorante di San Bernardino che non ha (incredibile!) nemmeno i tavolini, i piatti e le posate. È più tardi che ti rendi conto che The Founder non ha neanche lontanamente lo stesso sapore di The Social Network; quando nella seconda metà ti rendi conto che l'intreccio ruota sull'opportunità di inserire in menu un frappé liofilizzato. Manca molto più di un cetriolino; il formaggio è insapore; il bacon cartone abbrustolito, le patatine più gommose che croccanti. The Founder sembra il prodotto che ti servono in certi Mac, non sa di niente ma tanto tu lo manderai giù lo stesso perché il sapore del Mac ce l'hai già in testa, certe patatine sono solo un placebo. In cucina Keaton si dà da fare come al solito, ma tutto sembra dipendere da lui; le scene clou sono risolte in brevi dialoghi al telefono, le storie d'amore finiscono e iniziano nel tempo di alzarsi e sedersi dai tavoli. The Founder avrebbe potuto essere un grande film su una delle più straordinarie storie del capitalismo, ma a un certo punto è saltato il controllo qualità. È un vero peccato. All'Aurora di Savigliano, mercoledì 26 e giovedì 27 alle 21.
Daniel Blake sono io, sei tu, noi voi essi
15-04-2017, 22:34cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, invecchiare, lavoroPermalink |
| Che inquadratura statica, asimmetrica, che colori smorti. |
(C'è chi dice che i film di Ken Loach non sono cinema. Tanto per cominciare sono tutti a tesi, e pure la tesi è sempre quella, non potrebbe almeno cambiarla un po'? E poi è sempre tutto così appiattito, così realistico - ma senza quella fissa per i dettagli dei cineasti che hanno pretese - in una parola, così televisivo).
 |
| Che fotografia discutibile, e le luci poi, mah. |
(C'è chi dice che Ken Loach è superato. Non ha l'intensità dei Dardenne, la profondità di Mungiu, alla fine gira sempre lo stesso film).
Daniel Blake è quel tuo collega che un giorno si è ammalato e a tutti dispiaceva, all'inizio; ma col tempo ha prevalso il fastidio, lui proprio non si rassegnava a pre-pensionarsi e faceva sempre più assenze, sempre più problemi, finché un giorno è morto e di nuovo a tutti è dispiaciuto, ma almeno aveva finito di soffrire: e anche voi.
(C'è chi dice che Ken Loach non fa più cinema, se mai l'ha fatto. Prende un caso limite, e ci imbastisce il solito temino veterolaburista. Il suo Daniel Blake è l'ennesimo martire della società. Non ha difetti, divide il suo sussidio con gli orfani e la prostituta).
Daniel Blake sarò io, il giorno che qualcuno mi dirà che non posso più farcela... (continua su +eventi!) e all'Inps mi diranno che per la pensione è troppo presto, che ci avrei dovuto pensare prima. In realtà ci sto pensando, ma, ecco, una soluzione proprio non la vedo. Tranne salutare tutti, esser gentile con tutti, e sperare che quel giorno qualcuno sia gentile con me.
Il fantasma di Scarlett (e il suo guscio)
10-04-2017, 20:17cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, futurismiPermalink |
| Mi vuoi ancora bene? |
"Ancora?"
Aspetta, aspetta, nel futuro saremo tutti replicanti e smontabili e...
"Già visto".
Aspetta, aspetta, saremo tutti connettibili con gli spinotti dietro la nuca!
"Ancora gli spinotti? cos'è, il primo numero di Nathan Never (1991)? Persino la prof delle medie ha un tablet senza prese usb, vuoi dire che neanche nel futuro riusciremo ad avere un bluetooth decente?"
Nel futuro saremo tutti replicanti di Scarlett Johansson.
"Comprato".
Cosa ti piace di Scarlett Johansson? Quanti pezzi di Scarlett Johansson possiamo togliere a Scarlett Johansson prima che non ti piaccia più? Un braccio, ok, quello si può togliere anche a Charlize Theron, ma proviamo a togliere tutto tranne il broncetto. Sei ancora preso da Scarlett Johansson? Togliamo anche quello. Se ci pensate non è nemmeno il primo film in cui vi si pone il problema. Usciresti con un alieno assassino se però per attirarti si travestisse da Scarlett Johansson? Usciresti con un sistema operativo se almeno avesse la voce di Scarlett Johansson? (E se poi lo facciamo doppiare da Micaela Ramazzotti, ti innamoreresti lo stesso?) Nessun'altra diva ha giocato così tanto a decostruirsi, a farsi a pezzi, a ridursi a fantasma. Se date un'occhiata alla sua filmografia recente, sembra che non le interessi fare altro. Doppia cartoni animati, presta il viso a personaggi di fumetto che vengono animati da controfigure o computer-grafica, e si prende in giro da sola in una sequenza dei fratelli Coen. Che cosa sta cercando di fare Scarlett Johansson?
 |
| Il cyberpunk aveva questa fobia del vuoto, grattacieli, grattacieli ovunque, come i salami di Jacovitti. |
E tu? Cosa sei disposto a guardare per Scarlett Johansson? Un altro film degli Avengers? Un film di Luc Besson? Il remake di un anime degli anni '90, Blade Runner in salsa di soia? Tutto quel cyberpunk così terribilmente datato, quello coi cavi e gli spinotti e i pistoloni? Non potrebbe fare commedie brillanti, Scarlett Johannson? Sarebbe perfetta, no? Possibile che l'unica commedia rilevante sia stato un Woody Allen di più di dieci anni fa? È così carina quando sorride, perché deve fare la cosplayer imbronciata? In fondo anche alla Marvel la usano per i siparietti, e alla Marvel sanno quello che fanno, più che altrove.
(Magari non è colpa sua - avete visto commedie americane di recente? Forse il genere è stato preso in ostaggio da trenta-quarantenni misogini in addio al celibato da una vita. Mentre Scarlett si è data ai fumetti. È tutto sottosopra).
(continua su
Caccia al profeta in patria
04-04-2017, 01:15cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, provincia, snobismiPermalink"Gli autori dovrebbero morire dopo aver pubblicato il libro", diceva un autore vivo e vegeto, ormai tanti anni fa. Infatti di solito sopravvivono e alla lunga diventa seccante, vederli aggirarsi tra le loro opere, sempre più grigi e meno interessanti, come se attendessero all'ingresso le interpretazioni: questa può passare, questa proprio no, diventano i buttafuori delle loro creazioni, ma non si vergognano? Bisognerebbe ammazzarli; purtroppo è vietato. Il sistema più educato che abbiamo trovato, per farglielo capire, sono le statue. Quando lo scrittore vede che gli stanno innalzando un monumento, ecco, se non è un deficiente dovrebbe arrivarci da solo: è l'ora di togliersi di mezzo. Funziona anche coi premi, ma solo quelli molto prestigiosi, ad esempio il Nobel.
Gli argentini non hanno mai vinto un Nobel per la letteratura. Se pensate che vabbe', Borges a parte non è così strano, in fondo sono soltanto 40 milioni, ecco, tenete conto che il Cile ne ha vinti due. Il Cile, come dire il gemello cattivo - e uno l'ha vinto pure il Perù, 30 milioni di abitanti (tra cui Vargas Llosa). In Columbia poi è nato García Márquez, come fai a non darlo a García Márquez? Però a Borges no. C'è che Borges, di tutti i più celebri scrittori latinoamericani, è il meno latinoamericano - non sarà un po' il problema dell'Argentina, troppo periferica per essere mainstream, troppo bianca per essere almeno esotica? Magari El ciudadano ilustre è nato così, un esercizio mentale della premiata coppia di cineasti: uno scrittore argentino da premio Nobel, come te lo immagini? Un po' schizzinoso, senz'altro (continua su +eventi!)
Probabilmente si è trasferito in Spagna da anni (come Vargas Llosa) e però nei suoi libri continua a riciclare lo stesso paese natale (come García Márquez). Di sicuro irride le buone vecchie tradizioni, si prende gioco dei gauchos e alle grigliate non manca di ricordare che nemmeno la carne alla brace l'hanno inventata loro. Di sicuro non ama le cerimonie, ce lo vedi in marsina davanti ai reali di Svezia? Probabilmente si nega a tutti al telefono e poi si annoia. Cioè dopo un quarto d'ora che te lo stai immaginando ti viene già voglia di picchiarlo, questo nobel argentino, proprio voglia di inseguirlo con la carabina...
Presentato a Venezia l'anno scorso, El ciudadano ilustre è stato tradotto un po' frettolosamente "Il cittadino illustre", mentre la premessa del film è che dopo cinque anni di isolamento e crisi creativa, il premio Nobel Daniel Mantovani (Oscar Martínez, Coppa Volpi) decida all'improvviso di rispondere all'invito del suo piccolo luogo di nascita, che lo vuole nominare cittadino onorario. Laggiù per fortuna è ancora tutto brutto e disperato come si ricordava: le Pampas, un Polesine stirato per centinaia e centinaia di chilometri, alla mercé di allevatori ignoranti e fieri d'esserlo. La parata sul camion dei pompieri, con la reginetta di bellezza. Alla tv le pubblicità del mate dietetico. La cultura per i suoi compatrioti è una presentazione in powerpoint (geniale), l'arte un ritratto di Papa Bergoglio. Mantovani ci prova, a essere gentile con loro: ma forse è una trappola, forse se l'è organizzata da solo. In un'aiuola dei giardinetti c'è già il suo busto pronto, a tiro di piccioni. El ciudadano è anche un test divertente: c'è chi uscirà convinto di aver visto l'opera di due brillanti cineasti di Buenos Aires che demoliscono le velleità dei provinciali. È un'interpretazione come un'altra; ma è il film stesso ad autorizzarne di più sofisticate. Il cittadino illustre arriva al cinema Lux di Busca giovedì 6 e venerdì 7 aprile, alle ore 21.
Lei non si lascia scomporre
26-03-2017, 18:50cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, sessoPermalinkTua madre è innamorata, si è fatta un altro po' di botox. Tuo papà è ergastolano, ma ancora sta in tv. Tuo figlio vuol fare il papà, ha messo incinta una matta, chiede due mesi d'affitto più le spese. Al lavoro c'è un dipendente che gioca a incollare la tua faccia su delle animazioni 3d sodomite, ma d'altro canto se lavori nel campo dei videogiochi la tua quota di psicopatici ti tocca. Il tuo amante sta diventando un po' ossessivo, l'ex marito è depresso perché fa lo scrittore francese, che altro? Ah già, c'è un tizio che ogni tanto entra in casa e ti violenta. Quasi dimenticavi. Buon Natale, Michèle, e felice anno Nuovo.
Paul Verhoeven non si è mai dato troppa pena di giustificare quello che faceva. Gli piaceva un certo tipo di violenza che Hollywood, fino a un certo punto, gli ha consentito: oltrepassato quel punto è tornato in Europa, dove le regole sono più ambigue, non necessariamente più tolleranti. Dopo un lungo purgatorio è finito in Francia, ed è incredibile quanto ci si sia ambientato - non avrei mai immaginato che un film tanto verhoeveniano potesse anche essere tanto francese. È un film di ordinaria follia, ma anche di borghesi che vanno al Monoprix a scegliere il borgogna da accompagnare alla lasagna, se trovano il vicino di casa lo invitano - e hanno tutti una cantina insonorizzata dove chissà che cosacce fanno. O potrebbero averla. Non dovresti fidarti di nessuno, ma poi sono tutti così gentili che lo fai lo stesso. Anche se è tratto da "Oh...", un romanzo di Philippe Djian (da cui la quota sindacale di ironia sui romanzieri francesi) Elle non doveva essere così francese, in partenza. La produzione cercava un'attrice americana, ma non si trovava, e bastano pochi minuti di film per capire il perché. Alla fine è entrata Isabelle Huppert, a cui nel film capita qualsiasi cosa, ma forse la violenza peggiore è vederla doppiata. Quando l'anziana madre le chiede: ma se mi risposassi tu cosa faresti?, e lei le risponde: ti uccido, beh, in originale è un j'te tue, così semplice, così naturale, con la stessa intonazione con cui sceglierebbe un dessert o negherebbe un premio di produzione a un dipendente, che ti fa capire che non scherza: per lei l'idea di uccidere la madre è davvero la cosa più naturale al mondo.
Elle deve aver fatto uno strano effetto agli spettatori di Cannes. In mezzo a tanti film sul disagio del neoproletariato europeo, un film di borghesi parigini che si scopano e si uccidono con quel savoir faire che incute sempre un certo rispetto, se non ammirazione. Però non credo, come Francesco Boille, che a Verhoeven interessasse mostrare la degenerazione di una determinata classe sociale. Verhoeven non ce l'ha con la borghesia francese: è che alla prova dei fatti solo la borghesia francese è in grado di esprimere film così. Romanzo, soggetto, ambientazioni, attrice: altrove sarebbe stato impensabile. Invece Boille non ha tutti i torti sul modo in cui l'assenza di moralità di Verhoeven ci consente, per contrasto, di verificare la nostra: come ai tempi di Starship Troopers, più che un film fascista un test sul fascismo: lo prende, lo colora, lo rende più pop e più gender equal, e poi te lo sbatte in faccia: ti piace? Perché anche se ti piace rimane fascismo lo stesso, facci caso.
A Verhoeven interessa la violenza (continua su +eventi!)
 |
Elle si presta a varie interpretazioni, ma si può godere anche come un thriller dove qualsiasi cosa può succedere in qualsiasi momento; può farci arrabbiare o sorridere, e almeno la nostra rabbia e il nostro riso avranno avuto un senso. Ma può anche lasciarci indifferenti: che è poi la posizione della protagonista, e di uno dei personaggi meno in vista, a cui tocca una delle ultime battute del film. Una persona che all'apparenza è l'esatto contrario di Michèle: che ha una moralità, una religione; e che allo stesso tempo non è l'avversaria, anzi forse aveva capito tutto dall'inizio. Elle è al Vittoria di Bra (17:00, 20:00), al Fiamma di Cuneo (15:00, 18:00, 21:00) e all'Aurora di Savigliano (18:30, 21:00).
Non sono il tuo computer di colore
20-03-2017, 23:32cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, scienzaPermalink |
| WE ARE THE COMPUTERS. (COLOURED COMPUTERS). |
Bene, perché in effetti non è successo.
Ma in fondo è successo qualcosa di simile ad altre, quindi tutto sommato va bene così.
 |
| Ti ci mando io in orbita, baby. |
 |
| Dove nessun uomo è andato prima, o almeno io su quel piolo non ci ho ancora avuto il coraggio. |
Io insegno in una scuola e ogni tanto mi capitano ragazze che quando vogliono fare una domanda, esordiscono dicendo: "Non ci capisco niente". E tutte le volte: ma perché dici così? (Continua su +eventi!) Al massimo non avrai capito una cosa. E pensi che qua dentro qualcun altro abbia capito? Tu sei tra i pochi che almeno si stanno ponendo il problema, perché ti devi autodenigrare? Chi ti ha insegnato a comportarti così?
Wolverine sanguina! (finalmente)
13-03-2017, 23:29cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fumetti, mitiPermalink |
| Frank Miller, 1983. |
È sempre stato così, anche sui fumetti: gli altri eroi in costume possono anche fingere di non essere assassini, Logan questa ipocrisia non se la può permettere. Quante volte ha accostato un pugno al torace o al volto del suo nemico, quante volte abbiamo letto "SNIKT" nella vignetta successiva, senza che il disegnatore si mettesse nei guai mostrandoci i dettagli della macelleria? Ma se Wolverine è sempre stato così difficile da gestire, a chi è venuto in mente di farne un eroe in carta e pellicola? Ai lettori.
Logan non era nato per fare l'eroe. All'inizio era una comparsa in una storia di Hulk, uno di quegli antieroi esotici dai nomi buffi e dai poteri bizzarri che devono prenderle dal titolare della serie. A metà degli anni Settanta si trova inquadrato quasi suo malgrado in una banda di personaggi di secondo livello riciclati nel tentativo abbastanza disperato di salvare una testata. La testata è X-Men e nel decennio successivo diventerà anche grazie a Wolverine la più fortunata dell'universo Marvel, eppure già nei primi numeri Logan rischia il licenziamento: viene salvato da uno dei disegnatori, Byrne, per una questione di mero campanilismo (è l'unico eroe canadese). Ma all'inizio davvero non si sa come gestirlo: c'è anche qualche tentativo di utilizzarlo come una spalla comica, il tappo incazzoso che si arrabbia per primo e le prende più di tutti. Paperino. Poi piano piano il personaggio rivela delle potenzialità.
I lettori scoprono che è più vecchio degli altri; che sotto la maschera ha due basette d'altri tempi; che gli artigli non sono un gadget, ma parte del suo scheletro, per quanto questo sia anatomicamente impossibile; che le sue origini sono molto più intricate di quelle di qualsiasi altro eroe, e forse per sempre occultate da multipli lavaggi del cervello; che tutte le persone a cui vuol bene finiscono male; che guarisce da qualsiasi ferita con una velocità che varia a seconda delle esigenze di sceneggiatura, da pochi minuti a qualche giorno: quanto basta per renderlo protagonista di una serie di storie in cui prima viene massacrato da qualche nemico prepotente, poi risorge cristologicamente per vendicarsi con operazioni di chirurgia sommaria senza anestesia. Erano ancora i primi anni Ottanta e i lettori della Marvel non avevano mai letto o visto cose del genere. Wolverine, a una certa distanza è più facile capirlo, è il primo eroe americano post-Vietnam: è un reduce, è un mostro, si vergogna ma è pur sempre il migliore in quello che fa. Più vicino a Rambo che a Capitan America, Wolverine era l'eroe perfetto per far annusare un po' di sangue ai lettori preadolescenti che non potevano più riconoscersi in un Superman perfettino o uno Spiderman Bello di Nonna. Dopo di lui i fumetti si sarebbero riempiti di cloni, cyborg e ninja, tutti un po' troppo sbilanciati rispetto all'originale: con Wolverine la Marvel aveva azzeccato per puro caso il mix migliore tra umanità e ferinità.
 |
| Questo tipo di cose. |
 |
| Si chiama Dafne Keen: non è un amore? |
Il passo successivo della Fox è stato convincere Jackman a rimettersi per un'ultima volta quei maledetti artigli, ma stavolta per usarli davvero (Continua su +eventi!)
Logan è il primo film in cui Wolverine può mostrare quello in cui è il migliore: mutilare, decapitare, infilarti tre artigli nelle parti più molli del cranio e strappartelo via in scioltezza. Il fatto che sia stato annunciato come l'ultimo cinecomic di Jackman non dovrebbe lasciare molti dubbi su come andrà a finire: al suo fianco una bambina che sembra già pronta a prendere il testimone, e un memorabile Patrick Stewart: anche per lui non è solo il film d'addio a un personaggio impersonato per due decenni (il professor X), ma anche l'occasione per farci piangere più di rimpianto che di nostalgia: che grande attore, che eroe fantastico avrebbe potuto essere, se dal 2000 in poi la Fox ci avesse creduto un po' di più, se avesse messo in scena storie appena un po' più potenti. James Mangold dirige una cupa storia di riscatto e macelleria con lo stesso presagio di fine incombente: quando gli ricapita di avere un Wolverine con gli artigli in fuori? La sua idea migliore è aver stravolto completamente la storia a fumetti a cui il film in teoria si doveva ispirare. Qua è là c'è finalmente qualche idea originale che non rende Logan un capolavoro, ma probabilmente il cinecomic più interessante che vedremo quest'anno, e forse l'unico caso in cui la pellicola funziona meglio del fumetto. Se negli altri film la violenza veniva censurata, qui è talmente esibita che dopo un po' viene a noia - il che è perfettamente in linea col personaggio, un vecchio felino che non ne può più di ammazzare ma non riesce a starne fuori: e comunque è sempre il migliore. Logan è al Cityplex di Alba (19:00, 22:00, 21:00); al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:00, 22:45); all'Impero di Bra (20:00, 22:30); ai Portici di Fossano (18:30, 21:15) all'Italia di Saluzzo (21:30); al Cinecittà di Savigliano (21:30)
Il mondo finisce un'altra volta
06-03-2017, 17:06cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, vita e mortePermalinkOgni volta che muori, il mondo finisce con te: quindi di che cosa ti preoccupi? Di chi ti lasci indietro? Li hai ignorati per tutta la vita, la morte cosa cambia? Vorresti lasciare un buon ricordo? Comprensibile, ma forse è un po' tardi. Vuoi chiedere scusa? Si vede che non sei ancora così morto, ai morti queste cose non interessano. Non si sentono in colpa, non si sentono in dovere, non si preoccupano di noi.
"Tutto bene?"
"Sì che vuoi?"
"Niente. Sei occupato?"
"Devo scrivere la recensione".
"Ottimo. Ti è piaciuto il film?"
"Devo pensarci".
"Allora non ti è piaciuto".
"Ma a te poi che ti frega?"
"Quando ti piacciono te ne accorgi subito".
"Non hai veramente niente di meglio..."
"Quando tergiversi, quando vai a vedere le recensioni, le percentuali di giudizi positivi, i premi... hai paura di fare una brutta figura".
"Io? Si vede che non mi conosci".
"È più giovane di te, vero? Il regista".
"Questo cosa c'entra".
"Mi preoccupo, sai, perché..."
"Ma perché ti devi preoccupare, non ha proprio senso".
"...succederà sempre più spesso, man mano che avrai avanti. Musicisti più giovani, registi più giovani, persino un presidente del consiglio, se non sbaglio".
"Era l'ultimo dei suoi problemi".
"Devi cominciare ad accettarla, questa cosa".
"Che sto invecchiando? La accetto".
"Bravo".
"Non che ci fossero alternative".
"Una c'era. Quanti anni ha il regista?"
"Non lo so... va per i trenta".
"Uh, un ragazzo!"
"Non è questo il problema".
"Sicuro?"
"C'è un tipo di cinema che proprio non mi prende. Colpa mia. Io nasco lettore, è la mia formazione. Se mi prendi un testo teatrale e sostituisci i monologhi con gli sguardi intensi e i primi piani, io non ci casco".
"Quindi è un limite tuo".
"Non dovrei scrivere di cinema. Non di questo tipo di cinema, almeno. Per me il primo piano più intenso non sarà mai significativo come un discorso. Se hai da dire delle cose, dille. Se guardi fisso in camera non mi stai dicendo cose. Non importa quanto sia espressivo il tuo broncetto e ben impaginata l'inquadratura, tu non mi stai dicendo cose".
 |
| A lei comunque voglio bene. |
"In movimento, però".
"Perché non sei andato a vedere Lego Batman?"
"Non mancherà l'occasione".
"Insomma non ti è piaciuto".
"Non è il mio tipo di film".
"L'età non c'entra niente?"
"Cosa dovrebbe c'entrare?"
"Dolan non ha trent'anni, che vuoi che ne sappia?"
"È un regista bravissimo e bisogna dargli atto che un'ora e mezza filano dritte come un treno, sembra sempre che stia per succedere qualcosa di orribile che poi..."
"Non come regista. Come persona. Che vuoi che ne sappia di cosa vuol dire morire?"
"Immagino che ci abbia ragionato, come tutti".
"A vent'anni? Lo sai anche tu come sono i ventenni?"
"No non lo so".
"Romantici".
"Sai che non sono d'accordo. Davanti alla morte abbiamo tutti la stessa età".
"E quindi cos'è che ti affligge?"
"Non lo so, è una sensazione, è... hai presente Natural Blues di Moby?"
"Why does my heart feel so bad?"
"Quella?"
"Ti piace?"
"La odio".
"Ecco, mi pareva" (continua su +eventi!)
"È uno di quegli esempi lampanti di Kitsch in musica... Un banale pastone dance impreziosito da un campionamento blues falso come l'ottone. E non ci sarebbe niente di male".
"Non hai niente contro la dance, adesso?"
"È un prodotto come un altro, ma questa idea che Moby la voglia fare di nicchia, la techno d'autore. Sono Moby, sono un genio, ho messo il blues nella house, so che non vedevi l'ora di sentirti profondo mentre ballavi in un club fighetto a fine anni 90".
"Coraggio, dillo".
"Cosa devo dire?"
"Che tu già a fine anni '90 eri... coraggio!"
"Troppo vecchio?"
"...per queste stronzate".
"Ma non è un problema di età. È proprio un pezzo brutto".
"Tutte le generazioni hanno i loro pezzi brutti. Poi la nostalgia, sai com'è".
 |
| (Ma alla fine voglio bene anche a loro). |
"Non è un problema di nostalgia. La nostalgia la capisco. Sono cresciuto con questa canzone scema, so che è scema ma mi ricorda il primo amore, scusate, ok, ci siamo passati tutti, espediente non nuovo ma tollerabile. È il motivo per cui a un certo punto mette i Punk Bimbominchia, come si chiamano, i Blink-numero-a-caso".
"182".
"Ma Moby lo mette in fondo, Moby se lo tiene proprio come strappamutande finale, te lo immagini proprio questo ventenne che pensa adesso vedete che vi commuovo, adesso accendo le luci in sala e vi metto il pezzo che vi strizza il cuore come una spugna, dopodiché ecco cominciare un brano che per me ha lo stesso spessore emotivo della Lambada".
"È vero che a te piaceva la Lambada".
"C'è molta, molta più poesia nelle silhouette dei ballerini sul molo, contro il tramonto".
"Quindi lo stroncherai perché ha scelto la canzone sbagliata".
"Ma non è uno sbaglio, è proprio che... che il film è precisamente così, crede di essere una bomba emotiva e invece è solo il tranello di un dj disperato che pompa i bassi per far battere il cuore alla gente. E impreziosisce il tutto incastrandoci un testo teatrale raccattato dallo scaffale, ovviamente una cosa triste triste che gira a vuoto, perché mi sento così? Perché? Stai per morire, va bene, si è capito nei primi cinque minuti. Se non sai che altro dire... se non sai dire nemmeno quello..."
"Mi preoccupi, sai".
"Non è vero".
"Non vorrei che ti trasformassi in uno di quegli attempati brontoloni che..."
"Tu non sei in grado di preoccuparti, basta con questa stronzata".
"Non voglio dire che mi deludi, ma credo che potresti fare di meglio, l'ho sempre creduto".
"Piantala - poi questa cosa di urlarsi in faccia le peggio cose, tra famigliari, non so quanto Dolan si renda conto che è proprio un luogo comune del cinema continentale, cioè gira che ti rigira è riuscito a girare un film dove gli attori francesi passano il tempo a mandarsi affanculo o a dirsi "t'es malade", non esattamente il primo che vedo, ecco".
"E non ti fanno più effetto".
"I francesi che si urlano in faccia? Son quasi peggio degli italiani. C'è pure la scena in macchina, così possono litigare senza troppi controcampi. E allora è un genio anche Muccino, rivalutiamo Muccino".
"A te proprio non la si fa".
"Senti, l'ho già detto, è bravo. Però un'ora e mezza di riunione di famiglia di francesi che si urlano cose in faccia non... non..."
"Non è la fine del mondo".
"Non per me".
"Dovevi andare a vedere Lego Movie".
"Ti sto deludendo?"
"Non ti devi preoccupare di questo".
"Sei tu che non ti devi preoccupare".
"Facciamo che non si preoccupa nessuno".
"Tutto qui?"
"Puoi mettere un pezzo se vuoi".
"Chorando se foi quem um dia so me fez chorar..."
"Sei un idiota lo sai".
È solo la fine del mondo è al cinema Lux di Busca, giovedì 9 e venerdì 10 marzo alle 21. Spoiler: il mondo non finisce.
Jackie è nella Casa
01-03-2017, 22:39Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkSignora Kennedy lei non ha / bisogno di scusarsi per il fatto che si trovava fuori sul bagagliaio / negli attimi successivi al momento in cui suo marito era stato colpito. / tutti hanno potuto vedere quel che era successo / in queste fotografie con i propri occhi ... / perché è stata distorta la verità di esseri umani? / a che serve questa immagine eroica? / nessuno è un eroe... / perché sono deliberatamente ingannato con confuse menzogne / a proposito di ciò che vedo con occhi sani / chi sono io per essere insultato così?
Prima di ricomporsi in pubblico e adottare quella maschera cool che ci si aspettava da lui, Bob Dylan ebbe il tempo per lasciarsi sconvolgere dall'assassinio di Kennedy come qualsiasi altro americano. Scrisse quattro 'poesie' a caldo - in quel periodo definiva 'poesia' tutto quello che gli usciva di getto senza preoccupazioni metriche - la prima delle quali era dedicata alla vedova Jacqueline. Più che una poesia è una lettera, senza le affettazioni tipiche del Dylan-alla-macchina-da-scrivere-che-si-crede-un-poeta. È un messaggio di scuse, quello che oggi potrebbe scrivere un personaggio pubblico sulla bacheca di facebook di un altro personaggio pubblico. È anche una riflessione su come i media e le fotografie mettono le persone in cornice o sulla gogna. Nei giorni immediatamente successivi all'assassinio politico più famoso del XX secolo, qualcuno era riuscito a biasimare Jackie Kennedy perché invece di difendere in un qualche modo il marito si era alzata, sporgendosi sul bagagliaio. Ufficialmente lo aveva fatto per aiutare una guardia del corpo a salire sulla berlina. Nell'intervista a Theodore White, giornalista di Life, emerge un altro probabile motivo: un pezzo di testa del presidente Kennedy era schizzato sul bagagliaio; Jackie si era alzato per raccoglierlo. Lo aveva rimesso al suo posto. Era evidentemente in stato di choc. Ma era anche Jacqueline Kennedy: avrebbe tollerato che le cose non fossero al loro posto?
Jacqueline Lee Bouvier Kennedy Onassis, detta Jackie, a distanza di mezzo secolo, è ancora un personaggio delicato, che impone cautela a chi lo maneggia. Forse addirittura sta diventando più delicata col tempo - ho in mente quella vecchia serie NBC degli anni Ottanta, in cui tutto sommato passava per una signora di buona famiglia ossessionata dagli interni della Casa Bianca - nozione che il regista Larraín o lo sceneggiatore Noah Oppenheim non tentano nemmeno di smentire: si tratta piuttosto di scavarci intorno, di problematizzare la cosa, di spiegare che dietro la cura per soprammobili e passamanerie c'era una riflessione sulla regalità della figura del Presidente, che emergeva ormai dalle brume della prima guerra fredda come l'uomo più potente del mondo. A quel punto era necessario lavorare sui simboli e sulle scenografie: un re deve vivere in una reggia, e sfoggiare una regina consorte. Sennò poi succede come ieri, che ti ritrovi su tutti i giornali una tizia coi piedi sul divano in Sala Ovale, e la cosa potrebbe avere ripercussioni in politica estera.
Un certo tipo di mitologia casabiancana nasce proprio con Jackie, che fu molto criticata in vita per questo (anche dal marito). Oppenheim osa finalmente dichiarare l'evidenza: Jacqueline Kennedy era, nella coppia, la più all'altezza del ruolo. Il marito era un mezzo disastro, un miliardario pasticcione che in tre anni si fece coinvolgere nel flop della Baia dei Porci, nell'escalation del Vietnam, e con la crisi dei missili portò il mondo a un passo dal conflitto atomico. La stampa conservatrice lo trattava più o meno come i liberal ora trattano il nuovo inquilino miliardario. Nel frattempo la moglie trasformava la Casa Bianca in Camelot, che è poi la vera grande eredità del 35mo presidente degli Stati Uniti. Era tempo che Hollywood riconoscesse a Jackie quello che era di Jackie. Senonché ci si è messo in mezzo Pablo Larraín. Una scelta abbastanza bizzarra, ma curiosamente in linea coi tempi, che sono piuttosto confusi.
Ci pensavo l'altro ieri, a Oscar consegnati. Secondo me Hollywood è nel pallone (continua su +eventi!) - non per il caos alla premiazione, quello è un incidente dal quale con un po' di sforzo si può cavare un simbolo, se fossi un mitografo come il giornalista Theodor White - o la stessa Jackie - o Dylan - magari mi ci proverei. Non è neanche Trump il problema (magari lo sarà nei prossimi anni - o magari sarà una soluzione, finalmente c'è un villain all'altezza del ruolo). Secondo me Hollywood non sa più che film premiare. Se la sono tutti presa con La La Land, un film che oscilla continuamente tra il dilettantesco e l'ipercitazionista. Dicevano: 14 nomination sono troppe. Può darsi, ma a chi darle, sennò? Che altri bei film avete visto nel 2016? Siamo onesti: avrebbe dovuto vincere tutto Zootopia. La rosa dei candidati era qualcosa di deprimente. Moonlight è un film che fino a qualche anno fa molti giurati non avrebbero nemmeno visto per intero, un film all'europea, intimista, diciamo pure ombelicale. Ormai il grosso dei budget è concentrato sulle saghe, e le saghe si stanno divorando tra loro: buttano fuori la stessa zuppa sempre più abbondante, sempre più pasticciata, tanto la gente manda giù di tutto.
Non è che non ci siano idee, non è che manchino gli sforzi produttivi coraggiosi. Ma ormai si concentrano sulla tv. Jackie a un certo punto doveva essere una miniserie HBO, e questo spiega in parte lo strano respiro del film - è come se Larraín abbia potuto pescare da una rosa di scene madri, a un certo punto c'è una interminabile mega-sequenza che è un mix di tre finali di tre possibili episodi: Jackie sta parlando al giornalista ma sta anche parlando a un prete, ma sta anche seppellendo Jack, ma sta anche tenendogli in mano il cranio, stretto come un vaso perché ne coli meno sangue possibile. Nel frattempo io mi sto addormentando, ma anche domandando se non è il miglior film che ho visto del 2016; o se non è per caso il peggiore; se Larraín voglia bene a Jackie o se non abbia deciso di prendere in giro gli yanquis in un modo talmente sublime che rischiava di vincerci un Oscar (è abbastanza incredibile che Natalie Portman non l'abbia vinto).
Il film all'inizio doveva farlo Aronofsky con Rachel Weisz, poi si sono lasciati e Aronofsky ha avuto questa pazza idea di proporlo a un regista cileno che a Hollywood non aveva mai lavorato. In un certo senso aveva visto giusto: Jackie era un personaggio perfetto per Larraín. È una pubblicitaria, una mitografa, una persona che vive nel suo stesso racconto. Ma di solito Larraín questi personaggi li racconta da fuori, con un'esibita freddezza, che a Hollywood non si può che stemperare. La Jackie di Larraín è una comunicatrice navigata, ma è anche una donna sconvolta che si aggira per i corridoi della 'sua' casa bianca come Jack Nicholson in quell'albergo. Dice cose molto sottili ma anche cose pazzesche. A un certo punto si lamenta con Bob che l'assassino sia solo un comunista da due soldi: se almeno l'avessero ammazzato per i diritti civili, avrebbe avuto più senso, no? È sotto choc, ma è anche un po' mitomane. Perché il suo autista si ricorda di Lincoln e non degli altri presidenti assassinati? Perché ha abolito la schiavitù? No: perché ci fu un funerale in pompa magna. E quindi ci vogliono più cavalli! Più cannoni! Poi cambia idea. Poi la cambia di nuovo. In una miniserie forse Larraín avrebbe trovato il ritmo. Qui è tutto contratto, mescolato secondo libere associazioni, al punto che sembra un sogno e forse a un certo punto stavo sognando sul serio.
Io la rispetto Signora Kennedy / ma non ho bisogno di fotografie per fornire rispetto... / il mio rispetto nasce da motivi che sono nel mio animo / che non posso toccare / né spiegare...
Non mi sento meglio sapendo che lei è umana / Lo sapevo da sempre
Bob Dylan
Jackie è all'Impero di Bra alle 20:20 e alle 22:30; al Fiamma di Cuneo alle 21:10.
Quattro funerali e due divorzi a Manchester (sul mare)
21-02-2017, 10:59cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, dialoghi, vita e mortePermalinkHai presente certi ceffi che vedi al bancone, nel tardo pomeriggio o se ripassi all'ora di chiusura, sempre una pinta davanti mezza vuota, hai presente quel tipo di espressione...
"Non fissarlo".
...ma è più una smorfia, di uno che la vita l'ha preso a legnate ma per qualche motivo si è dimenticato di darle il colpo finale, e forse la birra serve a questo, o a lenire il dolore, o a dormire senza sogni, chi può dirlo.
"È meglio se non lo fissi, dammi retta".
È che mi ricorda qualcuno.
"Casey Affleck in quel film?"
Oddio cosa mi hai fatto pensare.
"Con venti chili in meno, magari".
Che è il principale problema di quel film.
"Un problema? Che Casey Affleck è in forma?"
Sono contento per lui e il suo affezionato pubblico, ma interpreta un tizio che, hai presente la trama? Beve una birra all'ora almeno da dieci anni. E ancora ha una linea fantastica...
"Sarà la neve che spala dal suo abbaino".
...ed è il sogno erotico delle inquiline dei palazzi in cui lavora da tuttofare. Allora sì, dico che c'è un problema con i corpi che Hollywood presta al cinema d'autore. Non sono realistici, non mi parlano del mondo in cui abito, non ho niente contro Casey Affleck, gli auguro tutti i premi, ma sembra calato nel Massachusetts da un film di gangster, o di supereroi, è di nuovo lo stesso problema di Captain Fantastic: sono tutti troppo belli perché io me la beva. E bersela è un po' il senso di andare al cinema, no?
"La sospensione dell'incredulità".
Esatto.
"Adesso comincia a fissarti lui, vedi?"
Chissà che gli è successo, poveraccio.
"Non sono fatti nostri".
Perché invece quello che succede a Casey Affleck?
"Eh? Stai scherzando?"
No. Spiegami per quale motivo al mondo dovrei interessarmi all'elaborazione del lutto di Casey Affleck. Un lutto finto, tra l'altro. Come se non avessi già i lutti miei che mi danno da fare.
"Hai bevuto".
 |
| Questo in realtà è un altro film, ma è la foto più recente che ho trovato di Casey Affleck al bancone. |
"Senti. È un film che è piaciuto a tutti. A tutti, capisci?"
E beh certo, chi vuoi che si metta contro dei bambini morti (continua su +eventi!)
"Può sembrarti ricattatorio, ma è un fatto che film di questo tipo funzionino. Forse assolvono a una funzione catartica".
E allora dichiaro che con me non succede.
"Ma sarà un problema tuo, non di Lonergan".
Sono uscito con sette euro in meno e un magone in più. Non dico che mi ci sbronzavo con sette euro, ma poteva essere un buon inizio, no? Ma sul serio ma la gente normale non ce li ha i suoi morti da piangere, che ne deve prendere in prestito di finti al cinema? Non ci ha nessun amico o parente che ti tormenta nei ricordi? Ah ma io vi invidio a voialtri che nel tempo libero giocate all'elaborazione del lutto come se fosse un passatempo.
"Parla piano, adesso ci guardano tutti".
Che io posso capire Nanni Moretti. Perché alla fine ormai è uno che conosco. O almeno ci ha dato questa sensazione. Per cui se Nanni Moretti perdesse un figlio, o una moglie, o una mamma, o il cane, non è escluso che tra dieci anni ci faccia un film su quella volta che ha smarrito il cane, io però comunque ci vado perché, cosa vuoi che ti dica, anche quando non è in forma ormai è un conoscente, Nanni Moretti, e se sta male mi sento in dovere di starci un po' anch'io, funziona così. Non dico che abbia un senso, eh? Però funziona.
"Ma perché tiri fuori Nanni Moretti in birreria, dai..."
 |
| E poi il ragazzo è uno stronzetto insopportabile, lo vogliamo dire? |
"Va bene, adesso usciamo".
No aspetta voglio dire qualcosa a quel tizio che continua a fissarci.
"Ma sei tu che hai cominciato".
Infatti e adesso vado là e gli rompo il naso. Sembra che me lo stia chiedendo.
"Ma perché vuoi fare una cosa del genere, fammi il piacere".
Perché non posso romperlo a Lonergan, né ad Affleck, il quale peraltro me le darebbe indietro. Invece 'sto tizio è proprio appesantito il giusto, ehi scusa, tizio ci conosciamo?
"Manchester By The Sea è il film drammatico di Kenneth Lonergan in programmazione al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo alle 21. È candidato a sei Oscar, è molto triste ed è piaciuto a praticamente tutti"
No? E allora perché mi fissi, eh? Si può sapere?
L'ultimo romantico (spaccia crack ad Atlanta)
16-02-2017, 07:55cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, omofobie, razzismi, sessoPermalinkDa Miami ad Atlanta (Georgia) sono mille chilometri; da Atlanta a Miami sono nove ore di autostrada, e non c'è nessuno al mondo per cui le faresti stasera, o no? Forse per quel ragazzo che al liceo ti ha messo al tappeto, non lo vedi da allora. Probabilmente è ormai un'altra persona, come te. Ti sei impegnato, hai mollato la scuola e hai trovato qualcuno che credesse in te (l'hai trovato in galera, ma sputaci sopra). Hai messo i muscoli dove avevi i lividi, ora non scappi più dai bulletti di quartiere; hai una bella macchina e un paradenti a 24 karati, la gente ti saluta non ti mette fretta. Li hai messi tutti in fila, non devi più niente a nessuno.
Ma se ti chiamasse quel ragazzo tu non ripartiresti in dieci minuti? Il cuore in gola come una scolaretta?
Se solo fosse uscito qualche giorno prima, Moonlight sarebbe stato il film più romantico nelle sale italiane per San Valentino. Altro che le 50 sfumature, col loro sadomasochismo omeopatico per coppie etero che non sanno più che sesso fare. Persino il Panavision di La La Land sbiadisce di fronte a un film di soli maschi afroamericani (le donne in scena fanno solo le madri, con risultati molto discutibili): qui c'è gente che si tocca una volta ogni dieci anni e poi vive nel ricordo. L'omosessualità è l'ultima frontiera del romanticismo, lo si era capito con Adele: certe situazioni, certi sentimenti sullo schermo grande e piccolo ormai li tolleriamo soltanto se riferiti a una minoranza da tutelare. Le uniche storie d'amore che riusciamo a guardare sono quelle insolite, per esempio qui ci sono due bambini / ragazzi / uomini che ogni dieci anni devono trovare una scusa per toccarsi. All'inizio si può giocare alla lotta, è cosa nota; ma poi diventa sempre più difficile, e purtroppo il film è quasi tutto lì: Chiron guarda Kevin, Kevin guarda Chiron, parlano del più e del meno col lessico molto impacciato di chi ha finito gli studi in galera (se inghiotti un popcorn ogni volta che nella versione originale dicono "man" ti ammazzi), cercano scuse per non salutarsi e andare via, e tu sei lì davanti, un po' il terzo incomodo - che è quello che succede in tutti i film d'amore, no? Ma qui non finisce mai. Parlano, si guardano, si guardano, parlano - in Adele succedevano anche altre cose, per dire.
Il regista Barry Jenkins e il drammaturgo Tarell McCraney hanno avuto fortuna, o colto l'attimo: l'anno scorso, in pieno movimento Black lives matter, i giurati dell'Academy non sono riusciti a candidare un solo attore afroamericano. Ne è ovviamente seguita una polemica. Poi è arrivato Trump, l'America razzista - o come si dice adesso, alt-right - ha perso il voto popolare ma ha messo il suo ometto nella Casa Bianca. Aggiungi che per Hollywood non è stato un anno esaltante, e il risultato è che Moonlight, un film d'autore che in altre stagioni non sarebbe uscito dal circuito dei festival, ha fatto man bassa di nomination, e qualche statuetta facilmente la porterà a casa: anche perché i rivali principali sono La La Land, già accusato di speculare sulla musica nera e sbiancarla, e Mel Gibson coi suoi trascorsi indifendibili, ubriachezza molesta e antisemitismo. E va bene così, abbiamo visto film anche meno meritevoli, e se è stato un colpo di fortuna è bello pensare che ogni tanto baci pure gente come Barry Jenkins, che aveva fatto un solo film nove anni fa (apprezzato dai critici) e poi si era messo a fare il carpentiere (continua su +eventi!)
 |
| C'è anche Janelle Monàe, di mestiere è una cantante matta, ma qui fa una particina quasi normale. |
L'audace colpo dei soliti ricercatori
07-02-2017, 18:43cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, drogarsiPermalinkSono tornati, hanno ancora fame. Dopo essersi spinti ben oltre i limiti della legalità, dopo averne pagato le conseguenze con gli interessi, i Ricercatori hanno finalmente trovato un Ente statale che apprezza le loro straordinarie competenze. E ha un lavoro da offrire, capite? Un lavoro.
A progetto, naturalmente.
Senza assicurazione, beh, ovvio.
In nero, già. Di chi si tratta?
Della Polizia di Stato. Cosa hanno da perdere? Tutto.
Possono almeno smettere quando vogliono?
No.
Sono passati appena due anni - sembra un'era - da quando Sidney Sibilia, al suo esordio dietro la macchina, scoprì la formula che trasformava in action comedy una frustrazione tutta italiana (la fuga dei cervelli, il precariato dei ricercatori). Smetto quando voglio ci pigliò benissimo, era qualcosa di cui non sapevamo quanto avessimo bisogno, finché non l'abbiamo provato.
Da allora la situazione è parecchio cambiata. Mentre Sibilia riposava altri si sono inseriti nel mercato, mettendo in circolazione formule ancora più spinte. Jeeg Robot e Veloce come il vento non sono nemmeno più commedie, sono action e basta: le inevitabili tracce di parodia ridotte al minimo. Smetto quando voglio 2 accetta la sfida: volete l'action? Vi daremo inseguimenti nel parco archeologico e un assalto al treno merci in side-car, con scazzottata in cima ai vagoni. E questo è ancora niente, per la terza puntata ne abbiamo in serbo di fortissime... Per fortuna Sibilia è molto più consapevole dei propri limiti di quanto non appaia: sotto l'apparenza sbruffona c'è una precisa valutazione di quello che può funzionare e quello che sarebbe bello sulla carta, ma è meglio lasciar perdere. Per esempio a un certo punto ci porta a Bangkok, ci illude facendoci sentire odore di kickboxing, ci guida tra i meandri di un mercato e proprio quando sembriamo arrivati a un ring clandestino, taglia corto e la butta in farsa. Action sì, ma con criterio, certe competenze non s'improvvisano. La scena più simbolica è davvero l'inseguimento ferroviario, movimentato e complesso ma prudentemente mantenuto ai sessanta km all'ora. Più forte di così per ora il cinema italiano non può andare: è un problema? Per un regista italiano è già molto, come fai a prendertela con Sibilia? Dopo un inverno di cinepanettoni, cinepandori, cinetorroni, i suoi ricercatori-supereroi sembrano venire da un altro pianeta. Lui stesso sembra sapere che i suoi clienti gli permetteranno qualsiasi cosa e ormai si comporta da impunito, scherza coi feticci del Terzo Reich, flirta col proibizionismo ma solo per far andare avanti la trama. Per quanto ispiri simpatia, si merita d'essere preso sul serio, perché è vero che ha già fatto tanto per l'ecosistema del cinema di genere italiano, ma con un piccolo sforzo potrebbe fare anche di più.
 Per esempio: c'era proprio bisogno di ampliare il cast? (Continua su +eventi!) Certo, siamo tutti contenti di vedere Giampaolo Morelli nella banda, ma ormai a ogni comprimario spetta poco più che un siparietto (mentre per paradosso il ruolo di Edoardo Leo diventa ancora più centrale). E se allargare la squadra era l'unico modo per mantenere alto il ritmo, possibile che anche stavolta non ci fosse posto per una ricercatrice? Forse che di studiose super-specializzate e sotto-occupate l'Italia non abbonda? Ecco, un rilievo che si può fare a Smetto quando voglio 2, è che per quanto ammicchi a prodotti americani come Suicide Squad e Ritorno al futuro, non riesce del tutto a uscire dal solco di Amici miei o dei Soliti ignoti: la sua Banda di intellettuali declassati continua ad assomigliare a una cumpa di amici in libera uscita. Un gruppo di soli uomini che fanno per lo più le cose stupide che fanno gli uomini quando escono da soli: zingarate, corse in furgone, droghe di sintesi.
Per esempio: c'era proprio bisogno di ampliare il cast? (Continua su +eventi!) Certo, siamo tutti contenti di vedere Giampaolo Morelli nella banda, ma ormai a ogni comprimario spetta poco più che un siparietto (mentre per paradosso il ruolo di Edoardo Leo diventa ancora più centrale). E se allargare la squadra era l'unico modo per mantenere alto il ritmo, possibile che anche stavolta non ci fosse posto per una ricercatrice? Forse che di studiose super-specializzate e sotto-occupate l'Italia non abbonda? Ecco, un rilievo che si può fare a Smetto quando voglio 2, è che per quanto ammicchi a prodotti americani come Suicide Squad e Ritorno al futuro, non riesce del tutto a uscire dal solco di Amici miei o dei Soliti ignoti: la sua Banda di intellettuali declassati continua ad assomigliare a una cumpa di amici in libera uscita. Un gruppo di soli uomini che fanno per lo più le cose stupide che fanno gli uomini quando escono da soli: zingarate, corse in furgone, droghe di sintesi.Non è che le donne del film siano stupide, tutt'altro: ma rappresentano una forza ostile che espone la Banda a tensioni distruttive. Greta Scarano (meravigliosa) è la poliziotta senza molti scrupoli che approfitta dei Ricercatori come un qualsiasi barone universitario; Valeria Solarino interpreta in modo sempre più arcigno il Principio della Realtà, pretendendo dal protagonista una normalità impossibile: quando lei è in scena anche il filtro del colore si deprime. E tra i pochi personaggi che non ritornano nel secondo episodio purtroppo c'è la moglie sinti dell'economista De Rienzo. Sarà un pelo nell'uovo, ma siamo nel 2017, persino quel burino di Luc Besson ha capito che i film d'azione oggi si fanno coi protagonisti femminili; e noi ancora stiamo alla moglie col pancione che si lamenta delle rate sulla lavastoviglie, pretende che il marito chimico-spacciatore-informatore faccia il buon marito e l'accompagni alle ecografie anche se è detenuto. E dire che sarebbe bastato aggiungere un'architetta geniale, o una psicologa, un'esperta di biotecnologie, ce n'erano dei rami da coprire. Speriamo nel terzo episodio: e che anche dopo nessuno abbia troppa voglia di smettere. Smetto quando voglio 2 - Masterclass è al Cityplex di Alba (19:30; 21:30); al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:00; 22:30); al Vittoria di Bra (21:00); ai Portici di Fossano (21:15); all'Italia di Saluzzo (17:00; 20:00; 22:15 e al Cinecittà di Savigliano (20:15; 22:30).
La La La ti sento eccome
02-02-2017, 02:51cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, musica, nostalgiaPermalinkLa La Land (Damien Chazelle, 2016)
"Buongiorno in cosa posso esserle utile?"
"Buongiorno, io... io ho visto La La Land".
"Allora ha chiamato il numero giusto, questo è..."
"E non m'è piaciuto!"
"...il numero verde per gli spettatori di lingua italiana a cui non è piaciuto. Noi offriamo assistenza a tutti quelli che si domandano..."
"C'è qualcosa che non va in me?"
"Assolutamente no, signora. È una questione di gusti".
"Ma è piaciuto a tutti tranne che..."
"No, signora, stia tranquilla, non è piaciuto a tanta gente. È normale".
"Anche se ammetto che certe cose erano davvero ben fatte, eppure..."
"Siamo lieti che lo valuti positivamente e la ringraziamo per il feedback. Ha avuto anche lei la sensazione che nelle sequenze iniziali la macchina da presa facesse parte della coreografia?"
"Può darsi. Ma non mi è piaciuto lo stesso!"
"Forse non le interessano i musical".
"Non saprei".
"Ha apprezzato altri musical di recente?"
"Io, boh... una volta ho visto Cantando sotto la pioggia..."
"Beh, se ne doveva scegliere uno solo, ha scelto bene".
"...e non c'è paragone".
"Allora vede, signora, forse lei è entrata in sala con aspettative eccessive, perché quando parliamo di Cantando sotto la pioggia siamo proprio al top di gamma, capisce? Sarebbe un po' come aspettarsi 2001 Odissea nello spazio tutte le volte che si va a vedere un film di fantascienza".
"Ed è sbagliato?"
"Non c'è nulla di giusto o di sbagliato, ma forse gioverebbe tenere l'asticella un po' più bassa, rimediare meno delusioni. Al cinema come nella vita".
"Comunque adesso che ci penso è davvero da tanto che non vedo un musical".
"In Italia fanno fatica. Ha presente Sweeney Todd?"
"No".
"Dieci anni fa. Forse l'ultimo Tim Burton importante. 150 milioni al botteghino, nomination a Johnny Depp".
"E in Italia non l'hanno distribuito?"
"Certo. Ma si erano dimenticati di avvertire che era un musical".
"Sul serio?"
"Nei trailer italiani i personaggi non cantavano. Allora forse, mi dico, forse, se attiri al cinema la gente e non l'avverti prima che i personaggi canteranno tutto il tempo, poi è naturale che ci restino male e detestino i musical".
"Ma perché ce l'avremmo coi musical, noi italiani?"
"Chi lo sa. Cocciante è andato in Francia. E Tano da morire? Nessuno si ricorda più di Tano".
"Forse è il rigetto per due secoli di melodramma, dobbiamo espiare per quanto abbiamo stressato il mondo con la Butterfly e la Traviata".
"Più probabilmente è un problema di doppiaggio. Il momento in cui gli attori passano dal recitativo al cantato è molto delicato. Se proprio in quel momento sente cambiare il timbro di voce e la lingua, magari la sospensione di credulità ne soffre e non riesce ad apprezzare il film".
"Ma l'ho visto in lingua originale!"
"Forse si è affaticata leggendo i sottotitoli. La gente è convinta di poter vedere un film e intanto leggere i sottotitoli, ma è più faticoso di quanto sembra":
"Dice che è per questo che a metà del secondo tempo stavo per addormentarmi?"
"Il calo di tono è necessario, fisiologico - sarebbe insostenibile un film tutto coreografato come la prima mezz'ora. Ed è perfettamente previsto dalla storia: prima ci si innamora ed è tutto bellissimo e promettente, e poi... le complicazioni".
"Niente di nuovo insomma".
"No, decisamente no. Ma credo fosse già chiaro dai manifesti, no? È un film sulla nostalgia".
"Ecco, forse sono stanca di tutti questi film nostalgici".
"Mi permetto di dissentire. È un film sulla nostalgia, non è un film nostalgico. Usa il passato in modo funzionale, per ottenere determinati effetti. Non prova neanche per un attimo a convincerti che esisteva davvero un paradiso perduto di gente felice e di oggetti belli".
"I vinile, i vecchi cinema che chiudono, la macchina di James Dean, il jazz fino a Miles Davis..."
"Ok, c'è un personaggio che è un maniaco di queste cose. Ma alla fine tutte queste ossessioni gli si ritorcono contro - anzi, no, sin dall'inizio. Mi sembra lo stesso problema che avevano alcuni con Whiplash: aiuto, c'è un protagonista che sacrifica gli affetti alla carriera! Sì, ma non è mica un personaggio così positivo. Neanche Gosling in questo film lo è".
"Un bianco che spiega il jazz ai neri".
"Per la verità è il contrario; è l'amico nero che gli spiega cos'è veramente il jazz: una continua evoluzione. Mentre lui sembra bloccato nella fase puberale. Ha perfettamente senso che sia bianco, a proposito. L'hipsterismo contemporaneo è roba da giovani bianchi benestanti. L'idea che il jazz coincida con la sua Storia, e che abbia un'età dell'oro, dell'argento, il bebop il cool il free e la Caduta, è una menata da critico bianco. Si ricorda Denzel Washington in Mo' Better Blues..."
"Vagamente".
"...che suona la tromba in una band post-bebop e si domanda: dove sono i fratelli? Perché ci vengono a sentire solo i bianchi? Insomma signora, le può dispiacere La La Land per un migliaio di motivi, ma un tizio che ascolta i vinile, si crede James Dean e si offende perché servono tapas in un locale di samba dev'essere bianco. Ma diciamola tutta. Dev'essere Ryan Gosling".
"Anche se non balla un granché bene".
"Ma ne è sicura?"
"Un po' legnoso".
"Ma signora, aveva detto che a lei non piacciono i musical, è sicura di poter giudicare la prestazione di Ryan Gosling? Di sicuro non è Fred Astaire, ma balla in modo più che passabile e ha una voce educata e gradevole. In più è perfetto per la parte, insomma, è sicura che avrebbero mai potuto trovare di meglio?"
"A questo punto mi aspetto che difenda anche Emma Stone".
"Beh, sì, è perfetta. Cioè, no, è proprio la sua imperfezione che la rende... perfetta per la parte. È una che non sei mai sicuro se ce la farà. Quando intona, quando parte a ballare, quando è a un provino, è sempre sull'orlo del baratro. E se ne rende conto. È una scelta ottima, davvero".
"E anche lei doveva essere bianca per forza?"
"Anche su questa cosa, ci ho riflettuto".
"Addirittura". (Continua su +eventi!)
"Perché se lo sono chiesto in tanti, ma il punto è questo: se avessero scelto un'attrice brava come lei, imperfetta come lei... però nera, le stesse scene avrebbero lo stesso senso? Quando passa di provino in provino e la scartano e ne minano l'autostima: funzionerebbe ugualmente? Non cominceremmo a sospettare che la scartano perché è nera? È un film sull'autoaffermazione, non sulla discriminazione".
"Magari a me interessa di più la discriminazione".
"Ha perfettamente ragione, è un tema più interessante".
"Cioè tutti questi film sulla gente che crede nei loro sogni, anche basta".
"Comprendo il suo fastidio, è un segmento molto coperto".
"Non ci sono già abbastanza talent in tv?"
"E tuttavia, signora, nel frattempo un tizio che faceva il giudice in un talent ha vinto le elezioni americane e sta alla Casa Bianca, per cui forse La La risente molto più dello spirito del tempo di quanto crediamo".
"Sta cercando di convincermi che La La può spiegarci Trump?"
"No, ma non è neanche quella fuga in un passato rassicurante che finge di essere... magari ti piazza un finale falso, un balletto in cui tutte le cose per un momento vanno per il verso giusto, ma la morale è molto meno edificante - ed è la stessa di Whiplash: uno su mille ce la fa ma poi passa la vita a domandarsi se ne valeva la pena".
"Non l'ho visto, Whiplash".
"Vale la pena. Non è un musical. Non c'è nemmeno una storia d'amore. Ha presente quando il maître del ristorante licenzia Gosling su due piedi? Ecco, Whiplash è tutto così, dura un'ora e mezza, è divertente e un po' angoscioso".
"E non balla nessuno".
"Suonano soltanto. Ma signora, le canzoni di La La non le sono piaciute? Secondo me sono la cosa migliore".
"Non credo di apprezzare il jazz".
"Non sono poi così jazz. Dica la verità, non le sta già canticchiando? Sono maledettamente orecchiabili. Tutt'altro che banali, eppure neanche così complesse. City of Stars è un classico immediato, si fischietta al primo colpo, la puoi imparare alla quinta lezione di pianoforte, ne scrivono una ogni vent'anni di canzoni così. Cioè bravo Chazelle, ma soprattutto Justin Hurwitz. Quando hai un talento del genere puoi anche concederti il lusso di metterti in discussione, di domandarti se è giusto insistere su un sound così fuori dal tempo. Perché il film fa questo: si presenta dicendo, ehi, abbiamo un'idea di jazz che forse è quella sbagliata, però sentite intanto cosa siamo riusciti a combinarci".
"Va bene, Hurwitz probabilmente un Oscar se lo merita".
"Grazie, signora".
"Ma altri tredici, dico, scherziamo?"
"Sono solo nomination".
"Non è mica Eva contro Eva".
"No, senz'altro no. Anche se il tema è simile - i giurati hanno un debole per i film che parlano della loro professione. Forse ha preso tante nomination perché oggi c'è meno competizione, tante professionalità si stanno spostando sulle serie tv... è un'ipotesi. Senz'altro La La è una risposta alla domanda: perché andare in sala oggi, perché non guardarsi un film a casa? La La va proprio visto in sala. Deve venirti voglia di smontare le poltrone".
"Eh?"
"Come ai tempi di Blackboard Jungle, ha presente? La gente entrava per ballare i titoli - che erano Rock Around the Clock, l'unico pezzo rock che si potesse sentire in città - smontavano le poltrone e si mettevano a ballarlo. Anche la prima sequenza di La La Land funziona così, in fondo".
"È uno scherzo, vero?"
"Sia sincera. Non le è venuta voglia di smontare le poltrone durante Another Day of Sun?"
"Mi è venuta voglia di uscire".
"Ecco, allora... non so che dire... mi dispiace".
"Non si deve dispiacere, sto a posto così".
"Pensa che lo scriverà su facebook?"
"Perché me lo chiede?"
"Perché è stato osservato questo fenomeno. Quelli a cui non piace La La sentono l'irrefrenabile desiderio di dichiararlo su facebook".
"E... nell'eventualità, diciamo, che male ci sarebbe?"
"Provo con un esempio. Io non riesco a mangiare la nutella".
"È una questione di gusti".
"No. La nutella è buona. È progettata per piacere a tutti. Piace praticamente a tutti. Ma io sono allergico alle nocciole".
"Oh, mi dispiace".
"Ecco, vede che le dispiace?"
"Non dovrebbe dispiacermi? Ho pietà di lei, non apprezzare la nutella è..."
"Lo dica".
"...una menomazione".
"Ecco. Ma si immagini che io scrivessi su facebook che schifo la nutella, che ne facessi una questione di orgoglio, cioè mica come tutti i pecoroni convinti di apprezzare una crema spalmabile di cioccolato e nocciole solo grazie al marketing... solo io sono in grado di capire che in realtà quella roba fa schifo: cosa penserebbe di me?"
"Che ha una notevole autonomia di giudizio..."
"Mmm"
"Per un tredicenne, voglio dire".
"Ecco, appunto".
"Appunto cosa?"
"Signora, non c'è niente di male a non apprezzare i musical, a non aver voglia di saltare le poltrone quando cantano reaching up the heights. Ma non c'è nemmeno nulla di cui vantarsi, capisce?"
"No".
"Fa lo stesso. Adesso scusi, questo spazio è gentilissimamente offerto da Piùeventi Cuneo e quindi ora devo dare i titoli: La La Land è anche stasera al CITYPLEX CINE4 di Alba (21:00), al CINELANDIA di Borgo San Dalmazzo (20:00, 22:40), al CINELANDIA FIAMMA di Cuneo (21:10), ai PORTICI di Fossano (21:15) e al CINECITTÀ (Savigliano). Buona visione, e smontate quelle fottute poltroncine!"
"Io non ci torno".
"Non me ne frega niente di quello che fa lei signora".
Dio è morto, il Giappone è una palude, e Scorsese sta benissimo
27-01-2017, 18:30cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, cristianesimoPermalinkSilence, (Martin Scorsese, 2016).
Verso il 1650 cominciò a girar voce che Sawano Chūan, già conosciuto come Cristóvão Ferreira, fosse morto: e prima di morire avesse ritirato la sua scandalosa apostasia, e proclamato a gran voce davanti all'inquisitore del Giappone la sua fede in Cristo, che 15 anni prima aveva rinnegato. Per questo era finalmente stato condannato al supplizio del pozzo: sospeso a testa in giù e dissanguato lentamente. La solita propaganda dei gesuiti: chi andò a controllare scoprì che Sawano-Cristóvão aveva avuto un funerale buddista, presso il tempio che aveva scelto conformemente alle leggi dello shogunato. Il suo nome giapponese si legge ancora sulla lapide. Forse in segreto continuò a credere nel dio cristiano per tutto quel tempo: ammesso che si possa credere a un Dio in segreto. C'è chi non lo ritiene possibile.
 |
| Un vero fumie: il volto di Gesù è consumato dalle centinaia di piedi che lo hanno calpestato |
Eppure Silence non è il film che il pubblico si aspetta da lui - men che meno i giurati dell'Academy, che in fondo hanno sempre diffidato di questo corpo esterno, questo seminarista fallito e riconvertito al cinema. Il film sembra concepito per confondere e tradire gli spettatori che abbiano una fede superficiale nel suo cinema. Scorsese li attende silenzioso al termine di un lungo viaggio in un Giappone antipittoresco, e dopo due ore e mezza non ha ricompense da offrire a chi lo trova: solo silenzio. Può darsi che non sia il suo migliore film. Neanche tra i suoi primi dieci film. Ma anche quando tace e prega, può tranquillamente dare lezioni di cinema e vita a chiunque sia disposto a imparare. Più che con altri suoi film, trovo inevitabile confrontarlo con quello che passano gli altri conventi: per esempio giusto un anno fa stavamo tutti applaudendo per Revenant. Anche quello un film lungo e senza compromessi, anche quello ambientato in un paesaggio naturale alieno, ostile, e ispirato a un fatto vero.
È un confronto impietoso (continua su +eventi!).
 |
| Un crocefisso abusivo, nascosto dietro la schiena di un Budda |
Sbarrando gli occhi durante la visione di Revenant riesci a vedere un regista milionario sul suo patio che si domanda cosa allestire per il pubblico bue e ai giurati degli Oscar: una storia di vendetta? Però nel finale bisogna ricordarsi che la vendetta è brutta, al massimo va subappaltata al buon selvaggio che resta buono anche quando scalpa un potenziale ladro di terra. Silence è un film che parla a ogni persona che ha cercato Dio e non l'ha trovato, o l'ha perso nel silenzio: è il regalo umile e superbo di un gesuita mancato che passa il tempo a tormentarsi: se soltanto fossi nato in tempi più semplici, con meno tentazioni in giro, meno droghe e meno macchine da presa... che gran cristiano che sarei stato.
Andrew Garfield oscilla continuamente tra l'imitazione di Cristo e la sua parodia: desideroso di seguire i suoi maestri, precipita in un sadico vangelo al contrario dove i buoni forse sono buoni per il motivo sbagliato, e i cattivi molto più ragionevoli, ma spietati proprio per questo. Cristo è un amico immaginario che ti porta davanti al baratro fra tortura e dannazione e ti lascia lì senza spiegarti niente, devi cavartela da solo. Scorsese non ha risposte, o non ce le vuole dire, e se le porterà con sé fino all'ultimo giorno.
Silence è alla Sala Polivalente di Piasco (21:10) e al Cinema Italia di Saluzzo (20:30).
Io e te, alieno, cosa abbiamo da dirci?
23-01-2017, 23:24cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, futurismi, scienzaPermalinkTi trovi in mezzo a un prato, o a un bosco, o un deserto, quando ti imbatti negli alieni. Come fai a presentarti, diciamo, come un animale raziocinante, abbastanza degno di un tentativo di comunicarci, piuttosto che d'essere sezionato o servito a cena? Il teorema di Pitagora potrebbe aiutarci anche in questo. Un animale che sappia disegnare per terra un quadrato dell'ipotenusa uguale alla somma dei quadrati dei cateti non dovrebbe essere considerato selvaggina. Matematica e scienza saranno il nostro terreno d'incontro obbligato: "triangoli", "cateti", "ipotenusa", "uguale", "quadrati", sono concetti che dovrebbero esistere in qualsiasi parte di questo universo, ed è molto difficile che una razza senziente riesca a viaggiare nello spazio senza averli scoperti e codificati.
Questo ottimistico punto di vista è ben espresso da un racconto del 1957, Omnilingual, in cui i fanta-archeologi che trovano su Marte resti di una civiltà avanzata estintasi millenni fa brancolano nel buio dei simboli finché non trovano, appesa a una parete, una tavola degli elementi: la Stele di Rosetta. Solo il collega più anziano, esperto di Ittiti e non di particelle, osa formulare il dubbio cosmico: Come facciamo a essere sicuri che i 'loro' elementi non siano diversi dai 'nostri'? La nuova generazione gli ride in faccia: nonno, posa il tuo relativismo umanistico. Che sia Marte o Alfa Centauri, l'idrogeno avrà sempre un protone. Le cose non possono essere più complicate di così. O no?
Storia della tua vita, il racconto di Ted Chiang che ha ispirato Arrival, mette appunto in crisi questo approccio. E se la scienza degli alieni fosse diversa dalla nostra? Se il calcolo integrale per loro fosse facile come le tabelline, e le tabelline viceversa calcoli astrusi e poco familiari? In teoria dividiamo lo stesso universo. Ma se avessimo una percezione dello spazio-tempo completamente differente? Che casino sarebbe... (ma che rivincita per il relativismo umanistico).
 |
| Questo per esempio è molto ingenuo. Come fai a dare per scontato che distinguano il nero dal bianco e lo considerino un simbolo? |
E se anche per gli alieni non esistesse il "prima" e il "dopo" degli umani? In questo caso la domanda più banale ("perché siete qui?"), sarebbe anche la meno comprensibile: potrebbe esistere un "perché" in un mondo in cui potessimo vedere ogni cosa già conclusa prima che accada? In altre parole: nella realtà descritta dal principio di Fermat, e dagli altri principi variazionali, ha ancora senso parlare di libero arbitrio? Non solo gli alieni non saprebbero fornirci un perché, ma anche noi umani dovremmo domandarci se i perché hanno un senso. Tutto accade nello stesso momento, e se potessimo vedere la nostra morte - come gli alieni - non potremmo comunque impedirla. È lo stesso Chiang a proporci una metafora: vivere oltre il tempo è come avere un figlio. Nel momento in cui lo concepisci sai già che soffrirà, ma non si torna indietro. Lui non ha scelto di vivere, e nemmeno tu in fondo hai potuto scegliere che nascesse.
 Questo parallelismo non così banale - il figlio come un alieno, o forse gli alieni sono i nostri padri che non possono e vogliono dirci perché ci hanno messi al mondo? - è quello che ha probabilmente conquistato lo sceneggiatore Eric Heisserer, e spinto a scrivere un copione che senza il successo di blockbuster come Interstellar o Gravity sarebbe rimasto un'idea folle, una sceneggiatura vagante nello spazio cosmico. Heisserer purtroppo ha tolto ogni riferimento a Fermat e inserito l'arrivo degli alieni in una specie di gelida parodia di Independence Day - qualcosa che in effetti Denis Villeneuve poteva aver voglia di girare (memorabile una delle prime sequenze, dove il panico mondiale viene descritto nel modo più quotidiano e canadese possibile: in facoltà gli studenti disertano le lezioni, due macchine si tamponano in un parcheggio. E col panico per questo film siamo a posto). Arrival è, come Sicario, il viaggio di una donna curiosa e competente alla scoperta di una dimensione nuova del mondo. Per il regista non è importante soltanto l'arrivo, ma anche le piccole cose che fanno il viaggio: i corridoi, i briefing, il silenzio già complice dei compagni appena conosciuti.
Questo parallelismo non così banale - il figlio come un alieno, o forse gli alieni sono i nostri padri che non possono e vogliono dirci perché ci hanno messi al mondo? - è quello che ha probabilmente conquistato lo sceneggiatore Eric Heisserer, e spinto a scrivere un copione che senza il successo di blockbuster come Interstellar o Gravity sarebbe rimasto un'idea folle, una sceneggiatura vagante nello spazio cosmico. Heisserer purtroppo ha tolto ogni riferimento a Fermat e inserito l'arrivo degli alieni in una specie di gelida parodia di Independence Day - qualcosa che in effetti Denis Villeneuve poteva aver voglia di girare (memorabile una delle prime sequenze, dove il panico mondiale viene descritto nel modo più quotidiano e canadese possibile: in facoltà gli studenti disertano le lezioni, due macchine si tamponano in un parcheggio. E col panico per questo film siamo a posto). Arrival è, come Sicario, il viaggio di una donna curiosa e competente alla scoperta di una dimensione nuova del mondo. Per il regista non è importante soltanto l'arrivo, ma anche le piccole cose che fanno il viaggio: i corridoi, i briefing, il silenzio già complice dei compagni appena conosciuti.Purtroppo dopo il momento della scoperta, bisogna anche far succedere delle cose, e Heisserer non è stato all'altezza del compito (continua su +eventi!)
Le intenzioni erano buone - aggiungere alla storia di Chiang quel minimo sindacale di conflitto, di action, persino di esplosioni che potevano rassicurare i produttori e fornire immagini seducenti per i trailer. Così abbiamo gente che mette le bombe perché "ha visto troppi film", abbiamo un generale cinese che vuole attaccare le astronavi (è abbastanza indicativo che i militari americani necessitino per comprenderlo della consulenza della stessa linguista che sta decifrando la lingua degli alieni). Il film non mette i cinesi tra i cattivi, ma quantomeno deve assumere che siano più impulsivi e timorosi degli americani - anche perché invece di cercare di tradurre gli stranieri, si sono messi a giocarci a mahjong (idea geniale, che nel racconto non c'era e che purtroppo è buttata lì un po' in fretta).
Il risultato è un po' una delusione, anche per le attese che questo film era riuscito a suscitare nella prima parte. Ma è giusto prendersela con Heisserer e Villeneuve per aver omesso il principio di Fermat? In generale, possiamo far loro una colpa dell'aver semplificato la storia fino a farla pericolosamente assomigliare a una baracconata new age con gli alieni onniscienti che vengono a regalarci la chiave della trascendenza? È un film di Villeneuve, senz'altro inferiore a Sicario ma con la stessa capacità di fondere l'intimo e il sublime. Ma è anche un film di fantascienza hard, che con la scusa degli alieni ti parla di linguistica e spaziotempo per un'ora e mezza; è un film tratto da un racconto che solo un pazzo poteva pensare di trasformare in pellicola, e Villeneuve sta riuscendo perfino a guadagnarci; insomma è un oggetto straordinario, che dimostra l'ottimo stato della fantascienza al cinema; che fino a tre o quattro anni nessun produttore sano di mente avrebbe pensato di finanziare e invece oggi eccolo qua; e chissà cos'altro arriverà domani, visto che film di questo genere non soltanto si fanno, ma incassano pure. Villeneuve andrebbe soltanto ringraziato per il dono che ha fatto all'umanità, invece di mettersi anche lui a macinare le solite storie viste e riviste, i soliti sequel e i soliti remake. Chissà cosa farà adesso.
"Blade Runner".
"Eh?"
"Sta facendo un Blade Runner".
"Ah".
"Ma in fondo era inevitabile".
"Era inevitabile dall'inizio".
Arrival è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:10, 22:40); al Vittoria di Bra (21); al Multilanghe di Dogliani (21:30); al Cinecittà di Savigliano (20:15, 22:30)
Brad Pitt, spia imperfetta (per fortuna)
17-01-2017, 16:55cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkA un certo punto - non rivelo nessun punto saliente della trama - Brad Pitt e Marion Cotillard stanno scappando in automobile. Brad si ferma un attimo davanti a un negozio perché deve sistemare una questione. Marion lo aspetta a bordo, con la bambina in braccio. Lui ha promesso di far presto, invece ci sta mettendo un po', e quindi lei non sa che fare. Non può entrare con la bambina, non può restare ferma lì. Dentro il negozio in effetti stanno succedendo delle cose, ma niente che non accada tipicamente nei film: rivelazioni, sparatorie. Soltanto un pretesto. Quello che veramente importa è nell'auto: l'attesa, l'angoscia, la bambina che è insieme un ostacolo e il senso di tutto quello che sta succedendo.
A un certo punto pensavamo di aver perduto Robert Zemeckis. Il regista di Ritorno al futuro 2, di Roger Rabbit, della Morte ti fa bella, aveva deciso di concentrarsi sull'animazione, e in particolare di quella branca dell'animazione in digitale che fin qui ha dato a investitori e spettatori meno soddisfazioni: la performance capture. Polar Express e A Christmas Carol erano due esperimenti freddissimi, come certe feste organizzate più per dimostrare le proprie capacità che per mettere a proprio agio gli invitati. La performance capture non è né animazione disegnata né realtà filmata: è una sfida della tecnologia digitale a entrambe. Un giorno vincerà, e gli attori saranno sostituiti da manichini digitali assolutamente identici ai modelli. La carriera delle star degli ultimi trent'anni (una generazione già longeva di suo) si prolungherà di qualche secolo: che bisogno c'è di cambiare le facce quando il pubblico è già affezionato a quelle vecchie? Qualche attore ringiovanito digitalmente lo abbiamo già visto. La scelta della Walt Disney, che dopo la morte di Carrie Fisher ha deciso di non utilizzare più la sua versione digitale, non ci incanta: ci aspettano altri cent'anni di Tom Cruise, di Di Caprio, di Matt Damon. Persino di Brad Pitt.
 |
| Non tanto l'uso del green screen, quanto il voler farcelo notare. |
Qualche volta azzecca il prodotto giusto, qualche volta rimane impantanato in un disastro (World War Z), ma ne esce sempre abbastanza dignitosamente. Dall'incontro con Tarantino sembra che abbia sviluppato un'ossessione per la Seconda Guerra Mondiale che in realtà ha perfettamente senso: ai film di guerra servono eroi tutto d'un pezzo, non troppo dinamici, meglio se laconici e imbronciati. Senz'altro gli anni '40 sono più congeniali a Pitt di un'apocalisse zombie o dell'assedio di Troia. La spia di Allied è in un qualche modo complementare al capitano del tank di Fury: tanto quest'ultimo era rassegnato a non sopravvivere alla distruzione di cui ormai faceva parte, tanto il primo si ostina a difendere un'oasi domestica di pace che forse era una menzogna sin dall'inizio: un picnic sul prato dove nottetempo è precipitato un bombardiere. È una spia fragile, in un mondo che non tollera debolezze.

A un certo punto la Disney ha chiuso lo studio di performance capture fondato da Zemeckis, dopo averlo rilevato: e il regista si è rimesso a fare film dal vivo. Questo almeno è quello che ci fanno credere. Ma Flight e Allied sono film strani proprio perché insolitamente convenzionali. È difficile spiegare perché, malgrado abbiano tutto quello che ti aspetti da un film, non sembrino veri film, sembrino... finti. Ma tutti i film sono finti, no? Sulla carta Allied è l'ennesima rivisitazione di luoghi comuni del film di spionaggio ambientato negli anni della guerra, con le suggestioni del caso: Orson Welles, Hitchcock, Casablanca. Sullo schermo... c'è qualcosa che non torna, ma è difficile dire cosa. Ci sono sfondi straordinari che è inevitabile immaginare rifatti al computer. C'è un senso della composizione che vince sulle necessità narrative (eppure la storia funziona, e avvince). C'è ancora qualche traccia di quel senso di freddezza che si provava davanti a Polar Express e a Christmas Carol. E infine, ci sono Marion Cotillard e Brad Pitt, in diverse scene le uniche due persone a sembrare vere nell'inquadratura: salvo che appunto, lei è troppo perfetta per esserlo davvero. Solo Pitt, con la sua faccia tirata, sembra garantirci che Zemeckis non lo abbia già sostituito col replicante digitale di sé stesso, che Allied non sia che un colossale scherzo tirato agli spettatori.
A un certo punto la performance capture vincerà: gli archivi di tutto il mondo forniranno agli sviluppatori tutte le fisionomie e le espressioni degli attori più importanti, e finalmente li vedremo interpretare qualsiasi ruolo nell'interpretazione migliore possibile, secondo algoritmi sempre più sofisticati. Ogni tanto magari qualche attore vero insisterà per recitare la sua parte sullo sfondo verde, e come faremo a capire che anche quell'attore non è una rielaborazione digitale? Lo noteremo dai difetti, come notiamo Brad Pitt. Che non è mai perfetto, e a un certo punto abbiamo capito che gli vogliamo bene proprio per questo.
Allied è al Cinecittà di Savigliano (21:30); al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:00, 22:40); al Citylplex di Alba (19:30, 22:00); all'Italia di Saluzzo (17:00, 21:30); al Vittoria di Bra (21:00)
Diventare mostri a Teheran
11-01-2017, 18:29cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink Rana una sera era stanca. Il trasloco, le prove a teatro fino a tardi. Era appena arrivata nel nuovo appartamento, aveva ancora il trucco addosso e voleva fare una doccia. Il citofono ha suonato e lei ha aperto. Ma non era suo marito. Sono incidenti che purtroppo capitano dappertutto: perché non a Teheran?
Rana una sera era stanca. Il trasloco, le prove a teatro fino a tardi. Era appena arrivata nel nuovo appartamento, aveva ancora il trucco addosso e voleva fare una doccia. Il citofono ha suonato e lei ha aperto. Ma non era suo marito. Sono incidenti che purtroppo capitano dappertutto: perché non a Teheran?A Cannes l'anno scorso c'è stato il festival del degrado urbano cinematografico. In una botta sola Mungiu (Bacalaureat), Ken Loach (Daniel Blake), i fratelli Dardenne e l'ultimo ottimo film di Asghar Farhadi - premiato per la migliore sceneggiatura. Nel complesso, un tripudio di marciapiedi crepati, piastrelle sbeccate, ruggine e polvere, sulla Croisette vanno pazzi per queste cose e un po' li capisco, tutti quegli yacht ancorati proprio dietro il Palazzo del Cinema dopo un po' ti devono venire a noia.
 Forushande condivide con Bacalaureat non solo la premessa iniziale - un caso di molestia sessuale, un capofamiglia che cerca di farsi giustizia da solo - ma anche questo torvo accanimento nell'esibire la bruttezza delle periferie. Se Mungiu si dedicava a sbriciolare ogni residuo esotico della Transilvania, portandoci a spasso per i sobborghi sconsolati di Cluj-Napoca, Farhadi ha un gusto per lo squallore, il cemento, la paccottiglia ammassata in un angolo che degrada in rifiuto, che lo innalzano sopra ogni confine culturale. Non importa se là fuori c'è un muezzin che invita alla preghiera, le targhe sono in alfabeto arabo; basta accendere la luce nella cucina di una casa sfitta, ingiallita dall'uso, ed è come se il film parlasse di noi.
Forushande condivide con Bacalaureat non solo la premessa iniziale - un caso di molestia sessuale, un capofamiglia che cerca di farsi giustizia da solo - ma anche questo torvo accanimento nell'esibire la bruttezza delle periferie. Se Mungiu si dedicava a sbriciolare ogni residuo esotico della Transilvania, portandoci a spasso per i sobborghi sconsolati di Cluj-Napoca, Farhadi ha un gusto per lo squallore, il cemento, la paccottiglia ammassata in un angolo che degrada in rifiuto, che lo innalzano sopra ogni confine culturale. Non importa se là fuori c'è un muezzin che invita alla preghiera, le targhe sono in alfabeto arabo; basta accendere la luce nella cucina di una casa sfitta, ingiallita dall'uso, ed è come se il film parlasse di noi.Sta davvero parlando di noi... (continua su +eventi!) che a volte siamo distratti e non alziamo la cornetta del citofono e poi ce ne pentiamo. Che a volte iniziamo a lucidare una finestra e poi ci blocchiamo sgomenti constatando l'enormità del compito. Che vorremmo essere migliori del mondo in cui viviamo, ma sarà vero? Se avessi un bulldozer tirerei giù tutto quanto e lo rifarei da capo, dice Emad al suo amico regista, più anziano. Lo hanno già fatto, risponde lui: e questo è il risultato. Emad è il protagonista (Shahab Hosseini, palma a Cannes): è un giovane insegnante, generoso, colto, recita a teatro, ci sembra naturale assistere alla storia dal suo punto di vista. Che possa essere proprio lui il moralista più intransigente, è una cosa che ci costerà un poco accettare. Come Mungiu, Farhadi sembra volersi prendere gioco del suo protagonista, che ogni tanto vediamo in scena truccato da vecchio, trasformato in quei cattivi padri depravati che disprezza e che intende punire. Mentre a scuola i ragazzini stanno già cominciando a ridergli alle spalle.

Il miglior cinema iraniano è sempre riuscito a usare le proprie limitazioni come punti di forza. In un film iraniano non si può parlare di prostitute? Farhadi ci gira intorno per tutto il film, costringe gli spettatori a non pensare ad altro, e nel frattempo fa recitare ai suoi personaggi Morte di un commesso viaggiatore, dove una prostituta c'è, e c'è un'attrice che la interpreta (vestita di tutto punto). In un film iraniano le donne devono coprirsi il capo anche in casa? Taraneh Alidusti si prenderà una botta in testa in una colluttazione, così può restare fasciata per tutto il film. Il modo in cui Farhadi riesce a prendersi gioco apertamente delle stesse convenzioni che rispetta ha qualcosa di epico, ma se fosse tutto qui si tratterebbe soltanto dell'ennesimo film che ci spiega com'è difficile vivere in Iran oggi: l'ennesima edificante visita di istruzione in un Paese totalitario offerta al pubblico dei festival europei.
Invece Forushande parla anche di noi, e per accorgersene basta aspettare che si accendano le luci in sala, e ascoltare gli spettatori. È un film che ci fa discutere, e non soltanto della condizione delle donne in Iran. È un film che non rinnega le questioni irrisolte del suo Paese, ma riesce anche a toccarne di universali: la giustizia, la vergogna, la vendetta, la corruzione. È anche una detective story, a modo suo, che per un'ora e mezza va avanti rapida senza una sola scena di troppo, e poi si concede un'ultima mezz'ora lentissima, estenuante, spietata come il suo protagonista. Meno male che non aveva un bulldozer, ti viene da pensare. E ricordi una delle prime battute del film: "Come fa un uomo a diventare un mostro?", chiedeva uno studente. "Col tempo", rispondeva l'insegnante.
Il cliente è in programmazione al Cinelandia Fiamma di Cuneo fino a mercoledì 18 gennaio (ore 21; sabato 14 ore 17.20-20-22.35; domenica 15 ore 15.40-18.20-21).
Nello spazio nessuno può sentirvi pomiciare
04-01-2017, 02:45cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, essere donna oggi, futurismiPermalinkTi svegli un mattino su un'astronave generazionale e scopri che c'è stato un errore: tutto il resto dell'equipaggio dorme e non si sveglierà che tra 90 anni. Re-ibernarsi è impossibile, suicidarsi la prospettiva più logica. Mentre ci rifletti, inciampi nella cella criogenica di Jennifer Lawrence, che sulla Terra faceva la giornalista ed era (ovviamente) molto spigliata e simpatica. La svegli? non ci pensi neppure.
Ma il giorno dopo ti svegli e sei di nuovo lì, tutto solo, davanti a Jennifer Lawrence congelata. Basterebbe ficcare un cacciavite nel circuito giusto, e potresti avere Jennifer Lawrence per tutta la vita, senza doverla dividere con nessuno, su un'isola deserta con tutti i comfort (per esempio sull'astronave c'è il karaoke e i ristoranti etnici e una piscina affacciata sullo spazio, altri comfort agli sceneggiatori non sono venuti in mente). Ma sarebbe un crimine, no? Una specie di omicidio, anzi forse peggio. Quindi non ci pensi più.
Ma il giorno dopo sei di nuovo lì, tutto solo, davanti a Jennifer Lawrence - non c'è rimedio a questa cosa. Del resto, se la svegli poi dovresti mentirle per tutta la vita. E convivere con questo orribile segreto (ma anche con Jennifer Lawrence). Che follia. Meglio pensare ad altro.
Ma il giorno dopo? E il giorno seguente?
 |
| Là dove l'uomo non è mai arrivato e forse neanche quelle famose foto che tenevo sul telefono. |
 |
| Ora ti salto addosso in sala mensa, così anche col femminismo siamo coperti |
E quindi ecco Chris Pratt e Jennifer Lawrence. Il trailer parlava chiaro, la locandina ribadiva il concetto: questo è un film in cui Chris Pratt e Jennifer Lawrence si baciano, tutti soli su un'isola deserta - no, in realtà è un'astronave, ma è quasi la stessa cosa, anzi se volete può anche essere più romantico perché... perché... ci sono le stelle, ad esempio, tutte le stelle che vuoi... le nebulose, e ogni tanto cose ancora più incredibili come... le giganti rosse, ecco, il giorno del compleanno di Jennifer l'astronave passa davanti a una gigante rossa, una rotta economicamente suicida, ma vuoi mettere il romanticismo (qualche ora dopo la gigante rossa è già sparita, del resto vanno alla metà della velocità della luce).
Un film del genere, una crociera spaziale di Jennifer Lawrence e Chris Pratt, la puoi portare nei cinema anche a ridosso di un capitolo di Star Wars senza troppa paura di patire la concorrenza al botteghino; è tutta un'altra idea di fantascienza, di fiction, di romance. Probabilmente non è l'idea che venderà più biglietti; sicuramente è un'idea che farà inorridire molti critici e qualche femminist* - parliamo di un film in cui il maschio fa il meccanico e la donna la scrittrice. Persino io, che per le astronavi generazionali ho una specie di ossessione, ho avuto qualche difficoltà ad accostarmi a un film che sembrava più indirizzato al pubblico di Io prima di te. Ma devo ammetterlo: sono rimasto piacevolmente sorpreso. Forse perché, davvero, non mi aspettavo niente di più che un film in cui la Lawrence scopre che Chris Pratt è l'uomo della sua vita (nonché l'unico in tutto quel braccio della galassia) e gli dà due bacetti senza svestirsi, e invece ho passato una prima mezz'ora solo con Chris Pratt che mi ha fatto pensare a un vecchissimo film di astronavi e solitudine, Silent Running. Ho incontrato il barista Arthur (Michael Sheen), uno degli androidi più verosimili mai visti al cinema: cordiale, ragionevole, un ideale compagno di bevute, a differenza del sistema operativo di Her non acquisisce mai umanità e anzi contribuisce in modo determinante a farcene sentire la mancanza.
 |
| La mia scena di bacetti preferita è quando ci provano con le tute ma è complicato. (Qui lei gli sta facendo notare che non può entrare nella tuta col vestito da sera). |
Con tutte le sue ingenuità, le sue giganti rosse e le gag involontarie, Passengers è un film che prova a raccontarci una storia diversa, che prende in prestito le suggestioni di tutti i successi fantascientifici degli ultimi anni (Gravity, Interstellar, The Martian) per ricordarci che anche nello spazio profondo continueremo a essere uomini e donne, ad attrarci e a respingerci per problemi altrettanto profondi. E poi, certo è anche un film in cui se Jennifer ha voglia di Chris, gli salta addosso in sala mensa. Migliore opera di fantascienza sentimentale del 2017, fin qui. Lo trovate al Vittoria di Bra (18:00, 20:10, 22:30), al Multilanghe di Dogliani (21:45) e al Cinecittà di Savigliano (20:20, 22:30).
I 25 film del 2016
02-01-2017, 12:29cinemaPermalink25) La notte del giudizio - Election Year.
Magari il terzo capitolo della Purga è uno di quei film di genere che crescono con gli anni (oppure magari no). Magari in futuro ci piacerà tornare a quello scorcio di 2016 in cui pensavamo ancora che il candidato repubblicano sarebbe stato un pretino alla Rubio o alla Rand Paul, e che la Clinton sarebbe diventata una specie di regina del ghetto facendo incetta di voti latinos e afroamericani (oppure magari no). Come quando oggi guardi Rambo III che flirta coi mujaheddin del valoroso popolo afghano. Magari ci vergogneremo pensando che dopotutto quello che non osavamo chiedere al cinema era una scena in cui i vertici repubblicani fanno un'orgia in una chiesa protestante, finché il Resto del Mondo irrompe coi kalashnikov e li secca tutti quanti, il che dopotutto ci abbassa al loro livello, no? Oppure magari no.
24) Captain America: Civil War
I film di supereroi pieni di supereroi che se le danno con altri supereroi. Tutti li vogliono fare, solo la Marvel (la Disney) riesce a farli funzionare. È una questione di tanti piccoli dettagli, di fluidità, di pazienza (dietro c'è un universo costruito in dieci anni, alla Warner vorrebbero metterci sei mesi), di rispetto per gli spettatori e amore per le proprie storie, anche le più assurde.
 23) Ave, Cesare!
23) Ave, Cesare!Se devo dire la verità, non lo so perché i film dei Coen mi piacciono sempre tanto. Anche quelli fatti un po' per scherzo, un po' per sbaglio, un po' perché la Johansson ha una settimana libera e Clooney e Tatum ancora voglia di scherzare sulla loro virilità. Anche quando la trama è un filo esilissimo che serve a mettere assieme le quattro o cinque sequenze che i Coen avevano voglia di girare - un balletto acquatico, un balletto di marinai gay, un sottomarino sovietico che emerge al largo della spiaggia della California. Anche così, a tempo perso, i Coen stanno in cattedra, non c'è chi non dovrebbe prendere appunti.
22) Il caso Spotlight
Più nostalgia del giornalismo vecchio stile che orrore per la pedofilia del clero. Spotlight è un film un po' grigio, un po' noioso, che difende l'idea che le cose andavano meglio quando erano un po' più grigie, un po' noiose. È coerente, è onesto, è un po' una palla al piede.
Quest'anno ho visto pochi film italiani, ed erano tutti buoni. Perfetti sconosciuti all'apparenza è il più convenzionale - ritratto di una compagnia d'amici in un tinello. Eppure è un film molto diverso dai suoi antecedenti anche più vicini, meno localista e più universale, sorretto da un'idea forte (anche se abbastanza inverosimile, ma proprio in questo sta la novità: finalmente un film italiano che funziona come un what if).
20) Perfect Day
Benicio Del Toro sembra sempre sul punto di mettersi a ridere. Perfect Day racconta la pagina più oscura degli ultimi vent'anni d'Europa, senza riuscire a prendersi sul serio. (Voleva essere un complimento). Chi faceva il volontario in quegli anni forse può capire - era tutto buffo e serio a un tempo.

19) Oceania
Ormai anche le principesse ribelli sono un tropo Disney a tutti gli effetti. Moana non sarà la più memorabile, ma non c'è un fotogramma in cui non sia adorabile e tutto funziona che è un piacere.
Essere italiani nel 2016; vergognarsene un po', scherzarci un po' sopra, provare ad andare avanti. Checco Zalone è un furbastro paraculo? Sì. Racconta il nostro mondo? Sì. Fa ridere? Molto. Si può chiedere altro a un comico popolare?
Shane Black a volte mi preoccupa. The Nice Guys è talmente gonfio di autocitazioni che forse l'unico modo di goderselo è non conoscere gli altri film di Shane Black. Una specie di testamento, ecco, mi sembra un po' presto per i testamenti. C'è ancora tempo per inventarsi qualcosa di nuovo, o no? Mi ha deluso ma spero in un sequel.
16) Alla ricerca di Dory
Posto che un film malriuscito della Pixar è quasi sempre meglio di quel che fa la concorrenza, Dory non è nemmeno così malriuscito - forse ha un finale un po' troppo fracassone, ma glielo si perdona volentieri. Voglio dire, è un film per bambini sul deficit di memoria a breve termine!
Ercole e la Sirenetta vanno in Polinesia
28-12-2016, 17:23animazione, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, mitiPermalink Oceania (Moana, John Musker, Ron Clements, 2016)
Oceania (Moana, John Musker, Ron Clements, 2016)Dopo che ebbe fatto affiorare le isole dal Grande Mare; dopo aver innalzato il Cielo; dopo aver catturato il Sole per convincerlo ad andare più piano affinché gli umani potessero badare ai loro affari, il semidio Maui domandò alla Madre: che mi resta per divenire immortale? E lei: rifugiati in un'isola, attendi mille e ancora mille anni, ché alla Walt Disney venga voglia di dedicarti un cartone animato. E lui: Madre, cos'è un cartone animato? E lei: è un sogno, figliolo, sempre uguale e sempre diverso, che non finisce mai.
 Buone feste a tutti. Ho iniziato a scrivere 'recensioni' per i cinema di Cuneo e provincia quattro anni fa, e questa è esattamente la numero 200. Ho cominciato con un folle film della Disney (Ralph Spaccatutto) e quattro anni dopo tocca ancora alla Disney, con un film forse un po' più bello, decisamente meno folle. Alla regia i due maestri del rinascimento Disney (La sirenetta, Aladdin, Hercules, La principessa e il ranocchio), che si cimentano per la prima volta col digitale, piegandolo alle loro esigenze come un semidio onnipotente ma vincolato da un incantesimo. Maui, l'Ercole delle leggende polinesiane, è un Genio della Lampada più sbruffone e tormentato; Moana (Vaiana in Europa) è la Sirenetta, Jasmine e Tiana in un personaggio solo (continua su +eventi!)
Buone feste a tutti. Ho iniziato a scrivere 'recensioni' per i cinema di Cuneo e provincia quattro anni fa, e questa è esattamente la numero 200. Ho cominciato con un folle film della Disney (Ralph Spaccatutto) e quattro anni dopo tocca ancora alla Disney, con un film forse un po' più bello, decisamente meno folle. Alla regia i due maestri del rinascimento Disney (La sirenetta, Aladdin, Hercules, La principessa e il ranocchio), che si cimentano per la prima volta col digitale, piegandolo alle loro esigenze come un semidio onnipotente ma vincolato da un incantesimo. Maui, l'Ercole delle leggende polinesiane, è un Genio della Lampada più sbruffone e tormentato; Moana (Vaiana in Europa) è la Sirenetta, Jasmine e Tiana in un personaggio solo (continua su +eventi!) Musker e Clemens sono del '53: la loro capacità di intercettare il gusto degli spettatori di oggi è tanto più notevole quanto il loro gusto per l'esotico è manifestamente rétro, il ricordo di un cinema antico e avventuroso che oggi nessuno fa più, qui celebrato con più sincerità che nel pixariano Up. Se non fosse Natale, se fossimo tutti un po' meno buoni, li potremmo quasi accusare di colonialismo culturale, di imperialismo hollywoodiano - insomma questi passano sulle leggende di tutto il mondo come un rullo compressore, macinano mitologia e restituiscono un foglio levigato e coloratissimo pieno di facce buffe e canzoncine motivazionali - quest'anno anche in 3d. In quali terre, in quali isole lontane bisogna andare per ritrovare l'ennesima unica storia, quella di una principessa predestinata a cambiare il corso delle cose? È davvero l'unica Storia che esiste, il viaggio dell'eroe virato al femminile, o è l'unico che interessi alla Disney? Non saprei, e forse non è così importante. Oceania è un bel viaggio, anche perché alla fine ci riporta proprio dove sapevamo che saremmo arrivati.
Musker e Clemens sono del '53: la loro capacità di intercettare il gusto degli spettatori di oggi è tanto più notevole quanto il loro gusto per l'esotico è manifestamente rétro, il ricordo di un cinema antico e avventuroso che oggi nessuno fa più, qui celebrato con più sincerità che nel pixariano Up. Se non fosse Natale, se fossimo tutti un po' meno buoni, li potremmo quasi accusare di colonialismo culturale, di imperialismo hollywoodiano - insomma questi passano sulle leggende di tutto il mondo come un rullo compressore, macinano mitologia e restituiscono un foglio levigato e coloratissimo pieno di facce buffe e canzoncine motivazionali - quest'anno anche in 3d. In quali terre, in quali isole lontane bisogna andare per ritrovare l'ennesima unica storia, quella di una principessa predestinata a cambiare il corso delle cose? È davvero l'unica Storia che esiste, il viaggio dell'eroe virato al femminile, o è l'unico che interessi alla Disney? Non saprei, e forse non è così importante. Oceania è un bel viaggio, anche perché alla fine ci riporta proprio dove sapevamo che saremmo arrivati.Oceania è ovviamente dappertutto, ad esempio al Cityplex di Alba (20:00); al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (15:00, 17:30, 17:40, 20:10, 22:35); all'Impero di Bra (20:15, 3d 22:30); al Fiamma di Cuneo (15:00, 17:30, 20:10); ai Portici di Fossano (17:45, 20:00, 22:15); al Bertola di Mondovì (19:00); all'Italia di Saluzzo (20:00, 22:15); all'Aurora di Savigliano (18:30, 21:00)
I 28 film più brutti del 2016
28-12-2016, 01:46cinemaPermalink26) Trumbo
Il grande sceneggiatore era un socialista, chi ha sceneggiato il suo biopic non lo è. Il Trumbo del film non deve soltanto sconfiggere gli odiosi censori maccartisti, ma anche riscattare il suo status iniziale di rivoluzionario col ranch. Soltanto quando si metterà a scrivere spazzatura per l'industria, trasformando i famigliari in sottoposti sottopagati: solo allora può diventare il simpatico protagonista di un film. Lui avrebbe saputo fare di meglio, ma lui non c'è più.
27) Tutti vogliono qualcosa
Probabilmente Everybody Wants Some è il tassello di una cosa più complessa che ha in mente Linklater e che si capirà meglio tra quindici anni. Nel frattempo il suo Porky's-senza-battute lascia uno strano segno. Entusiasta e inconsistente al punto di irritare, e il ricordo di essere stati altrettanto entusiasti e inconsistenti non sempre aiuta.
 |
| Il Sud Dakota com'è davvero. |
29) Rogue One
Ambientare un film di guerra nell'universo di Star Wars: presentare una manciata di personaggi e farli ammazzare tutti davanti agli spettatori. Problematizzare un po' il mito, mostrare eroi della resistenza che si comportano da terroristi. L'idea era sublime, lo svolgimento insomma.
30) Cicogne in missione
I personaggi di Storks, umani e pennuti, hanno sempre quell'espressione schizzata - occhi a palla, un sorriso esagerato a mascherare inutilmente il panico. Sono sempre su di giri, stanno sempre facendo baccano mentre nascondono qualcosa. Tutto avviene sempre in pochi secondi, col ritmo esagitato dei vecchi Loney Toones, e una storia di ambizioni insaziabili. Vanno tutti troppo veloce per me, ma non credo sia un problema per loro.
 |
| QUALCUNO LE COMPRI QUEL PANE |
I film più smaccatamente militaristi degli ultimi anni li ha girati un regista sudafricano, Gavin Hood, forse senza neanche accorgersene. Anche stavolta i politici sono ingenui, fatui, frignoni e si attaccano ai cavilli; i militari sono seri, hanno scrupoli, e se ti ammazzano puoi star certo che ci hanno pensato, ne hanno discusso coi superiori, hanno soppesato i pro e i contro e hanno capito che la cosa più onesta da fare era ucciderti. Pare che dobbiamo farcene una ragione.
32) Café Society
Quando non sa che altro fare Woody Allen può sempre giocare con le aspettative dello spettatore: se in Crimini e misfatti aveva mostrato un delitto senza castigo, qui manca pure il delitto. Tutto sembra puntare in quella direzione - e invece il film finisce. A ripensarci è una delle migliori sorprese alleniane degli ultimi anni.
 33) Love and Mercy
33) Love and MercyBrian Wilson è una figura tragica, ma di tutti i punti di vista per illuminarlo forse quello della seconda moglie non era il più interessante. Accettando acriticamente la sua versione dei fatti Love and Mercy finisce per suggerire allo spettatore che Wilson si sia liberato di uno psichiatra tirannico soltanto per consegnarsi a un altro tiranno. La sua vita continua a essere uno straordinario film che nessuno riesce a raccontare.
34) Trafficanti
Un'altra storia che andava raccontata - anche qui magari evitando di prendere per oro colato la testimonianza di una delle due parti in causa. Jonah Hill sembra condannato a recitare stoner comedy, come se l'unico modo di superarsi fosse espandersi, fisicamente e moralmente: fare feste più grosse, più pericolose, feste mortali a cavallo del mondo.
 35) Animali notturni
35) Animali notturni Una delle cose che definisce Animali Notturni sono le dissolvenze incrociate. Chi usa più le dissolvenze incrociate? Uno stilista che fa un sacco di soldi vendendo occhiali e si finanzia i film da solo. Non sono brutti, non assomigliano a nient'altro anche se potrebbero, forse non lasciano il segno ma è bello che ci sia ancora qualcuno che fa le dissolvenze incrociate.
36) Joy
Ormai David O. Russell ha messo su una compagnia - quattro facce che ti fa piacere rivedere a prescindere dai ruoli, più qualche guest star che ti tiene viva l'attenzione. Finalmente la Lawrence è il nome più grosso sul cartellone e non deve rubare la scena a nessuno. Purtroppo si tratta dell'autobiografia di una televenditrice, che ne approfitta per rivendersi e santificarsi, e il tentativo di Russell di spingere la cosa ai limiti dell'autoparodia non funziona.
37) Il figlio di Saul
Non lo so. Mi sembrava di guardare un videogioco tristissimo - sarebbe stato tristissimo e deprimente anche se la consolle l'avessi tenuta in mano io, ma nemmeno questo, capite? Stavo guardando il tutto dietro le spalle del giocatore, lo so che è un film straordinario e molto moderno che trova un nuovo modo di raccontare l'orrore della Storia, ma mi annoiavo.
 38) Captain Fantastic
38) Captain Fantastic Certi film semplicemente non capisco cosa volevano dirmi - magari anche niente. Crescere al di fuori della società sarebbe necessario, ma è impossibile. Va bene. Viggo Mortensen spettacolo della natura, ma non è il mio tipo. Mi dispiace pure.
39) Brooklyn
Un film dove per una volta a Saoirse Ronan non succede niente di male. Ma neanche niente in generale, purtroppo.
40) Star Trek: Beyond
Di tutte le saghe che si potevano ibridare con Fast and Furious, proprio quella in partenza meno ipercinetica, meno esagitata, meno giovanilista. Alla fine ogni generazione ha il suo Star Trek che si merita, mettiamola così.
 41) Codice 999
41) Codice 999 Un poliziesco corale senza un solo acuto - a parte la Winslet, incredibile e anche Harrelson, è impossibile non voler bene a Harrelson.
42) Go With Me
Quella sera potevo scegliere tra due commedie americane sceme, alla fine ho preferito il noir svedese rifatto nel Pacifico occidentale. Niente di che, davvero, ma credo di aver fatto la scelta giusta. Hopkins si impegna più di Liotta.
43) Ghostbusters 3d
A un certo punto il Ghostbusters femminile era diventato una cosa da difendere a prescindere, il fronte della battaglia contro gli stereotipi di genere, e questo rende ancora più triste il fatto che non sia un gran film: come dire, uno a zero per gli stereotipi di genere.
44) Deadpool
Se hai ancora un po' di scuola media nelle vene due risate te le strappa. In generale un po' più di autoironia ai cinecomics non guasterebbe, anche se è difficile ridersi addosso senza sembrare patetici. Deadpool almeno ci prova.
 45) Pets
45) Pets In un anno di straordinari lungometraggi animati, quello che ha macinato più soldi è quello che si è accontentato di ricucinare le vecchie ricette senza aggiungere niente di nuovo, e senza nemmeno capire cosa davvero funzionava nel vecchio. Pixarploitation senza scrupoli.
Un altro film che doveva funzionare a scuola e invece secondo me no, un'altra occasione sprecata. Jesse corre poco e chiacchiera troppo, o meglio tutti chiacchierano intorno a lui, tutti hanno discorsi memorabili, i nazisti son cattivi e i capitalisti salvano il mondo superandoli in cinismo.
47) La famiglia Fang
La tragedia di crescere in una famiglia situazionista. I problemi degli scrittori, i problemi delle attrici, insomma non il mio genere di problemi, diciamo così.
48) Suffragette
Così in basso? Perché? Non saprei, è scivolato piano piano. C'è da dire che me ne ricordo pochissimo: che l'intuizione di descrivere le suffragette come anarcoterroriste era buona, ma la trattazione un po' scolastica (dico così ma in realtà non m'è venuta voglia di mostrarlo a scuola, che è il motivo per cui questi film provo a vederli), un po' televisiva (bisognerà anche cambiare aggettivo, visto che ormai in tv c'è più problematizzazione che al cinema), insomma mi sono annoiato, magari era colpa mia, avevo mangiato pesante, va' a sapere.
49) X-Men: Apocalypse
Ci sono cinecomics belli, cinecomics brutti, e poi ci sono quelli degli Xmen che non riescono mai a spuntare né da una parte né dall'altra. Nell'anno di massima saturazione del genere, arriva questo ennesimo riassestamento di una saga che non riesce mai ad avvincere, più o meno per gli stessi motivi: troppi personaggi, una trama sempre uguale, Magneto che distrugge tutto e poi si pente per l'ennesima volta, ecc..
 50) Colonia
50) Colonia Insomma all'inizio del film c'è Emma Watson che se la prende coi comunisti cileni perché passano in clandestinità invece di cercare il suo ragazzo tedesco. Provano anche a spiegarglielo che il problema non riguarda soltanto il suo ragazzo, che stanno sparendo tutti, che c'è in ballo qualcosa di un po' più grave di una banale avventura su sfondo esotico - lei non ci arriva, e in generale sembra che non ci arrivi neanche il film. Questa idea che il pubblico perdonerà qualsiasi ingenuità se il regista si ricorda di dare la colpa di tutto ai nazisti.
 |
| MIA MADRE ERA PIU' MARTHA DELLA TUA |
Questo sta così in basso perché, a parte il caos dell'allestimento, nemmeno Frank Miller era riuscito a distruggere la sua opera a fumetti con tanta pervicacia. Posso perdonare tante cose a chi gira cinecomics, le ingenuità, le strizzate d'occhio, i tentativi sempre maldestri di tenere insieme ragazzini e affezionati adulti: ma strappare tavole del Cavaliere Oscuro e rimontarle a casaccio è vandalismo. D'altro canto forse i brutti cinecomics sono il modo in cui ci salveremo dai cinecomics.
52) Vita da gatto
No, sentite, non è che mi aspetti dei capolavori dalla factory di Luc Besson - ma nemmeno roba buttata lì così, vecchi concetti disneyani ricopiati senza far caso a dove stesse il cuore. La prova che non basta ambientare tutto tra i grattacieli e strapagare un cast hollywoodiano se la storia non funziona. E che i film per famiglie sono più difficili da clonare degli action scemi - vabbe', mica serviva il 10% del cervello per capirlo.
 |
| "Zio la vetrina è il simbolo, se non spacchi la vetrina non sei nessuno". |
SS non è quel tipo di film di cui non ti stancheresti mai di parlar male - uno di quei film la cui bruttezza ti ripaga della fatica - SS è più inquietante, è la dimostrazione che una volta azzeccato un personaggio da cosplayer, magari femminile, il resto (la storia, l'azione, la psicologia, l'ambientazione, gli effetti) si può tranquillamente ritagliare a casaccio: ai ragazzini piacerà lo stesso. Sul serio, per quelli arrivati in prima media a settembre è il film della vita. Va bene che la vita è lunga, ma insomma, trovo criminale che qualcuno truffi così dei ragazzini. Ce n'è uno che era entusiasta del fatto che ai Suicidi iniettassero una bomba col timer, ovviamente poi quando gli racconti di Jena Plinsky ci restano male.
Star Wars episodio 3 e 1/2, la riscossa dei militi ignoti
20-12-2016, 20:17cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink |
| La Morte non è mai stata così grande, così bella. |
Va bene, ragazzi, si parte. Non facciamola lunga - tanto lo sappiamo che la storia non finirà bene - forse in generale sì, ma non per noi, noi siamo quelli sacrificabili, i pedoni, in un altra saga indosseremmo la tutina rossa. Siamo gli operai, quelli che fanno il lavoro sporco, e finiscono esplosi nei fuochi artificiali con cui inizia la saga vera. Come ci si sente quando si capisce che il tuo film non è il grande film, è solo una mossa laterale, una manovra di alleggerimento, un diversivo della Walt Disney per ammortizzare l'investimento senza consumare troppo il brand? Come ti senti quando capisci che ti stanno mandando a morire in una galassia lontana lontana solo per far brillare un po' di luce in lontananza?
I fans di Star Wars sono strani. Quello che desiderano lo hanno messo in chiaro già parecchio tempo fa: un certo tipo di astronavi, un certo tipo di combattimenti, un certo tipo di robottoni e robottini, qualche pupazzo buffo ma non troppo buffo, un certo tipo di filosofia ma non troppa filosofia. Va bene. I produttori di Star Wars recepiscono, e verso Natale provano a servire la pietanza. C'è sempre qualcosa che non va. Ma le astronavi non sono quelle giuste? "No, non sono giuste, sono esattamente le stesse, non va bene". Ma vi abbiamo messo i robottini. "È una strizzata d'occhio, non ci piacciono le strizzate d'occhio". I fans di Star Wars non vogliono cose diverse ma non vanno nemmeno pazzi per le solite identiche cose. I film della saga sono condannati a orbitare intorno agli stessi tre quattro concetti: dev'esserci un orfano in un pianeta difficile, deve arruolarsi in qualche modo nella resistenza e diventare rapidamente un leader che guida l'Alleanza all'ennesima battaglia finale. Scusate gli spoiler, eh, ma non c'era proprio modo che non finisse così. L'unico a tentare delle strade diverse fu proprio Lucas, e non gliele hanno apprezzate, per cui temo convenga rassegnarsi: c'è ancora una galassia da scoprire, tutta di pianeti desertici in cui vivono orfani e orfane predestinati al combattimento. Alcuni sono più sfigati di altri, alcuni glielo leggi negli occhi che sono sacrificabili. Se non riesci a leggergli negli occhi guarda la locandina: c'è scritto A Star Wars Story, capisci? Non è la Storia di Star Wars, quella con gli Jedi e gli Skywalker e i Solo; è "una storia": mi dispiace ragazzi. La galassia andrà avanti anche senza di voi.
 |
| Una foto per il monumento ai caduti, grazie. |
Eppure all'inizio doveva esserci un'idea interessante. I fans sono
Prima di entrare al cinema avevo sentito dire che Diego Luna era il nuovo Han Solo. Ecco, ci speravo, ma l'equivoco è proprio qui. Per me Han Solo è sempre stato un po' l'adulto di tutta la saga, ovvero quello che ci crede fino a metà, quello che ha bisogno ogni volta di essere convinto a muovere il culo e che sembra tenere più alle grazie della principessa che alla libertà della galassia. Lui non vive nello stesso universo degli altri adolescenti, dove i cattivi sono neri e i buoni fanno discorsi saggi. Ha problemi da adulto, debiti e mutui da pagare, astronavi da far funzionare. E ci scherza sopra, gli adulti questo fanno (fanno anche sesso).
 |
| Le possibilità che ridiate delle mie freddure sono del 13,5%. |
Sono nato durante la Guerra Fredda, i nostri insegnanti condividevano una certa idea del nazismo. Pensavano che i nazisti fossero perlopiù onesti padri di famiglia che obbedivano agli ordini perché erano stati cresciuti così, e quindi era importante che noi crescessimo diversamente. Neanche l'obbedienza era più una virtù, figurarsi il martirio. Chiunque ce lo proponesse andava immediatamente investigato, senz'altro c'era sotto una fregatura. Quelli lesti al suicidio erano sempre i nemici, gli agenti dell'hydra o i kamikaze. Poi il vento è cambiato. Me ne sono accorto quando 300 di Snyder fece il botto. A me avevano insegnato a dubitare di chiunque ti decanti le Termopili - ed ecco che i ragazzini andavano in estasi per il nobile sacrificio degli spartiati ariani. Così come non era poi così strano immaginare gli affiliati di Al Qaeda che si gasano guardando Matrix prima di farsi esplodere su un aeroplano, così davvero c'è da domandarsi fino a che punto la Disney si sia lasciata scappare un monumento ai martiri sconosciuti, fino a che punto sia lecito cavalcare un certo Zeitgeist, raccontare ai bambini che ci sono Speranze per le quali vale la pena di morire.
 |
| "Scugnizzi Uno" non era poi male. |
Rogue One è al Cityplex di Alba (19:00, 21:30); al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (21:00 in 3d; 20:00, 22:40); all'Impero di Bra (20:00 in 3d, 22:30); al Fiamma di Cuneo (21:00); ai Portici di Fossano (21:15); al Bertola di Mondovì (21:15); all'Italia di Saluzzo (21:30); al Cinecittà di Savigliano (21:30).
Capitan Fantastico scende in città
15-12-2016, 18:12Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkLassù sulle montagne, dove l'aria è più buona e il capitalismo non arriva, vive senza chiedervi il permesso la famiglia Cash. Sono filosofi e carnivori; di giorno cacciano e disossano i cervi e la sera, intorno al fuoco, bivaccano studiando la teoria delle stringhe. Scalano montagne, affilano lame, sono buddisti ma armati. Un giorno scenderanno a darvi una lezione. Non si sentono superiori a nessuno; lo sono.
Fino a qualche anno fa non succedeva mai, e quest'anno è capitato già più volte, di ritrovarmi di fronte a un film americano pensando "beh ma preferivo la versione italiana". Non so se abbia più a che fare con la salute del cinema USA o con la mia. Il paragone tra Captain Fantastic e Le meraviglie di Alice Rohrwacher non ha molto senso, comunque: anche se entrambi sono molto piaciuti a Cannes. Da una parte un prodotto d'autore europeo, drammatico (con qualche virata nel simbolico), dall'altra un comedy-drama americano, uno di quei film da Sundance che di indipendente non hanno nemmeno la confezione; l'ennesimo tentativo di far convivere le suggestioni del ritorno alla natura con un linguaggio che infallibilmente ne restituisce immagini patinate. È una di quelle situazioni in cui i famosi production values americani, quei livelli ineguagliati di professionalità e organizzazione, si ritorcono contro la macchina: fai fatica a spiegarci Henry David Thoreau se i tuoi strumenti sono quelli con cui si gira la pubblicità di uno shampoo... (continua su +eventi!)

Matt Ross ha voluto girare un film diametralmente opposto alla sua opera prima, 28 Hotel Rooms: là c'erano soltanto due attori in 28 camere d'albergo diverse (da cui il titolo), qui c'è tutto l'Ovest, dalle foreste dello Stato di Washington fino ai campi di golf del New Mexico, uno schiaffo alla miseria e alla siccità; e una famiglia di selvaggi sapienti che è un trionfo di casting - ragazze e bambini hanno tutti pochi minuti per lasciare un segno, e ce la fanno. E poi c'è Viggo Mortensen, padre-padrone illuminato, che per metà film sembra davvero l'uomo più saggio del mondo: com'è prevedibile, basterà scendere un po' a valle perché tutto venga messo in discussione. Ma appunto, è un po' troppo prevedibile. È capitato ad autori più esperti di Ross di scontrarsi con lo stesso argomento, e di consegnare agli spettatori qualcosa di irrisolto o ambiguo (vedi Into the Wild). È come se intorno all'argomento ci fosse qualcosa di sostanzialmente sacro: magari ritornare alla natura è impossibile, ma non è comunque consentito riderne.

Il manuale di base della sceneggiatura televisiva prevede che l'eroe si scontri con le convenzioni; che a ogni parziale successo corrisponda l'accettazione dei propri limiti; le convenzioni sono elastiche, si lasciano penetrare, ma in cambio l'eroe deve capire che hanno un senso. Captain Fantastic deve accettare di essere un po' meno fantastic; passare dalla caccia all'agricoltura; in cambio resterà un filosofo e continuerà a conservare la sua famiglia bellissima. È un finale che ha un senso soltanto al cinema o in tv, e soltanto in America. Qui da noi è diverso, al punto che di un film così forse non sappiamo che farcene. Captain Fantastic questa settimana resiste solo al Fiamma di Cuneo (giovedì 15, venerdì 16, lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 alle ore 21; sabato 17 ore 17.30 - 20.00 - 22.30; domenica 18 ore 15.00 - 18.00 - 21.00).
Vita da gatto, un film da cani
09-12-2016, 14:15animali, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink Perché la maggior parte della gente cerca di comportarsi bene? Ok, qualcuno pensa di andare in paradiso. Qualcuno spera di lasciare un buon ricordo. Qualcuno proprio per fare il cattivo non è tagliato (ci vuole coraggio, ambizione, inventiva, è complicato). Ma la maggior parte della gente, perché non si comporta male tutto il tempo? Probabilmente credono nella metempsicosi: sperano di reincarnarsi nei gatti d'appartamento. Che altro chiedere dalla vita? Per dire che anche dietro a un film apparentemente inutile come Una vita da gatto c'è un'importante figura dell'inconscio collettivo: il sogno di finire come Kevin Spacey, palazzinaro di New York, troppo preso dalla sua carriera per vedere le esigenze di moglie e figlia bla bla bla bla, che una sera cade dal suo grattacielo e si risveglia nel corpo del gatto di famiglia. Scoprirà che non sono tutte rose e fiori e gomitoli di lana.
Perché la maggior parte della gente cerca di comportarsi bene? Ok, qualcuno pensa di andare in paradiso. Qualcuno spera di lasciare un buon ricordo. Qualcuno proprio per fare il cattivo non è tagliato (ci vuole coraggio, ambizione, inventiva, è complicato). Ma la maggior parte della gente, perché non si comporta male tutto il tempo? Probabilmente credono nella metempsicosi: sperano di reincarnarsi nei gatti d'appartamento. Che altro chiedere dalla vita? Per dire che anche dietro a un film apparentemente inutile come Una vita da gatto c'è un'importante figura dell'inconscio collettivo: il sogno di finire come Kevin Spacey, palazzinaro di New York, troppo preso dalla sua carriera per vedere le esigenze di moglie e figlia bla bla bla bla, che una sera cade dal suo grattacielo e si risveglia nel corpo del gatto di famiglia. Scoprirà che non sono tutte rose e fiori e gomitoli di lana. Perché l'Europa Corps non fa dei bei film, invece di farli brutti? Non è una domanda così peregrina. Nine Lives aveva un budget di 30 milioni di dollari (il triplo di Big Game): sono pochi? Se puoi scritturare Kevin Spacey, Christopher Walken e Jessica Gardner, e alla regia Barry Sonnenfield (La famiglia Addams, Men in Black); se hai abbastanza computer-grafica da riuscire ad animare un gatto che sembra vero, perché non riesci a costruirci non dico un capolavoro, ma un film abbastanza carino? Coi film d'azione forse è più facile - no, non mi riferisco a Lucy, Lucy è un episodio imperdonabile. Però finché è azione puoi sempre spararle grosse, magari non centri il bersaglio ma un effetto lo ottieni lo stesso, e anche un po' di ridicolo involontario non guasta mai (vedi il ciclo di Taken). Nine Lives invece vorrebbe essere un film per le famiglie: una cosa molto più delicata. Lo hanno scritto in cinque, senza mai azzeccare il tono. Si capisce che l'idea della trasformazione in gatto non è partita da un autore - qualcuno che avesse veramente voglia di dire qualcosa sui gatti d'appartamento, sul loro modo di essere e non essere parte della famiglia - ma dal reparto effetti speciali: ehi, guarda qui, siamo riusciti ad animare un gatto che sembra vero. Facciamoci un film, come quelle vecchie pellicole della Disney in cui a Dean Jones succedevano le cose più strane - in uno si trasformò effettivamente nel cane di famiglia. Perfetto, che problema c'è?
Perché l'Europa Corps non fa dei bei film, invece di farli brutti? Non è una domanda così peregrina. Nine Lives aveva un budget di 30 milioni di dollari (il triplo di Big Game): sono pochi? Se puoi scritturare Kevin Spacey, Christopher Walken e Jessica Gardner, e alla regia Barry Sonnenfield (La famiglia Addams, Men in Black); se hai abbastanza computer-grafica da riuscire ad animare un gatto che sembra vero, perché non riesci a costruirci non dico un capolavoro, ma un film abbastanza carino? Coi film d'azione forse è più facile - no, non mi riferisco a Lucy, Lucy è un episodio imperdonabile. Però finché è azione puoi sempre spararle grosse, magari non centri il bersaglio ma un effetto lo ottieni lo stesso, e anche un po' di ridicolo involontario non guasta mai (vedi il ciclo di Taken). Nine Lives invece vorrebbe essere un film per le famiglie: una cosa molto più delicata. Lo hanno scritto in cinque, senza mai azzeccare il tono. Si capisce che l'idea della trasformazione in gatto non è partita da un autore - qualcuno che avesse veramente voglia di dire qualcosa sui gatti d'appartamento, sul loro modo di essere e non essere parte della famiglia - ma dal reparto effetti speciali: ehi, guarda qui, siamo riusciti ad animare un gatto che sembra vero. Facciamoci un film, come quelle vecchie pellicole della Disney in cui a Dean Jones succedevano le cose più strane - in uno si trasformò effettivamente nel cane di famiglia. Perfetto, che problema c'è? C'è che i gatti non sono cani, per esempio (continua interessantissimo su +eventi!) Immaginare un gatto che si strugge per cercare di dimostrare la propria umanità è faticoso. In generale, è faticoso immaginare un gatto che si strugge. Se sogniamo tutti di reincarnarci in felini è proprio perché sappiamo che quando finalmente ci arriveremo non ci fregherà più nulla di nulla - il nirvana. Gatto-Spacey invece si dà un sacco da fare, deve salvare la sua azienda, finire in qualche video buffo su youtube, creare quei simpatici casini domestici che fanno gli animali, e scoprire tante cose importanti sulla propria famiglia. Addirittura a un certo punto cerca di aiutare sua figlia coi compiti - ma un gatto che fa i compiti non è un gatto. Non fa nemmeno ridere. Nine Lives è un film che mette meccanicamente assieme tante cose che in teoria potevano fare un film, ma non ci riesce. Resta un'accozzaglia di cose messe lì. Negli USA è uscito il 5 agosto 2016, una delle date più terribili della storia del cinema mondiale (uscì anche Suicide Squad). Nine Lives non è altrettanto brutto, ma dimostra che il cinema americano non è un'alchimia così semplice. Anche con buoni attori americani, con un veterano americano alla regia, con un concetto tipico dei film per famiglie americane, il risultato è inferiore alla somma degli addendi. Lo trovate al Cityplex di Alba (19:00); al Vittoria di Bra (20:15); al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (15:15, 17:20, 20:15, 22:30); al Fiamma di Cuneo (18:10, 21:10); ai Portici di Fossano (20:00); all'Italia di Saluzzo (20:00); al Cinecittà di Savigliano (20:20, 22:30).
Capitan Sully, l'eroe di due minuti
04-12-2016, 23:27cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkAnche i migliori a volte hanno dei dubbi. Per esempio Clint Eastwood, come dire, la Storia del cinema. Secondo me ogni tanto se lo domanda: e se avessi sbagliato qualcosa? E se avessi fatto un errore? Quell'inquadratura era da dilettanti. Quel raccordo non riesco a perdonarmelo. Quante cazzate che ho fatto, e diciamolo, come attore valevo nulla. Ok, ho scoperto Michael Cimino, ma forse era meglio se lo avessi lasciato a girare pubblicità, per lui e per tutta l'industria. Magari sta uscendo da una macchina, Clint Eastwood, magari cammina su una passerella; tutt'intorno un cordone di sicurezza, sconosciute che vorrebbero abbracciarlo, c'è gente a cui Clint fa sesso a 80 anni, e intanto lui pensa: forse faccio pena.
L'unico modo per cambiare idea è riguardarsi uno dei suoi film. E commuoversi. No, Cristo, io non faccio pena, io sono la fottuta storia del cinema. Ho portato a casa film impossibili, ho dato un capo e una coda persino ad American Sniper - ok, la gente sarebbe andata a guardarlo anche se fosse stato girato e montato da un ragazzino daltonico, ma io ne ho fatto un fottuto film di guerra e di pace, e ci ho messo anche la retorica, ma solo quel pizzico che non stomaca e ti lascia il sapore dolce sul finale. Ed era la storia di un cecchino mitomane, Cristo, lasciate perdere i critici. Non sanno cos'è il mestiere, non se lo immaginano, non possono capire. Nessuno sa cosa vuol dire trovarsi sul set sotto pressione, a un'età in cui dovreste stare ai giardinetti, a stingere i denti e macinare un altro film da 60 milioni di dollari. Nessuno sa quanto sono bravo. Solo io posso capirlo. Gli altri al limite devono fidarsi. Di Clint Eastwood.
Sully forse non è un grande film, ma proprio per questo è un film straordinario. C'erano tanti modi di raccontare un'impresa epica, ma brevissima (cinque minuti tra il decollo di un jet di linea e l'ammaraggio più riuscito della storia dell'aviazione civile, 155 superstiti salvati nelle gelide acque del fiume Hudson, nessuna vittima). Hollywood conosce tantissime ricette per allungare il brodo e produrre film di successo, e Clint Eastwood le ha scartate tutte. Avrebbe potuto concentrarsi sulla biografia del pilota, darci dentro coi flashback; e invece a Eastwood dopotutto il passato di Sully non interessa un granché. Avrebbe potuto insistere sui passeggeri, raccontare le loro vite che si intrecciano casualmente sullo sfondo di una tragedia contemporanea evitata per un soffio - trovando nei nostri cuori più di una corda da suonare, in fondo siamo tutti passeggeri, siamo tutti potenziali vittime, potenziali eroi - invece no, neanche i passeggeri in fin dei conti sono così importanti per Clint. Avrebbe potuto insistere sul procedurale, offrirci dettagli ancora più specifici dell'inchiesta, le manovre vere o presunte della compagnia per pagare qualche migliaio di dollari in meno d'indennizzi - non ci avremmo capito quasi nulla, ma ci sarebbe piaciuto lo stesso, come in quei film di avvocati o broker finanziari. Ma non era quello il punto.
A Clint Eastwood interessavano solo quei due minuti: quelli in cui capitan Sully ha fatto la differenza (continua su +eventi!)
 |
| Questo non è il film (ma nel film è uguale). |
A Clint Eastwood interessavano solo quei due minuti: quelli in cui capitan Sully ha fatto la differenza. Ce li mostra una, due volte: e poi le simulazioni, quattro simulazioni, in tempo reale; e giusto quando stavamo pensando Grazie, Clint, basta anche così, ci infila a forza le cuffie e ci fa riascoltare la scatola nera. Non è neanche più esattamente cinema, non è narrazione, ma nemmeno documentario; alla quinta volta che ritorni nella stessa cabina, è qualcosa di più simile a un addestramento, o a una liturgia. Scordati il passato, non pensare alla famiglia, non preoccuparti dei processi che ti faranno - faranno bene a farteli, ma adesso non ci devi pensare: e anche al boato dei passeggeri lì dietro, non c'è tempo per soffrire con loro, devi salvarli. È tutto lì. È veramente tutto lì. E se andrà a finire bene, ti daranno dell'eroe o del pazzo incosciente, ma che ne sanno? Non ne sanno nulla. Tutti i critici veri o computer-simulati non possono capire cosa vuol dire trovarsi al comando in quel momento, e prendere la decisione che non è mai giusta, la decisione che è meno sbagliata delle altre. Ti odieranno, ti ameranno, ti daranno dell'eroe, ma nessuno potrà capirti. E tu stesso avrai dei dubbi, tu stesso saprai di non poterti fidare dei tuoi ricordi. La memoria fa scherzi assurdi, l'inconscio di notte cambia le carte in tavola.
Sully è la piccola storia straordinaria di un tizio che fa una manovra mai fatta, viene immediatamente acclamato come eroe, ma in cuor suo sospetta di aver sbagliato tutto, di aver perduto un aereo, la pensione, e (soprattutto) l'autostima. Sully è un film che si appoggia con la leggerezza di un jet sul grande tema dello stress post-traumatico: che tra mille modi di commuoverci sceglie di ricordarci quei momenti in cui ci svegliamo di soprassalto pensando a un incidente che stavamo per commettere, e che in un mondo parallelo è successo, e siamo morti tutti, tutti. È un film che prosegue con un paragone azzardatissimo: dopo aver salvato il suo equipaggio, Sully salverà sé stesso, con lo stesso stile: poche semplici manovre al momento giusto. Il discorso con cui impone alla commissione la sua versione dei fatti è efficace e stringato (un altro segno subliminale che l'età di Obama è finita, forse anche nei film di Spielberg i discorsi si asciugheranno). Eastwood aveva a disposizione 60 milioni di budget e Tom Hanks nell'ennesimo ruolo di Capitano d'America. Poteva usarli come li voleva: li spende per dirci che il successo, il boato del popolo che ti ama e ti abbraccia, non significa niente. Se sei un professionista, l'unica verità sta nella scatola nera. Se sei un professionista, il miglior critico di sé stesso sei tu. E Sully questo è: un professionista. Come le hostess che da un attimo all'altro cominciano a eseguire una procedura mai fatta prima, una di quelle che non funziona quasi mai e di solito dopo si muore di schianto. Come tutta la città di New York, tutti i suoi abitanti e impiegati portuali che se vedono un aereo planare non perdono neanche un istante a domandarsi cosa fare: c'è una cosa sola da fare, se sei un professionista. E poi sarai anche un eroe, ma l'impresa eroica è quel tipo di cosa che ti capita se sei un professionista.
Sully è al Cityplex di Alba; al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo; al Vittoria di Bra; al Fiamma di Cuneo; al Multilanghe di Dogliani; ai Portici di Fossano; al Baretti di Mondovì; al Cinecittà di Savigliano.
Obama tramonta, Snowden resta (ma a Riotta non va proprio giù)
27-11-2016, 02:16Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, giornalisti, internetPermalinkRicordate il giorno in cui avete pensato di coprire la webcam del vostro computer, il giorno in cui non vi è sembrata più una paranoia? Quando è successo? Difficilmente prima dell'estate del 2013. In primavera l'ex agente NSA Edward Snowden aveva abbandonato la sua postazione di lavoro alle Hawaii portando con sé in una card più di due milioni di documenti riservati dei servizi americani (e inglesi, canadesi, australiani, neozelandesi). In giugno li aveva consegnati ai reporter del Guardian che lo avevano raggiunto in una stanza d'albergo di Hong Kong. Qualche giorno dopo il suo avvocato riusciva a metterlo su un aereo. Snowden sperava di trovare asilo in Sudamerica, ma una volta arrivato in Russia, gli USA gli hanno revocato il passaporto. È ancora là.
Man mano che l'astro di Obama tramonta, è più facile accorgersi di come Edward Snowden sia una delle figure più importanti dell'ultimo decennio. Non ha semplicemente gettato una macchia sul presidente più cool di sempre; non si è limitato a rivelare segreti militari, non ha soltanto bruciato qualche agente di antiterrorismo: Snowden ci ha fatto coprire le webcam. Se prima dell'estate del '13 avevamo qualche sospetto di essere spiati dalle nostre compagnie telefoniche, da lì in poi abbiamo dovuto accettarlo: non c'è paranoia che non si stia realizzando. Ogni smartphone è una cimice, ogni videocamera fa rapporto a qualche grande fratello. A inizio 2013 sarebbe stata la premessa di un film di fantascienza distopica: tre anni dopo è già materiale per Oliver Stone.
Forse la storia più congeniale a essergli passata per le mani dai tempi di Nato il 4 luglio, a cui fin troppo somiglia. Prima di questo film la nostra idea di Snowden oscillava tra l'hacker e l'attivista per i diritti civili; ma lo Snowden di Stone è per prima cosa un veterano. Si ricomincia dal solito addestramento da accademia militare: correre nei boschi, strisciare nel fango, urlare sissignore all'istruttore. Potrebbe essere l'inizio dell'ennesimo film di guerra, se il giovane Edward non si fratturasse le ossa alzandosi dalla brande con troppo zelo. Non importa, gli spiega l'ortopedico: ci sono altri modi per servire la tua patria. Ma anche quando si dimetterà dalla CIA per scrupolo, trasformandosi in una specie di contractor privato; anche quando sceglierà di tradire il suo Paese, lo Snowden di Stone resterà a suo modo un soldato, proprio come il Kovic di Nato il 4 luglio che aveva bisogno di scoprire la militanza pacifista per rimettersi a urlare ordini ai sottoposti. Snowden è disciplinato e responsabile, Snowden valuta i pro e i contro di ogni situazione; rispetta il presidente come comandante-in-capo; prova devozione filiale per i superiori e un malcelato disprezzo per i camerati che per far carriera compiono gesti irresponsabili. E come il cecchino di American Sniper, di cui è una specie di gemello buono, ha una donna che vorrebbe proteggere e che in un qualche modo lo protegge.
Stone prende una complicata storia di leak e di intelligence e la smonta fino a trovare i fattori primi, umani, che funzioneranno anche con gli spettatori digiuni di crittografia. Se il rischio è accreditare il personaggio come un genio del computer, Stone lo corre volentieri. Non ha mai avuto la mano leggera, ma forse in questo caso c'era proprio bisogno di trasformare entità astratte in immagini potenti. La webcam che diventa un occhio: un ragazzino con la camicia in fuori che in qualche ufficio dall'altra parte del mondo può spiarti l'account facebook per antiterrorismo o per capriccio. Stone preferisce girare all'estero, ma quel che vuole realizzare è proprio il caro vecchio blockbuster americano: non esita a mettere al centro una storia d'amore; ce la mette tutta pur di inserire sequenze che non stonerebbero in film di spionaggio o di azione. E come Michael Moore, sente l'esigenza di ricordarci a ogni pié sospinto che è altrettanto americano dell'America che sta criticando (continua su +eventi!)

A Washington c'è un posto dove gli innamorati
mettono i lucchetti?
PS: per un approccio più completo, segnalo questa epica recensione di Gianni Riotta sulla Stampa, che vi riassumo per sommi capi e per divertimento:
Primo paragrafo: nel 1932 Walter Duranty, un giornalista del NYT vinse un Pulitzer con un'inchiesta filostalinista (che c'entra con Snowden, vi chiederete? Dopo lo spiega);
secondo paragrafo: Zizek è affascinato da Trump e Stone bazzica il Cremlino: Putin gli avrebbe affidato un documentario sull'Ucraina (in realtà Stone ha prodotto un documentario di un regista ucraino naturalizzato negli USA, vabbe', dettagli);
terzo e quarto paragrafo: l'avvocato russo di Snowden è un uomo di Putin, Snowden è una sua marionetta, anche Stone è una sua marionetta e inoltre a una festa ha messo una mano sul collo della documentarista Laura Poitras. Nel romanzo che l'avvocato russo ha scritto sul caso Snowden tutti i nomi sono cambiati, il che non c'entra veramente nulla col film ma Riotta si mette a elencarli, per dimostrare che ha letto il libro (e il film, lo avrà visto?);
quinto paragrafo: Snowden ha arrecato gravissimi danni al controterrorismo, almeno a detta delle agenzie americane e francesi di controterrorismo. Kerry voleva arrestarlo, invece Oliver Stone ci ha fatto un film. È un regista che ha vinto degli Oscar, ma anche a un giornalista stalinista una volta hanno dato un Pulitzer, vi ricordate? Credevate che Riotta fosse andato fuori tema, eh? E invece no, tutto torna. E il film? Beh, il film lo liquida in una riga: "girato con telecamerine spia per effetto, è intriso di «superparanoia». Capita, come capitò a Duranty, cui, 90 anni dopo, vorrebbero togliere il Pulitzer". In realtà non risulta che Duranty fosse affetto da superparanoia, con o senza virgolette. L'ossessione di Riotta per un vecchio premio Pulitzer ha radici abbastanza contorte: qualche anno fa Glenn Greenwald (nel film è Zachary Quinto) definì un intervento di Riotta su Snowden "the opposite of journalism". Qualche mese dopo vinse il Pulitzer, appunto, per lo scoop su Snowden. Si vede che il critico cinematografico della Stampa se l'è legata al dito.
L'America di Tom Ford, incubo patinato
22-11-2016, 02:22Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkSusan (Amy Adams) si annoia. Alla sua età, col suo reddito, è praticamente un must. Susan ha una ricca casa e un maggiordomo; una galleria d'arte che gestisce con sempre meno convinzione; un marito ricchissimo che la tradisce nel modo più discreto; e un fantasma del passato, un ex marito scrittore fallito (Jack Gyllenhaal) che dopo 19 anni le invia un manoscritto. Il mondo di Susan è finzione, ma ricorda: il mondo vero è molto peggio.
 |
| ...That you're tired of yourself and all of your creations... |
 |
And you say, “Oh my God, Am I here all alone?”
|
 |
| Standing on a corner a ringin' my bell, Up stepped the sheriff from Thomasville. He said 'Young man is you name Brown? Remember you blowed Sadie down." |
(35 anni fa) Simon Le Bon ci ha salvato la vita
14-11-2016, 18:55cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, musica, OttantaPermalinkSing Street (John Carney, 2016)
C'è stato un momento - mica come adesso sapete. C'è stato un periodo in cui truccarsi non era una scemenza vanitosa come adesso, c'è stato un momento in cui era questione di vita o di morte. Ti mettevano in un angolo e te ne davano finché il trucco non ti serviva davvero a qualcosa. C'è stato in un periodo in cui non andavi ai talent a farti compatire, c'è stato un momento in cui dovevi farti compatire in casa, girarti un video e mandarlo in giro nella speranza che qualcuno dall'altra parte del mondo volesse perdere un po' di tempo e denaro per compatirti. C'è stato un momento in cui Simon Le Bon era avanguardia, in cui gli Spandau Ballett erano la ribellione, in cui i Cure potevano servirti con le ragazze. Ci sono stati gli anni Ottanta ma non erano la favola di plastica che vi raccontano adesso; erano ormoni, sangue, nicotina, brufoli, disperazione, e in mezzo a tutto questo, per quanto assurdo potesse sembrare, un George Michael.
A metà anni Ottanta, Cosmo piove dallo spazio in un sordido liceo di Dublino (nei titoli finali ci avvertono che adesso invece è una scuola bellissima che diploma tantissimi ragazzi successful: andateci). Due genitori che litigano, un fratellone depresso che passa il tempo a girare canne e 33giri, un compagno bullo che ha intenzione di sodomizzarlo entro gli esami. Bisogna avere un progetto, anche solo far colpo su una ragazza. Bisogna mettere su una band, girare un video, far finta finché non funziona (continua su +eventi!). Il successo sembra un traguardo impossibile, eppure la terra promessa è solo a un braccio di mare. Il film più autobiografico di John Carney non è probabilmente il suo meglio riuscito: la necessità di rendere un tributo a chi lo ha aiutato e a chi è rimasto indietro gli impedisce forse di guardarsi indietro col distacco necessario. Coi metri che usiamo da vent'anni, il suo eroe non è che un poser: si esprime per citazioni che ha appena mandato a memoria, cambia look a seconda del videoclip che è riuscito a guardare il giorno prima. Il suo stesso immaginario è poco più elaborato di una mensola di videocassette. Cosa dire, salvo che negli anni Ottanta eravamo davvero così: ignoranti, superficiali, disperati, determinati. Ci esprimevamo per versi malintesi di canzoni, e sognavamo per videoclip. Ne abbiamo copiata di roba prima di trovare una voce personale, ammesso che l'abbiamo trovata e che interessi a qualcuno. Del resto avevamo quindici anni: e il suono più meraviglioso del mondo non era la campana della scuola e neanche il rullante della batteria. Era la voce gracchiante al citofono del tuo migliore amico appena conosciuto, che ti chiedeva se avevi voglia di andare al parco a scrivere una canzone. Sempre.
Sing Street è al Moretta di Alba lunedì e martedì alle 21; al Fiamma di Cuneo alle 21:10 fino a mercoledì.
Sorridi Brian (e aggrappati all'Ego)
07-11-2016, 19:32cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, musicaPermalinkLove and Mercy (Bill Pohlad, 2014).
Immagina di nascere musicista, con un gusto istintivo per le melodie e le armonie. E ricevere da bambino uno schiaffo paterno che ti lascia per sempre un orecchio sordo: un acufene perpetuo dal quale emergono rumori già sentiti, frammenti di cori sognati, discussioni, voci angeliche, voci che ce l'hanno con te, voci che non ti sopportano. Immagina di avere dischi di platino alle pareti e una diagnosi di paranoia schizoide in un cassetto. Immagina di essere Brian Wilson: e ora sorridi, non è meravigliosa la vita?
Brian Wilson è uno dei geni musicali del secolo scorso; Brian Wilson ha passato due anni in un letto a ingrassare. Brian Wilson coi suoi Beach Boys è stato il principale sfidante americano dei Beatles, sconfitto ma di misura e con onore; Brian Wilson è stato succube per anni di uno psichiatra più matto di lui che lo imbottiva di pillole. Brian Wilson ha scritto la canzone preferita di Paul McCartney. Brian Wilson ha licenziato suo padre che lo picchiava da bambino, ma per divergenze artistiche. Brian Wilson convive con le sue allucinzioni uditive dal 1964. Bruce Wilson non è mai andato in surf ma nella sua villa teneva un pianoforte su una buca di sabbia, e componeva a piedi nudi. Brian Wilson voleva scrivere un disco che avrebbe reso tutto il mondo più felice, lo avrebbe chiamato Smile, ma impazzì durante la lavorazione. Un giorno entrò in un cinema per vedere Operazione diabolica, il film era già cominciato e un attore nel buio stava dicendo "si accomodi signor Wilson". Lo choc gli fece smettere di comporre musica e non entrò più in un cinema per vent'anni. Brian Wilson è un film vivente, ma nessuno è ancora riuscito a girarlo. Troppi aneddoti, troppe storie, forse troppa musica tra un'immagine e l'altra.
Love and Mercy è il tentativo più serio fin qui, se non altro per la passione con cui Bill Pohlad si è dedicato all'impresa, tornando dietro la macchina da presa dopo 25 anni (passati a produrre film come Into the Wild, The Tree of Life, 12 anni schiavo). Pohlad è evidentemente innamorato del Brian Wilson giovane compositore, un genio incontrollato che usa lo studio di registrazione come un giocattolo, unendo professionalità e improvvisazione alla ricerca di qualcosa che gli canta dietro al muro del suono che ha in testa (le scene dedicate alla lavorazione di Pet Sounds sono girate con musicisti veri, come nel tentativo di ricreare un miracolo in laboratorio).
Pohlad non vuole strafare... (continua su +eventi!)
Pohlad non vuole strafare: gli interessa sdoppiare il personaggio, ma opta per una soluzione molto più convenzionale di quella adottata da Todd Haynes nel suo biopic su Dylan I'm Not There (benché uno sceneggiatore sia lo stesso). L'idea che Wilson a vent'anni sia Paul Dano e a quaranta John Cusack è declinata nel modo più convenzionale possibile - e almeno ci risparmia uno di quegli invecchiamenti hollywoodiani al digitale. Pohlad ha senz'altro in mente A Beautiful Mind (anche al matematico John Nash fu diagnosticata una schizofrenia paranoide), ma laddove Ron Howard non esitò a trasformare le allucinazioni uditive in visive, contaminando realtà e sogno, Pohlad fa un passo indietro e si concede soltanto qualche lynchiano passettino nel delirio. E alla fine è troppo succube del proprio amore per accorgersi che lo stanno plagiando: il film adotta placidamente la versione dei fatti raccontata dalla seconda moglie di Wilson, Melinda Ledbetter, senza farsi venire nessun dubbio. Il risultato è che il grande antagonista di Melinda, lo psichiatra-guru Eugene Landy, diventa una macchietta, malgrado le settimane trascorse da Paul Giamatti ad ascoltarne le registrazioni per imitarne meglio i tic verbali: non è affatto escluso che Landy fosse davvero così sgradevole, uno di quegli avvoltoi che prosperavano nella California del grande riflusso, volteggiando sul malessere dei ricchi alienati. Ma è uno di quei casi in cui la verità è un ostacolo alla verisomiglianza. Anche le ottime prove di Cusack e Dano congiurano a definire il ritratto di un Brian Wilson eterno bambino, continuamente in cerca di conferme sulla sua genialità, frustrato da un genitore invidioso, da un cugino scettico, da uno psichiatra arraffone, insomma da tutti tranne Melinda. Non è affatto escluso che le cose siano andate così, ma trattandosi della vita di un paranoico, forse un'altra campana era necessaria.
Love and Mercy è al Cinema Lux di Busca giovedì 10 e venerdì 11 novembre alle 21.
Cicogne, tornate al core business
31-10-2016, 10:27animazione, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkCome sapete, da un po' di tempo in qua le cicogne non portano più i bambini. Troppo rischioso, troppo coinvolgimento, insomma adesso preferiscono recapitare smartphone e altri beni di prima necessità. Gli affari vanno bene, tutti sono contenti, noi umani abbiamo trovato un sistema per fare bambini comunque, eppure... eppure forse si stava meglio prima.
Bastano pochissimi minuti per capire che gli autori di Storks hanno lavorato anche al meraviglioso Lego Movie. Le scenografie sono diverse (più convenzionali, purtroppo), i mattoncini hanno ceduto temporaneamente il posto a un mondo di fattorini pennuti, eppure l'atmosfera è la stessa: una grande azienda, un meccanismo grigio, omologante, perfettamente oliato dove basta che qualcuno non sia dove dovrebbe essere per scatenare un'esplosione caotica e vitale. Questo è probabilmente il miglior pregio di Storks: in una fase in cui ormai esce un buon film d'animazione alla settimana, e il rischio che si assomiglino tutti è inevitabile, la nuova divisione digitale della Warner quantomeno sta riuscendo a costruirsi un'identità.
Se non può rivaleggiare con la Pixar per qualità o per ambizione, almeno sta diventando un'anti-pixar dal punto di vista ideologico: se la compagnia di Monsters & co., e Inside Out ha sempre celebrato l'importanza del lavoro di gruppo, anche nella versione più corporativa e aziendale, Lego e Storks cercano di suggerirci che le ditte sono la morte dell'individualità e della fantasia. Giusta o sbagliata che sia, almeno è un'idea: alla Universal con Pets si sono contentati di prendere vecchie idee Pixar e rimetterle assieme senza aggiungerci niente, e il botteghino sta dando ragione a loro. Ma Storks è un film più interessante. Sfortunatamente, l'altro punto in comune con Lego è l'ipercinesi (continua su +eventi!)
Il poeta e il suo poliziotto
24-10-2016, 01:17cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, poesiaPermalinkPosso scrivere i versi più tristi questa notte. Posso scrivere: io l'amai, e a volte ella mi amò. Si chiamava Rivoluzione, Classe Operaia o Comunismo; lei mi amava, ma a volte io ero al bordello. La notte è stellata e lei non è con me: questo è tutto. Ma la poesia dura altre venti righe. Lontano, qualcuno canta, lontano la mia anima non si dà pace di averla perduta. E blà e blà e blà, posso andare avanti tutta la notte, questa notte.
 |
| Ma di giorno si suda (cit.) |
La storia sta per bussare alla porta, Neruda sta per scoprire quanto costa militare in un partito comunista clandestino. Larraín guarda dalla finestra. Nessuno lo ha invitato. Dal nulla prende forma un personaggio da giallo Mondadori: è Gael García Bernal con un cappello da detective. Figlio del bordello e del primo poliziotto di Santiago.
Neruda è un'operazione sofisticata - la scomposizione di un personaggio storico ancora ingombrante - che nasconde, neanche tanto bene, un desiderio di ingenuità disarmante: dichiararsi figlio di Pablo Neruda, invece che di genitori che collaborarono col suo probabile assassino, Augusto Pinochet. Troppo contemporaneo, troppo sgamato per ridurre il Poeta alla sua statua: per non vederne i difetti, la pancia, le occhiaie, l'infedeltà e quella vanità senza la quale forse non si diventa eroi: dalla sua postazione di spione immaginario, Larraín vede tutto ma vuole bene a Neruda lo stesso, come si vuole bene al padre anche quando torna tardi a casa e puzza di whisky e di donnacce.
Anche nel Nordovest gli uomini odiano le donne
18-10-2016, 01:55cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink |
| Questi due li conosco da tre ore, vogliono aiutarmi con uno stalker, a momenti si facevano ammazzare, hanno un fucile da oche nel baule. A parte questo tutto ok. |
La longevità di molti attori - e l'invecchiamento degli spettatori - ha portato alla nascita di nuovi generi di cui forse non tutti sentivamo l'esigenza: dopo il filone "pensionati che fanno i mercenari o le spie" (da Expendables a Red), quello "ottuagenari vendicatori": Remember di Egoyan, Il mistero del caso irrisolto di Bill Condon, e ancora prima questo Blackway, bislaccamente ribattezzato Go With Me per il mercato italiano che se lo ritrova in sala in un piovoso weekend di ottobre a due anni dall'uscita. Ma si può raccontare la vecchiaia senza farne uno spettacolo? E si può farne uno spettacolo senza averne pudore? Stiamo guardando Hopkins nella parte di un vecchio che non ha più niente da perdere, o stiamo solo vedendo Hopkins invecchiare? Certi suoi sguardi smarriti sono fuori o dentro la parte? (continua su +eventi!)
 |
| Puoi farmela un po' più grigia, per favore? |
 |
| Che poi i boss dello spaccio di solito non si riducono a stalkerare le cameriere, boh. |
Il film regge la prova del ferro-da-stiro (si può vedere con un occhio solo: trama lineare, dialoghi didascalici) e sembra già progettato per i lunghi pomeriggi e le seconde serate di chi lavora in casa e ama i noir dove chi se la prende con le donne e gli anziani finisce malissimo. Lascerà invece perplessi gli spettatori ormai assuefatti al consumo intensivo di serie televisive: dietro ai personaggi appena sbozzati si intuiscono drammi che potrebbero riempire una mezza dozzina di puntate, e invece tutto resta sospeso e non detto. Dietro la macchina da presa c'è il regista della versione svedese della trilogia Millennium, che per il suo esordio americano sceglie di non spostarsi da ciò che gli è già congeniale: vecchi uomini che odiano le donne, paesaggi quasi vergini da riprendere virati in quel grigio irritante che un giorno dovrà pur passare di moda. All'UCI di Moncalieri alle 20 e alle 22:25.
La vita segreta (non troppo originale) degli animali
12-10-2016, 02:14animali, animazione, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink |
| MORTE AL GENERE UMANO! |
Pets è il sesto film della Illumination Entertainment - se contiamo anche il primo Cattivissimo me (2010), che era ancora un prodotto della francese Mac Guff, acquisita di lì a poco. L'Illumination ha l'esclusiva per i film di animazione della Universal e grazie ai Minions è diventata una delle più grandi realtà dell'animazione digitale: più grande della branca animazione della Fox, da cui proviene il fondatore (Chris Meledandri lavorò ai primi due Era glaciale), più grande della Dreamworks che forse Meledandri si comprerà. Più in altro c'è solo la Disney/Pixar, ma per ora più che competere sembra che la Illumination si contenti di imitare. Gru e i Minions almeno avevano una loro identità, magari non originalissima, ma tra tanti prodotti in 3d si facevano riconoscere; Pets non prova neanche per un istante a sembrare diverso da quel che promette nei trailer: una rifrittura di concetti e luoghi pixariani e disneyani.
 |
| Che poi non si capisce come vada a finire: diventa vegetariano? |
 |
Quanto sia meccanico l'approccio lo si vede bene nel momento in cui il film si ritrova all'improvviso in una situazione 'alla Up': da qualche parte nella grande città c'è una piccola casa col giardino, dentro forse c'è ancora un anziano signore che aspetta uno dei personaggi. Una scena del genere, in un Pixar autentico, sarebbe stato un colpo al cuore: il classico momento dei lacrimoni. Qui niente. Viene persino pronunciata la parola speciale, "morte" - una parola che in un prodotto per bambini deve essere usata con una cautela - ma non ci si ferma a riflettere, men che meno a piangere: è solo uno snodo qualsiasi della trama, lo spunto per un battibecco in attesa dell'ennesimo inseguimento. Verrebbe da dire che per i bambini magari è meglio così, il pathos di certi film della Pixar è inadatto a loro - ma poi c'è una scena d'azione eccessivamente intensa, in cui i personaggi praticamente annegano, roba che gli stessi bambini potrebbero sognarsi di notte. Non è una questione di budget, non è un problema di rendering: è proprio che manca il cuore. Ma c'è un sacco di animaletti buffi, e sta piacendo a tutti. Al Vittoria di Bra (alle 20:00 in 3d, alle 22:20 in 2d); al Fiamma di Cuneo (alle 21:00); al Multilanghe di Dogliani (alle 21:30 in 2d) e ai Portici di Fossano (alle 18:30 in 2d).
Woody torna a Hollywood, Woody torna a NY
02-10-2016, 13:36cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, Woody AllenPermalinkNon importa se nel frattempo ti sei scavato il tuo buco in questo mondo: quante mani stringi, quante persone conosci, quanti ti devono un favore. Lì su un divano c'è il tuo primo amore, per quanto hai scavato è riuscito a snidarti. Vuole controllare che stai bene, vuole mostrarti che sta meglio. Chiacchiera di cose che non ti interessano, cose che non ritenevi dovessero interessarle: cose che comunque non avresti potuto permetterti, tutte queste cose teoricamente inutili che ormai stanno tra te e lei. Spalanca una finestra su quel teatrino che avevi messo insieme con due ricordi, quella farsa che chiamavi il passato trascorso assieme: non è trascorso davvero, non eravate realmente assieme: ogni discorso era un equivoco in attesa di una terza, o una quarta persona. Rimane solo un gran vuoto, ogni tanto qualcuno ti avvertirà che lo stai fissando.
Cafè Society questa settimana è il film proiettato in più sale, anche nella provincia di Cuneo - se la gioca con la pesciolina Dory - del resto lo abbiamo visto, ormai il marchio Woody Allen è una specie di Walt Disney per la terza età. La gente non va a vedere molti film, ma i suoi sì. Non è un film particolarmente divertente, non è nemmeno una tragedia: è il tipico film del tardo WA. Un cast notevole, costumi stupendi, fotografia pazzesca - in un certo senso è più un film di Storaro che di Allen, luci e inquadrature sembrano più importanti delle chiacchiere pure interminabili dei personaggi. La trama è più evanescente del solito e questo è forse un vantaggio, rispetto agli ultimi anni di canovacci un po' scontati: come se volendo evitare la solita storia, si fosse ritrovato quasi senza storia da raccontare. Siccome i fratelli Dorfman sono una coppia classica del cinema alleniano - il gagster e il giovane innocente di belle speranze - per buona parte del film ti aspetti una svolta tragica che invece, sorpresa! non avviene. Qualcuno viene effettivamente ucciso e nascosto, ma per futilissimi motivi, quasi non se ne possa fare a meno: c'è una pistola sul set, usiamola.
Forse una relativa novità sta nell'idea di mostrare un triangolo sentimentale dal punto di vista del giovane infelice. Sappiamo che per Allen le ragazze sono naturalmente attratte da uomini col doppio dei loro anni: non necessariamente ricchi o potenti (ma aiuta), senz'altro più saggi e colti (continua su +eventi!). Un tipo preciso di relazione da sempre vista con sospetto nelle commedie sentimentali e quasi del tutto rimossa da quelle di ultima generazione, che per WA è una specie di condizione di natura, indiscutibile, al punto che nel film dell'anno scorso la studentessa Emma Stone non aveva nessuna difficoltà a scambiare effusioni col suo professore Joaquin Phoenix sul prato della facoltà - sono quelle piccole cose che ricordano allo spettatore che siamo nel mondo di Allen, un mondo dove un cinquantenne troverà sempre una ventenne disposta a impazzire per lui.
Poi le cose non vanno sempre a finire nel migliore dei modi, ma forse è la prima volta che Allen sceglie di mostrarci la storia dal punto di vista opposto al suo: il ragazzo giovane che viene scaricato perché l'uomo ricco e potente (Steve Carell), per una volta, ha deciso che lascia davvero la moglie per la segretaria. È una piccola rivoluzione copernicana, ma forse è anche il motivo per cui il film gira un po' a vuoto, malgrado Jesse Eisenberg sia quel tipo di attore che sembra nato per recitare film di Allen. Si capisce che il regista vorrebbe dare al suo personaggio un po' di profondità - gli regala anche un siparietto divertente con una ragazza squillo che ai fini dello sviluppo della trama non ha molto senso - e però fino alla fine questo giovane Dorfman resterà poco più che una silhouette, uno che prende continuamente le distanze dalla superficialità e dal cinismo hollywoodiani salvo andare a infilarsi in un posto altrettanto superficiale e cinico come un nightclub newyorchese. Come se WA, dopo aver deciso di mettere in scena l'educazione sentimentale di un giovane, si fosse distratto - tanto che le battute migliori stanno in bocca ad attori attempati e riguardano, come al solito, la morte ("vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, e un giorno o l'altro ci azzeccherai"). Partito con l'idea di raccontare le illusioni perdute della gioventù, WA sembra davvero ritrovarsi soltanto davanti a quell'ingrigito padre ebreo che senza alzarsi da letto lancia la sua sfida alla morte: me ne andrò, ma non staro zitto. "Protesterò"; e a quella moglie in vestaglia che gli risponde: protesterai con chi, protesterai di cosa?
Infine c'è Kristen Stewart, che con Eisenberg recita spesso e si trova bene - anche se neanche con lui sembra mai davvero a suo agio - coi suoi broncetti imbarazzati che contagiano lo spettatore e lo lasciano sempre interdetto - è brava a sembrare imbarazzante, o è imbarazzante e basta? Quando è sulla spiaggia col fidanzato giovane, e i raggi dell'amore si velano all'improvviso dell'ombra del rimpianto che Kristen sottolinea trattenendo a stento il fiato come a reprimere un rutto: cattiva recitazione o colpo di genio? Perché a volte le ragazze fanno davvero così, io le ho viste. Credo. È passato del tempo. Non sono più la stessa persona. Vivo in un'altra città, faccio un altro lavoro, tutti mi salutano l'unica cosa che mi è rimasta è che vado ancora a vedere i film di Woody Allen - oggi al Citiplex di Alba (17:00, 19:00, 21:15), al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (15:20, 17:40, 20:20, 22:30), al Vittoria di Bra (17:30, 20:00, 22:00), al Fiamma di Cuneo (15:15, 18:15, 21:15), ai Portici di Fossano (16:00, 18:30, 21:15), al Baretti di Mondovì (21:00), al Cinecittà di Savigliano (16:00, 18:10, 20:20, 22:30).
I cagnolini della guerra
27-09-2016, 01:36Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, guerra, traffico d'armiPermalinkVoi cosa combinavate a 22 anni? Nel 2006, Efraim Diveroli gestiva dal tinello del suo appartamento una ditta scalcinata che gli aveva passato il padre per levarselo di mezzo. Cercava di vincere appalti per forniture all'esercito. Appena l'esercito metteva il bando su un sito, Diveroli si metteva a cercare le forniture più a basso costo che trovava. Le forniture erano armi, fucili e munizioni, raccattate il più delle volte a prezzi di saldo dai magazzini dei Paesi del vecchio blocco sovietico. Qualche volta vinceva un appalto, qualche volta lo perdeva, e nel giugno del 2006 ne vinse uno per trecento milioni di dollari. Questo faceva Efraim Diveroli a 22 anni - e a 24 era in galera. Ma non c'è rimasto poi tanto, e in seguito non ha nemmeno cambiato mestiere - solo il nome alla ditta. In fondo cos'aveva fatto di male? aveva soltanto smerciato munizioni albanesi agli afgani filo-USA, senza sapere che erano di fabbricazione cinese. Pare che per il Pentagono non sia un problema se armi i tuoi alleati con Ak-47 degli anni Sessanta e con proiettili recuperati in qualche bunker in Albania, magari da un tizio che è sulla blacklist e usa come prestanove un ventiduenne sovrappeso di Miami. Però se scopre che è roba fatta in Cina, è un guaio, ehi, con la Cina c'è un embargo. La guerra è così. L'America è così. E Trump non ha ancora vinto, pensa
Un film come War Dogs si scrive da solo, ma se l'avesse scritto Scorsese saremmo tutti più felici (continua su +eventi!)
 |
| Fa ridere perché sono al Ministero della Difesa ma si sono appena fatti una canna e quindi sono in para dura AH AH AH (no sul serio forse sono troppo vecchio, boh), |
Un film come War Dogs si scrive da solo, ma se l'avesse scritto Scorsese saremmo tutti più felici. Un bel vortice di avidità e dissipazione, l'ascesa e la caduta dell'ennesimo personaggio posseduto dallo spirito animale del capitalismo eccetera. Invece è toccato a Todd Phillips, reuccio della stoner comedy, avete presente, quei film coi ragazzi americani che si fanno le canne (il che pare sia divertente in sé, almeno questa è la spiegazione che mi do: i giovani americani vanno al cinema a vedere giovani americani farsi le canne, perché ciò li diverte). Molto spesso c'è Jonah Hill, che in Wolf of Wall Street faceva proprio da anello di congiunzione tra la stoner comedy e l'universo adulto (ma ancora più stonato) di Scorsese. E benché Jonah e la sua spalla perfettina Miles Teller, mentre inseguono i loro sogni avidi, citino più volte Scarface di De Palma, è a Scorsese che Phillips torna in continuazione. E va benissimo: siamo tutti in crisi di astinenza da Scorsese, in quella fase in cui non si va tanto per il sottile e mandi giù di tutto, anche Bradley Cooper che fa il ricercato internazionale (del resto produce lui). War Dogs avrebbe potuto riuscire meglio: l'epopea di due ragazzini americani ignoranti che si ficcano in guai più grandi di loro meritava forse una narrazione più distesa; ma la formula originale per miscelare il moralismo con la fascinazione per il crimine la conosce solo Scorsese, e se la tiene ben stretta. O forse si sarebbe potuto insistere di più su come l'esercito americano si sia voltato dall'altra parte per non vedere da dove i fornitori gli procuravano le armi - imbroglioni di mezza tacca, ragazzini che fotoscioppavano i bilanci, a un certo punto andava bene di tutto, e se non ci si fossero messi in mezzo i giornalisti forse Diveroli starebbe ancora trafficando kalashnikov della guerra fredda. Magari lo sta ancora facendo. Hill e Teller sono in parte, ma non sembrano giovani come effettivamente erano Diveroli e il suo socio Packouz: del resto a 22 anni qui da noi sei ancora un ragazzino. I due protagonisti sembrano già sulla trentina, quel momento nella vita in cui certe porte si chiudono, magari una compagna resta incinta e sì, se un tuo vecchio amico ti avesse proposto di trafficare munizioni in medio oriente, tu saresti stato abbastanza disperato da accettare. Trafficanti è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo alle 20:20 e alle 22:45; al Cinecittà di Savigliano alle 20:20 e alle 22:30.
Alla ricerca del sequel perfetto
23-09-2016, 01:35animazione, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkCara Pixar,
c'è qualcosa che volevo chiederti, ma non ricordo cosa.
A proposito, complimenti per il successo del tuo nuovo film - il seguito di Nemo, tredici anni dopo - sembra che stia mettendo tutti d'accordo, e con i sequel non è facile, sai? Ma certo che lo sai. Ormai siete i più esperti: tra la saga di Toy Story, Cars 2 e... e... quell'altro film coi mostri che ho pur visto e adesso... c'è un altro tuo film al cinema, lo sapevi? Beh, sì, immagino di sì.
Stavamo dicendo?
 |
| Il prossimo fatelo sul polpo per favore |
quello che vorrei dirti è che sono proprio contento per i tuoi ultimi successi. Ti credevamo un po' appannata, poi Inside Out ha fatto il botto e soprattutto non era il solito film, era qualcosa di davvero nuovo. L'altro film coi dinosauri non è andato altrettanto bene, ma anche in quel caso non si può dire che abbiate scelto l'approccio più banale al problema. Invece ero un po' in pensiero a causa dei sequel. No, non ho niente contro i sequel, immagino che siano investimenti sicuri. Non si vive di soli Inside Out, certe volte bisogna anche prendere fiato. E poi bisogna ammettere che il vostro approccio ai sequel è tutt'altro che banale. Questa idea, per esempio, di spostare l'attenzione sul comprimario, su un personaggio che nel primo film sembrava monodimensionale - è una mossa interessante, perché sfida davvero le tue aspettative di spettatore. Anche solo l'idea di dire: facciamo un film con Cricchetto protagonista e Saetta McQueen da spalla - è chiaro che la prima reazione dello spettatore è: non funzionerà mai. Cricchetto è ridicolo, è imbarazzante, inaffidabile, non ha la profondità che serve. E invece. Stessa cosa col mostro-monocolo di Monsters University, come si chiama... è solo una spalla comica, non puoi caricare tutto il film sulle sue palpebre, no? E invece...
È un po' come con la vita vera, quando all'improvviso condividi qualcosa con una persona che fino a quel momento era rimasta sempre all'orizzonte delle tue conoscenze, e ti rendi conto che è una persona in carne e ossa proprio come te, e che tu l'hai snobbata fino a quel momento. È un effetto molto particolare, ma non ricordo assolutamente perché ne stavo parlando con te che sei... chi sei? Ah sì, la Pixar.
Per dire, hai presente Nemo? Immagina che un giorno ne facciano un sequel, e invece di raccontare un altra storia di Nemo che si perde, si concentrino, che ne so! sulla tartaruga hippie, o magari su quella pesciolina che aiutava il padre di Nemo e che aveva un problema con la memoria a breve termine, come si chiamava? Ecco, immagina una cosa del genere. La tua prima reazione è: ma cosa puoi raccontare su una pesciolina che perde la memoria ogni cinque minuti? È solo una comparsa, una spalla, non può funzionare. E dopo un'ora di film immagina che stai piangendo per la sorte della pesciolina, e di Nemo non ti frega più niente, è diventato la comparsa nella vita di qualcun altro. Sarebbe incredibile, no?
Ecco, forse sto scrivendo alla Pixar per proporre una storia del genere.
O il romanzo di formazione di Anton Ego.
O le avventure di Charles Muntz sul suo dirigibile.
Cara Pixar,
ultimamente ho qualche problema a mantenere la concentrazione - (continua su +eventi!)
Cara Pixar,
ultimamente ho quaalche problema a mantenere la concentrazione - sarà l'età, o gli impegni, insomma, quel che scrivo può risultare un po' sconnesso. Volevo dirti che ho visto il tuo ultimo film ma... non sono così sicuro di averlo visto. Ma correggimi se sbaglio. C'è un comprimario di un film precedente che nella prima mezz'ora si comporta in modo insopportabile. Finché non ti rendi conto che dietro questa scorza imbarazzante c'è una persona vera (anche se è solo un personaggio di pixel), col suo fardello di traumi e delusioni. Scommetto che si ritroverà sperduto in una situazione più grande di lui, e potrà farcela soltanto grazie al sostegno di amici vecchi e nuovi, perché lo spirito di squadra è il minimo comun determinatore di ogni lungometraggio Pixar. E ci sarà una scena madre attentamente preparata per sessanta minuti, che ci farà piangere come fontane, e poi un po' di azione insensata e divertente prima del finale. Ecco, questo è il film che tra un po' uscirà nelle sale, e non vedo l'ora. Anche se non vado matto per i sequel. Ma non si può sempre aver tutto.
 |
| Non mi freghi piiaaaaaaaaaaawwwww |
mi è venuto un dubbio. Forse il film dopo tutto l'ho visto, ma ero stanco, oppure in sala c'erano troppi bambini che chiedevano di essere rassicurati: ma poi tornano il papà e la mamma? ma poi lo ritrova Nemo? Ma poi dove va il polpo? Ma poi, ma poi, ma poi. Cara Pixar, adesso che mi ricordo forse volevo scriverti che sono un po' stanco del modo in cui riesci sempre a manipolarmi: a farmi odiare un personaggio (Dory per metà film è insopportabile) e poi a farmi piangere per lei. Che ormai ho capito come funzioni e non c'è neanche più bisogno di ricordarseli, i tuoi film, dopotutto la struttura si ripete. Che questo, in particolare, funziona fino a un certo punto: i vecchi personaggi sono ridotti a macchiette, i nuovi sono interessanti ma non c'è quasi tempo per svilupparli (il polpo in particolare non sta fermo un attimo). Che la sequenza finale è un po' troppo fracassona, come era già successo con Cars 2, uno dei tuoi film più deboli. Che insomma forse a questo punto è ora di lasciarci, perché è più colpa mia che tua. Tu hai i tuoi franchise da mandare avanti per quei milioni di bambini che hanno il diritto di sentirsi raccontare le vecchie storie. Se io comincio ad annoiarmi, a fissarmi sui dettagli o a intravedere i meccanismi, è un problema mio. Devo passare ad altro. Magari facendo finta di non vedere che c'è più cinema in un tuo sequel riuscito a metà che in molti film cosiddetti d'autore. Cara Pixar.
Non mi ricordo più cosa ti stavo dicendo. Ma sai che c'è? Non importa. Non vedo l'ora di vedere il tuo prossimo film, ho sentito che è nelle sale! Anche se è un sequel. Alla ricerca di Dory è al Cityplex di Alba (19:45, 22:00), al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:20, 22:35), all'Impero di Bra (alle 20:20 in 3D, alle 22:30 in 2D), al Fiamma di Cuneo (21:00), al Bertola di Mondovì (21:00), all'Italia di Saluzzo (20:00, 22:15), al Cinecittà di Savigliano (20:20, 22:30).
Poteva andarti peggio, potevi nascere in una famiglia situazionista
12-09-2016, 23:44arti contemporanee, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, generazione di fenomeniPermalink |
| Sono traumi che uno poi si porta dietro per tutta la vita, capite |
Forse non è solo merito di Cristian Mungiu se i problemi di un padre di famiglia nella Romania in sfacelo mi appassionano di più di quelli di due quarantenni wasp di successo, ancora arrabbiati coi genitori che non li hanno portati in gita col camper nel Grand Canyon. Forse Nicole Kidman (che ha fortemente voluto il film, e lo ha prodotto), per quanto credibile nel ruolo di grande attrice perennemente insicura, non lo è altrettanto nel ruolo di orfana irrisolta; forse Jason Bateman, a cui non manca il mestiere, ha perso del tutto di vista l'aspetto comico della situazione (che a un Baumbach, per esempio, non sarebbe sfuggito).
 |
| Interpreta il ruolo di un'attrice che per restare sulla breccia comincia a concedere scene in topless. (Ma siccome la vera Kidman non è messa così male, questo è tutto il topless che vedrete). |
Se almeno fossero personaggi realmente esistiti, li si potrebbe odiare un po' e poi farsi venire un po' di pena per loro, ma se li è inventati Wilson, e se si è lasciato sfuggire una stilla d'umanità di troppo, Bateman non l'ha vista. Se è molto facile prendere le distanze da due sessantenni che credevano di cambiare il mondo con le candid camera, dall'altra si fa più fatica del previsto a empatizzare con un autore di saghe young adult affetto da blocco dello scrittore e un'attrice quarantenne che riuscirà a realizzarsi soltando recuperando qualche parte prestigiosa a Hollywood.

Ragazzi, alla vostra età non dovreste essere voi quelli
che sloggiano i figli da casa?
La famiglia Fang non è un film sgradevole, ma conferma qualche sospetto sullo stato del comedy-drama statunitense: è un film che vorrebbe toccare qualche corda in modo delicato, e invece non fa che urlare per tutto il tempo: LASCIATI ALLE SPALLE I TUOI GENITORI (le musiche, intrusive e paracule, hanno la loro parte di responabilità). Credevo che non avrei mai scritto una cosa del genere, ma un film così mi fa venir voglia di riguardarne uno italiano di qualche stagione fa, Anni felici di Luchetti, che parlava di cose simili ma osservate dal vero, con una delicatezza e una profondità che Bateman e soci si scordano. E dire che al tempo mi ero pure concesso il lusso di parlarne male, Luchetti se puoi perdonami. La famiglia Fang è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo alle 20:10 e alle 22:30.
Compra un esame in Transilvania (prima che lei compri te)
06-09-2016, 02:18cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, invecchiarePermalinkUn padre, una figlia (Bacalaureat, Cristian Mungiu, 2015).
Romeo ha una cinquantina d'anni, una moglie che non lo guarda più negli occhi, un appartamento dignitoso al piano terra di un quartiere in sfacelo, un telefono che suona in continuazione, un reparto di ospedale da mandare avanti, un'amante che comincia a lanciare ultimatum, un'unica figlia a cui ha insegnato l'importanza dell'onestà, dell'integrità, del duro lavoro. La Romania è un disastro, ma Eliza può farcela; ha vinto una borsa di studio per l'Inghilterra, l'importante è superare l'esame di maturità. Cosa può mai andare storto? Romeo ha una settimana di tempo per rovinare tutto; perdere la famiglia, la stima di sua figlia e di sé stesso. Può bastare un sasso, una distrazione, una tentazione, una macchina ferma sul lato sbagliato della strada. La Romania è un cantiere abbandonato, chi ha vinto l'appalto è scappato per primo, c'è gente che ci si nasconde e gente che gira a vuoto, in cerca di uscita.
 |
| Oh com'è difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme imbiancano - oh oh oh oh |
(Ani de liceu, cand tii soarele in mana si te crezi legendar Prometeu...)
Vien voglia di chiedere la cittadinanza onoraria, anche perché Mungiu si è fatto un po' prendere la mano. Ormai lontana la secchezza di 4 mesi 3 settimane e 2 giorni, con quella scansione fulminante in tre atti: Bacalaureat dura venti minuti in più, di cui alcuni passati semplicemente a far girare a vuoto il protagonista, o a farlo riflettere immobile su una panchina. E per quanto la sceneggiatura sembri infierire contro di lui, alla fine non si riesce a non voler bene a questo povero tizio che vuole salvare la figlia dal disastro che lui stesso è diventato. Del resto Bacalaureat parla di corruzione sociale ma anche fisica - di come sia inevitabile venirci a patti, a una certa latitudine e a una certa età. Ma anche chi è scappato in terre meno corruttibili potrà voler dare un'occhiata - il film è al Fiamma di Cuneo fino a mercoledì (ore 21); da giovedì è al Monviso (sempre a Cuneo, sempre alle 21).
Chi vi uccide sa quello che fa, date retta
29-08-2016, 00:45cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, guerra, terrorismoPermalink |
| Ora vi spiego la guerra, signorini. |
C'è un Occhio che gira intorno al mondo e vede quello che vuoi e che non vuoi. C'è una casetta da qualche parte in Kenya, con stanze separate da tramezze che non arrivano al tetto (molto comodo per le inquadrature dei mini-droni). Dentro ci sono terroristi fanatici, che forse credono che la cittadinanza inglese o americana li protegga dall'Occhio. Stanno per indossare pettorine e andarsi a fare esplodere in qualche luogo affollato. Bisogna colpirli prima che colpiscano - ma c'è una bambina in strada, a pochi metri dal probabile impatto, vende focacce e non si sposterà finché non avrà il paniere vuoto. Ci sono soldati che devono fare il loro mestiere. Ci sono politici che non sanno che ordini dare.
 |
| È fortissimo, James Bond gli taglia le unghie dei piedi. |
 |
| QUALCUNO LE COMPRI QUEL PANE |
Hanno già le armi più potenti e precise mai adoperate, ora reclamano anche di avere sentimenti raffinati e coscienze tormentate. Come il ragazzino di Ender's Game, a cui Hood non consentiva soltanto la licenza di sterminare una razza aliena, ma anche il privilegio di sentirsi in colpa e rimediare. Anche stavolta la voce più falsa è quella di una donna che fa appello ai buoni sentimenti; nella penultima battuta del film, il generale le fa il cazziatone. Io ho visto il mondo, ho raccolto i cadaveri di quattro attentati suicidi, non si permetta più di spiegarmi cos'è la guerra. Uno vorrebbe tanto che Hood fosse un po' meno militarista di così, perché bravo è bravo; o che almeno lo fosse in modo più onesto (alla Clint Eastwood?), senza confondere le acque, senza mimare la tenerezza e nascondersi dietro il velo quasi integrale di una povera bambina innocente. E invece anche stavolta si può andare a vedere il suo film convinti che si tratti di una parabola sugli orrori della guerra; si può tremare per un'ora sul destino della povera vittima collaterale, ma poi?
 |
| Non esistono razze superiori, salvo rare eccezioni come gli attori britannici di una certa età. Rickman e la Mirren sono perfetti e lo sarebbero anche se interpretassero i droni. |
Ma poi sulla strada di casa ti accorgi che i militari sono quelli che ne escono meglio. Sono attori di razza come Helen Mirren e Alan Rickman (nel suo ultimo ruolo), ma c'è anche tantissima varietà razziale, ci sono ragazze ispaniche e morette dell'Iowa con occhioni pronti a inumidirsi, c'è una coppia fantastica di spie kenyote, tra cui il Barkhad Abdi già visto di Captain Phillips. Sono tutti bravi, sono competenti, dicono le bugie solo a fin di bene ed è chiarissimo che non godono a uccidere la gente, anzi. Chi potrebbe mai pensarlo. Alan Rickman è molto preoccupato per la bambola che deve comprare alla nipote. Le vittime collaterali dovrebbero sentirsi fiere di essere uccise da gente così.
Per contro, i politici sono tutti bianchi e preoccupati. Sudano, strillano, si tolgono la giacca, il Ministro degli Esteri è al gabinetto a Hong Kong perché ha mangiato gamberetti - non che l'Occhio del Cielo non riesca a trovarlo anche lì, ma insomma Hood non rinuncia a nessun espediente per ridurre l'autorevolezza degli eletti dal popolo. Un discorso a parte gli americani, che non capiscono che tempo ci sia da perdere e preferirebbero sparare prima e farsi le domande poi. Eye in the Sky resta un film importante: forse il primo dramma da camera ambientato intorno al mondo. Semplicemente non è il film controverso che il trailer ci vende: è un film sulla guerra telecomandata e chirurgica, su come funziona bene e soprattutto su come funzionerebbe meglio senza troppi civili nella sala dei bottoni. Un eventuale ufficio propaganda delle forze armate britanniche non avrebbero saputo produrne uno migliore - anche per la pubblicità offerta ai mini-droni di ultimissima generazione
Finalmente hanno riaperto l'Aurora di Savigliano, che lo proietta alle 18:30 e alle 21:15, e il Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (alle 15:15, alle 17:35, alle 20:15 e alle 22:35).
La vera Squadra Suicida si chiama Warner Bros
22-08-2016, 12:03cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fumettiPermalinkCom'è che i nemici di Batman e di Superman scappano sempre di prigione? Non ci stanno mai più di qualche mese, se sciogli l'acido nell'acquedotto di Gotham City ti danno massimo tre settimane con la condizionale. Era ancora l'Età dell'Argento dei fumetti di supereroi, gli anni '60 nel mondo reale, quando qualche lettore cominciò a porsi il problema: è verosimile che Joker esca dal manicomio criminale ogni tre per due? Perché i lettori di fumetti sono così. Possono accettare che Superman abbia il superudito e la supervista, ma dev'essere calato in un contesto verosimile. E gli sceneggiatori questa cosa la capiscono, e invece di farsi due risate si sforzano di trovare spiegazioni, per esempio... c'è un superservizio segreto che arruola i supercriminali in missioni suicide in cambio di sostanziosi sconti di pena. Batman lo sa ma non ci può fare niente, ha le bat-mani legate.
 |
| Avete quindici minuti per incontrarvi, raccontarvi che siete uno più cattivo dell'altro, ammazzare gli altri cattivi e sviluppare un maschio senso di cameratismo. |
La Warner Bros?
Da qualche parte ai piani alti della Warner Bros dev'esserci un gruppo di, come definirli, diversamente umani. Qualche figlio di, qualche ragazza di, qualcuno che passava di lì e aveva bamba per tutti, una squadra di iperattivi ipodotati che se hanno mai sfogliato un fumetto non riuscivano a decifrare le scritte nelle nuvolette; se mai sono entrati in un cinema, si sono addormentati dopo i trailer. Una gang di deficienti con una missione suicida: salvare il cinema da sé stesso. Perché andiamo, dopo 15 anni di cinecomics, non sentite anche voi una certa stanchezza? Nell'anno in cui abbiamo già visto Batman pestare Superman e incontrare Wonder Woman, i Fantastici Quattro horror, gli X-Men anni Ottanta, gli Avengers che litigano, Deadpool che scoreggia, e potrebbe andare avanti così per decenni, i calendari sono pieni di uscite fino al 2020, nelle fumetterie c'è un archivio di trame e personaggi praticamente inesauribile... chi può fermare il treno in corsa? Chi può salvare il cinema da tutto questo? La Warner può. La Warner può colarsi a picco prendendo i supereroi e i supercattivi più popolari del mondo e buttarli in film senza senso finché il pubblico non si stufa. Sembra impossibile, ma può funzionare.
 |
| "Zio la vetrina è il simbolo, se non spacchi la vetrina non sei nessuno". |
Già, i trailer.
Ecco quel che sanno fare alla Warner: i trailer (continua su +Eventi!)
Per cui a un certo punto qualcuno deve aver proposto la cosa: ma perché non ce ne fottiamo della struttura del film, del ritmo, della costruzione dei personaggi, e non montiamo semplicemente una ventina di trailer movimentati e colorati? Ai ragazzini piacciono, magari riusciamo a non addormentarne qualcuno. L'idea che si possa sostituire una storia con la pubblicità della storia è di un'arroganza, di un'ignoranza spettacolari. Da qualche pezzo di trama che emerge qua e là in mezzo a questo carosello di esplosioni e smorfie si capisce che David Ayer una storia se l'era immaginata (uno squadrone di antieroi votati alla morte lo aveva già messo in scena in Fury). Forse era una storia troppo noir, poi Deadpool ha fatto il botto col suo umorismo da spogliatoio delle medie e ai piani alti hanno deciso di spazzare via tutto e lasciar per terra i rottami. Una giovane archeologa scopre in un sito antichissimo uno Spirito che la possiede e che vuole dominare il mondo: avvincente, no? No? Come dite? è la storia più vecchia del mondo, la Mummia, vi cascano le palle? Vabbe', la riassumiamo in un trailer di tre minuti e ci mettiamo un pezzone classic rock in sottofondo. Un assassino nato, siccome è impersonato da Will Smith, vuole riallacciare i rapporti con la figlia preadolescente. Originale, vero? È tipo la trama di tutti i film d'azione con maschi stagionati per protagonisti, da Liam Neeson a Kevin Costner? Non importa, tanto te la riassumiamo in due minuti e ci mettiamo su un altro pezzone rock, dai che siamo la Warner. E poi c'è Joker, già, Joker.
 |
| "Però stavolta cattivi". |
Joker secondo me è il personaggio più facile del mondo. Ti metti una maschera e fai il matto. Non devi avere giustificazioni, non devi avere scrupoli, fai una risata e strabuzzi gli occhi. Jack Nicholson, certo. Heath Ledger, mi rendo conto. Ma solo perché nessuno ha mai pensato a Costantino Vitaliano, io credo che sarebbe stato un buon Joker anche la Gegia con il trucco e il parrucco adeguato. Non a caso, nel vecchio telefilm di Batman, i cattivi tutti-matti li facevano fare agli ospiti, una volta lo ha fatto pure Liberace divertendosi tantissimo. Qui c'è Jared Leto, e non ho pregiudizi contro Jared Leto: almeno voleva farlo un po' diverso. Ma non gli danno il tempo. Non fa neanche in tempo a picchiare la sua ragazza, cosa che succedeva persino nei cartoni animati in tv e dava un senso a entrambi i personaggi. Cinque minuti di smorfie e risatine e poi passiamo ad altro. La seduzione della sua psicologa, una storia potenzialmente fortissima e inquietante, bruciata in tre scene con la voce fuori campo, manco fossimo in piazza col cantastorie che mostra i pannelli col dito: GUARDA-IL-PERFIDO-JOKER-SEDURRE-LA-PROFESSORESSA. È un film veramente suicida, nel modo in cui brucia sul suo cammino decine di storie e situazioni interessanti. Manipolazione, amour fou, folie à deux... che palle però dover raccontare tutta questa roba. Che palle dover raccontare qualsiasi cosa. Troppi dialoghi! Troppe cause ed effetti, noi vogliamo le esplosioni! Però, attenzione, nessuno si deve fare troppo male. Esplosioni per famiglie.
A un certo punto Harley Quinn - Margot Robbie, di cui tutti parlano bene - spacca una vetrina con la sua mazza iconica, e a chi le chiede conto risponde: Beh, che v'aspettate? Sono cattiva. I cattivi fanno queste cose, no? Spaccano vetrine. In effetti è la cosa più cattiva che la ragazza di Joker fa in tutto il film. Suicide Squad è quel figlio di papà che si concia da Black Bloc quando gli passa il corteo sotto casa, e poi si eccita ribaltando un cassonetto: rivoluzione! Cattivo come i tatuaggi che informano i passanti che sei un duro, perché altrimenti non ci farebbero caso e anche tu, allo specchio, qualche dubbio te lo faresti venire.
Suicide Squad ha fatto il pieno subito - era il minimo, con tutto il battage che c'era intorno - ma non è il colpo grosso che la Warner si aspettava per ridurre le distanza con la Disney/Marvel. In patria è crollato alla seconda settimana, come Batman v Superman (a dire il vero un po' meno). Viva il passaparola, e viva anche la pirateria, che punisce i film-evento non all'altezza dell'evento. E viva anche gli squadroni di pagatissimi deficienti che mandano in sala catastrofi del genere. Sono la nostra unica speranza di sopravvivere ai supereroi. Suicide Squad è al Fiamma di Cuneo (20:05, 22:45), al Multilanghe di Dogliani (21:30) e al Vittoria di Bra (20:00, 22:30).
L'uomo che batteva i nazisti (e i cavalli)
17-08-2016, 22:43cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, nazismo, razzismi, sportPermalink |
| Il trucco è che il colpo di pistola spaventava un po' il cavallo, e intanto Owens era partito. |
 |
| Il ralenti sarà banale, ma con l'atletica funziona sempre. Hopkins non lo usa, sembra che abbia fretta di mostrarti le gare per passare ad altro. |
(Quando capisci che un biopic non funziona? Per esempio, quando è meno avvincente della pagina di Wikipedia).
Come si fa a sbagliare un film su Jesse Owens? Da una parte un afroamericano che resta a ottant’anni di distanza uno dei più grandi atleti di tutti i tempi: dall’altra hai i nazisti e i razzisti dell’Ohio. Per trasformare l’atletica in tragedia e in spettacolo, puoi ripassare Chariots of Fire; per capire come parlare di razzismo e di sport, puoi rifarti ad Ali di Michael Mann. Quanto alle olimpiadi di Berlino, prendi la Riefenstahl e vai sul sicuro. Ma se tutte queste lezioni le ignori, se i dilemmi etici degli atleti li risolvi in discussioni di tre minuti, se il razzismo lo dai per scontato, se i tuoi nazisti sembrano cattivi da melodramma (sul serio, ogni volta che parla Goebbels partono i violini), se la Riefenstahl ti interessa solo come personaggio, il risultato finale si avvicinerà pericolosamente al livello di una fiction italiana, con un budget più alto, ma con meno personalità addirittura.
 |
| Il reverendo che sposò gli Owens aveva i baffetti alla Hitler, il che mi fa impazzire. |
Proprio lui che col suo biopic su Sellers aveva dimostrato di saper sfidare le regole del genere - quella però era un’icona che supplicava di essere profanata; con Owens, con la leggenda olimpica, non si scherza, e il risultato è anche che non se ne riesce nemmeno a discutere seriamente. Più che personaggi in scena ci sono delle figurine: hanno tutti obiettivi lineari (l’atleta nero vuole vincere, l’allenatore bianco vuole riscattare i suoi insuccessi, il dirigente olimpico vuole sconfiggere i nazi) e quando qualcuno o qualcosa si mette di traverso, s’ingrugnano, finché qualcuno non li sblocca, di solito con un bel discorso. Anche Hopkins è succube di questa moda del discorso taumaturgico, che tanti danni ha fatto negli ultimi anni (vedi il Lincoln di Spielberg). Ma nel suo caso l’ossessione rasenta il comico, perché molto spesso i discorsi non c’entrano nulla col conflitto in atto: ad esempio, quando Owens è incerto se boicottare o no i Giochi come gli ha chiesto un’associazione afroamericana, l’allenatore lo commuove spiegandogli che una volta si è schiantato con un aeroplano. Non c’entra tantissimo, ma nel frattempo è partita la base languida e pare che adesso funzioni così, ogni volta che un personaggio è frustrato e deve prendere una decisione tu inserisci un blocco di testo qualsiasi nel copione, un attore lo legge, i violini partono, voilà, la decisione è presa. Pazienza se il protagonista sembra non aver personalità, e oscillare a seconda dei discorsi che ascolta.

Luz Long è un gran personaggio, ok,
ma arriva dopo un'ora e mezza di film.
Lo sport è spesso ingrato coi suoi protagonisti: li piazza alla ribalta e poi cala il sipario all’improvviso. Il caso di Owens è esemplare anche perché ha sempre rappresentato quello che gli Stati Uniti vorrebbero essere - la patria multietnica che piglia Hitler a calci in culo. Se la storia finisse lì, se Owens non avesse poi dovuto interrompere subito la carriera e fare i conti col razzismo in patria, sarebbe una storia fin troppo edificante - probabilmente quella che aveva in mente Hopkins. Race torna sul grande schermo giovedì (ore 22) a Bra, frazione San Matteo, in occasione della rassegna Cinema d’estate in periferia.
Un'altra estate, un'altra Purga
08-08-2016, 18:15Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, traffico d'armiPermalinkL'idea va avanti dal 2014. Un budget contenuto, un regista giovane che dal primo episodio si è liberato dell'ansia di strafare, un concetto originale anche se un po' passé: un carnevale per adulti, una notte in cui, in un'America futura appena un po' fascistizzata, tutti possono "sfogarsi" commettendo tutti i reati che vogliono. Con tutte le armi che vogliono. A un primo livello, abbiamo una satira dell'ossessione particolarmente americana per le armi da fuoco. E andrebbe già benissimo così. Ma la carta vincente della Purga (nella versione italiana lo traducono Lo Sfogo e fa ridere lo stesso) è la sua grezzissima ipocrisia: la scelta di stare sempre dalla parte delle vittime, encomiabile se non venisse da chi ha inventato il marchingegno di tortura.
The Revenant, due ore e mezza di saporita ricerca della vendetta e cinque minuti finali per dire che la vendetta è una cosa ingiusta. Ecco, The Purge fa la stessa cosa: mette da una parte i buoni, pacifisti e tolleranti; dall'altra dei personaggi che sono un po' repubblicani, un po' nazisti, un po' satanici, insomma il peggio del peggio del peggio, e non vedi l'ora che i pacifisti li massacrino. Naturalmente questi ultimi devono esitare un po', devono essere perseguitati e costretti, perché sono pacifisti. Ma quando alla fine succede, ecco, è una gran Purga, volevo dire un grande Sfogo. DeMonaco gioca col senso di colpa dello spettatore progressista con un cinismo d'altri tempi: dai, sfogati, ti senti in colpa? Lo sai perché ti senti in colpa? Perché sei un ipocrita. Sfogati un altro po', ti farà bene. E così via, episodio dopo episodio.
Quest'anno poi è tempo di elezioni, e The Purge non poteva assolutamente perdere l'occasione: si scopre così che, malgrado tutto finora ci lasciasse pensare il contrario, l'America di The Purge è ancora una democrazia, e che non c'è oligarchia satanica che non possa essere rovesciata dal voto popolare ogni quattro anni: basta conquistare gli anziani della Florida ed è fatta. C'è addirittura una candidata (Elizabeth Mitchell, la dottoressa di Lost) che promette di abolire la barbara usanza che pure ha aumentato l'indotto delle armi e della sicurezza, e ha ridotto drasticamente la disoccupazione. Ovvio che il partito al potere voglia farle la pelle, approfittando della notte della Purga. Nel frattempo trovi stranieri - turisti della Purga - che vanno in giro per la capitale degli Stati Uniti travestiti da Abraham Lincoln e da Statue della Libertà, per sfogarsi su innocenti passanti americani. In un vicolo qualcuno sta ghigliottinando qualcun altro, tutto regolare. Teeen-ager birichine vanno in giro cosparse di sangue brandendo seghe elettriche. Però chi va al cinema aspettandosi esattamente questo, un'ora e mezza di violenza folle e insensata, ci rimane sempre male, perché? Perché questa roba rimane sullo sfondo, è la spezia con cui DeMonaco attira gli spettatori al cinema. Ma poi li vuole intrattenere con qualcos'altro che è una specie di agenda politica, progressista a suo modo, e scorrettissima. (Continua su +eventi!)
 |
| Questi sono i Buoni, multietnici come è giusto che sia. Ammazzano tantissima gente, ma per un buon motivo e senza goderne troppo visibilmente. |
I Cattivi sono gente vecchia e sanguinaria, tutti rigorosamente bianchi (sembrerebbe una proiezione distopica se non avessimo visto un pubblico del genere alla Convention repubblicana): adunati in una chiesa presbiteriana, conducono riti orgiastici che prevedono l'eliminazione di poveri e senzatetto. Quanto ai Buoni, sono tutti minoranze etniche, perlopiù afro e latinos, con facce che non vedi di solito a Hollywood e che gridano blaxploitation (Betty Gabriel). I soli bianchi dalla loro parte sono il candidato donna e il suo gorilla, l'efficiente e spigoloso Frank Grillo, l'unico sopravvissuto dal film precedente. Il candidato dei tristi satanici invece è un pretino, abbastanza simile ad alcuni rivali di Trump alle primarie - nemmeno un visionario come DeMonaco poteva immaginarsi Trump candidato. Il risultato non è semplicemente un sano film di fuga metropolitana che adatta i temi dei Guerrieri della notte o di 1997: fuga da New York ai nuovi tempi e allo spirito di fraternità interrazziale di Fast and Furious; è anche il manifesto politico più sfacciato che credo di aver visto in vita mia. Per un'ora e mezza non fa che dirti che i cattivi sono i bianchi ricchi, tranne quella che, con molta sensibilità e diplomazia, guiderà la rivolta dei ghetti. Non so quanto lo staff di Hilary Clinton possa apprezzare. Tanto le elezioni si vincono coi voti dei pensionati in Florida. Però quando un giorno i nostri figli ci chiederanno: papà, cosa hai fatto per evitare che vincesse Trump? DeMonaco avrà almeno la risposta pronta: con un budget medio-basso ho fatto il film di propaganda più smaccato di sempre. L'ho fatto con tutta la violenza che serviva per conquistare le sale dei quartieri più malfamati d'America. Di più di così un regista di genere cosa poteva fare? La notte del giudizio: Election Year è all'Italia di Saluzzo alle 20 e alle 22:15, e al Fiamma di Cuneo alle 21:15.
I fantasmi dell'84 (non li cacci via)
01-08-2016, 15:40cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, nostalgia, OttantaPermalinkC'è stato un tempo in cui avevamo paura dei fantasmi. C'è stato un tempo in cui ridevamo dei fantasmi. Oggi tutto questo è molto lontano, oggi i fantasmi siamo noi. Viviamo in un limbo di cose né morte né vive, cose che principalmente sono successe intorno al 1984, e per un bizzarro inghippo del destino non sono state dimenticate. Infestiamo questa casa, tirando orribili scherzi a chiunque prova a entrare per dare un'occhiata. La maggior parte bisogna dire che se lo merita, vogliono solo grattare qualche soprammobile vintage e rivenderlo, c'è un mercato pazzesco per queste cose. Altri invece sono solo curiosi, è tutta la vita che sentono parlare di questo benedetto/maledetto 1984, vorrebbero capire cosa si provava a entrare in una sala per vedere Ghostbusters e beccarsi i primi trailer di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Perché se davvero c'è stato un momento in cui tutto il nostro immaginario si è azzerato ed è ripartito, non può che essere l'anno di Terminator, Nightmare, Gremlins, Karate Kid, Amadeus, La storia infinita, Footlose, e potrei andare avanti. È successo qualcosa di pazzesco nel Palazzo Incantato del 1984, ed è normale che la gente voglia entrare per capire, per provare, anche solo per passarci la notte.
Ma non ne hanno il diritto, quel palazzo appartiene a noi. Li cacceremo via, li prenderemo a sassate su Youtube o Imdb. Come osano reclamare la proprietà intellettuale sui marchi dei nostri ricordi, su ciò che ci tiene vivi, ammesso che sia vita questa (se la passi a trollare le attrici di Ghostbusters 2016 probabilmente non lo è).
A un certo punto della leggenda dei sequel di Ghostbusters - leggenda che si perde ormai nella bruma dei tempi, è da trent'anni che il progetto restava nel limbo delle cose inevitabili quanto irrealizzabili - sembra che Bill Murray avesse dato l'ok per partecipare al terzo film, soltanto a un patto: avrebbe dovuto interpretare un fantasma. Era in effetti un'idea geniale, che inspiegabilmente Paul Feig ha lasciato cadere. Avrebbe dato una profondità a un film che sembra volerla evitare a ogni costo. È come se dopo aver rilevato un marchio che ha lasciato un segno indelebile su una generazione; dopo aver avuto l'idea forte, e commercialmente rischiosa, di investire su un cast femminile (e usare Chris Hemsworth come damigella in pericolo, più che un'idea una gag), Feig avesse tirato i remi in barca e pensato solo a ridurre i danni. Il marchio è pesante, il cast è controverso, il budget impressionante, il film è una commediola divertente che si comincia a dimenticare già prima dei titoli di coda. Tocca difenderla perché è stata messa sotto attacco dai troll maschilisti e razzisti, ma la difenderemmo più volentieri se Feig oltre a mettere le donne in primo piano ci avesse anche dimostrato che sono brave: che possono fare un Ghostbusters non dico migliore dell'originale, ma spassoso, potente, originale.
Purtroppo non è andata così, però sarebbe ingiusto prendersela con Feig per il fatto che il suo Ghostbusters non funzioni come quello del 1984. Non è colpa sua se certe merendine non torneranno più. C'è qualcosa di particolarmente irripetibile, nel successo del primo film, che lo rende un tesoro tanto prezioso della nostra preadolescenza. Nell'elenco sommario dei grandi successi del 1984, Ghostbusters spicca per un motivo che a prima vista magari non si vede: è l'unica commedia. Quasi. Altri film hanno grossi inserti di commedia, ma Ghostbusters è l'unico a nascere intorno a un gruppo di attori e autori comici - Aykroid e Ramis, che all'inizio pensavano a Belushi, e poi lanciarono cinematograficamente Murray. Il risultato fu un film che metteva insieme ingredienti instabili, mai mescolati prima, in un'alchimia probabilmente irripetibile: commercializzato come prodotto per le famiglie, convinse tanti decenni come noi a farsi portare al cinema, per vedere non solo le prime scene horror della nostra vita (gli effetti speciali sono ancora notevoli), ma anche la prima commedia per adulti - una scena in cui un'entità invisibile slaccia la cintura a Dan Aykroid nei coevi film di Bud Spencer non s'era mai vista.
Uscivamo dalla sala, nel 1984, con la sensazione di aver finalmente passato una serata coi fratelli maggiori, quelli che già fumavano e si portavano le tipe negli angoli: e non è che ci avessimo capito molto, ma ce l'avevamo fatta, nessuno ci aveva mandato via, nessuno ci aveva preso in giro, alla fine ci eravamo anche divertiti. Forse tra i troll maschilisti che hanno preso di mira le attrici del nuovo film c'è qualche mio coetaneo che visse quella proiezione del 1984 come un rito di passaggio all'età adulta; un rito che evidentemente non ha funzionato molto bene, ma di tutto questo Feig e il suo cast non hanno responsabilità. In un certo senso la scommessa di Feig conserva qualche tratto dell'impudenza dell'originale: Aykroid e Ramis volevano mescolare l'horror, l'action e il Saturday Night Live. Feig vuole mettere d'accordo i nostalgici degli anni Ottanta con i fan e soprattutto le fan delle migliori attrici comiche e monologhiste della sua generazione, e sulla carta è un'idea coraggiosa. Ma è proprio l'idea che non si realizza. In molti casi, semplicemente, le ragazze non sono divertenti come dovrebbero, come potrebbero essere. Specie se il film lo guardi doppiato, e due o tre sketch basati sui doppi sensi vanno a farsi benedire.
Ma forse il problema dell'adattamento è più profondo: pensate all'ultima commedia americana che avete trovato divertente (continua su +eventi!)
Scommettiamo che vi tocca risalire di almeno tre o quattro anni? Melissa McCarthy, un talento indiscusso, in Italia continua a essere conosciuta soprattutto come comprimaria in Una mamma per amica. E a proposito di serie: vi ricordate che una volta c'erano sit-com americane in prima serata sui canali generalisti e adesso ormai non ci sono più? È difficile da dimostrare, ma è come se la comicità americana nell'ultimo decennio fosse diventata meno esportabile, meno traducibile. Forse semplicemente c'è una generazione di autori che lavora più sulla parola e meno sulle situazioni. Il risultato è che le commedie in Italia ormai ce le facciamo in casa (con risultati alterni), e i film di Feig con la McCarthy li ritroviamo al cinema tra luglio e agosto.
Lo stesso ruolo di quest'ultima in Ghostbusters poggia su riferimenti che si perdono parzialmente nella traduzione: per lo spettatore italiano è facile scambiarla per la donna grassa e buffa (buffa perché grassa), mentre negli USA la sua è piuttosto la taglia standard, quella che vedi per strada e non al cinema e in tv. Non è una cicciona divertente, è la donna media che col suo buon senso e qualche dote sconosciuta riesce sempre a dimostrarsi migliore dei comprimari e antagonisti maschi. In questo film Feig la degrada a spalla: dopo averla presentata in una delle prime scene come la classica amica eccentrica, in seguito la usa come la più assennata del quartetto. È la vecchia amica a cui potevi raccontare i tuoi incubi da bambina, quella a cui non telefoni da 15 anni ma non esiteresti a tuffarti in un varco spazio-temporale per salvarla. Tutto questo però ti tocca indovinarlo perché Feig non lo racconta. Non calca sui rapporti umani, non calca sull'horror (del resto ormai sarebbe impossibile far spaventare il pubblico con un'invasione elementale di New York), non crea un antagonista inquietante, non si capisce veramente cosa faccia per 120 minuti - a parte insistere su quanto può essere scemo Chris Hemsworth e quanto è matta Kate McKinnon ingegnera protonica. Forse di questa occasione sprecata che è stato il Ghostbusters al femminile ricorderò soprattutto la scena in cui le ragazze, per tirarsi su il morale, scendono nel vicolo a provare nuove armi ammazzafantasmi: questa idea che non ci sia problema che non si possa risolvere provando qualche arma di grosso calibro dietro casa. Sarà una coincidenza, ma è già il secondo film del 2016 in cui vedo donne americane sparare al bersaglio per risollevarsi l'umore. Ghostbusters, solo in versione 3d, è al Fiamma di Cuneo alle 21:10 e al Multilanghe di Dogliani alle 21:30.
Fast & Furious: the Star Trek Rift
25-07-2016, 20:12cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, futurismi, tvPermalinkSpazio, ultima frontiera, o quasi. Abbiamo aspettato due film - otto anni - che il capitano Kirk e la sua ciurma maturassero, ma adesso finalmente dovremmo esserci. Questi dovrebbero essere i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di strani, nuovi mondi... più o meno. Cioè ci avete mai pensato a quanto è lunga una missione quinquennale? Sessanta mesi nello spazio profondo? Sempre con le stesse tutine gialle azzurre o rosse? E se uno/una ha voglia di farsi una famiglia? O una bevuta in un locale trendy in una di quelle stazioni spaziali che disegnano adesso con l'autocadCGI? Insomma possibile che non ci si possa fermare ogni tanto a ricaricare i motori a curvatura, possibile che in fondo a questa nebulosa non ci sia un bar?
 |
| Ti immagini che driftate. |
Neanche male, cioè, se parti con l'idea di vedere un film scritto da Simon Pegg (alla trilogia del Cornetto, per capirci) e girato dalla crew di Fast and Furious, Beyond non delude affatto. Un sacco di battute e di sgommate - l'Enterprise tecnicamente non può sgommare, per cui verrà ritrovata una motocicletta nel luogo meno verosimile - ma comunque anche la nostra astronave preferita si può infilare a rotta di collo in una nebulosa, mandare a sbattere contro uno sciame di navette nemiche e far impattare sul pianeta più roccioso della galassia, una specie di Tokyo Rift spaziale. Niente di nuovo del resto, ormai Kirk distrugge una media di un'astronave e mezza a film, e vabbe', una volta si tirava al risparmio, mentre adesso la gente vuole vedere le esplosioni, devi chiarirlo già dai trailer che hai intenzione di spaccar tutto anche stavolta. Ci potrebbe stare anche questo, se si tratta di salvare un po' di spirito di Star Trek. Ma ecco, il punto è proprio questo. Qual è lo spirito di Star Trek?
Se lo potessi chiedere a Lin e Pegg, credo che mi risponderebbero all'unisono: il cameratismo (continua su +eventi!)
Se lo potessi chiedere a Lin e Pegg, credo che mi risponderebbero all'unisono: il cameratismo. L'unica cosa che incidentalmente hanno in comune la trilogia del cornetto e Fast and Furious: questa idea della famiglia allargata, della squadra multetnica e affiatata che in F&F per fortuna comprende anche le ragazze, purché cazzutissime piloti o stunt. Anche in Beyond, del resto, il cast cresce per accumulazione: pianeta che trovi, cazzutissima ragazza che arruoli. La nuova arrivata (Sofia Boutella) ci sa naturalmente fare con le armi e con le riparazioni, ha un qualche aggeggio che la rende invisibile o la sdoppia, e nella versione originale probabilmente parla come un rapper old-style perché ha imparato l'inglese sugli mp3 di Beastie Boys e Public Enemy. Poi una volta sconfitto il nemico vanno a farsi una bevuta in un superattico ai confini della nebulosa, il comandante con la crew superstite, tutti in borghese con le giacche di pelle, giusto un mezzo secondo per ricordare che metà equipaggio è caduto in combattimento, è chiaro che chi ha scritto questa roba non ha fatto il militare. E io non vorrei essere quello che rimpiange la cosa, non ho niente contro il cameratismo contemporaneo o i film di inseguimenti in macchina, non vorrei essere il cattivo che dice che una volta era diverso, una volta i membri della flotta spaziale sapevano cos'era il sacrificio, la dedizione, la disciplina. Però accidenti. Beyond sta piacendo quasi a tutti, evidentemente il problema sono io che continuo a cercare un'idea di Star Trek che non è quella di Lin e Pegg, non è quella dei trekker, forse a questo punto è solo mia. Cosa c'era in quei vecchi telefilm, che mi piaceva tanto?
 |
| Andare dove nessun uomo è mai stato, e farci due penne in moto. |
Un'astronave nello spazio. Tutto qua. E lo spazio era profondo davvero, non c'erano megacittà orbitanti dietro l'angolo dove fare rifornimento e abbracciare i famigliari. Non c'erano famigliari, neanche sul ponte di comando: a darsi del tu erano in Kirk, Spock e McCoy, fine. Non c'era soap opera, Spock e Uhura non passavano gli anni a giocare a Non So Se Ti Amo Davvero. Non c'era niente di questa roba appiccicosa, non ce n'era tempo e non ce n'era bisogno. E allora cosa c'era?
La frontiera. L'universo sconosciuto. Ogni episodio, un pianeta diverso, o un problema nuovo. La voce della ragione (Spock), le ragioni del sentimento (McCoy), e Kirk sulla sedia a comandare e improvvisare. Star Trek non è quella serie di hard science fiction che molta gente crede che sia: è un'idea che hanno messo in giro i trekker mentre si affilavano le orecchie in gommapiuma. Certo, il budget era quello che era, il lato action consisteva in qualche sparuto raggio laser, qualche buon vecchio pugno, e per rendere l'idea di un'esplosione in plancia si faceva ballare la macchina da presa. Star Trek per sopravvivere nel palinsesto tv doveva avere delle storie incredibili, potenti, e in giro c'era gente che le sapeva scrivere: Richard Matheson, Robert Bloch, Theodore Sturgeon, Harlan Ellison, Fredric Brown. Senza offesa, ma Lin e Pegg non giocano nello stesso campionato. Abrams almeno se ne rendeva conto, e nel suo modo contorto cercava di rendere omaggio a una generazione di inventori di storie che veramente ci hanno aperto la mente.
Il nuovo Kirk e il nuovo Spock non hanno niente che non vada, ma sono ovviamente l'espressione di un'epoca diversa, afflitta da una tipica fobia del vuoto che è il contrario di quello smarrimento metafisico che la vecchia ciurma provava davanti all'immensità dello spazio: dovunque devono esserci città immense con tante strade per fare sorpassi spettacolari (almeno stavolta non si chiamano col cellulare dagli opposti del sistema solare, una cosa che ti ammazza il sense of wonder). Persino il nemico, il mostro, l'alieno, se lo guardi bene siamo sempre noi con un trucco diverso e qualche idea oscurantista da vecchio brontolone - nulla che valga la pena di capire: da quel poco che riusciamo a interpretare, il cattivo di turno vuole ammazzare tanta gente perché odia la pace e ama la guerra, neanche i cinecomics ormai osano tagliarla così grezza. Ma va bene, sono antimilitarista e multiculturalista, viva il melting pot di razze che colonizzano l'universo e dappertutto creano luoghi trendy dove fottere i turisti coi drink fluo. Mi sono divertito coi Guardiani della Galassia, perché dovrei dirmi deluso da Fast and Furious nello spazio. Facciamo che la prossima volta che esce uno Star Trek io me ne sto a casa a rileggeremi Le Grandi Storie della Fantascienza del 1954.
Comunque Star Trek: Beyond lo trovate all'Impero di Bra alle 20:15 e alle 22:30, al Fiamma di Cuneo alle 21 e al Multilanghe di Dogliani alle 21:30.
Zootopia è un mondo impossibile, il nostro
18-07-2016, 22:30animazione, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink
Zootropolis (Zootopia, Byron Howard e Rich Moore, 2016).
"E il lupo e l'agnello giaceranno insieme, ma l'agnello dormirà ben poco".
Secondo i più recenti studi di ciascuno di noi, vivere insieme è impossibile: d'altro canto è necessario. Siamo troppo diversi? Sì. Siamo programmati per diffidare del diverso e cercare di allontanarlo? Altroché. Il nostro cervello è naturalmente portato a processare gli impulsi e a ridurli in stereotipi, e agire rapidamente in base a pregiudizi? Senz'altro. Forse un giorno potremo superare queste ataviche diffidenze e vivere tutti insieme in pace? Chi lo sa. Abbiamo alternative?
No.
Qualche anno fa Luke Epplin, dell'Atlantic, notò come tutti i grandi cartoni animati in circolazione nei cinema in quel momento raccontassero la stessa storia profonda: un outsider (può essere una lumaca, un aeroplano spargiletame, un mostriciattolo divertente) lotta contro il proprio destino per vincere un gran premio, o un giro del mondo, o il titolo di mostro più spaventoso della facoltà. È il culto dell'autostima, scriveva Epplin: questi film stanno raccontando ai nostri bambini che hanno il diritto di diventare qualsiasi cosa vogliono diventare. Basta credere ai propri sogni. Peccato che non sia così.
Molti anni prima, quando l'autostima era ancora un lusso per pochi, Walt Disney portava nelle sale la sua silly simphony più controversa, The Flying Mouse. È la storia di un topolino che non riesce a darsi pace perché non ha le ali: finché non trova una fatina che gliele regala, solo per scoprire di essere diventato un enorme pipistrello, orribile a tutti e anche a sé stesso. È un cartone stranamente crudele, che lasciava perplessi anche i disegnatori a cui Disney chiedeva di infierire sul povero topo con alcune gag piuttosto sadiche. Sui forum dei vecchi appassionati c'è ancora qualcuno che si confessa segnato per la vita da quel cartone animato, o dal suo sinistro ritornello, "You're nothing but a nothing". ("Dite quel che volete su quel che dovrebbe significare, ma l'effetto che ha avuto su di me è che mi ha terrorizzato con l'idea di essere diverso dagli altri").
Ottantadue anni dopo, Judy Hopps soffre ancora dello stesso complesso del topo volante. Stavolta è una coniglietta che non vuole sentirsi chiamare "carina" (solo i conigli hanno il diritto di chiamarsi così, se lo fa qualcun altro è razzismo). Judy viene della Tana dei Conigli con un sogno: farà la poliziotta. Dopotutto, perché non dovrebbe riuscirci a Zootropolis (nell'originale Zootopia), il luogo dove predatori e prede vivono in armonia? Ma il punto è tutto qui: Zootopia non è l'utopia di un filosofo o di un profeta. È il mondo brulicante e complesso studiato dagli animatori della Disney, così caotico e stratificato che per un'ora e mezza di film ti sembra vero. Si capisce che in cattedra c'è ancora Lasseter, e sulla lavagna la lezione che ha portato dalla Pixar: non basta una storia, bisogna inventarci un mondo attorno. A Zootropolis i bei discorsi si infrangono subito nella prassi: prede e predatori convivono, ma diffidano, con conseguenze inattese anche se prevedibili: se i predatori sono la minoranza, è così sorprendente che qualcuno cerchi di speculare sulla paura che ispirano? (Continua su +eventi!)
A Zootropolis puoi diventare tutto quello che vuoi, ma più facilmente diventerai quello che gli altri si aspettano da te. Se davvero vuoi dare una svolta alla tua storia, hai bisogno di forzare le porte, di farti amici in ogni nicchia ecologica, dai bassifondi ai corridoi del potere: e di tanta fortuna, naturalmente. Zootropolis si presenta come un film progressista - il culto dell'autostima è temperato da un'altra lezione Pixar, l'importanza del lavoro di squadra - ma è talmente disincantato da rasentare lo scetticismo, e può essere apprezzato anche da chi alla società multiculturale non si rassegna - dopotutto chi può credere a un roditore che da grande sogna di diventare un elefante?
 Zootropolis è un film che parla esattamente dell'America di oggi: un gelataio elefante che si rifiuta di servire la volpe sta approfittando di una legge molto simile a quella firmata in Indiana dal governatore Mike Pence (il vicepresidente che Trump si è appena scelto). Allo stesso tempo, è uno dei film più profondamente disneyani degli ultimi anni, dopo gli sbandamenti manga di Big Hero e i mondi pixellati di Ralph Spaccatutto. Judy ha gli occhioni di Tippete, il suo nemico/amico Nick è un degno discendente della volpe Robin Hood. Se Zootropolis ha un difetto, è il ritmo indiavolato con cui concentra in 100 minuti una trama che avrebbe potuto svilupparsi in una miniserie. Certe ambientazioni meravigliose, studiate fino al minimo dettaglio (la città dei roditori!), nel risultato finale resistono solo come sfondi per una o due gag. Certo, col successo che ha avuto i sequel non mancheranno. Vale la pena di vederlo sul grande schermo, martedì 18 luglio ai Cine Dehors dei Portici di Fossano, dalle 21:30.
Zootropolis è un film che parla esattamente dell'America di oggi: un gelataio elefante che si rifiuta di servire la volpe sta approfittando di una legge molto simile a quella firmata in Indiana dal governatore Mike Pence (il vicepresidente che Trump si è appena scelto). Allo stesso tempo, è uno dei film più profondamente disneyani degli ultimi anni, dopo gli sbandamenti manga di Big Hero e i mondi pixellati di Ralph Spaccatutto. Judy ha gli occhioni di Tippete, il suo nemico/amico Nick è un degno discendente della volpe Robin Hood. Se Zootropolis ha un difetto, è il ritmo indiavolato con cui concentra in 100 minuti una trama che avrebbe potuto svilupparsi in una miniserie. Certe ambientazioni meravigliose, studiate fino al minimo dettaglio (la città dei roditori!), nel risultato finale resistono solo come sfondi per una o due gag. Certo, col successo che ha avuto i sequel non mancheranno. Vale la pena di vederlo sul grande schermo, martedì 18 luglio ai Cine Dehors dei Portici di Fossano, dalle 21:30.La cena delle notifiche
12-07-2016, 02:03cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, telefonatePermalinkIl dramma della Comunicabilità, la tragedia di una generazione che può permettersi l'Iphone ma non ha imparato a silenziare le notifiche. Li senti poi sui treni che chiacchierano con la suocera, pur di farci vedere che hanno relazioni umane: li vedi sui balconi mentre guardano nel vuoto e parlano con l'ex, o con la next; mentre attraversano gli incroci una volta, due volte, con l'auricolare; mentre sextano in coda al bagno pubblico e poi entrano per scaricare la fotina. Vogliono essere scoperti, questa è la verità. Come i serial killer. Vogliono essere osservati - che gusto c'è ad avere segreti se nessuno se ne accorge?
 |
| "Tante volte può essere il T9". |
 |
| "Son stato frocio due ore e m'è bastato". |
Il nome del figlio riprendeva dall'originale francese l'idea di una borghesia ormai spaccata in due, così pronta alla guerra civile che la scintilla potrebbe scoccare in qualsiasi momento, anche a una cena tra amici. Di queste tensioni in Perfetti sconosciuti non rimane traccia: non c'è più toponomastica sociale, borgatari portatori di una sana vitalità o professori di sinistra isterici, grazie al cielo. Non c'è una guerra segreta tra post-berlusconiani e post-anti: c'è un liquido gruppo di amici, di cui sappiamo appena il mestiere, che credono di conoscersi finché una sera hanno l'imperdonabile idea di fare il Gioco della Verità 2.0: tenere i cellulari aperti, sul tavolo, per tutta la cena. C'è bisogno di dire che quel venerdì sera chiameranno tutti? Ma proprio tutti, non solo la figlia e l'amante incinta: anche l'ospizio, il gioielliere, fin oltre il dessert continueranno a sputtanare gli incauti commensali. Per quanto irrealistica, l'idea è originale, ma se funziona è merito degli attori, tutti in forma, e di una sceneggiatura che non lascia né a loro né allo spettatore il tempo di prender fiato e riflettere sull'assurdo della situazione. Buon cinema, ottimo teatro.
Non è un ingranaggio perfetto - verso la fine c'è uno svelamento che forse in una prima stesura funzionava da colpo di scena, ma a quel punto ormai siamo tutti esausti e non ci stupiremmo più di niente - però riuscire a trovare il ritmo giusto e non perderlo per quasi un'ora e mezza non è da tutti. E far sembrare fresca una commedia degli equivoci, nel 2016, strappa l'applauso. Poi c'è il finale, che fa qualcosa di molto raro nel cinema italiano: nel momento in cui ci aspetteremmo la risoluzione della crisi, un po' di quiete dopo la tempesta (persino Polanski chiudeva Carnage coi bambini che giocano assieme), Genovese fa un passo indietro, restituendo a tutti i loro segreti. E quando nell'ultima scena Battiston scende dalla macchina, ti accorgi che stai trattenendo il fiato.
Perfetti sconosciuti giovedì 14 è programmato in ben due rassegne di cinema all'aperto: il Cinedehors di Fossano (dalle 21:30) e il Cinema all'Arena di Alba (dalle 21:45).
Siamo tutti figli di Cuarón
05-07-2016, 12:42cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, futurismi, razzismiPermalinkL'umanità è diventata sterile, l'Inghilterra è invecchiata e isolata. I più giovani - hanno sedici anni ormai - si radicalizzano, mettono bombe a casaccio, non si sa nemmeno cosa vogliano. I vecchi se la prendono coi migranti, nessuno ricorda più il perché. Succederà tra vent'anni - no, aspetta, nove sono già passati.
È vero che ci sono film più recenti in sala, ma se al Castello di Roddi sabato 9 luglio fanno I figli degli uomini, forse vale la pena di ridare un'occhiata per scoprire quanto poco sia invecchiato un film che dieci anni anni fa sembrava già una cosa notevole, se non proprio un capolavoro. Quel che è successo nel frattempo è che non solo le tematiche del film non hanno smesso un attimo di restare attuali - anzi, i rifugiati nei recinti e i campi profughi militarizzati somigliano sempre di più a una profezia - ma che lo stile sfoggiato da Cuarón nell'occasione è diventato tipico del migliore film d'azione. Nel 2007 esistevano già i found footage; Von Trier e Gus Van Sant ci avevano già assuefatto alla nausea da handicam; e però i piani sequenza insistiti (e truccati); la scenografia un po' Bagdad un po' videogioco sparatutto, sono cose che sono diventate moneta corrente dopo i Figli degli uomini, se non grazie ai Figli degli uomini (continua su +eventi!).
Non voglio dire che non avremmo avuto film acclamati il Figlio di Saul, o l'ultimo Mad Max, ma forse li avremmo apprezzati meno se nel 2007 Cuarón non ci avesse iniziato a un nuovo modo di girare l'azione, visionario e più immediato: anche questo film è in sostanza un solo lungo inseguimento; anche Cuarón è deciso a narrare soprattutto attraverso le immagini, riducendo al minimo gli spiegoni. Vedi l'intermezzo dell'"Arca delle Arti", un progetto che viene semplicemente menzionato e mostrato, senza che nessun personaggio o voce narrante si preoccupi di spiegarci cos'è: ce lo devono dire le immagini, e il maiale rosa sulla fabbrica e il David di Michelangelo con una gamba rotta, e ci riescono egregiamente. Del romanzo di P. D. James restano solo le suggestioni: la trama è stravolta anche da un punto di vista politico, senza troppe preoccupazioni per la logica (un'Inghilterra condannata a invecchiare sarebbe costretta a importare i lavoratori stranieri più che a scacciarli, e in effetti la James nel romanzo prevedeva dei campi di lavoro coatto). Cuarón la taglia a fette molto meno sottili: sceglie come nuova Eva (che all'inizio avrebbe dovuto essere Julianne Moore) una ragazzina d'origine africana con un pessimo gusto per i nomi: trova i sobborghi meno caratteristici di Londra e chiede ai suoi scenografi di messicanizzarli. Per lui il confine tra primo e terzo mondo ormai è un fronte mobile. Gli preme mostrarci un'Inghilterra senile e xenofoba, e dieci anni dopo è difficile dar torto alla sua intuizione.
In generale rivedere su un grande schermo I figli degli uomini potrebbe rivelarsi un'esperienza straniante per chi ha la sensazione che tutto stia precipitando all'improvviso: è un film che appartiene assolutamente al decennio scorso, all'era pre-crisi dei bond, ai tempi in cui il nemico numero uno era Bin Laden - la scena della bomba a Londra fu girata poche settimane dopo l'attentato suicida del 2005 - e ci mostra come tutti gli incubi che crediamo avere avuto negli ultimi anni ce li stiamo portando avanti ormai da più di dieci. Non è che i cinema siano già chiusi, ma non mi pare che questa settimana ci sia in giro qualcosa di più interessante e attuale dei Figli degli uomini. . Al Castello di Roddi dopo le 21, sabato 9 luglio.
Tutti ne vogliono
30-06-2016, 19:15cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, ragazziniPermalinkNel crepuscolo dell'estate 1980, Jake ha 18 anni, una collezione di dischi in una scatola e una Oldsmobile 442 che lo sta portando dritto al college. Tutto sta per succedere, tutto deve succedere, per la prima volta. L'autoradio pompa i Knack, il sole del Texas splende sugli shorts delle ragazze. Qualcosa prima o poi andrà storto, ma perché dovrebbe succedere proprio in questo film? E se per una volta tutto filasse liscio, senza conflitti? Se Linklater volesse raccontare la storia più americana possibile nel modo meno meno americano possibile?
Per fortuna la sua missione non era mostrare come anche la generazione di Porky's avesse una profondità. Piuttosto rivivere quei magici quattro giorni in cui tutto sembrava possibile, e l'amicizia virile e la carriera sportiva e il sesso e l'amore sembravano frutti maturi sui rami dello stesso magico albero. Quel prezioso momento in cui stavi scegliendo chi diventare, che forma prendere, e in attesa di ricevere qualcosa dentro di te facevi il vuoto. Sempre con quel sorriso mezzo scemo di Blake Jenner, che intuisce come nulla che si possa prendere sul serio o sottogamba. Il nuovo compagno di dormitorio chiacchierino può essere un coglione o dirti la più profonda verità. Ha vent'anni ma potrebbe averne trenta. Sarà un campione di baseball o un fallito psicopatico. Tutto è un gioco, tutto è importante. Un tuo amico è diventato punk per scherzo e quello sarà il suo destino, tu invece passi in una mezz'ora dalla discoteca al locale country, e poi la festa del Dams con gli attori e i ballerini. Quello che diventerai, non è che dipende soprattutto dalla ragazza che ti risponderà al telefono? (continua su +eventi!)
Presentato come il seguito "spirituale" di Dazed and Confused, Tutti vogliono qualcosa funziona altrettanto bene come fratello maggiore di Boyhood: stavolta Linklater concentra tutto in quattro giorni di festa pigra e furiosa. Si beve un po', si sopporta il nonnismo dei compagni più grandi, si gioca a qualsiasi cosa (a baseball, a ping pong, a space invaders, a chi aspira più vapore da un bong). Si balla quel che c'è da ballare, e chi riesce a trovare un letto scopa. C'è anche l'amore ed è la nota più stonata, perché Linklater non ci risparmia il corteggiamento, e non ha pudore di mostrarci quanto possono essere ingenui e suonare falsi due diciottenni che cercano di conoscersi al telefono e trovare un pretesto per passare la notte assieme. Due soli adulti compaiono brevissimamente in tutto il film. Tutto grida privilegio, e mi domando onestamente se Linklater sia consapevole di quanto la sua età dell'oro sia stata un momento irripetibile - il Vietnam dietro le spalle, l'Aids ancora in sordina, nessuna recessione in vista. Tutti vogliono qualcosa è entusiasta e inconsistente al punto di irritare, e il ricordo di essere stati altrettanto entusiasti e inconsistenti non sempre aiuta. Però un bel film, già scomparso dalle sale di Cuneo. Il cinema più vicino ormai è il Greenwich Village di Torino (ore 21).
Sia lodato Gesù Cristo, ma perché?
28-06-2016, 01:57Bud Spencer, cinema, coccodrilliPermalinkSe invece mi chiedi cos'è la vittoria, ecco, ho già provato a spiegarlo (non che abbia molto senso, comunque): "non m'importa quante palle mi mettete dentro: l'importante è la sola palla che un giorno metteremo noi. Ne basterà una sola, a un certo punto ci sbloccheremo, scenderà Bulldozer, il signore degli Eserciti, vi faremo un culo così, la palla schiacciata in meta scoppierà e non ne verranno fabbricate altre, non ci saranno rivincite, il mio romanzo finirà in quel momento".
Bud Spencer era un atleta e un clown, eppure ho scoperto che quel che mi prendeva di più dei suoi film non erano le coreografie a base di schiaffoni (ancora imbattibili). Ma il modo in cui ogni tanto gli scappava di fare l'eroe, e gli veniva naturale, come dovrebbe venire a ogni padre per quanto sudato e corpulento. La prossima volta che un ferito grave ci implorerà con lo sguardo di portarlo a Manaus, Bud Spencer non potrà più coprirci. Toccherà a noi, che non siamo immortali, in effetti nessuno lo è. Bisognerà farsene una ragione.
Prima sfasci le vetrine, poi ti deridono, poi vinci, poi continuano a deriderti
23-06-2016, 02:02cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink |
| Emmeline Pankhurst. "Fatti, non parole" era il suo motto. Nel film esorta le proletarie a rompere le vetrine. |
 |
| L'ultima battaglia di Emily Davison. |
Peccato perché la storia da qualche parte c'era, e alcuni spunti di partenza erano fantastici - ad esempio a un certo punto il film mostra di sfuggita una suffragetta che spiega alle altre alcune mosse di autodifesa, ebbene, pare che una membra del WSPU fosse un'esperta di Ju Jitsu. La cosa muore lì, del resto sarebbe stato difficile far funzionare una scena in cui Carey Muligan o Helena Bonham Carter abbattono un bobby a colpi di Ju Jitsu. La Gavron non si accontenta della ricostruzione storica - quella ormai è a portata di qualsiasi produzione televiva - vorrebbe anche avere qualcosa da dire sul presente, al punto di rischiare l'anacronismo: l'astuto segugio di Scotland Yard che spia le mosse delle femministe ha un pallino per le fotografie, ne scatta tantissime alle manifestazioni e durante le cariche della polizia.
Un'altra occasione piuttosto persa è il taglio che dà alla scena della morte di Emily Davison. Perlopiù sconosciuta qui da noi, la Davison in patria è un personaggio leggendario, non tanto per i nove arresti o i ripetuti digiuni, ma per le circostanze in cui morì - travolta da un cavallo a un derby, e non da un cavallo qualsiasi: da quello del re. L'incidente le costò la vita, ma diede anche al suo movimento quella pubblicità che i suoi scioperi della fame non erano riusciti a ottenere: ma fu davvero un incidente? Se ne discute più o meno da allora. Aveva intenzione di farsi travolgere o voleva semplicemente attaccare una fascetta al cavallo, con uno slogan che chiedeva il voto alle donne? Era in grado dalla sua posizione di riconoscere il cavallo del re, o lo intercettò per pura (s)fortuna? Il film decide di sposare la tesi più semplice, facendo della Davison una militante suicida, che decide di sacrificarsi lì su due piedi, senza pensarci troppo. Forse il personaggio meritava più spessore.
Anche la leader del movimento, Emmeline Pankhurst, è resa da Meryl Streep in modo impeccabile ma un po' freddo: una che inneggia più o meno alla lotta armata, per dileguarsi svelta appena arrivano i bobby. Invece il personaggio di Carey Mulligan, la protagonista, è inventato: uno di quei ruoli abbruttenti che sembrano obbligatori per le attrici di livello internazionale (la smorfietta vezzosa ormai simile a un'emiparesi facciale alla Stallone). È l'operaia che all'inizio non sa cosa sia il suffragio e poi, a furia di essere accostata a queste amiche pericolose, picchiata con loro, arrestata con loro, finisce per radicalizzarsi. Suffragette è alla Sala Polivalente di Piasco giovedì e venerdì alle 21:10.
Il Terzo Reich in miniatura
14-06-2016, 00:59cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, memoria del 900, nazismoPermalink11 settembre 1973: a Santiago del Cile, durante il golpe del generale Pinochet, un fotoreporter tedesco (Daniel Brühl) scompare. Emma Watson, la sua ragazza, si prende una settimana di ferie (fa la hostess) e indaga. Una pista la conduce alla Colonia Dignidad, una specie di enclave nazista sulle Ande, una comunità cristiana integralista governata col pugno di ferro da un predicatore bavarese ricercato in patria per pedofilia. Il luogo ideale dove torturare i detenuti politici - pare che anche Mengele si sia rifugiato lì per un po'. Ovviamente il luogo è un incubo totalitario, un lager con tanto di recinto elettrizzato. Ovviamente uomini e donne sono separati, guardati a vista, istigati a spiarsi e torturarsi a vicenda. Il piano di Emma è vestirsi da suorina, bussare al cancello, chiedere di entrare a far parte della congregazione, sopportare frustate e privazioni finché non le riesce di trovare Daniel, e poi scappare insieme in un qualche modo.
Ci riesce.
E vabbe', un po' implausibile, ma se è tratto da una storia vera...
 |
| Il vero cancello della Colonia. |
C'è un regime del terrore in cui basta chiedere in giro e tutti sanno dove sono nascosti i desaparecido. C'è una comunità segregatissima che accoglie la povera Emma sulla fiducia, non le guarda nemmeno i documenti. Lì tutti si controllano, tutti si spiano, eppure Emma riesce a uscire dal dormitorio quando le va. Siccome questa cosa durante una rilettura dev'essere sembrata un po' assurda, gli sceneggiatori si sono inventati il turno di notte delle pelapatate: cioè in questa colonia ci sono talmente tante patate che bisogna pelarle anche di notte, un'ottima scusa per uscire e scuriosare in giro. L'evasione sembra impossibile, salvo che sotto la montagna di patate c'è una botola che, indovina!, conduce alla sala delle torture e poi direttamente fuori, e fuori c'è senz'altro una strada e un camionista che può dare uno strappo fino a Santiago - 400 km, bazzecole. Poi c'è un inseguimento finale con colpo di scena all'aeroporto, come in Argo, ma senza ritmo. Alla fine prevale un senso di pena per i due comprimari, che ce la mettono tutta per tenere il film a galla.
Gallenberger è un valido narratore per immagini, ma non riesce mai a coinvolgerci in quello che succede: le scene iniziali sul golpe nelle strade di Santiago sono impeccabili ma freddissime, Emma e Daniel sembrano due turisti attirati dal folklore rivoluzionario in un orrendo viaggio organizzato. C'è una scena in cui lei va a cercare i vecchi compagni di lui, li trova che si stanno organizzando per passare in clandestinità, e si scandalizza perché non rischiano la vita per cercare Daniel: nei giorni in cui spariscono centinaia di cileni, per Emma conta solo il suo ragazzo tedesco. L'eurocentrismo dà meno fastidio quando ci trasferiamo nella colonia, un universo concentrazionario di cui sarebbe interessante capire il senso. Ma anche lì qualcosa non funziona: il leader, che dovrebbe essere straordinariamente carismatico, passa il tempo a insultare e picchiare e molestare e non c'è modo di capire come si sia conquistato tanto potere sui suoi sudditi: il suo carisma è dato per scontato, né spiegato né messo in scena. Di buono c'è che alla fine del film viene voglia di saperne di più. Colonia è al Monviso di Cuneo oggi (martedì) alle 21.
Shane Black e il portaceneri gigante
11-06-2016, 02:53cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkRyan Gosling è un mentecatto. Tanto per cambiare, già. Ryan Gosling è un ex sbirro che ha già dato il suo meglio, e da quel che ci è dato di capire, anche quel meglio non era un granché. È uno di quei personaggi che all'inizio dei vecchi film sonnecchiano sulla loro scrivania di detective privati, tra cicche e bicchieri vuoti, in attesa che arrivi un ispettore o una bionda fatale a svegliarli, a ributtarli nella mischia. All'inizio del film effettivamente Ryan sta dormendo immerso in una vasca da bagno, in giacca e cravatta, ma lo sveglierà sua figlia perché da qualche tempo in qua il regista Shane Black ha deciso che vuole portare al cinema anche la nuova generazione, e l'unico sistema che gli è venuto in mente è piazzare minorenni nelle sue storie - anche in quelle hard-boiled ambientate nel mondo della pornografia californiana. Funziona? Insomma. Ma è un trucco talmente vecchio che sembra quasi fresco, come certe barzellette che ti ricordi improvvisamente dopo trent'anni.
Shane Black a un certo punto dev'essersi creduto un autore, uno che ha una cifra stilistica tutta sua e la persegue a dispetto di logiche commerciali o del buon senso. Forse. È un'ipotesi, neanche la più triste. Sempre la California, fragile e letale - macchinoni che precipitano dentro villette prefabbricate - sempre gli stessi personaggi fragili e perdenti che però in un qualche modo alla fine portano a casa il risultato. Gente a cui è invariabilmente successo qualcosa di brutto e non ci vuole più pensare, piuttosto ci beve sopra fino a morirne. A metà di un film non memorabile, Ryan Gosling si ritroverà seduto a fumare sul trampolino di una piscina vuota, ingombra di mozziconi. Questo cos'è, gli chiederà Russel Crowe, un portaceneri gigante? Ho la sensazione che sarà l'unica scena che mi ricorderò del film (continua su +eventi!)
Shane Black ha gusto per i dialoghi surreali, ma non è Tarantino; sa costruire una scena d'azione ma non è Tony Scott; ha un po' di sincera nostalgia per la California anni '70 ma non ci sguazza come P. T. Anderson. Ma ci sono quei piccoli momenti in cui riesce a mostrarti la disperazione in un'immagine - un uomo in un portaceneri gigante, oppure una bambina seduta in un prato, con una torcia, che racconta una storia a delle bambole che non esistono più, ecco, quelle piccole spine nel cuore Shane Black le sa conficcare. Magari sarebbe diventato un autore davvero, se Hollywood si fosse fidata un po' di più. Magari non ci ritroveremmo davanti a un prodotto che sembra pensato apposta per l'estimatore di Shane Black (ma siamo così tanti?): un catalogo di situazioni che non erano originalissime neanche quando le usava in Arma Letale, nell'Ultimo boy scout, in Kiss Kiss Bang Bang e... basta, via, non è che abbia scritto tutti questi film Shane Black. Magari lui stesso avrebbe cose più interessanti da dirci, ma a questo punto è come il vecchio amico che ritroviamo in un bar, uno da cui vogliamo sentire esattamente le stesse storie, la stessa barzelletta, non perché ci faccia ridere ma perché ci consola sapere che si è rincoglionito almeno quanto noi.
The Nice Guys è al City Plex di Alba alle 22:20; al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo alle 20:15 e alle 22:45; all'Impero di Bra alle 22:30; all'Italia di Saluzzo alle 20:00 e alle 22:15; al Cinecittà di Savigliano alle 20:15 e alle 22:30.
I mutanti non muoiono mai (quasi)
25-05-2016, 22:52cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fumettiPermalinkX-Men: Apocalypse (2016, Bryan Singer)
 |
| I primissimi X-Men, quelli con la casacca della Nocerina. Jean Grey sta già battendo la fiacca. |
Nei primi anni Sessanta, Stan Lee ottiene inconsapevolmente un dono da cui derivano grandi responsabilità: qualsiasi idea gli frulli per la testa, anche scema, si trasforma immediatamente in oro, tirature esaurite, ristampe, merchandising. E se Superman invece di essere uno solo fosse un gruppo, anzi una famiglia, ognuno con un potere specifico? Li potremmo chiamare... Fantastici Quattro! E se in ragazzino morso da un ragno radioattivo cominciasse ad arrampicarsi sui muri? E se uno scienziato durante un esperimento diventasse una belva irrefrenabile, grigia, anzi verde perché in quadricromia viene meglio? Sessant'anni dopo queste idee ancora funzionano, ancora ci tormentano, ancora macinano soldi. Ma nel 1963 Lee non lo sapeva. Poteva durare ancora pochi mesi, bisognava battere il ferro finché era caldo, la gente voleva leggere di teenagers trasformati in supereroi a causa di qualche incidente atomico o cosmico, ma Lee a un certo punto non sa più che incidenti inventarsi. Decide di buttarla in genetica, e si mette a inventare un gruppo di ragazzi che semplicemente coi poteri ci è nato. Mutati geneticamente, anzi, mutanti. È l'idea più inquietante che gli sia venuta, ma ci mette del tempo a ingranare: forse perché i primi costumini non erano un granché. Poi nel 1975 un giovane sceneggiatore (Chris Claremont) cambia i costumi e gran parte dei personaggi, ma soprattutto decide di dare ai suoi personaggi uno spessore emotivo.
 |
| La quintessenza di Claremont: perché inventarsi dei nemici? I nemici siamo noi. (Ho perso il conto di quante volte Xavier ha ripreso l'uso delle gambe). |
 |
| Gli X-Men del 2000, almeno in foto, non sembrano invecchiati così male: ma non ho proprio voglia di controllare. |
Negli ultimi anni la Fox le ha provate tutte per ridare smalto alla saga. L'idea migliore (anche se non troppo originale) è stata quella di giocare la carta vintage, retrodatando la saga agli anni Sessanta. Nel frattempo gli attori cominciavano a invecchiare, e bisognava trovare una scusa per cambiarli tutti tranne Jackman - che bisogna ammetterlo, ci crede tanto, s'impegna, fa palestra, dieta, insomma il successo se lo merita: anche se ogni volta che lo guardo mi sembra di sentire Andrew Lloyd Webber in sottofondo. Ovviamente, tra ripartire da zero facendo tabula rasa della prima trilogia un po' bruttina, e ingarbugliare tutto con un viaggio del tempo e una serie di paradossi temporali, non c'è mai stata scelta. Tutto questo ci porta all'assurdità della trama di X-Men: Apocalisse, dove nuovi mutanti simili a quelli vecchi ma con nomi e provenienze geografiche diverse combattono contro un cattivo mutante che vuole distruggere la Terra... negli anni Ottanta. Il che ci fa escludere a priori che possa esserci riuscito, assai prima che i nostri amici giovani mutanti riescano a coordinarsi e annientarlo, ops, spoiler. È il terzo film della seconda trilogia, e ancora abbiamo la sensazione che la storia debba cominciare davvero.
Quello che fa arrabbiare è che gli X-Men avrebbero tutto per essere il miglior gruppo di supereroi al cinema: la spensierata gioventù, ma anche la competitività scolastica e professionale. Gli intrecci sentimentali, l'interiorizzazione del conflitto razziale, eccetera eccetera... niente da fare. Alla fine in due ore la ricetta è sempre quella: trova un cattivo mutante nuovo, fallo attaccare i nuovi, distruggi un po' di mondo, e poi tarallucci e vino. A salvarsi sono i singoli numeri dei singoli eroi, alcuni ormai codificati al punto che sembrano già concepiti per essere ritagliati e condivisi su Youtube: la scena Hugh-Jackman-uccide-tutti, la scena Evan-Peters-corre-e-gli-altri-stanno-fermi, la scena Fassbender-s'incazza, qualcuno-fa-qualcosa-di-insensato-e-poi-si-scopre-che-è-Jennifer-Lawrence-mutaforma. Poi che dire, la Lawrence è meravigliosa anche quando è blu, Olivia Munn dovrebbe stare in scena più spesso (non solo in questo film), il nuovo Nightcrawler è simpaticissimo malgrado l'accento assurdo del doppiaggio: il classico ragazzo appena arrivato dall'estero che capisce metà di quel che succede ma ha tanta voglia di far bene e alla fine salva tutti un paio di volte. Ad alcune scene d'azione anche divertenti si alternano recitativi ridicoli, spiegoni scritti coi piedi, sotto la media di qualsiasi altro film supereroistico del 2016: e nota che è l'anno di Deadpool e di Batman Vs Superman.

16 anni dopo siamo messi così, e non è chiaro chi siano
gli X-Men e chi siano i nemici.
Poi c'è il solito problema di Magneto (che negli ultimi tre film è Fassbender), un nodo presente già nei fumetti che al cinema viene inevitabilmente al pettine. Magneto è un mutante cattivo che però si pente. Si pente sempre: non prima di aver ammazzato un numero indefinito di esseri umani. Nei fumetti c'è lo spazio per fargli provare dei rimorsi, per fargli spiegare le sue ragioni, dopotutto è un reduce da Auschwitz, ecc. ecc.: al cinema è tutto automatico, un momento prima stai distruggendo il mondo e un momento dopo sei diventato buono. Succede anche ad altri personaggi, ed è una cosa che ammazza la ricezione finale del film, perché anche lo spettatore meno raffinato non può impedirsi di pensare eh vabbe', però questi mutanti sono davvero inaffidabili. Per fortuna che non esistono, perché un film come Apocalypse di sicuro non ce li renderebbe più simpatici, anzi.
La morale forse è che di gente come Stan Lee o Chris Claremont ce n'è poca. Quando li leggi non è che ti sembrano particolarmente raffinati, in fondo facevano robaccia: fumetti per gli adolescenti, novelas con ragazzini in costume. Però sapevano farla. Sembra facile imitarli, e infatti ci hanno provato in tanti. E il mondo si è riempito di ragazzi in costume con storie complicatissime che muoiono buoni, risorgono cattivi, poi si convertono alla bontà, poi incontrano il loro clone cattivo, poi scoprono di essere cloni essi stessi, e così all'infinito. E il pubblico? Continua a comprare i fumetti, anche i biglietti al cinema da un po' di tempo in qua. Si vede che la qualità non è poi così importante dopotutto. X-Men: Apocalypse è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo in 2d alle 20:30 e alle 22:10, in 3d alle 22:20; al Multisala Impero di Bra alle 21:45 (2d); ai Portici di Fossano alle 21:30; al Bertola di Mondovì alle 20:30.
Un autobus chiamato 63
20-05-2016, 01:52cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, malattiaPermalinkLe pazze non sono simpatiche, le pazze sono pericolose. Agli altri e a sé stesse, e lo sanno. La notte si rigirano, telefonano alle solite persone sbagliate, ingollano valium clandestino, tengono lontani i cattivi ricordi a botte in testa. Le pazze, potendo scegliere, guarirebbero stasera. Ci fosse una terapia, un lavoro socialmente utile, una scossa a centoventi volt - o tornare da papà, o tornare dal bambino, tornare indietro. Le pazze vorrebbero solo essere felici.
Da quand'è che Virzì non sbaglia un film? Una volta capitava anche a lui. Ma dopo N è come se avesse ingranato una marcia diversa: da lì in poi una serie positiva che fa quasi sgomento. Persino La pazza gioia, quante possibilità aveva di raccontare la malattia mentale senza indulgere al pietismo, senza inveire contro strutture coercitive che in effetti non esistono più, senza trasformare le sue matte in eroine depositarie di una Verità Più Profonda, sconosciuta ai sani di mente? I trailer alimentavano i peggiori timori: Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti che fanno le matte, scappano in decappottabile e si divertono. Sta a vedere che Virzì ha sbagliato un film - beh, prima o poi doveva succedere. Via il dente, via il dolore.
 |
| "Il cinema italiano, non so se si rende conto". |
Con un senso dell'equilibrio che non ha paragoni in Italia, una mano mai tanto salda - sarebbe bastata una sbavatura, una parola di più, una caratterizzazione appena appena più marcata, una concessione a quei bozzetti grotteschi che una volta erano il suo punto di forza. Il confine tra commedia e tragedia è una lama su cui le protagoniste saltellano senza cascare veramente mai.
Si intuisce, dietro, un lavoro di osservazione quotidiana, di riflessione sulla malattia, che solleva il film di svariate lunghezze sopra ogni altro recente tentativo di fare cinema intelligente. Quando a un certo punto compare, in un mezzo secondo, il volumetto Einaudi di Un tram chiamato desiderio, più che una strizzata d'occhio ha tutta l'aria di un'ammissione: Virzì e Francesca Archibugi non hanno bisogno di citar nomi importanti per ricordare al pubblico di essere colti, ma nemmeno possono fingere che nel personaggio della Bruni Tedeschi non riviva il fantasma di Blanche. La Ramazzotti invece è una nuova Maria Farrar, l'infanticida di Brecht che nessuno ha voluto aiutare. Intorno a loro le figure maschili sono più evanescenti del solito: ex amanti, padri e mariti non hanno più nulla da dare, se mai hanno dato qualcosa. Per Virzì e per le sue attrici era forse il film più difficile, il passo falso che gli avremmo perdonato. Niente da fare, neanche stavolta. Tocca aspettare il prossimo.
La pazza gioia è al Cityplex di Alba alle 20:00 e alle 22:15; al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo alle 20:10 e alle 22:35; al Multisala Impero di Bra alle 20:10 e alle 22:30; al Fiamma di Cuneo alle 21:00; all'Italia di Saluzzo alle 21:30; al Cinecittà di Savigliano alle 20:15 e alle 22:30.
Capitan America 3: una questione privata
10-05-2016, 01:06cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fumettiPermalinkA ogni supereroe di segno positivo corrisponde una catastrofe di segno contrario. L'ipotesi che formula Visione all'inizio del film ('Da quando esistono gli Avengers non succedono che disastri. Vuoi vedere che c'è una correlazione?') nella versione a fumetti è dimostrata dal capo da Mr Fantastic con un'intera lavagnata di calcoli. Perché nei fumetti tutto è sempre un po' più complicato. In realtà la formula è semplicissima (eroe + catastrofe = 0) ed è un corollario di quanto il buon Umberto Eco aveva scoperto intorno al mito di Superman mezzo secolo fa. Ciò che rendeva interessante il supereroe, ai tempi ormai remoti in cui Eco cominciava a studiarlo, era il fatto che vivesse più o meno nel nostro mondo; che condividesse i valori di un buon cittadino americano; che si cambiasse nelle cabine telefoniche. E tuttavia un mondo non può rimanere simile al nostro a lungo, se è popolato da eroi potenti come Superman. Per ristabilire l'equilibrio, per evitare che Superman sconfigga i sovietici, risolva la crisi energetica e trasformi il suo mondo in qualcosa di troppo diverso dal nostro, egli deve costantemente essere sfidato da supercattivi potenti quasi quanto lui. Superuomini e supercattivi nascono più o meno nello stesso momento, a volte scaturiscono dallo stesso incidente; hanno poteri complementari e il loro scopo è annullarsi a vicenda, e impedire che il mondo invecchi. Sui fumetti in realtà le cose si sono molto complicate (già Eco stava notando il fenomeno delle realtà parallele, prima che esplodesse), però al cinema, cosa vuoi, cosa pretendi? In due ore devi caricare a molla i superbuoni, i supercattivi e sgomberare. A volte, per risparmiare tempo e idee, si fanno combattere i superbuoni tra loro. Di solito in mezzo c'è un equivoco che si può risolvere (vedi l'ultimo film di Batman e Superman). Altre volte no.
 |
| War Machine ha sempre quell'aria da usato sicuro (e invece...) |
Quando la Disney divulgò il titolo del terzo film su Capitan America, molti lettori di fumetti in tutto il mondo ebbero un tuffo al cuore. La Civil War cartacea è una delle saghe più complesse mai intrecciate dalla Marvel; tanto più notevole quanto non è l'opera di qualche genio irregolare e solitario, ma un progetto su scala industriale, portato avanti da decine di sceneggiatori e disegnatori: prendiamo tutti gli eroi del nostro mondo fantastico e facciamoli scontrare tra loro - non per il solito equivoco che poi si risolve, ma per un problema fondamentale, una questione politica: gli eroi devono rispondere allo Stato o solo alla loro coscienza? Il solito problema: chi vigila sui supervigilantes? Facciamoli parlare di Libertà e di Responsabilità, mentre si tirano pugni e raggi cosmici. Manteniamo un'ambiguità di fondo e continuiamo a chiedere al lettore: tu da che parte stai? Fu un esperimento pazzesco e forse non del tutto riuscito. Certamente è una cosa che ha lasciato un segno.
Però nessuno, credo, nemmeno il più cieco fan della Marvel pretendeva davvero di ritrovarselo al cinema. Al cinema non c'è spazio per tutti quei discorsi. Non puoi intrecciare le nuvolette, piazzare didascalie dappertutto. Le scene d'azione rubano minuti al fondamentale dibattito, i pugni funzionano sempre meglio che le idee. E manca l'aspetto corale, che poi era anche quello più assurdo: non ci sono in giro per la sola New York migliaia di vigilantes mascherati, gli accumuli e i detriti di mezzo secolo di albi a fumetti; nei film ce n'è giusto una dozzina, più che una guerra ci fai una mischia di football. Insomma, non c'era un modo di fare una vera Civil War in un film. Il massimo che si poteva fare era ridurre i danni. Un bignami dignitoso con qualche buona scazzottata che non tradisse l'impianto problematico della storia originale. I fratelli Russo sembravano quelli giusti: col Soldato d'Inverno erano riusciti a problematizzare persino quel cetriolone blu che risponde al buffo nome di Capitan America. Ora si trattava di farlo litigare coi suoi amici, non per i soliti equivoci che poi si risolvono, ma per una questione di ideali e di politica. Com'è andata?
 |
| Ma ha pure le ali sul casco, giuro non ci avevo mai fatto caso. |
È andata che le scazzottate sono fantastiche. Hai detto poco: in film del genere le coreografie sono importanti più delle interpretazioni. Il genere supereroistico forse comincia ad accusare un po' di stanchezza: i due titoli migliori degli ultimi mesi (Antman, Deadpool) erano esplicitamente parodici. Nel frattempo I fantastici quattro hanno dimostrato che una grande produzione del genere può ancora sbagliare tutto e floppare (è quasi consolante), e Batman v Superman pur andando benissimo ha lasciato tutti un po' perplessi. Civil War, che tratta temi molto simili a BvS, è un film meno stritolato dalle ambizioni, molto più sicuro dei suoi mezzi. Ogni volta che vedo i Russo al lavoro mi viene questo aggettivo, "fluido". Scorre sempre tutto che è un piacere, non solo i combattimenti: l'intreccio, i dialoghi, il modo in cui i personaggi entrano ed escono e ognuno fa sempre il suo numero senza esagerare. Persino il grande Joss Whedon ogni tanto strappava, e tra una bella scena e un'altra necessaria ti trovavi un pezzo che sembrava attaccato con lo scotch alla sceneggiatura da un galoppino della Marvel. Coi Russo non succede mai, coi Russo va tutto liscio. Al massimo dopo una settimana ti dimentichi di cosa parlasse il film (continua su +eventi!)
Tra Civil War Batman v Superman c'è un po' la stessa differenza che corre tra un buon albo a fumetti regolare e la graphic novel dell'autore d'eccezione con pretese artistoidi e letterarie. Alla fine forse parlano della stessa cosa, ma BvS è il delirio di un profeta ubriaco, procede a tentoni tra illuminazioni geniali e crolli improvvisi nel ridicolo; CW è il compitino ben fatto di uno studente che non voleva assolutamente dirti qualcosa di diverso da quello che già sai. Di fronte a un film come questo, che è senza dubbio lo stato dell'arte del cinema di supereroi, a me capita davvero, non me ne voglia Raffaele Alberto Ventura, di "spegnere il cervello". Lo stesso cervello che davanti a BvS continuava a mandarmi messaggi stizziti: ma che succede? Ma che combinano? Ma questa cosa non ha senso! E quest'altra nemmeno!, dopo mezz'oretta di CW ha messo il pilota automatico. CW è sotto tutti gli aspetti un film più riuscito di BvS. Ma non è più intelligente. La mamma di Tony Stark non è più problematica della mamma di Batman. La verità è che la mamma è sempre la mamma, e che Capitan America e Iron Man non stanno litigando per una fumosa questione ideale, ma per i soliti banalissimi motivi: la mamma morta e l'amichetto che si ficca sempre nei guai. Sempre il solito amichetto. Sempre la solita mamma. E lo sanno entrambi che non ha senso: l'amichetto è francamente ingestibile e la mamma ormai è morta da un pezzo. Però guarda come se le danno di gusto.
Ripensandoci, non poteva che finire così. La Civil War dei fumetti metteva in crisi uno degli aspetti fondamentali dei supereroi di carta: l'identità segreta. In seguito a una catastrofe più insensata del solito, Casabianca e Campidoglio avrebbero deliberato la registrazione di tutti i supereroi mascherati: chi non avesse rivelato la sua identità al Presidente era da ritenersi fuorilegge (non a caso la storia girava intorno a Spiderman, il più geloso difensore della propria privacy, che viene convinto da Stark a rivelarla pubblicamente). In controluce c'era la guerra al terrorismo, il Patriots Act, eccetera. È passato qualche anno, ma il dibattito sulla privacy on line e fuori sarebbe ancora attualissimo: a quanti di noi è successo, negli ultimi anni, di perdere le nostre identità segrete on line, quelle che ci permettevano di scorrazzare liberi e di vendicarci delle frustrazioni quotidiane (anche se le identità invece che a Obama le abbiamo date a Zuckerberg)? Lo stesso Snowden, quanto assomiglia a un eroe tormentato che ha dovuto scegliere tra la fedeltà al suo Paese e ai suoi ideali, è stato costretto a rivelare la sua identità e ne ha pagato le conseguenze? Portare tutto questo al cinema, e nelle sale in cui si proiettano di solito film in calzamaglia, sarebbe stata una mossa davvero ammirabile.
Ma probabilmente impraticabile, perché le identità segrete, così tradizionalmente associate ai supereroi su carta, nell'universo cinematico Marvel sono quasi del tutto scomparse. Qui Stark ha fatto coming out già nel primo film: in generale, tutti sanno chi è chi. E quindi qual è il problema? Cosa sta chiedendo l'Onu ai Vendicatori? Devono stare attenti a fare meno danni? E sul serio: se un'invasione aliena minaccia New York, te la prendi con quei cinque o sei supereroi che l'hanno risolta da sola, mentre l'esercito era già pronto a deflagrare un'atomica? Lo capisce pure un ragazzino che è un pretesto. E i ragazzini che hanno visto il primo Iron Man a dieci anni, quest'anno votano.
Insomma no, CW non è quell'intrattenimento intelligente che vorrebbe farti credere di essere. Di solito i film Marvel alternavano ai combattimenti qualche sketch di commedia: i Russo hanno lubrificato il processo e ormai commedia e combattimento coincidono, è tutto un gran balletto in cui si scherza ma ci si può anche far male. Tra un numero e l'altro, qualche recitativo serioso manda avanti la trama. E anche qui, non è roba da buttare: vedere un supercattivo per una volta umanissimo, solitario, un modesto artigiano del Male invece del solito scienziato pazzo superaccessoriato - e immaginare tutti questi eroici yankee in corazza o calzamaglia manipolati dal buon vecchio Niki Lauda, pardon, Daniel Brühl... non era affatto una cattiva idea. Però, appunto, siamo al solito luogo comune: eroi che combattono non perché divisi da un'idea, ma perché un cattivone li ha manipolati. Si poteva osare di più? Se non ci è riuscita la Marvel, credo di no. Alla fine è un cinecomic, cosa pretendi? Certo, i bambini che festeggiarono il decimo anniversario al cinema con Iron Man I, quest'anno diventano maggiorenni. Tra un po' avranno bisogno di qualcosa di più. E forse ci arriveremo, al polpettone superoistico problematico. Ma che fretta c'è, dopotutto.
Le pagelle:
Capitan America. Se mi avessero detto che nella mia età adulta avrei visto non uno, ma ben tre film sul cetriolone blu, non ci avrei mai creduto. Se poi avessero aggiunto che a dare spessore al personaggio avrebbe contribuito l'umano carisma di Chris Evans, già odiosissima Torcia Umana, avrei iniziato a ridere forte. Pure, è andata così. Onore al Capitano.
Vedova Nera. Dopo cinque minuti Scarlett ha già salvato l'Africa da una pandemia mortale - e non si è ancora messa il costume. Poi vabbè, io non ce la faccio a essere oggettivo con Scarlett. Ormai ho accettato che è un personaggio secondario ambiguo e doppiogiochista, e mi sta bene così. Sta a tutti bene così. Se il film avesse un senso logico, a un certo punto Iron Man dovrebbe farla fuori. Non succede.
Black Panther. Secondo me è andata così: a un certo punto si sono accorti di aver dato un gregario nero sia a Iron Man che al Capitano, e che la cosa già discutibile in sé sarebbe riuscita ancora meno sopportabile in un film corale. A quel punto che fare? Ammazzarne uno? Peggio ancora. L'unica possibilità era infilarne un terzo che finalmente splendesse di luce propria. Storicamente, BP ha assunto questa funzione: è nero ma non è secondo a nessuno, tutti lo chiamano sua Maestà e s'inchinano, nelle edicole degli anni Settanta doveva essere uno choc. BP si conquista il suo spazio a unghiate, ma è un personaggio sostanzialmente ridondante, e tutta questa voglia di vedere un film su di lui non mi è venuta.
Iron Man. Il passaggio da golden boy maledetto a leader tormentato non è che sia stato così lineare: ho perso il conto, ma forse è il quarto film in cui dice di volersi ritirare e non lo fa. In più, siccome hanno deciso di risparmiare tagliando Gwyneth Paltrow, gli viene attribuita un'abbastanza gratuita frustrazione sentimentale. In realtà Downey Jr è ancora uno dei pilastri di tutta la baracca: lo si vede nel siparietto col nuovo Spider Man.
 |
| Altro che "Stark ha detto questo, Stark ha detto quello". |
Spiderman. Poi per carità a me va bene tutto. Anche Marisa Tomei zia, anzi, avercene. Questo Spidey giovanissimo ed entusiasta è perfetto per quello che deve fare qui. Però per favore non dite che era uguale all'originale. L'originale, quando calava la maschera, non guardava più in faccia a nessuno. Non si sarebbe ficcato in una zuffa solo perché Tony Stark gli dice che è giusto; non se la sarebbe presa coi nemici di Stark solo perché glielo dice Stark. Lo Spidey originale ha sempre fatto di testa sua e ha sempre preso le distanze da qualsiasi figura pseudopaterna.
Occhio di Falco. Jeremy Renner ha tre minuti tre a disposizione e anche stavolta li usa al meglio. Alla fine è il personaggio più vicino al papà che porta i suoi bimbi al cinema: un tizio che malgrado tutto non riesce a sentirsi troppo vecchio per queste stronzate. Forse non c'è niente di meglio del momento in cui con una freccina apparentemente sbagliata manda al tappeto Iron Man.
Antman. È un tipo a posto, dai. Non impegna, non ingombra, fa il suo numero e poi scompare.
Visione e Scarlet Witch. La verità è che li ho sempre un po' detestati sulla carta - oggettivamente, chi li ha progettati aveva un gusto tremendo. Non ho mai capito perché un sistema operativo incarnato debba avere la faccia magenta - a parte il fatto che in quadricromia veniva bene (lo sapete, vero, che Hulk è diventato verde perché stamparlo in grigio era troppo difficile?), però nei film, davvero, che motivo c'è. Hai tutta la sapienza del mondo e decidi di tenerti una faccia magenta? E il mantello? Invece la ragazza non ha ancora un costume. Spero che vada avanti così.
Il soldato d'inverno. Sta diventando imbarazzante. È il secondo film in cui la principale preoccupazione di Capitan America è salvare Bucky. Cosa ti chiami Capitan America a fare, se alla fine pensi soltanto a salvare il tuo amico Bucky? E da quel che ho capito potrebbe andare avanti così ancora a lungo. Io staccherei la spina.
Captain America: Civil War è al Citiplex di Alba (solo in 2D alle 20:30); al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (in 2D alle 20:30, 21:00, 22:10; in 3D alle 19:50, 22:45); all'Impero di Bra (solo in 3D alle 20:45); al Fiamma di Cuneo (solo in 2D alle 21:00); al Multilanghe di Dogliani (solo in 2D alle 21:15); ai Portici di Fossano (solo in 2D alle 18:30, 21:15); all'Italia di Saluzzo (solo in 2D alle 21:30); al Cinecittà di Savigliano (solo in 2D alle 21:30).
Perché Accorsi sembra uno sballato
04-05-2016, 02:21auto, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, drogarsi, Emilia paranoica, OttantaPermalink |
Ma come lo stai girando, tutto perfettino, con gli stacchi giusti, le curve tonde, soccia, che due balle fai venire. Ma te, ti diverti mai quando giri?
C'è un momento, diobono, in cui non pensi alla postproduzione, alla distribuzione, all'ipoteca che ti mangerà la casa se il film va di merda e tutte le altre balle? C'è un momento in cui ti gasi e basta? Lo sai di cos'hai bisogno, te?
Di benzodiazepina. Dodici gocce e poi vai liscio.
No, scherzo.
Te hai bisogno di Loris. E sei fortunato, eccomi qua.
(Però anche la benza non ti farebbe mica male sai, anzi, se hai venti carte ci passo io in farmacia, all'Operaia mi fanno gli sconti).
Ho visto Veloce come il vento e ora nessuno potrà convincermi che Stefano Accorsi non abbia passato gli anni del suo apprendistato a imitare Vasco Rossi per far ridere i compagni; se non era proprio Vasco era lo scoppiato del quartiere. Poi da cosa nasce cosa, uno spot qua, un Muccino là e vent'anni dopo Stefano Accorsi è attore di livello quasi internazionale. Il primo a crederci poco è probabilmente lui, e questo è il motivo per cui in fondo è impossibile volergli male. Ogni tanto ci pensiamo: ma che fine ha fatto? Quand'è che torna a farsi vivo, con una delle sue genialate?
(Hanno tutti fatto uno spot ridicolo ma quello di Accorsi non ce lo dimentichiamo. Prima o poi hanno tutti avuto un'"idea", ma solo "un'idea di Stefano Accorsi" è diventato un tormentone. Non c'è un perché, Accorsi non sarà un grande attore ma non è nemmeno il più cane di tutti. Non diremmo mai di Accorsi quel che si dice di solito a scuola, che uno è bravo ma non s'impegna. Accorsi s'impegna pure, Accorsi non puoi mai dire che non ci stia provando).
Veloce come il vento era, sulla carta, un film suicida. Una storia vecchia come la Turbosedici nascosta nel casolare, implausibile come un manga fine anni Settanta, o una storia di Bug Barri di Basari e Giovannini, nessuno sa di cosa sto parlando. Una ragazza minorenne al volante di una Granturismo, che durante la prima gara resta orfana (il padre si piglia un infarto nei box, la madre è fuggita anni prima) e con un fratellino a carico. Tutto questo poteva forse essere verosimile sulle pagine del Corrierino o del Giornalino, ma verso il 2015 lo spettatore italiano è ormai abituato a standard di verosimiglianza molto diversi. Poi però succedono due cose.
La prima è che Jeeg Robot, un film ancora meno plausibile su un borgataro che beve la monnezza radioattiva del Tevere e diventa Supercoatto tiene le sale per un mese intero e si presenta alla consegna dei David di Donatello col carrello della spesa. E lo riempie. Segno che il pubblico e persino la critica stanno cominciando a fottersi della verosimiglianza e a manifestare interesse per qualcosa di diverso che in mancanza d'altro chiamiamo "film di genere" (ma ha ancora senso chiamarlo così come se fossero gli anni Settanta e lo spettatore medio andasse al cinema una volta alla settimana? (Continua su +eventi!)
La seconda è che la sceneggiatura di Veloce come il vento a un certo punto è arrivata ad Accorsi, che magari non ha sempre voglia di recitare e lo capisco, ma stavolta aveva voglia di divertirsi a fare lo Scoppiato Anni Ottanta per un'ora e mezza. Perché con tanto rispetto per il giovane Rovere che ha talento, e gira sorpassi e curve e inseguimenti che Ron Howard, per dirne una, non ne ha fatti di migliori; con tanta ammirazione per la giovanissima Matilda De Angelis che regge il volante e la scena senza sbavare, Veloce come il vento non filerebbe così bene - Veloce come il vento non filerebbe nemmeno se Accorsi non riempisse ogni buco e fessura di trama. Il suo sporc-drughè, struggente ed esilarante e completamente fuori le righe, chi ha condiviso un po' di anni Ottanta nei parchetti dell'Emilia-Romagna non potrà trovarlo famigliare - quando spalanca le braccia ti sembra di sentirlo puzzare. Non so se chi è nato a nord del Po e a sud degli Appennini possa sentire lo stesso turbamento: ma qui ce l'abbiamo tutti un fratello, cugino, zio maggiore ridotto così. Cioè: ce l'avevamo. E in un qualche modo lo rimpiangiamo. Perché è vero che era un deficiente e ci ha rubato pure le posate. Però era nel nostro sangue, e quando se ne è andato è come se ci avesse tolto il divertimento. Quello non torna più, le posate si ricomprano.

Alla quarta settimana di programmazione, Veloce come il vento regge ancora al Comunale di Barge (21:15), al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:10, 22:40); al Nuovo Lux di Centallo (21:00). Vai, vai, ballerino.
Kate Winslet è il boss
26-04-2016, 14:05cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink |
| Che fine ha fatto Kate? |
Codice 999 è un poliziesco corale, come a dire uno di quei film in cui bisogna incastrare gli impegni di sette od otto attori di primo livello e il rischio che si corre è di sembrare comunque un Heat dei poveri. Il punto di vista oscilla continuamente tra buoni e cattivi, ma è un oscillare del tutto meccanico: se Heat o The Departed ne approfittano per mostrare che i due fronti si assomigliano più di quanto dovrebbero, e che insomma il bene e il male son concetti relativi ecc., Codice 999 è semplicemente un canovaccio scritto così, perché si usa così. I poliziotti sono marci, e i cattivi sono ancora più marci - tanto che alcuni di loro sono poliziotti deviati. Perché sono marciti? Non c'è un perché - cioè, Chiwetel Ejiofor ha decisamente sposato la persona sbagliata (la sorella di una boss russo-israeliana), che tutto sommato può essere un motivo valido per far esplodere le persone. No, la gente marcisce perché sai, la società, tutti sono armati, c'è tanta violenza a
 |
| Qui era fatto anche il fotografo |
La cosa è talmente smaccata che fino a un certo punto ti aspetti il colpo di scena, cioè dai, è impossibile... (continua su +eventi!)
La cosa è talmente smaccata che fino a un certo punto ti aspetti il colpo di scena, cioè dai, è impossibile che i neri siano i cattivi, i latinos siano ancora più cattivi però cialtroni e iperviolenti che non ragionano, gli ebrei i più cattivi di tutti che tramano trame - e i bianchi quelli buoni, quelli che danno sempre il meglio, che vorrebbero "fare la differenza". C'è persino una poliziotta asiatica che è un mago al computer.
Si sa come vanno le sceneggiature in questi casi: prima ti fanno credere una cosa e poi... scommetti che alla fine salta fuori che in cima a tutta la piramide del Male c'era il capo Harrelson con la sua ridicola cravatta stellestrisce? E quella brava coi computer in realtà faceva finta? E invece? E invece non è che posso dire il finale ma insomma, forse è persino una buona notizia: finalmente un film in cui ai neri capita di essere i cattivi (però professionali), agli ebrei capita di fare i mafiosi (ok, non è una novità) e ai bianchi di salvare la giornata, e nessuno lo trova razzista. Neanche in patria sembra che ci siano state molte polemiche. C'è anche Gal Gadot in quota israeliana ed è uno spreco terribile - una truzza mafiosa senza qualità, serve a far risaltare l'intelligenza della sorella Kate.
Il film ha un buon ritmo ma non si ferma mai - soffre di quell'affanno tipico di sceneggiatura troncata perché è vero che Hillcoat ha fatto La strada, ma non è né Mann né Scorsese e non può concedersi quella mezz'ora in più per spiegare perché certi personaggi si comportino in certi assurdi modi. Il risultato, temo, è che tra un paio d'anni ci ricorderemo ancora tutti dei film di Mann e di Scorsese, e di Codice 999 resterà il vago ricordo di un film in cui Harrelson si re-inventava poliziotto marcio ma completamente diverso dal suo true detective, e soprattutto Kate Winslet si trasfigurava in imperatrice ebreorussa del male, un'Imma Savastano dove meno te lo aspetti.
Codice 999 è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:15, 22:45); all'Impero di Bra (22:30); all'Italia di Saluzzo (20:00, 22:15); al Cinecittà di Savigliano (20:20, 22:30).
Villeneuve non ha pietà
21-04-2016, 19:23cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkSicario (Denis Villeneuve, 2015).
Anche qui arriveranno i lupi e i macellai, non c'è confine o barriera che possa contenerli. Reggie e Kate sono due agenti FBI di stanza in Arizona, per lo più indagano sui rapimenti e tirano giù porte coi calci. Un giorno squarciano un muro di cartone e si ritrovano nell'inferno del narcotraffico messicano. La cosa migliore sarebbe farsi trasferire in una piccola città, un posto dove le leggi possano avere ancora senso, dimenticare tutto. Ma Kate ovviamente non può.
 Quando qualche anno fa uscì Polytéchnique, un critico scrisse che il regista era riuscito a trasformare un massacro scolastico (ispirato a una storia vera) in un'esperienza estetica. Con Villeneuve si corre spesso questo rischio: storie agghiaccianti fotografate in un modo magnifico. Nessuno è mai riuscito a tirar fuori tanta arte dai profili delle tute antiproiettile stagliate su un tramonto: una ricerca estetica che rasenta il Kitsch e di solito ai registi statunitensi non interessa - rischia di distrarre l'attenzione dall'intreccio.
Quando qualche anno fa uscì Polytéchnique, un critico scrisse che il regista era riuscito a trasformare un massacro scolastico (ispirato a una storia vera) in un'esperienza estetica. Con Villeneuve si corre spesso questo rischio: storie agghiaccianti fotografate in un modo magnifico. Nessuno è mai riuscito a tirar fuori tanta arte dai profili delle tute antiproiettile stagliate su un tramonto: una ricerca estetica che rasenta il Kitsch e di solito ai registi statunitensi non interessa - rischia di distrarre l'attenzione dall'intreccio. |
| "Finisci di mangiare". |
Il mondo di Sicario lo abbiamo già visto altre volte al cinema o in tv: eppure sin dall'inizio abbiamo la sensazione che stavolta sarà diverso (continua su +eventi!)
Non possiamo fidarci di chi ci accompagna: sicuramente non è chi dice di essere. Villeneuve sfida tutte le convenzioni del genere, e soprattutto nella prima straordinaria mezz'ora sembra concentrarsi su tutte le situazioni che un buon professionista hollywoodiano eviterebbe: riunioni a un tavolo dove nessuno dice nulla d'interessante, trasferimenti silenziosi in auto o in aeroplano, e poi quel briefing che sembra una presa in giro, tra agenti distratti e assonnati che pochi minuti dopo faranno una strage. Emily Blunt ci presta gli occhi, Brolin in ciabatte ci mette a disagio sonnecchiando e sgranocchiando noccioline, Del Toro è l'orco buono dietro a cui nascondersi, salvo che non sta scritto da nessuna parte che sia buono davvero. Sicario è la dimostrazione che si possono violare tutte le regole del cinema d'azione e fare lo stesso uno straordinario cinema d'azione - o meglio, che lo può fare Denis Villeneuve. Lo si può rivedere venerdì 22 al Nuovo Cinema Lux di Centallo (21:00).
Un videogioco ad Auschwitz
13-04-2016, 21:23cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, ebraismo, memoria del 900, nazismoPermalinkUn giorno o l'altro uscirà un videogioco su Auschwitz. Sarà probabilmente un buon prodotto, assolutamente rispettoso della memoria delle vittime, che riuscirà a terrorizzare e a suscitare un genuino orrore in tutti i volonterosi giocatori. Si potranno interpretare diversi personaggi, sonderkommando o kapò o fuggitivi. Ci saranno missioni da compiere: trovare una macchina fotografica con la quale documentare il terrore; organizzare una rivolta; seppellire il proprio figlio con un rito religioso. Un giorno qualcuno lo farà, e dopo la sorpresa iniziale, non ci sembrerà una cosa così strana o sbagliata. Un modo di esercitare la memoria, di combattere il negazionismo, di far vivere ai giovani qualcosa di lontanamente simile a un'esperienza... Ciononostante le polemiche fioccheranno: è giusto ambientare un'avventura ad Auschwitz? Forse non è giusto, ma ormai ci ha gà pensato il cinema, no? I videogiochi seguiranno.
 |
| No, è fatto meglio di così. |
Il figlio di Saul è piaciuto a tutti tranne me... (continua su +eventi!) I
l figlio di Saul è piaciuto a tutti tranne me, e non so quanto c'entri il dibattito su quanto sia giusto ambientare fiction ad Auschwitz. Può trattarsi più banalmente di una questione di gusti: a me i videogiochi non dicono molto. E se un film in soggettiva posso capirlo, ho una personalissima idiosincrasia per i "film di nuche", quelli in cui il punto di vista coincide con una specie di angelo custode che segue il personaggio passo a passo, offrendoci frequenti primi piani non solo del suo volto (quello di Géza Röhrig, squadrato e un po' ieratico, ricorda davvero il rendering digitale di un gioco da consolle) ma anche delle spalle e della nuca, vi ricordate quanto piacevano a Gus Van Sant le nuche? A me non piacciono le nuche nei film, ma non credo di capirne più di Van Sant. Un film d'azione ambientato in un campo di concentramento me lo vedrei volentieri; ma la sintassi videoludica, quel continuo spalancare porte e aggirarsi per i corridoi, e origliare conversazioni, sempre alla ricerca di qualcosa, dopo un po' mi addormenta. Ma coi ragazzini capisco che potrebbe davvero funzionare. Il figlio di Saulè all'Aurora di Savigliano giovedì alle 21:15.
Anche in Bosnia può andar peggio
07-04-2016, 02:25cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, guerraPermalinkDa qualche parte in Europa ci sono i Balcani; da qualche parte nei Balcani c'è la Bosnia; da qualche parte in Bosnia c'è un pozzo d'acqua buona; da qualche giorno nel pozzo c'è un cadavere. Per toglierlo serve una corda, ma corde non ce n'è più. Ci fai tante cose con le corde: puoi legare gli animali o impiccare i cristiani. O i musulmani. Da qualche parte in Bosnia c'è una missione umanitaria, che si arrabatta come può. Sotto ogni carcassa di vacca può esserci una mina. Dietro ogni angolo, un posto di blocco. La guerra è finita, in teoria. La pace è molto in là da arrivare. I paesi sono rottami, la gente ride per un niente e si ammazza per un saluto, per un pallone. Se ti fermi a pensarci non ne esci più. Meglio scherzarci sopra e concentrarsi sul prossimo posto di blocco, sulla prossima carcassa, sul prossimo pozzo. Quel che deve andare a puttane c'è già andato; quel che ancora può salvarsi, magari si aggiusterà da sé.
 Perfect Day meriterebbe di essere visto anche se non fosse il piccolo film perfetto che è, per quel pezzo della nostra storia che ci rimette davanti, dopo anni passati anche a cercare di dimenticarcelo: la Bosnia. Piccola come l'Emilia e la Toscana, alle stesse latitudini, ad appena qualche centinaio di km. Per quarant'anni un mistero sulle cartine politiche che avevamo a scuola - se ne sentiva parlare solo per l'attentato a Sarajevo - e poi all'improvviso l'inferno: il fratello che uccide il fratello, i cetnici, gli ustascia, i mujaheddin. Noi cresciuti a pane ed euromissili, convinti che la guerra fosse solo una cosa fredda, globale, assoluta, ce la siamo trovata davanti così piccola, tossica e incomprensibile, come una muffa che ci prende la cantina e non la cacci più via. Non avevamo mai sentito parlare di stupri etnici, di enclavi, di nazionalismo serbo. Ma stava succedendo a pochi passi e bastava prendere un furgone per andare a controllare nelle retrovie, che faccia familiare avesse l'orrore. Perfect Day ci riporta in quei giorni e riesce per un attimo a recuperare quel romanticismo fuori tempo che negli anni Novanta conservavano le ONG, prima dello scandalo della missione Arcobaleno.
Perfect Day meriterebbe di essere visto anche se non fosse il piccolo film perfetto che è, per quel pezzo della nostra storia che ci rimette davanti, dopo anni passati anche a cercare di dimenticarcelo: la Bosnia. Piccola come l'Emilia e la Toscana, alle stesse latitudini, ad appena qualche centinaio di km. Per quarant'anni un mistero sulle cartine politiche che avevamo a scuola - se ne sentiva parlare solo per l'attentato a Sarajevo - e poi all'improvviso l'inferno: il fratello che uccide il fratello, i cetnici, gli ustascia, i mujaheddin. Noi cresciuti a pane ed euromissili, convinti che la guerra fosse solo una cosa fredda, globale, assoluta, ce la siamo trovata davanti così piccola, tossica e incomprensibile, come una muffa che ci prende la cantina e non la cacci più via. Non avevamo mai sentito parlare di stupri etnici, di enclavi, di nazionalismo serbo. Ma stava succedendo a pochi passi e bastava prendere un furgone per andare a controllare nelle retrovie, che faccia familiare avesse l'orrore. Perfect Day ci riporta in quei giorni e riesce per un attimo a recuperare quel romanticismo fuori tempo che negli anni Novanta conservavano le ONG, prima dello scandalo della missione Arcobaleno.Sarebbe insomma un film da vedere anche se fosse un noioso e tragico affresco sull'assurdità di una guerra contemporanea eccetera. Tanto meglio se invece di affliggerci o ricattarci, León de Aranoa prende una strada del tutto laterale e minata, e la butta in commedia... (continua su +eventi!) Riuscire a far coesistere dialoghi divertenti e dramma dei Balcani era una sfida quasi impossibile che in un qualche modo il film si porta a casa. Merito anche di un cast affiatato: Benicio del Toro, operatore umanitario che ne ha viste troppe e racconta a tutti che vuole andare a casa; Tim Robbins, il collega fuori di testa che guida per le mulattiere minate con lo stereo a palla; Mélanie Thierry alla prima missione, che deve imparare a guardare i cadaveri; Olga Kurylenko, boss in trasferta (ammirabile anche il modo in cui la regia riesce a gestire la sua ingombrante bellezza); Fedja Stukan, flemmatico interprete. Non sono in Bosnia per scherzare, ma qui se non si scherza si diventa matti. La guerra è dappertutto e in nessun luogo: nessuno sparerà un solo colpo, ma la morte è a ogni svolta di strada, a ogni portone. Ogni faccia che vedi ti sembra di conoscerla, e hanno tutti i loro motivi per ucciderti. Siamo in Bosnia: che altro ancora potrebbe andare storto? Perfect Day è al Lux di Busca, giovedì 7 e venerdì 8 aprile alle ore 21.
Batman contro Superman non ha senso (neanche se li costringi)
01-04-2016, 01:20cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fumettiPermalink Batman v Superman: Dawn of Justice (Zack Snyder, 2016).
Batman v Superman: Dawn of Justice (Zack Snyder, 2016).Due città si dividono la baia, e se nessuno è ancora riuscito a inquadrarle assieme, forse c'è un motivo.
A est c'è Zackopolis, terra solare di Dei olimpici o aspiranti tali. I templi sono più ottone che oro, se vogliamo proprio dirla tutta, ma l'aspirazione alla grandezza è genuina. C'è un'attesa messianica, un senso del divino e della meraviglia, quella nota di fascismo che gli americani sulle prime non riconoscono - addolcito da quella spezia camp, appesantito da qualche cedimento pacchiano che possiamo scambiare per ironia. Di film di supereroi ne trovi a ogni cantone, ma nessuno li inquadra come Zack. Nessuno ci crede davvero, hanno tutti paura di passare per ragazzini e ci scherzano su.
 |
| Come hai detto che si chiama tua madre? |
 |
| Ho fatto il militare in Israele, cosa volete che m'impressioni Doomsday |
 |
| "Clark Kent e Bruce Wayne! Come mi piace mettere in contatto le persone" |
Peccato che a Nolan City si faccia più o meno il contrario.. (continua su +eventi!) Come ai tempi del Joker di Nolan, c'è di nuovo un cattivo pazzo con un piano che non ha senso, a volte sembra calcolato al millimetro e a volte improvvisato sul set. Il film sembra riscritto dozzine di volte con dozzine di priorità diverse: facciamo un Superman realistico, che si misura con la contemporaneità: un po' di undici settembre (e persino l'attentato a Massoud, che riemerge come in un sogno) No, anzi, facciamo il Cavaliere Oscuro di Miller, anche se ai tempi Superman era Ronald Reagan e Batman piegava già verso i neonazi... Ho cambiato idea, facciamo un universo cinematico come la Marvel! Un cameo a Wonder Woman, un altro per Flash, via che si va... dite che è roba già vista? Ok, giochiamoci la carta di Doomsday. Ma sentite, e se il cattivo lo facessimo fare a Zuckerberg? Non a quello vero, no, all'attore... Oppure facciamo tutto, mettiamoci di tutto, e speriamo che qualcuno confonda la complicazione con la profondità. Con Nolan dopotutto funzionava.
E funziona anche stavolta. Il terzo miglior weekend di sempre negli USA - ok, a lunedì si era già sgonfiato di parecchio, ma al miliardo di $ ci arriverà. Ed è solo l'inizio, perché è talmente scombiccherato che i nerd, il nocciolo duro, dopo averne parlato male per un mese correrà a ordinare il dvd con le Scene Tagliate che dovrebbero Spiegare Tutto e invece probabilmente Faranno Ancora Più Casino. In questo stesso momento centinaia di blogger convinti di avere un senso critico stanno lavorando a un pezzo sui Cinquantasette Buchi di Trama di Batman v Superman (il Quarantaduesimo Ti Sconvolgerà!) Quella è gente che un film del genere se lo merita. Lo guarderanno e lo riguarderanno fino a sognarselo, finché non lo costringeranno ad avere un senso, come i predicatori con la Bibbia. Magari il cinema dovrebbe essere un'altra cosa - anche quello di intrattenimento, anche quello coi tizi in mantello che volano e tirano raggi laser. Una cosa meno seriosa, meno inutilmente complicata. Poi vai a vedere gli incassi, e... Batman v Superman è anche questa settimana al Cityplex di Alba (21:00), al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (19:50, 21:10, 22:45), al Vittoria di Bra (21:00), al Fiamma di Cuneo (21:00), al Multilanghe di Dogliani (21:05), ai Portici di Fossano (18:30, 21:15), al Cinecittà di Savigliano (21:30).
Saoirse va a Brooklyn
26-03-2016, 21:48cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, migrantiPermalink |
| I'll dye my petticoats, I'll dye them red and it's round the World I will beg for bread until my parents would wish me dead. |
- no dai basta.
Eh?
- Basta film di supereroi, non se ne può più.
Dici?
- Alla tua età poi. Sei patetico.
Ma ci vanno tutti...
- Tra l'altro pare sia un brutto film.
Capirai. Batman contro Superman, cosa pretendi?
- Pretendo della qualità, dello stile. Stasera andrai a vedere un bel film.
Ma ho già visto i fratelli Coen la settimana scorsa...
- Questa settimana è uscito Brooklyn. Con Saoirse Ronan.
Uh, che brava Saoirse. Di che parla il film?
- Di emigrati.
È un tema molto attuale!
- No, sono emigrati irlandesi negli USA, nel dopoguerra.
Sì, ma probabilmente l'autore ne approfitterà per mostrare i caratteri universali del dramma dell'emigrazione...
- No.
Ah no?
- È un film molto legato alla sua epoca. Ricostruzione filologica. Personaggi molto anni Cinquanta. Potrebbero essere i nonni. È la classica storia che ti raccontano i nonni.
Bene, quindi immagino che Saoirse all'inizio del film viva in Irlanda, in un contesto di povertà, di abbruttimento, dal quale non ci si può riscattare se non...
- In realtà sono tutti molto dignitosi.
Ah.
- Però lei è disoccupata e allora un prete le trova un visto e un lavoro a Brooklyn.
Un prete! Che ovviamente nasconde qualche vizioso segreto... magari è a capo di un racket, la tratta delle celtiche...
- No.
No?
- È una bravissima persona, attenta e riservata. La iscrive a un corso serale di contabilità. Le paga due anni di retta.
 |
| Anche i vostri nonni, almeno una sera, non sapevano come abbracciarsi. |
- Deluso?
Beh, in effetti non è che possono sempre fare i cattivi, i preti.
- Non sarebbe realistico.
Voglio dire, un prete o una suora malvagio/a ogni tanto ci sta proprio bene, ma alla lunga diventa un cliché.
- Invece un bravo prete un po' ti spiazza.
Già.
- Già.
E se andassi a vedere Batman?
- Non essere ridicolo. Andrai a vedere un film giustamente candidato all'oscar. Ed è piaciuto a tutti.
Tutti quelli che l'hanno visto.
- Certo.
Cioè magari non proprio tantissimi... ma quindi Saoirse arriva a Ellis Island e la ispezionano, la schedano, quarantena, magari le cambiano nome...
- No.
Ah no?
- Ha già i documenti a posto, saluta la guardia di frontiera ed è già in città.
Dove va a vivere? Sotto il ponte?
- In affitto da una signora.
Una megera che abusa di lei!
- No, una brava signora. Lei peraltro è una ragazza molto seria e diventa presto la sua inquilina preferita.
Ah, perché ce ne sono altre!
- Certo. Un po' meno serie.
E quindi invidie, macchinazioni, beffe crudeli, bullismo...
- No, anzi, è così adorabile che l'aiutano a truccarsi.
Ma insomma che lavoro fa?
- Commessa ai grandi magazzini.
Vessata dalla caporeparto!
- No, anche lei è una brava persona che le dà ottimi consigli.
A che punto del film saremmo?
- Più o meno quaranta minuti.
E non è ancora successo niente.
- Come fai a dire che non è ancora successo niente? (continua su +eventi!)
Il cinema è un Messia
20-03-2016, 13:33cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, CristoPermalink Il cinema non ha futuro, non sopravviverà agli anni Cinquanta. Presto in ogni casa ci sarà un televisore e Hollywood non avrà più soldi per i suoi Pantheon di cartapesta. Sempre che non scoppi la Bomba. Sempre che i rossi non ci attacchino. Sono già dappertutto, hanno un uomo in ogni produzione, un ballerino o una comparsa o uno sceneggiatore che inietta comunismo subliminale nei copioni. Il cinema sta per affondare, con Eddie Mannix saldo al timone. Questa settimana deve trovare un marito alla ninfetta incinta, trasformare un cowboy in un damerino, liberare un centurione e convincere l'allenatore di suo figlio a farlo giocare interbase. Ah, e smettere di fumare. Non sarebbe tanto più semplice cambiare mestiere, lavorare per la Bomba?
Il cinema non ha futuro, non sopravviverà agli anni Cinquanta. Presto in ogni casa ci sarà un televisore e Hollywood non avrà più soldi per i suoi Pantheon di cartapesta. Sempre che non scoppi la Bomba. Sempre che i rossi non ci attacchino. Sono già dappertutto, hanno un uomo in ogni produzione, un ballerino o una comparsa o uno sceneggiatore che inietta comunismo subliminale nei copioni. Il cinema sta per affondare, con Eddie Mannix saldo al timone. Questa settimana deve trovare un marito alla ninfetta incinta, trasformare un cowboy in un damerino, liberare un centurione e convincere l'allenatore di suo figlio a farlo giocare interbase. Ah, e smettere di fumare. Non sarebbe tanto più semplice cambiare mestiere, lavorare per la Bomba?E se i fratelli Coen odiassero il cinema? Se l'è chiesto un critico sul Wall Street Journal. Il loro omaggio a una presunta età dell'oro è demistificante e anche un po' gelido. L'idea di rifare i vecchi film sottolineando i temi che ai tempi dovevano passare sotto silenzio (l'omosessualità su tutti), non è più così nuova: altri ci hanno provato con più sensibilità (Haynes) o più filologia (Soderbergh). Mentre i Coen, si sa: per loro niente ha mai senso, figurati se ne possono trovarne uno nel technicolor. È più facile prenderli sul serio quando danno per primi l'impressione di voler essere seri, e affondano i loro personaggi in qualche bruma esistenziale. La giornata di Eddie Mannix è una serie di eventi assurdi esattamente come quella di Llewyn Davis, ma nelle traversie del secondo intuivamo una profondità, forse l'accanirsi di un oscuro disegno divino. Stavolta, invece... (Continua su +eventi!)
Stavolta invece abbiamo un film apparentemente buffo, con una voce fuori campo impostata in un modo ridicolo, che sembra costruito a furia di suggestioni: perché non facciamo emergere un sottomarino, così, giusto perché sarebbe una scena fichissima? Cosa c'è di meglio della Swinton che fa la giornalista di gossip? La Swinton che fa due giornaliste di gossip. Perché non chiamiamo la Johansson e le diamo uno di quei numeri da sirenetta sincronizzata? Perché non chiamiamo Tatum e gli facciamo fare una di quelle coreografie da marinai, però più gay? E a proposito di cripto-omosessualità: perché non ci scherziamo un po' su con George Clooney? Ecco, forse una delle cose notevoli è il modo in cui ancora una volta i Coen giocano a demolire la figura pubblica di quest'ultimo, il suo fascino di progressista engagé: e come Clooney si presti al gioco fino a pigliarsi i ceffoni. Sembra impossibile apparire profondi con un materiale del genere, eppure.
Eppure resta il dubbio: se questo mosaico di cameo e di sketch - metti tre preti e un rabbino a parlare di cinema, una barzelletta - fosse davvero quello che sostiene di essere all'inizio, cioè un Racconto del Cristo? (A Tale of the Christ era anche il sottotitolo del primo Ben Hur). Se Mannix non fosse che l'uomo giusto, tormentato dagli eventi, che per tutto il film cerca il volto del Messia e alla fine in qualche modo ritrova la sua, come si dice, fede? Se quegli schiaffi a George Clooney non fossero soltanto liberatori, ma un Vade Retro Satana, perché non pensi come Dio ma come gli uomini? Allora potremmo rispondere che sì, i Coen odiano il cinema, almeno certe mattine: come capita a tutti di odiare il lavoro che pure ci siamo scelti. Come si odia il proprio destino, quando capisci che non puoi più scappare: è un circo senza senso, ma è il nostro circo: sempre meglio di lavorare per la Bomba. Ave, Cesare! è al Citiplex di Alba (21:30), al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (15:20, 17:40, 20:20, 22:40); al Vittoria di Bra (18:15, 22:20); al Multilanghe di Dogliani (18:35); al Baretti di Mondovì (18:00, 21:00); al Politeama di Saluzzo (18:00, 21:30); al Cinecittà di Savigliano (22:30).
Non entrate nella Stanza
14-03-2016, 18:55cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkQuando era molto piccolo un giorno Jack scese dall'abbaino sin nella pancia della mamma. Nove mesi dopo ne sgusciò fuori e adesso è il più veloce di tutta la Stanza, cioè il mondo, non più di 16 metri quadrati: un gabinetto, una vasca una cucina, un televisore che mostra persone che non esistono, e un armadio per chiudersi dentro quando la sera arriva il Vecchio Nick. Lui è l'unico uomo dell'universo: a volte porta qualcosa da mangiare, a volte un regalo, ma non è un amico. Questo è il grande mondo di Jack, che oggi compie cinque anni. Buon mattino sedia uno. Buon mattino sedia due. Buon mattino, lavandino.
Qualcosa mi diceva di stare lontano da Room, qualcosa che avrei dovuto ascoltare con più attenzione. Forse è una stagione della vita, una crosta che verrà via qualche anno: diciamo che i bambini maltrattati mi danno da fare - no, è un po' più grave. Mesi fa ho abbandonato un film a metà perché un bambino piangeva e nessuno correva ad aiutarlo: non avrei mai dovuto guardare Room. Non è uno di quei film che dopo due ore finisce. C'è una piccola stanza che ti entra nel cervello e chissà quando se ne va. Senza mai mostrare una sola scena di autentica violenza, affidandosi soltanto alla verosimiglianza, Abrahamson costruisce uno degli inferni più credibili mai portati al cinema. Diventa impossibile non introdursi col pensiero in quella stanza e cominciare a riflettere su cosa avremmo fatto al posto di Jack e della sua mamma disperata, buonasera sedia uno, buonasera sedia due. Per sfuggire all'orco che gli ha dato la vita Jack deve trattenere il fiato, morire e rinascere: è il bambino più coraggioso del mondo, ma intanto stavo morendo io... (continua su +eventi!)
Il regista sembra limitarsi a scegliere la storia più agghiacciante e il punto di vista più innocente: Room non è l'esperimento tecnico che rischiava di essere, in compenso spacca abbastanza il cuore. C'è un'enorme crudeltà che viene data per tutto il tempo data per scontata: una domanda (perché?) che continueremo a urlarci dentro ma che al coraggioso Jack non interessa: nessuno si domanda perché è venuto al mondo dopotutto. È come chiedersi perché il cielo è azzurro, perché Dora l'esploratrice è bruna. Nessuno è veramente cattivo nel mondo di Jack: persino i giornalisti di cronaca, che in tutti gli altri film sono sempre le persone più orribili e superficiali, stavolta sono visti con occhi diversi, più sottili. Brie Larson porta a casa senza neanche troppo sforzo la parte della vita, ma per quanto meritato il suo oscar è impreciso: l'unico vero protagonista è il piccolo Jacob Tremblay, non c'è un solo istante in cui questo piccolo, orribile, indimenticabile film non sia suo. Addio sedia numero uno. Addio sedia numero due. Addio lavandino
Room è al Cityplex di Alba (19:30), al Fiamma di Cuneo (21:00) e al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (22:30).
Cuore di un ragazzo che senza paura sempre lotterà
06-03-2016, 11:47cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkLo chiamavano Jeeg Robot (Gabriele Mainetti, 2016).
Vai a vedere Jeeg Robot. Me l'hanno detto tutti per una settimana. Io nicchiavo, ero rimasto bruciato dal primo tentativo del cinema italiano di abborracciare un supereroe. In realtà Jeeg è agli antipodi del Ragazzo Invisibile, praticamente in tutto: al servizio di Salvatores si era messa una macchina industriale anche efficiente, ma che di supereroi non sapeva nulla e non ci teneva neanche troppo a informarsi - tanto è roba per ragazzini e i ragazzini si bevono tutto, no? No, sono anzi molto esigenti.
Invece Jeeg, per come ce la raccontano, è un progetto portato avanti in solitaria da un regista testardo che il target non lo ha studiato a tavolino, ma se lo porta tatuato su qualche organo interno. Jeeg è un film per il ragazzino che è rimasto intrappolato in ciascuno di noi. È un disadattato che si è arrangiato a vivere nel nostro condominio interiore - tutti i suoi amici o sono svaniti all'Apparir del Vero, o si sono trovati una famiglia e un lavoro - ma lui è ancora lì, rannicchiato su qualche puzzolente divano, vuole solo guardare porno e mangiare yogurt. Si esprime per citazioni misteriose, cartoni giapponesi, canzoni di vecchi Sanremo. Non farebbe male a una mosca ma allo stesso tempo è violento - la violenza è l'unico linguaggio che conosce - tanto violento quanto fragile.
Vai a vedere Jeeg Robot, mi dicevano. Avevano tutti la mia età, un brutto segno. Perché noi quarantenni continuiamo ad andare al cinema a vedere questi tizi in calzamaglia, quando ce ne piace di solito uno su cinque, perché ci siamo intestarditi su una delle tendenze, diciamolo, più bimbominchia della storia del cinema? Dall’Uomo Ragno di San Raimi in poi, non ce ne siamo persi uno, e non ce n’è uno che ci abbia convinto per più di un film. Che cosa stiamo cercando esattamente? Abbiamo avuto l’approccio scanzonato alla Marvel, l’approccio serioso alla DC, il finto gotico di Burton, il bislacco Nolan. Film di genere, li chiamano: come se gli autori non avessero provato in tutti i modi a colonizzarli, a darci il supereroe intelligente, il supereroe tragico shakespeariano, il supereroe horror. Va’ a vedere Jeeg – e già sapevo più o meno cosa aspettarmi: una farsa in romanesco col coatto che “ci ha i poteri”, tante strizzate d’occhio citazioniste a chi è cresciuto a pane e anime. E invece?
E invece ho visto il tizio in felpa che riavvia una giostra e poi salva una bambina, e un inquilino della mia Tor Bella interiore si è messo a piangere come una fontana: finalmente! è questo che ho sempre voluto vedere, coglione. I supereroi non sono buffi, non sono seri, i supereroi fanno quello che vorresti fare tu se avessi la forza di schiacciare un termosifone. Non passano il tempo a strizzar l’occhio allo spettatore, a confortarlo sul fatto che è molto, molto più intelligente di così, ed è in sala soltanto per gentile concessione al suo bambino interno o esterno. I supereroi sono quelli che i bambini li salvano, afferrandoli un attimo prima che cadano nel burrone. Non sono invincibili, anzi ne devono prendere tante dai gemelli cattivi – e perdere pezzi per strada.
Andate a vedere Jeeg Robot. Anche se ormai ce l’ha fatta: è ancora in sala dopo dieci giorni, anche in provincia di Cuneo (ad Alba oggi alle 18:45 e alle 21). Claudio Santamaria e Luca Marinelli mettono l’anima in due personaggi straordinari e implausibili, ma è Ilenia Pastorelli che continuerà a tormentarvi anche a fine visione: con gli occhi e gli strilli insopportabili di tutti i bambini che dovevate salvare, e non ne avete avuto il coraggio, le forze.
Gli effetti davvero speciali
01-03-2016, 02:20cinema, futurismiPermalinkPer questo il premio che in assoluto mi ha fatto più piacere è quello su cui davvero non contavo: gli effetti speciali a Ex Machina. Un film piccolo, con un budget modesto che Iñárritu avrebbe bruciato in una settimana di riprese "solo luci naturali". Ex Machina lottava contro macchine da guerra milionarie: Star Wars, lo stesso Mad Max col suo tripudio di stuntmen, il costosissimo orso digitale di The Revenant, il pianeta Marte di Sopravvissuto, rimodellato nell'altopiano del Wadi da Ridley Scott con videocamere 3d. Contro colossi come questi, Ex Machina poteva opporre solo un'idea, una trovata vecchio stile: riprendere Alicia Vikander e cancellarne parzialmente le forme col Rotoscope. Il caro vecchio Rotoscope - no, niente nostalgia. Si usano i vecchi mezzi perché costano poco, e perché funzionano bene: il risultato è straordinario, e ha commosso persino i giurati dell'oscar. Sarò onesto: fino a domenica ero convinto che la maggior parte non se lo fosse nemmeno visto, Ex Machina. Hai in gara l'orso che maciulla Di Caprio, hai le astronavi anticate degli Jedi, hai Mad Max, cosa stai lì a guardare un film tutto parlato dove l'unico effetto è un'androide carina?
E invece l'androide ce l'ha fatta, perché è davvero inquietante il modo in cui gioca con i nostri desideri e la nostra percezione. Ci mostra un volto adorabile, ci ricorda a ogni istante che sotto c'è un vuoto. Qualcosa di freddo e ostile. Eppure ci cascheremo ugualmente. Ex Machina è una trappola non proprio perfetta, ma è un bell'esempio di quello che sta succedendo alla fantascienza al cinema negli ultimi anni, a partire direi da Moon di Duncan Jones. Budget piccoli, idee forti. Ha funzionato così bene che sta influenzando anche i prodotti ad alto budget: Her, Gravity, Interstellar, The Martian. Manca ancora un vero capolavoro che segni i tempi: diciamo che la primavera è promettente.
Guida sragionata agli oscar 2016
26-02-2016, 12:00cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink
 |
Tutti gli altri premi. Non ci provo nemmeno. Non ci azzecco mai.
Non t'immischiare con Capitan Totomorto
23-02-2016, 10:37cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fumetti, invecchiarePermalink |
| Lei è Morena Baccarin. |
Dopo i supereroi coi superproblemi, i supereroi dal destino tragico e dalle grandi responsabilità, i supereroi recalcitranti, finalmente arriva Deadpool, ed è soltanto un coglione. Non è una ventata d'aria fresca? Un po' lo è. D'altro canto, non basta ammettere di essere coglioni per smettere di esserlo. A volte è il primo passo. Ma può anche essere un passo indietro. Di solito è il modo in cui cercavamo di sfangarla al liceo.
A volte penso a quanto sono fortunati i ragazzini di adesso, con tutti questi supereroi al cinema che ai miei tempi te li potevi soltanto sognare. Altre volte penso a quanto dev'essere difficile crescere in un mondo in cui i genitori conoscono tutti i personaggi dei tuoi sogni. Prendi Star Wars. Trent'anni fa era un mondo nuovo, qualcosa che creava un'immediata frattura tra il tuo mondo e quello dei grandi. Tuo padre non sapeva chi fosse Luke Skywalker - non era previsto che lo sapesse. Anzi, era previsto che non lo sapesse e non lo capisse. Invece adesso noi maledetti grandi coi capelli grigi sappiamo tutto, tutto. Tutte le vite di tutti gli eroi. Per i buchi di memoria ci sono le ristampe, le antologie, se proprio butta male wikipedia.
Nel frattempo, in virtù di un calcolo di mercato neppure troppo oscuro, l'Universo Cinematico Marvel continua a insistere su storie di quarant'anni fa, che perfino noi abbiamo letto in ristampa. Vedi l'ultimo Avengers: contiene due personaggi irrimediabilmente datati, l'androide Ultron e il suo antagonista buono, Visione, un tizio col mantello. Non so se vi rendete conto: il mantello. E quell'incarnato magenta che probabilmente negli anni Settanta era più pratico da stendere in quadricromia. Qual è il senso di resuscitare situazioni così vecchie, a parte compiacere i genitori che portano figli e nipotini e vogliono mostrare di saperla lunga? Per fortuna che da qualche cassetto la Fox ha tirato fuori Deadpool.
Una mossa abbastanza disperata, da parte di una major che negli ultimi anni ha fatto tutto quello che poteva fare per sputtanare gli eroi Marvel di cui deteneva ancora i diritti. Un Uomo Ragno per ragazze, un X-Men che ha definitivamente incasinato la timeline, un Fantastici Quattro horror, e poi cosa?
"Ci sarebbe un assassino psicopatico onnisessuale che non tace mai".
"Stai scherzando?"
"Ryan Reynolds ci tiene tantissimo".
"Ah beh allora".
"È un personaggio autoironico, dice un sacco di parolacce, infilza la gente con le spade..."
"Non si può fare, lo vieterebbero ai minori".
"Magari così funziona".
"Dici?"
"Teniamo basso il budget e vediamo. Insomma qualcosa prima o poi dovrà pur funzionare. È la legge dei grandi numeri".
Beh, ha funzionato. Però resta un sospetto. Forse più dell'autoironia da quattro soldi, di quel turpiloquio da macchinetta delle merendine, più di quella cosa così sovversiva che è sfondare la quarta parete (che non è un valore in sé, se la sfondi solo per dire cretinate) Deadpool ha funzionato proprio perché noi vecchi non lo conosciamo. Chi è questo Deadpool, in fin dei conti?
Se Deadpool ha un merito - non sono del tutto sicuro che ce l'abbia - è proprio quello di tagliarci fuori. Finalmente un supereroe che non è fatto per noi. Il film non ha niente di originale - anzi, cavalca senza vergogna e con una certa foga tutti gli stereotipi del genere "origini di un eroe". Di buono ci mette uno script compatto, che mira al sodo e taglia tutto il grasso; si sente che stavolta gli sceneggiatori non provavano la solita ansia da primo episodio ("Oh mio dio devo raccontare le origini di questo famoso personaggio senza tradire i fans e trasformandolo in un eroe maturo a metà del secondo tempo"). Deadpool non è una leggenda, Deadpool è una barzelletta: era essenziale non tirarla in lungo. Detto questo, rimane pur sempre la storia della sfida mortale tra due galletti che ce l'hanno a morte perché hanno iniziato a sfottersi in un corridoio. Il target è più ristretto del solito: è un film che in patria è vietato ai minori di 16 e che nessun normodotato maggiore di 24 dovrebbe avere un motivo serio per guardarsi. Gli X-Men forniscono due guest star, si fa per dire, due avanzi di continuity che rappresentano abbastanza fedelmente l'idea che lo spettatore tra i 16 e i 24 ha della generazione successiva (una teen-ager musona che whatsappa durante il combattimento) e della precedente, ovvero Colosso. Ecco: il nobile Colosso, che finalmente ha recuperato il suo accento russo, è il personaggio in cui gli spettatori più grandi sono costretti a immedesimarsi. Per tutto il film non fa che chiedere a Deadpool di non fare il deficiente. Indovinate che figura ci fa.
Deadpool, tra le altre cose, è un segnale eloquente che mi manda l'industria cinematografica: la vuoi piantare di andare a vedere i film di supereroi e di uscire deluso? Cosa ti aspetti ancora alla tua età da dei tizi in maschera e tutina colorata? Da bravo, perché non vai a vedere i film intensi o di denuncia sociale o non porti semplicemente i tuoi popcorn ai piccioni nel parchetto più vicino? Niente di personale ma insomma ci spaventi i clienti veri. I ragazzini. Deadpool è al Citiplex di Alba (20:00, 22:15), al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:20, 22:40), all'Impero di Bra (20:20, 22:30), al Cinecittà di Savigliano (20:20, 22:30).
Tutti gli uomini del Cardinale
19-02-2016, 13:42cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, giornalisti, pedofilie, preti parlantiPermalink |
| Alla fine per una buona metà del tempo ci sono loro in un ufficio che si spiegano le cose. |
Liquidato da alcuni come un film necessario, ma un po' troppo convenzionale, Spotlight è un oggetto molto più curioso di quanto non appaia a prima vista. Per essere un film sul più grande scandalo di pedofilia della Chiesa cattolica, è notevole quanto poco compaiano sullo schermo sia i bambini sia i preti. Non c'è nessun sadico bavoso in sottana, nessun paperino che piange nascondo rintanato in un angolo. L'orrore è del tutto verbale, riportato da vittime che non sono più bambini da un pezzo - uomini ingrassati, nervosi, non proprio quel genere di persona che ti muove all'empatia. Addirittura il regista sceglie di staccare prima che si mettano a piangere. È una scelta antispettacolare davvero inusuale: un film che invece di commuoverti vuole farti ragionare, pazzesco. Spotlight sulla carta si era scelto i cattivi più facili su cui infierire - i preti pedofili - e invece di segnare a porta vuota, decide di parlare d'altro: di giornalismo, soprattutto.
 |
| Buongiorno, sono una vittima. Non piaccio a nessuno. |
 |
| Aspetta, forse ho sbagliato film. |
Spotlight si giocherà qualche oscar accanto a un film che gli somiglia come il gemello cattivo, The Big Short. A monte di entrambi c'è una sfida: raccontare al pubblico medio una storia importante e difficile. Completamente opposto è il modo in cui i due registi dispongono dei loro cast d'eccezione: McKay, il regista di Big Short, li lascia liberi di gigioneggiare a loro piacimento: McCarthy li mette al lavoro come se fossero onesti lavoratori di una fiction con un lavoro da portare a termine. Tanto è pessimista e sarcastico Big Short, tanto è composto e a suo modo epico Spotlight: il primo si guarda intorno disperato, accumula tentativi di spiegazioni e metafore inconcludenti. Il secondo regge la barra in mezzo alla tempesta e continua a dirti che ce la possiamo fare: il giornalismo può essere indipendente, può essere di qualità, può spiegarci le cose e migliorare il mondo. Anche per questo, più di Keaton o di Ruffalo il personaggio a emergere è il direttore, interpretato da Liev Schreiber e vicino all'ideale di boss che chiunque vorrebbe avere avuto - un tizio inflessibile e mite che ti propone un lavoro anche difficile, ti dà tutto il tempo che ti serve, e nel momento del dubbio ti dice le sole dieci parole che ti servono: non prendertela con te stesso, capita a tutti noi di brancolare nel buio per mesi e anni. Ma l'importante è ritrovare la luce, e tu stai facendo un ottimo lavoro. Sarà anche per questo messaggio, tutto sommato rassicurante, che Spotlight è piaciuto persino al nuovo cardinale di Boston.
O forse il fatto che i preti bavosi siano lasciati fuori dal cono di luce? Due anni fa, un altro film di denuncia come Philomena di Stephen Frears mi lasciò un gusto amaro: non avevo apprezzato l'apparizione finale di una suora mostruosa, l'incarnazione di tutto il male che fino a quel momento era stato soltanto descritto a parole: un modo un po' troppo facile, osservavo, di catalizzare l'indignazione del pubblico. Spotlight se non altro mi ha fatto capire meglio la scelta di Frears. È un film onesto, un film che non vuole tirar pugni allo stomaco ma spiegare quanto sia importante avere un giornalismo professionale, e direttori tutti d'un pezzo, alieni a qualsiasi condizionamento ambientale. Ma è pur sempre un film che parla di mostri senza neanche provare a mostrarne uno. Spotlight è al cinema Stella Maris - Moretta di Alba (21:00), al Fiamma di Cuneo (21:00) e all'Aurora di Savigliano (21:15).
E Trumbo prese la macchina da scrivere
11-02-2016, 13:13Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink"Mi appello al primo emendamento".
"La mamma è comunista?"
"No".
"E io?"
"Facciamo il test. Se a scuola un tuo compagno non ha la merenda, tu cosa fai? Gli dici di trovarsi un lavoro? Gli offri un prestito al cinque per cento?"
"Papà..."
"O condividi la tua merenda con lui?"
"Non credo che questo sia proprio il comunismo classico, sai".
"Ah no?"
"Il comunismo è quando i miei compagni senza merenda, essendo diventati la maggioranza, si impadroniscono delle merende di chi le ha e le collettivizzano".
"Vabbe' ma non è che dobbiamo proprio entrare nei dettagli".
"Papà, ma questo dialogo deve avvenire proprio mentre tu mi fai fare un giro su un pony nel nostro bellissimo ranch?"
"Che ti posso dire, io l'avrei scritto diversamente. Ma Hollywood ha sempre l'ultima parola, quando sarai grande capirai".
Trumbo (Jay Roach, 2015).
 |
| La sua posa iconica (gli hanno anche fatto una statua). Purtroppo se ci provi col laptop rischi la vita. |
Trumbo è uno di quei classici film con cui Hollywood si specchia in sé stessa, trovandosi non priva di difetti ma dopo tutto irresistibile - film che a noi sudditi di periferia non dicono un granché, ma che qualche nomination la portano sempre a casa. Stavolta è Bryan Cranston, più noto per i suoi ruoli televisivi (Breaking Bad), che si ritrova in lizza per l'Oscar tra Di Caprio e Fassbender. Come tutti i biopic più convenzionali, Trumbo è più interessante per le cose che decide di non raccontare: il protagonista compare in scena già fatto e finito, un radical chic che discetta di giustizia sociale mentre firma contratti milionari. Non interessa la traiettoria che lo ha portato fin lì, ma quel che accade dopo: la caduta in disgrazia di lui e degli Hollywood Ten, i mesi di detenzione che un atteggiamento più prudente e meno idealista avrebbe potuto evitare - e soprattutto la faticosa risalita, nei dieci anni di esilio in cui l'ex sceneggiatore-più-pagato-d'America si ritrova a sbarcare il lunario scrivendo robaccia per il mercato di serie B. Solo perdendo il suo snobismo - e il suo ranch - il Trumbo del film diventa un personaggio simpatico, un poveraccio che tira la carretta mentre i figli crescono e smettono di capirlo, un forzato della macchina da scrivere che deve dimenticare la lotta del proletariato e buttar giù ogni sera cento pagine di sparatorie e inseguimenti.
Così, dopo averlo allontanato e poi riabilitato, Hollywood si rimpossessa di Trumbo costringendolo a rinnegare il comunismo, non a parole ma nei fatti: trasformandolo in un caporale che smista il lavoro ai sottoposti, e la sua lotta per la libertà di opinione in una americanissima battaglia personale per rivedere il suo nome nei titoli iniziali. I dialoghi coi famigliari e col personaggio fittizio di Louis C.K. - un compagno arrabbiato che non riesce a rinnegare il suo radicalismo e cede al rancore e al cancro - puntano tutti lì: Trumbo deve partire comunista col ranch per finire come un eroe che paga ai figli il college e ambisce a una gloria puramente individuale, una bella statuetta e un applauso.
 |
| FOR THE MONEY AND THE PUSSY! |
Goodman è ancora una volta impiegato col contagocce, ma è il vero centro del film - anche perché la storia di Trumbo è affidata a Jay Roach, un regista che ha esordito con Austin Powers e proseguito con la saga di Ti presento i miei. Roach non è del tutto immune da un certo timore riverenziale, ma si capisce che l'idea che il celebratissimo Trumbo abbia passato anni a scrivere robaccia per gli analfabeti gli piace parecchio. Sarà stato anche un comunista, ma a salvarlo sono stati dei mezzi gangster ignoranti che volevano far soldi e picchiavano con le mazze da baseball - lo vedi figliola? Hollywood alla fine vince sempre.
Uomo nero inferno bianco
07-02-2016, 08:15Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink |
| Nessun Gesù verrà a salvarvi |
Incredibile chi puoi trovare nella merceria di Minnie in una notte di bufera. Anziani generali del Sud, ex schiavi criminali di guerra. Cacciatori di taglie, sceriffi, boia e malviventi da impiccare, tutta la filiera della giustizia. Cowboy che tornano dalla mamma per Natale e stallieri messicani che sanno suonare il pianoforte. Gente di ogni tipo, razza e qualifica - anche se qualcuno magari non è proprio chi dice di essere. Ma nella bufera che differenza fa.
Sotto la neve saranno tutti uguali.
 |
| Starting to see pictures, ain't ya? |
Non resteremmo comunque storditi dagli attrezzi di scena, da quel luccicante feticcio che è il 70mm, dal coraggio con cui questo figlio di Hollywood continua a ignorare le regole di casa e ricreare un cinema che non sarà il più originale del mondo, ma è completamente a sé? Da anni gioca in un campionato a parte, per forza vince sempre. Nessun altro regista avrebbe preso in mano soggetti come Basterds e Django, nessun altro sarebbe riuscito a farne due film non ridicoli. L'Odioso Ottetto, viceversa, sulla carta sembrava un'idea meno folle: un delitto nella stanza chiusa, calato in quel preciso contesto storico che continua a tormentare gli spettatori americani: la guerra civile tra le razze, mai dichiarata, mai terminata.
Ad avere dei dubbi, stavolta, era lo stesso Tarantino. Quando una bozza di sceneggiatura cominciò a circolare abusivamente, sembrava voler cogliere l'occasione per rinunciare al film. Due cose pare gli abbiano fatto cambiare idea: la prima fu una lettura pubblica che andò benissimo, e che ha lasciato fin troppo il segno nella realizzazione. L'Ottetto che alla fine Tarantino ha girato, malgrado la ricercatezza della fotografia, è quasi un radiodramma. Verso il finale, dopo un colpo di scena escogitato per prendere alle spalle chi ha letto la vecchia bozza, ci si sorprende a domandarsi come abbia fatto il regista ad arrivare a tre ore. La storia non è più complicata del solito, Tarantino semplicemente non ha fretta - lui può permetterselo - e anche i suoi infreddoliti attori sembrano innamorati delle frasi che recitano. Tutti se le rimasticano nel loro accento preferito. È un film di dialoghi che sembrano monologhi.
L'altro fattore che ha convinto Tarantino a girare l'Ottetto è stata l'insistenza di Samuel Leroy Jackson (continua su +eventi!). Così come Joy è un film che David O. Russell doveva a Jennifer Lawrence, The Hateful Eight somiglia a un compenso per tutti i servizi che questo attore grandissimo ha reso a Tarantino - che effetto fa rendersi conto che non gli aveva ancora dato un ruolo da protagonista? E ripensando alla carriera di Jackson tra Spike Lee, Star Wars e Marvel (Per il Guinness dei primati è l'attore più profittevole in attività), che effetto fa pensare che in vent'anni l'Academy Awards si sia vagamente ricordato di lui solo con una nomination per Pulp Fiction? Se la metti in questi termini, anche l'ultima polemica sulla mancanza di candidati afroamericani all'oscar sembra meno pretestuosa.
The Hateful Eight è al Cityplex di Alba alle 16, 17, 19, 21 e 22; al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo alle 15:40, 19:10, 21:30 e alle 22:30; all'Impero di Bra alle 18:30 e alle 21:30; al Fiamma di Cuneo alle 15:40, 19:10 e 22:30; al Multilanghe di Dogliani alle 21:35; ai Portici di Fossano alle 18:15 e 21:30; al Bertola di Mondovì alle 18 e alle 21; all'Italia di Saluzzo alle 15:30, 18:30 e 21:30; al Cinecittà di Savigliano alle 21:30.
Non hai bisogno di un principe (quando hai un mocio miracoloso)
03-02-2016, 09:42cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkJoy (David O. Russell, 2015)
Joy ha un sogno: spiccare il volo, portare luce nel mondo. Joy ha due ipoteche sulla casa, tre figli a carico, una madre rimbambita dalle soap e un ex marito appoggiato nel seminterrato che studia ancora da cantante. Joy ha un'idea: nessuna donna dovrà più strizzare il mocio con le mani. Joy ha incubo che si chiama famiglia: un padre che vuole insegnarle gli affari, una matrigna che sceglie male gli avvocati, una sorellastra invidiosa che paga le fatture sbagliate. Joy ha una via d'uscita: diventerà una star delle televendite, fonderà un impero, e poi busserà a Hollywood e si farà realizzare un film su misura - così che tutti sappiano che ha sempre avuto ragione lei. E tutti vivranno soddisfatti o rimborsati.
Joy è anche il terzo film che David O. Russell gira con Jennifer Lawrence, quello che finalmente sembra tagliato per lei. Come se il regista sentisse di doverle qualcosa: quando la provinò per il Lato Positivo stava cercando una 40enne. Lei aveva 21 anni, lo convinse e poi ci vinse l'oscar. Persino più bizzarra, benché indimenticabile, la sua presenza in American Hustle, dove recitava quasi un mini-film a parte. Stavolta i comprimari sono gli altri - Bradley Cooper, anche lui alla terza presenza di fila, è in scena pochi minuti (ma sono fondamentali). Fa piacere ritrovare anche De Niro: Russell sembra l'unico direttore che riesce a trovargli ruoli dignitosi. Il regista che era famoso per i litigi con gli attori sembra aver fondato una piccola compagnia - sarebbe bello se si aggregasse anche Isabella Rossellini. C'è aria di famiglia ed è proprio quella che serviva a dare il tono alla fiaba (continua su
Certo, spiace un po' che l'occasione a Russell di lavorare coi suoi attori preferiti stavolta sia stata fornita da una dea americana delle televendite, l'inventrice Joy Mangano: lei voleva né più né meno che un'agiografia sulla donna che si è fatta da sola, lui gliel'ha confezionata senza mezze misure. L'idea di base - una Cenerentola emancipata, che non ha bisogno di principi ma di brevetti magici - è portata avanti con tanta convinzione che ci si è pure inventati una matrigna e una sorellastra.
Qualche spezzone di finte soap dovrebbe esprimere l'autoironia dell'operazione, ma è un espediente meccanico, a un continente di distanza dalle finezze di un Ozon. Russell ha la mano un po' più pesante, non riesce a dissimulare un certo tono rancoroso così tipico delle autobiografie dei self-made men (e delle self-made women); nella seconda parte sembra cedere il microfono alla committenza.
Forse è il primo film che parla di televendite senza prendersene gioco: anche perché a cantarne le lodi non c'è una Vanna Marchi qualsiasi, ma un estatico Bradley Cooper: quando scandisce "Qualità, Valore, Convenienza", tu per un attimo ci credi, e in quell'attimo potrebbe venderti un set di coltelli. Niente di male, ma fa un certo effetto pensare che dietro la macchina da presa ci sia lo stesso regista di I Heart Huckabees. Joy magari è un film più riuscito - certo meno irrisolto - ma è anche quel tipo di spettacolo di cui Russell dieci anni fa ci avrebbe voluto mostrare gli strappi, le cuciture, le crepe.
Joy è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:00, 22:35), all'Impero di Bra (20:10, 22:30) e al Fiamma di Cuneo (21:10).
Un genio incompatibile (e il suo sceneggiatore)
26-01-2016, 01:06cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, teatro, tvPermalink |
| Abbiamo mezz'ora e il copione, pardon, intendevo il software, è tutto da riscrivere. |
Questo è Aaron Sorkin, acclamato drammaturgo e sceneggiatore di The West Wing, The Social Network e... no, scusate, questo è Steve Jobs. Ma è anche un po' Sorkin, che ha preso l'immensa biografia di Jobs e ne ha ricavato qualcosa di assolutamente personale e incompatibile con qualsiasi altro film nelle sale; un dramma in tre atti, ambientato nei backstage di tre teatri diversi. Sono pochi i film che ti fanno pensare: chissà come renderebbe su un palco. Steve Jobs sembra pensato apposta per una messa in scena alla vecchia maniera sperimentale: niente sipario, gli attori cominciano a parlare di quello che deve andare in scena, e lo spettacolo consiste in questo. Lo stesso regista Danny Boyle, un po' meno frastornante del solito, sembra aver fatto qualche passo indietro di fronte all'evidenza: Steve Jobs è una questione privata tra Aaron Sorkin e il suo (alter)ego.
 |
| Lisa questo è Mac, Mac questa è la tua sorellina, ora disegnate un po' coi pennarelli e non rompete le palle a papà. |
 |
"RICONOSCI LA MIA IMPORTANZA!" "AMMETTI LA TUA SUBALTERNITA''!"
|
Sorkin non ha mai rifiutato l'autoreferenzialità, ma nelle serie tv almeno la disperde su più personaggi, coinvolgendoci in scene corali che ci fanno dimenticare come tutti i colori provengano dallo stesso prisma. Stavolta il coro non c'è: sulla scena Fassbender è solo. La Winslet, ovviamente ottima, non è che l'appendice del protagonista, necessaria a far risaltare il suo ego. Jeff Daniels ha a disposizione pochi minuti, lungo tre atti, per evocare un tortuoso complesso di Edipo - del resto è un Sorkin formato cinema, tutti camminano e parlano come indiavolati. La versione italiana sarà probabilmente un macello, quella coi sottotitoli va bene se invece di guardare il film vuoi leggerti i sottotitoli.
E quindi? Chi voleva vedere un film sull'inventore della Apple, potrebbe restarci male - e sarà la seconda volta in due anni. Se invece interessa l'opera di un talento individuale che voleva specchiarsi in un altro talento e raccontarci com'è difficile essere grandi in un mondo di mediocri, Steve Jobs è il pilota di una serie che butteremmo giù tutto d'un fiato, e uno straordinario dramma in scena stasera anche al Cityplex di Alba (19:45, 22:10); al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:10, 22:40); al Vittoria di Bra (21:30); al Fiamma di Cuneo (21:10); ai Portici di Fossano (18:30, 21:15); al Politeama di Saluzzo (15:30, 17:45, 20:00, 22:15); al Cinecittà di Savigliano (20:15, 22:30).
La vendetta è un piatto che si conserva a -40°
22-01-2016, 14:35Americana, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink |
| Il Sud Dakota secondo Iñárritu. |
 |
| Il Sud Dakota com'è davvero. |
"Chi?"
"Quei due ragazzi, alla fine li hai ammazzati?"
"Fitzgerald e Bedger? Ah, no".
"E perché no?"
"Bedger era un ragazzino, e quanto a Fitzgerald..."
"Non avevano la stessa età?"
"...Si era già arruolato. Se gli avessi torto un capello mi avrebbero impiccato. Ci siamo messi d'accordo con 400 dollari, e mi restituì il fucile. Questo qui".
"Non erano 300 dollari?"
"Infatti".
"Ma hai appena detto 400".
"Mi sarò sbagliato. Figliolo, quando hai visto la morte in faccia, e hai sopravvissuto a una bufera di neve accucciandoti nella carcassa di un cavallo..."
"Ma era giugno".
(Se vi è piaciuto Il viaggio di Arlo, non perdetevi la versione per adulti, col mille per cento di sangue e cicatrici in più, e un'animazione digitale ancora più raffinata - l'orso sembra vero! Padre e figlio si scambiano le parti, c'è un po' più di sangue e di visioni dall'oltretomba, e Di Caprio presta la voce - il rantolo - a un mammuth ferito ma non domo).
 |
| Il salvaschermo più costoso mai realizzato |
A Iñárritu interessa il cinema vero, quello senza green screen e altri trucchetti, quello che si fa con la pellicola, e l'esposizione naturale, e gli animali veri, e le ferite e i colpi di tosse veri - come se tutta questa verità non costasse comunque milioni di dollari. Gli interessava il ritorno alla naturalezza, anche se l'orso che cerca di finire Di Caprio battendolo come un materasso è un prodigio di computergrafica. Con l'ipocrisia ingenua e inconsapevole di quei milionari che sognano il ritorno alla natura ma hanno più in mente il triathlon - a proposito, c'è anche il saggio capo indiano che si lamenta perché il viso pallido gli ha tolto tutto. E nessuno che gli dica: senti nonno, tra venticinque anni potrei anche capire, ma siamo nel 1820, "tutto" cosa? A momenti non c'è un solo viso pallido in tutto il Dakota, e comunque appena arriva lo scotenni e gli rubi il bottino di caccia, a chi la vuoi raccontare? Non ci hai fatto gli affari anche tu, coi visi pallidi, finché t'è convenuto? Eh, ma questi bianchi sono cattivi sul serio. Rubano le donne, impiccano per divertimento, aggiungendo un cartello di spiegazione come i nazisti - anche se nessuno sa leggere in un raggio di trecento miglia.
È difficile sfuggire a The Revenant, alla sua fotografia da National Geographic, al titanismo essenziale del suo eroe, maschiaccio di poche parole laddove pare che il vero Hugh Class fosse un affabulatore, magari pure un contaballe. Questa parte del suo ruolo se la prende Tom Hardy che prosegue il suo stato di grazia: un antagonista nervoso e rapace che non sta in scena per più di mezz'ora, ma ha più dialoghi di tutti gli altri personaggi messi assieme. Iñárritu ha coraggio da vendere, e anche stavolta non si può che dargliene atto. Dopo due ore senza una sola scena in interni, cominci a capire quello che intendeva Cimino mentre affondava sul ponte dei Cancelli del cielo: i film dovrebbero essere viaggi, dovrebbero prenderti di peso e portarti in un altro luogo, in un altro tempo.
Cosa sta succedendo allora a Hollywood, se Cimino sprofondò e Iñárritu ha preso 12 nomination? Siamo entrati in una nuova età del cinema, o il nuovo regista pazzo è un po' meno pazzo, un po' più paraculo di quanto non voglia sembrarci? Disprezza i fumettoni, ma il suo eroe sembra avere lo stesso fattore rigenerante di Wolverine. Vuole le luci naturali, ma sa che la gente verrà a vedere l'orso finto. Vuole la storia vera, ma poi se la reinventa da capo a piedi, ricattandoci col sentimento più a buon mercato - l'amor paterno. Il vero Glass era un fanfarone che si fece duecento miglia per trecento dollari e un fucile. Il Glass del film deve attraversare canyon e ghiacciai per vendicare un figlio. È una storia talmente costruita che alla fine Iñárritu se ne vergogna - e anche stavolta, come in Birdman, il finale manda un po' a gambe all'aria il film.
Vorrebbe essere profondo, vorrebbe essere autocritico, vorrebbe rivedere le sue stesse premesse. Ha fatto sanguinare Di Caprio, ha opposto bianchi sterminatori a pellerossa in armonia con la natura, e alla fine ci ha ricordato che la vendetta è un buon trucco per costruirci attorno un film - ma che resta sostanzialmente una cosa sbagliata, ragazzi, mi raccomando non vendicatevi a casa. Che gli puoi dire? Bravo è bravo. Ma resta lì sospeso nel bianco delle sue bufere fantastiche, né troppo pazzo né troppo furbo per arrivare davvero al punto. The Revenant è al Cityplex di Alba (21:30), al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:30, 22:10), all'Impero di Bra (19:45, 21:45), al Fiamma di Cuneo (21:00), al Baretti di Mondovì (21:00), all'Italia di Saluzzo (21:30), al Cinecittà di Savigliano (21:30)
L'ultimo gigante
20-01-2016, 11:22cinema, coccodrilliPermalinkDei tre è il più borghese, quello che meno si vergogna di esserlo: è difficile immaginare Risi e Monicelli alle prese con il manifesto antipauperista di Brutti, sporchi e cattivi (Pasolini invece pare che volesse girarne il prologo, magari una versione in pellicola dell'Abiura). È anche quello che ha più ambizioni autoriali: nel 1970 fora la quarta parete in Dramma della gelosia, ma forse il vero choc del film è che il sex symbol Mastroianni è un marito becco e ingrigito con un destino da straccione; l'anno dopo coinvolge Sordi nella rischiosa trasposizione cinematografica della Panne di Dürrenmatt, La migliore serata della mia vita. Non è che tutto fili liscio, ma si capisce che all'alba degli anni Settanta la commedia gli sta stretta. Ci lavorava da vent'anni; era parte integrante di un sistema che funzionava, che riempiva le sale (restava da conquistare la critica, ma quella ci mette sempre un po' più tempo). Avrebbe potuto riprodurre le stesse formule ancora per parecchio. Ma tutti i suoi uomini stanno invecchiando, e lui è il primo a rendersene conto. Lui e Germi, che muore nel '74 passando a Monicelli la pratica di Amici Miei. Nello stesso anno esce C'eravamo tanto amati. Le maschere della commedia all'italiana si scoprono le rughe; si staccano dalla ribalta del presente e cominciavano a guardarsi intorno: chi eravamo? Cosa siamo diventati? E ora cosa ci succederà?
Dovendo scegliere un film solo di tutto un periodo e di un genere, a malincuore sceglierei C'eravamo tanto amati, che pure non è così tanto rappresentativo. È davvero un film manierista, se non barocco. Dentro c'è tutto: il romanzo generazionale, il conflitto sociale, il gioco delle citazioni non solo cinematografiche ma anche teatrali e televisive, la quarta parete fatta a pezzi. È anche il primo vero film forrestgumpista, in straordinario anticipo rispetto agli epigoni italiani, indegni di comparire al suo cospetto (La meglio gioventù? Per favore, dai). Ogni volta che lo vedo ci trovo qualcosa di nuovo - o che probabilmente mi ero dimenticato, e di nuovo rabbrividisco al pensiero che una volta gli italiani sapevano fare film così. In realtà di film davvero così ce n'è uno solo, e forse si poteva realizzare soltanto in un periodo in cui gli italiani il biglietto l'avrebbero staccato comunque. Bastava che in cartellone ci fossero Gassman e Manfredi - e la Sandrelli, certo.
La commedia all'italiana mi piace tutta, dai Soliti ignoti fino alla Terrazza. È un amore nato davanti alla televisione; maturato con la serale complicità di Retequattro; integrato con qualche videocassetta. Ci ho messo parecchio a capire cosa mi piacesse davvero tanto in quei film, cosa invidiavo ai miei genitori che avevano vissuto in un mondo di mostri di bravura, anche se al cinema loro non ci andavano spesso. Non un attore in particolare, per quanto i loro volti ricorrenti mi rassicurassero; nemmeno un regista. Alla fine mi sono reso conto che sono i dialoghi di Age e Scarpelli, e un po' anche di Scola. Credo che la differenza con quello che è venuto dopo sia tutta qui. Non ho paura ad affermare che oggi in Italia ci sono molto più che cinque attori bravi, per tacere delle attrici (c'erano anche allora, ma lo star system era una cosa molto angusta). Anche i registi: ne abbiamo senz'altro all'altezza dei grandi degli anni Sessanta, se non altro perché sono seduti sulle loro spalle. Il problema è che questi bravi attori, ripresi da ottimi registi, molto spesso non hanno niente d'interessante da dire. Non c'è più Age, non c'è più Scarpelli, adesso non c'è più Scola. Dispiace? Sì, mica da oggi. È da 35 anni che non lavoravano più assieme. Nel frattempo altre due generazioni hanno provato a raccontarsi; il confronto è impietoso.
La grande truffa dei mutui (che nessuno ha capito)
13-01-2016, 14:37cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, economiePermalink |
| A CHRISTIAN, FACCE L'ASPERGER! |
Nel più grande film mai realizzato sui trucchi della finanza - che non è questo, ma più probabilmente The Wolf of Wall Street - ogni tanto Di Caprio ci guarda in camera e comincia a raccontarci uno dei suoi maneggi, per interrompersi subito: non avete capito niente, vero? Fa lo stesso, tanto voi siete qui per vedere il tiro al bersaglio coi nani, le feste al quaalude, il lancio d'aragoste contro i federali. Lasciate perdere la tecnica. Divertitevi.
 |
| Mi sa che stavolta non ce la pubblicano |
È un po' lungo, ma non annoia, La grande scommessa (continua su +eventi!)
Nei suoi momenti migliori sembra uno spinoff televisivo del Lupo di Wall Street, come se si fossero detti ehi, qui da questa parte c'è materiale per una serie, proviamoci. È uno di quei film che ti servono a capire per contrasto quanto è grande Scorsese, e quante cose apparentemente semplici, così naturali quando c'è lui che guarda in macchina, non siano alla portata dei registi mortali. Non è che Adam McKay non ci provi, anzi forse il guaio è che ci prova troppo. Si prende dei rischi, gioca con quarta parete, con la voce fuori campo, coi salti di inquadratura dal mondo irreale della finanza a quello vero fatto di case invendute e barboni sotto i ponti. Tutto sembra gridare: non sono il solito regista di pilota tv. Io ho una visione.
Magari non è la più originale. Un po' confusa. Certo non cinica come quella di Scorsese. I miei eroi non bruciano i risparmi dei loro clienti in pillole e coca, anche a Las Vegas vanno a letto presto. Se si appartano con le lapdancer è solo per capire come gestiscono il loro eccesso di liquidità. Hanno tutti una famiglia o desiderano averla; si arricchiranno grazie alle falle del sistema, ma ogni tanto si sentono in colpa. È una visione un po' benpensante, ma forse è quella che ti può sbloccare il budget. Ci metti la critica sociale, ci metti un po' di valori rassicuranti, ma soprattutto ci metti Bale, Carell, Gosling e Pitt - chi ti potrà più dire niente? Certo, si poteva anche provare a dirigerli. Il film era già centrifugo di suo, forse andava evitata la sensazione di quelle orchestre all-star dove a turno i virtuosi fanno un assolo di dieci minuti. A Bale tocca l'Asperger di talento - ormai è un personaggio codificato, l'Arlecchino del Duemilaedieci: l'asociale stravagante che ha ragione ma non riesce a spiegare il perché. Brad Pitt si immobilizza saggiamente in una posa redfordiana e almeno non dà fastidio. Gosling, nei panni dell'unico vero rampante senza scrupoli, continua a prendersi in giro: è il terzo ruolo antiparodico in tre anni, come se il suo adorabile faccino cominciasse a pesargli. Carell sarebbe sorprendente se non ci avesse già sorpreso in Foxcatcher. Dovrebbe essere il vero perno drammatico del film, ma il copione non lo aiuta: s'incazza a casaccio, e si sorprende di tutto quello che gli succede, come se fino al giorno prima avesse diretto un hedge fund a Disneyland.
Nessuno ci odia più di Checco
05-01-2016, 12:07cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink C'è un mondo là fuori. Può essere la giungla africana o il circolo polare, ma è sempre un mondo più civile. Laggiù, sapeste! non si suona il clacson appena il semaforo è verde. Non ci si fa svegliare dalla mamma a quarant'anni. Non si critica un film comico soltanto perché ha fatto più di venti milioni in meno di una settimana. Non lo si rimpalla tra destra e sinistra, non si approfitta dello spazio di una recensione per parlare di Renzi o della storia della commedia all'italiana. C'è un mondo là fuori, e avremmo tutti una gran voglia di andarci, anzi di esserci già! e invece restiamo qui. Nessuno sa perché. Forse è il prezzo delle ciliegie.
C'è un mondo là fuori. Può essere la giungla africana o il circolo polare, ma è sempre un mondo più civile. Laggiù, sapeste! non si suona il clacson appena il semaforo è verde. Non ci si fa svegliare dalla mamma a quarant'anni. Non si critica un film comico soltanto perché ha fatto più di venti milioni in meno di una settimana. Non lo si rimpalla tra destra e sinistra, non si approfitta dello spazio di una recensione per parlare di Renzi o della storia della commedia all'italiana. C'è un mondo là fuori, e avremmo tutti una gran voglia di andarci, anzi di esserci già! e invece restiamo qui. Nessuno sa perché. Forse è il prezzo delle ciliegie. Quelle che alcuni non perdonano a Checco sono in sostanza le regole d'ingaggio della satira di costume. Certo, Checco proietta i nostri difetti rendendoli più tollerabili. Certo, si offre al pubblico più vasto possibile con un prodotto che ha almeno due livelli di lettura - un occhiolino a chi non sopporta più le auto in seconda fila, un cenno d'intesa a chi l'ha parcheggiata sul marciapiede del cinema. Come se questa doppiezza non fosse la formula della commedia all'italiana dai Soliti ignoti fino a Fantozzi e alle sue derive cinepanettonesche. Il fatto che si rimproveri a Zalone di fare bene il suo mestiere significa come minimo che non siamo più abituati a vedere qualcuno che quel mestiere sappia farlo. Che dovrebbe fare un comico, a parte farci ridere mentre suggerisce che come popolo siamo da rottamare? Pretendiamo qualcosa di più? Deve entrare in politica, pure lui? E dopo saremo contenti?
Quelle che alcuni non perdonano a Checco sono in sostanza le regole d'ingaggio della satira di costume. Certo, Checco proietta i nostri difetti rendendoli più tollerabili. Certo, si offre al pubblico più vasto possibile con un prodotto che ha almeno due livelli di lettura - un occhiolino a chi non sopporta più le auto in seconda fila, un cenno d'intesa a chi l'ha parcheggiata sul marciapiede del cinema. Come se questa doppiezza non fosse la formula della commedia all'italiana dai Soliti ignoti fino a Fantozzi e alle sue derive cinepanettonesche. Il fatto che si rimproveri a Zalone di fare bene il suo mestiere significa come minimo che non siamo più abituati a vedere qualcuno che quel mestiere sappia farlo. Che dovrebbe fare un comico, a parte farci ridere mentre suggerisce che come popolo siamo da rottamare? Pretendiamo qualcosa di più? Deve entrare in politica, pure lui? E dopo saremo contenti?Alcuni si premurano di informarci che Checco non è Totò, né Alberto Sordi - grazie, correvamo il rischio di confonderci - ma il confronto andrebbe fatto con quel che passa in convento negli anni Dieci. Checco continua a sembrare uno dei pochi che ha capito che l'Italia non è un giardino fiorito stuprato da consorterie di uomini cattivi, politici e imprenditori. No, l'Italia è quel che è perché gli italiani sono così. I politici - vedi Lino Banfi, retrocesso con affetto a caratterista - non sono che emanazioni di una civiltà che è da buttar via e rifondare da capo.
A un certo punto del film c'è un bambino razzista. (Continua su +eventi!)
A un certo punto del film c'è un bambino razzista. I bambini di solito nei nostri film sono creature naturalmente buone, che dicono sempre la verità. Nel film di Checco no. Ci sono bambini educati (in Norvegia), che credono in qualsiasi Dio o anche in nessuno, e poi ci sono bambini razzisti. E sono proprio i tipici bambini italiani pettinati da calciatore, che giocano a pallone in piazza e non ti fanno entrare in squadra se non parli il loro dialetto. Veltroni non li vede, Checco sì. Checco vive nella mia Italia, Veltroni non so. Poi dite che è di destra. Un film in cui i cattivi sono i bambini pettinati da calciatori, e i buoni sono gli scienziati con la famiglia aperta. Un personaggio comico che continua a ribadire, film dopo film, che gli italiani non possono più vivere alle spalle dei genitori e dei figli; che devono cambiare: non perché lo impone il Politico cattivo o l'Euro assassino, ma perché oltre a essere necessario, sarà bello. A un comico così si perdona anche il fisiologico calo del secondo tempo (del resto il primo era partito a razzo), e il finale coi lacrimoni e i buoni sentimenti e l'Africa e la medicine.
Checco non sarà Sordi, ma il minimo che si possa dire è che si sta impegnando. A questo punto della favola Luca Medici e Gennaro Nunziante potrebbero riempire un'ora e mezza di pellicola di gag da quattro soldi, e invece insistono a cercare cose nuove, a cambiare situazioni e ambientazioni. Potrebbero restare anche loro nel casolare in campagna, e invece vanno al circolo polare a scherzare sul riscaldamento globale. Un esempio qualsiasi: non si ride quasi più dei gay. È un dettaglio, ma pensate a quanto era centrale la figura dei gay in Cado dalle nubi. Qualcun altro al suo posto avrebbe replicato la ricetta (per dire, sui gay di Cado dalle nubi hanno girato uno spinoff l'anno scorso senza Checco ma con Belén). Invece Medici e Nunziante, con un solo personaggio a disposizione hanno già fatto quattro film senza ripetersi. Villaggio e Salce con Fantozzi non ci sono riusciti.
Farei prima a scrivere i cinema in cui non proiettano Quo vado. La sala Lux di Busca, ad esempio (fanno Timbuktu), onm il cinema San Giacomo di Roburent dove c'è Star Wars. Invece al Cityplex di Alba (17:30, 19:30, 20:00, 21:30, 22:00), al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (14:15, 15:20, 16:20, 17:30, 18:30, 20:20, 20:40, 21:00, 22:35, 22:45), al Multisala Impero di Bra (20:20, 22:30), alla Sala Borsi di Ceva (16:00, 18:00, 21:00), al Fiamma di Cuneo (15:30, 17:40, 20:30, 22:40), ai Portici di Fossano (18:30, 20:30, 22:30), al Bertola di Mondovì (18:00, 21:00), all'Italia di Saluzzo (20:00, 22:15), al Cinecittà di Savigliano (20:20, 22:30) c'è Quo Vado. Tanto ci siete già andati
Sei film del 2015 che valeva la pena di vedere ma è troppo tardi (II)
30-12-2015, 22:48cinemaPermalink Chi è senza colpa (The Drop, Michaël Roskam).
Chi è senza colpa (The Drop, Michaël Roskam).Il problema di molti noir di derivazione letteraria è che vorrebbero avere il respiro di un romanzo senza sbordare oltre le due ore. The Drop risolve il problema abbassando le aspettative: è una short story in tutti i sensi, la storia circoscritta di un barista che trova un cane in un cassonetto e ha un problema con la mala. Probabilmente non funzionerebbe così bene se la short story in questione non l'avesse firmata Dennis Lehane. James Gandolfini ci saluta dando corpo a un memorabile gangster irlandese di mezza tacca. Tom Hardy si ritrova fuori ruolo (dovrebbe essere il cugino di Gandolfini, con un passato oscuro alle spalle), in una di quelle situazioni in cui puoi salvare la situazione soltanto con una prestazione memorabile. Se è tardi e non avete sonno e in tv non c'è niente che vi piaccia.
Vizio di forma (Inherent Vice, Paul Thomas Anderson)
Sto ancora aspettando che lo proiettino a Cuneo o provincia. Oltre a essere uno dei film più folli dell'anno, oltre a farci riscoprire quel lato giocoso di P. T. Anderson, che da tempo sembrava sotterrato sotto detriti tragici e pensosi, Inherent Vice è anche un altro esempio riuscito di letteratura al cinema - chi l'avrebbe detto che Pynchon avrebbe funzionato meglio di un Ellroy? Anderson getta alle ortiche ogni prudenza e decide di affrontare nel modo più letterale possibile le circonvoluzioni paranoidi del suo autore feticcio. Ai titoli di coda ti può capitare di provare le stesse sensazioni di quando finalmente chiudi uno di quei suoi libri sul tutto e sul niente: il sentimento di non averci capito un cazzo, ma in quattro dimensioni. Non so se mi spiego. Se non conoscete Pynchon questo film può perfino essere un buon punto di partenza, almeno per capire se vi piace il genere. E i Freak brothers vi dicono niente? Robert Crumb? Un grande Lebowski in acido, giusto per capirsi? Non è un film per tutti, ma lo dico con tristezza.
 |
Anche questo non è un film per tutti, anzi mi domando per chi sia. Per caso vi riconoscete nel sottoinsieme di appassionati di fantascienza classica anni Quaranta che per qualche strano motivo non hanno letto All You Zombies di Heinlein o se lo sono dimenticato? Allora Predestination è il film che fa al caso vostro - ma a questo punto probabilmente ve lo siete anche visto. Gli Spierig hanno anche tentato di attualizzare la storia (già perfetta in sé), con qualche vago riferimento al terrorismo ed elevando il già complesso intreccio al quadrato: non è che scorra tutto liscio, ma per me nelle afose notti di luglio non c'è niente come una sala deserta e refrigerata e una storia bizzarra e fuori dal tempo come questa.
Sei film del 2015 che valeva la pena di vedere ma è troppo tardi (I)
30-12-2015, 01:55cinemaPermalinkChe è una domanda veramente buona.
Io con un figlio di quattro anni e mezzo se non avessi avuto un paio d'ore alla settimana per il cinema sarei impazzito. Ecco dunque la lista dei film del 2015 che vi siete quasi sicuramente persi e ai quali invece vale la pena dare una chance - secondo me. Niente capolavori, ma quando non sapete cosa guardare, qui c'è del buono. In ordine più o meno sparso:
 Run all night (Jaume Collet-Serra, 2015)
Run all night (Jaume Collet-Serra, 2015)Negli ultimi anni Liam Neeson, già Oskar Schindler e Michael Collins, si è specializzato nel ruolo di 'superpadre che spacca il culo a chi rapisce i suoi figli', scoprendo una nicchia di mercato di tutto rispetto, facendo $ a palate nonché salvandosi dall'alcolismo e dalla depressione - Che vuoi di più? Run All Night è il quinto film del genere, quello che ha incassato meno ma forse anche il più classico - in sostanza è Un dollaro d'onore ambientato a New York tra la mala irlandese. Non sono un patito di questo genere di porno-per-padri, ma guardando Run All Night mi sono divertito parecchio, e se lo trovo una sera sul digitale probabilmente me lo rivedo da capo. In un anno senza western di rilievo, Run All Night fa la sua porca figura.
La regola del gioco (Kill the Messenger, Michael Cuesta, 2014).
Questo è un film che fa incazzare. Non soltanto perché racconta di come Reagan permise ai narcotrafficanti di finanziare i contras in Nicaragua spacciando crack nei ghetti delle metropoli americane; non solo per il modo in cui la più blasonata stampa USA isolò e affondò l'unico reporter che aveva avuto il coraggio di raccontare la storia; ma anche perché avrebbe dovuto essere un gran film e purtroppo non lo è. Onore a Jeremy Renner che ci ha messo i soldi e la faccia, perché era una storia che valeva davvero la pena di raccontare. Ma andava raccontata meglio.
C'è una minuscola percentuale di spettatori di Star Wars VII, che nel momento in cui Kylo Ren si toglie il casco, ha avuto un'illuminazione: il servo del Lato Oscuro della Forza è l'Hipster! Adam Drive in effetti nel 2015 aveva già prestato il volto a un'intelligenza oscura molto più inquietante di quella del nipotino di Darth Vader. While We're Young è il ritratto del Giovane Stronzo, un alieno che arriva dal nulla e si nutre dei ricordi della generazione precedente. È un film passato quasi inosservato, non solo da noi dove è arrivato nella stagione più morta. Avremmo dovuto guardarlo tutti, anche solo per il gusto di criticarlo. Parla di noi 40enni e del modo in cui stiamo invecchiando; dei berretti buffi che ci mettiamo in testa, della paura che ci fa l'artrite e della rabbia che ci fanno i giovani che si impossessano di tutto ciò che c'è di più sacro (ad es. Star Wars), e non c'è nulla che possiamo fare per evitarlo. (Continua...)
Chi ha ucciso Woody Allen
29-12-2015, 02:54cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, invecchiare, Woody AllenPermalink– Woody Allen ha ucciso qualcuno. Impossibile stabilire chi e perché. Un'amante che sapeva troppo, un ricattatore, un semplice passante che non doveva essere in un certo posto proprio in quel momento. Woody Allen ha pagato un sicario, oppure lo ha ucciso con le sue mani: e il rimorso lo tormenta da allora - ma non si costituirà mai. Però ce lo sta dicendo da più di vent'anni - Crimini e misfatti è del 1989, e a ben vedere sotto il travestimento è una confessione fatta e finita. Da allora è tornato sullo stesso soggetto quante volte? Settembre, Pallottole su Broadway, Match Point, Cassandra's Dream, e adesso Irrational Man: tutte variazioni sul tema. Come si fa a non notare l'ossessione, come si fa a non sentire il muto grido di dolore sepolto sotto il rassicurante tappeto di fotografia elegante e swing d'epoca? Woody Allen è un assassino. Oppure:
– Woody Allen è morto. Impossibile stabilire chi è stato e quando. Un'amante che sapeva troppo, un ricattatore, un semplice psicopatico che lo ha trovato in un certo posto nel momento sbagliato. Woody Allen ci ha lasciato da un pezzo, ma il piccolo carrozzone che ha messo assieme in più di quarant'anni di carriera, la sua piccola Disney per anziani, doveva in un qualche modo andare avanti. Un film all'anno, niente che il pubblico pagante non si aspetti già. All'inizio hanno usato qualche vecchio copione scartato. Poi hanno iniziato a scriverne di nuovi alla sua maniera. Ultimamente usano un software che riesce a simulare anche l'invecchiamento di Woody Allen, per cui per esempio il 'suo' ultimo film, Irrational Man, sembra veramente scritto da un ottuagenario molto preoccupato di farsi capire a spettatori altrettanto rintronati. Joaquin Phoenix è un insegnante di filosofia morale depresso e alcolizzato: lo si potrebbe indovinare dagli occhi disperati, dal pancino alcolico, ma anche dal fatto che tira continuamente fuori una fiaschetta di scotch (la offre anche alle studentesse in mezzo al campus), e dalla voce fuori campo che martella ogni due minuti. ERO DISPERATO. LA VITA NON AVEVA PIU' SENSO. INFATTI AVEVO VOGLIA DI MORIRE. DA UN PO' ERO ANCHE IMPOTENTE. VI AVEVO GIA' DETTO CHE ERO MOLTO DEPRESSO? Così per un'ora. Nel frattempo Emma Stone si innamora di lui. Lo si capisce dal modo in cui sgrana gli occhioni, dal fatto che accetti di passeggiare con lui in mezzo al campus, che lo inviti alle feste dei compagni e a casa dei genitori,, dalle scuse che racconta al suo ragazzo ufficiale, nonché da dialoghi del tipo OH PROFESSORE HAI CAPITO CHE MI SONO INNAMORATA DI TE? ORA TI FICCO LA LINGUA IN BOCCA FAMMI UN CENNO SE TI ARRIVA IL MESSAGGIO. Woody Allen, insomma, è morto. Questa almeno è la mia ipotesi preferita, ma ce ne sono anche altre.
– Woody Allen sta benone, (continuava su +eventi!) rilascia interviste lucidissime. Ultimamente ha compiuto 80 anni e un sacco di gente su facebook si è divertita a stilare la sua lista dei cinque film migliori. È un gioco che funziona con Allen meglio che con qualsiasi altro regista, perché chiunque ne sappia almeno un po', senza sforzo riesce a ricordarsi una ventina di titoli. Tanta prolificità ha anche il suo lato oscuro, e infatti a un certo punto per il puro istinto di distinguermi ho pubblicato la classifica dei film di Allen che mi erano piaciuti di meno. Se ci riflettete, ha molto più senso, perché nessuno ci ha fatto vedere tanti film mediocri come Woody Allen – qualsiasi altro autore, dopo un paio di mosse false lo avremmo abbandonato. Invece da lui siamo tornati anno dopo anno, sempre sperando di assistere al miracolo di un nuovo Harry a Pezzi, un nuovo Zelig. E ci siamo sciroppati Another Woman, Vicky Cristina Barcelona, Magic in the Moonlight, senza neanche lamentarci troppo.
In questo senso Woody Allen è un po' come Bob Dylan, che oltre ai suoi capolavori, è riuscito a venderci una discreta manciata di dischi talmente scadenti che nessun altro artista ci avrebbe potuto propinare senza perdere la sua credibilità: dischi così orrendi che li ricordiamo con affetto. Alla fine chi ascolta Dylan, o chi guarda un film di Allen, ha soprattutto voglia di ritrovare un vecchio amico – non importa quanto sia fuori forma. Woody Allen magari è in perfetta forma, ma a questo punto si preoccupa dell'inevitabile invecchiamento del suo pubblico. Si chiederà: ma che razza di rincoglioniti tornano in sala a vedere qualunque cosa io faccia? Meglio non rischiare, meglio l'usato sicuro: ancora Dostoevskij, ancora un Raskolnikov (pazienza se rischia di sembrare quel tipo di studentessa di un suo film, che di ogni autore conosceva solo una citazione a effetto). Il protagonista deve essere un misantropo disilluso. Forse è meglio ribadirlo ogni due o tre minuti, metti che qualcuno in sala si addormenti – ehi non è uno scherzo, fare film di Woody Allen è una scienza, magari si sono addormentati durante un focus group.
Il protagonista deve commettere un omicidio, perché da sempre questo è l'unico modo che hanno i personaggi di Allen di votarsi al Male – omicidi e al limite le corna, ma queste ultime da un pezzo sono state derubricate a peccato veniale. Tutto il resto non conta - ad esempio farsi corteggiare da una studentessa davanti a colleghi e compagni di lei, per Allen è un comportamento normalissimo, accettato anche da superiori e genitori: ed è anche l'indizio più forte del fatto che ci troviamo ancora nell'universo mentale dell'autore e vecchio satiro Woody Allen, e non in quello di un software in grado di produrre intrecci verosimili.
Come in Pallottole su Broadway ci dev'essere un artista irresponsabile, irrazionale, assassino, e un piccoloborghese che lo ammira ma non potrà seguirlo per la sua strada: non si tratta di una vera e propria scelta, semplicemente la via del Male (ma anche dell'Arte) non è per lui/lei. Rispetto a dieci o vent'anni fa, la novità di rilievo non è tanto la colonna sonora più blues, ma l'atteggiamento sempre più didascalico, ai limiti dell'autoparodia. La trama che occupava una mezz'oretta di Crimini e Misfatti è dilatata sui novanta minuti. Allen può lavorare con gli attori migliori sulla piazza, e quello che vuole da loro ormai è che vestano una specie di costume kabuki e continuino a ripetere al centro della scena: SONO DISPERATO. VOGLIO MORIRE. TUTTO È ASSURDO. MA SE AMMAZZO QUALCUNO LA MIA VITA CAMBIA. AMMAZZO QUALCUNO. ECCO LA MIA VITA È CAMBIATA. SONO FELICE. HO FAME, RIESCO ANCHE A SCOPARE. Il risultato è un prodotto che oltre a funzionare in sala – ma in sala ormai ci andremmo in ogni caso – avrà un senso anche sul digitale terrestre tra un annetto o due, al pomeriggio, mentre stiriamo o diamo la polvere: quelle fiction che riesci a seguire anche se guardi una scena ogni tre.
Woody Allen a ottant'anni ci conosce meglio di noi stessi: ha capito che cominciamo a perdere colpi e si sta adeguando. Continua a macinare film che nessun altro sa fare, e che forse a nessun altro perdoneremmo. D'altro canto prima o poi ci regalerà qualche altra perla, anche solo un Whatever Works. Nel frattempo Irrational Man è al Cityplex di Alba (21:10), al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (15:10, 17:20, 20:10, 22:20), al Baretti di Mondovì (21:00) e al Cinecittà di Savigliano (22:30). Prego notare che è alla terza settimana di permanenza in sala; ed è quella tra Natale e Capodanno. Whatever works.
Un uomo serio a Berlino
24-12-2015, 19:39cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, memoria del 900Permalink |
| Sembra che a Berlino stiano costruendo una specie di... muro. |
Rudolf Abel - ovviamente non si chiamava così - imparò a dipingere in America. Il mestiere del pittore era la copertura ideale per una spia: quando sei un artista, nessuno fa caso ai tuoi orari o ai tuoi itinerari. Puoi sparire per mesi e nessuno si preoccupa. Ma anche se resti fermo nello stesso posto per ore e ore, nessuno si porrà il problema: basta che davanti hai un cavalletto. Abel non era un pittore, ma non è che avesse molto altro da fare nei suoi lunghi pomeriggi en plein air o nella sua base segreta camuffata da atelier. Durante la guerra era stato un elemento prezioso, ma negli anni Cinquanta, a New York, l'impressione è che tirasse a campare: dopo l'esecuzione dei Rosenberg, gran parte dei suoi contatti erano bruciati. In più il KGB gli aveva procurato un compare inaffidabile, un finlandese che si scordava in giro i microfilm e col vizio peggiore che una spia possa avere, l'alcool.
 |
| Il nemico ti ascolta. |
A volte Spielberg sembra voler estrarre il cuore pulsante dell'America, altre volte sezionarne il sistema nervoso. Quello che ci conquista è il fatto che sia impossibile capirlo prima di dare un'occhiata: gli basta passare da una storia all'altra per oscillare allegramente dal pacifismo alla paranoia. L'autore che più di tutti ha amato gli alieni e ci ha invitato ad accoglierli a braccia aperte, è anche quello che ce li ha mostrati più spietati e assetati di sangue. Potrebbe essere interessante cercare di organizzare i suoi film in coppie antitetiche, ad esempio: Incontri ravvicinati come un anti-Squalo, La guerra dei mondi un anti-ET. Il soldato Ryan un anti-1940, The Terminal un anti-Prova a prendermi. Per certi versi Lincoln si presentava come una specie di Schindler allo specchio: le malefatte di un presidente eroico contro le opere di bene di un nazista profittatore.
 |
Star Wars 7, la recensione che non cede al lato spoiler
16-12-2015, 15:13cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, futurismiPermalinkÈ un grande potere quello sento in me, ora. Saprò usarlo al meglio? Saprò scrivere una recensione senza danneggiarvi, senza farvi venire neanche il sospetto che il nuovo xxxxxxxxxxxxx e il xxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxx, e che alla fine xxxxxxxxxxxxx si xxxxxxxxxx per xxxxxxxxxxxxxxx?
È così difficile, Maestro!
Oh come potrei approfittarne.
Star Wars VII: il risveglio della Forza, (J. J. Abrams, 2015)
 Sento il Potere, ma sento anche la Paura. Forse non sono l'uomo adatto. Sono salito in questa cosa quando ero appena un giovanetto. Non capivo nulla di intreccio e di suspense, di montaggio men che meno, non capivo nulla di cinema e forse mai lo capirò. Volevo solo scappare dal mio pianeta di rottami, volevo vedere lo spazio. Ancora non sapevo quanto potesse essere freddo e avvilente, certe volte. Mi hanno detto un arnese in mano, tie', datti da fare. Spara ai film brutti e difendi quelli belli, inoltre da qualche parte c'è una principessa da salvare, un mega-cannone che ha sempre un minuscolo punto debole, e non scordarti che estetica ed etica sono gemelle dello stesso seme.
Sento il Potere, ma sento anche la Paura. Forse non sono l'uomo adatto. Sono salito in questa cosa quando ero appena un giovanetto. Non capivo nulla di intreccio e di suspense, di montaggio men che meno, non capivo nulla di cinema e forse mai lo capirò. Volevo solo scappare dal mio pianeta di rottami, volevo vedere lo spazio. Ancora non sapevo quanto potesse essere freddo e avvilente, certe volte. Mi hanno detto un arnese in mano, tie', datti da fare. Spara ai film brutti e difendi quelli belli, inoltre da qualche parte c'è una principessa da salvare, un mega-cannone che ha sempre un minuscolo punto debole, e non scordarti che estetica ed etica sono gemelle dello stesso seme."Estetica e cosa?"
"Lascia perdere. Spara ai brutti. Io ti copro".
Trent'anni più tardi eccomi qui, Recensore della Grande Provincia di Cuneo. C'è senz'altro in me un briciolo di grandezza - ma c'è anche tanta meschinità, tanta invidia - ed ecco che all'improvviso precipita da queste parti un droide con un biglietto per la prima proiezione di Episodio VII. Che cosa devo fare maestro?
Chiudi gli occhi.
Ma così non si vede un...
È un modo di dire, idiota. Immagina il respiro dei tuoi lettori. Domandati: cosa vogliono da te? Vogliono sapere che alla fine xxxxxxxxxxxxxxxxx è xxxxxxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxx? O vogliono sapere soltanto se è una bella storia che vale la pena.

Che importa? Tanto ci andranno lo stesso.
Non cedere.
Massì, chissenefrega, è Star Wars, potrebbero riempire interi film di dialoghi di soap e mostri di gomma e la gente riempirebbe le sale lo stesso, con le loro spade colorate da minchioni. Non ha senso farli belli, questi film. Questa gente non si merita niente.
Non cedere al lato oscuro.
Poi certo, la Disney per togliere Star Wars al suo oscuro padrone si è svenata, è ovvio che deve recuperare presto l'investimento. Un film all'anno e pedalare. Dove c'erano solo rottami nel deserto arriveranno i centri commerciali, apriranno i discount. J. J. Abrams non fa prigionieri.
Ma ha fatto un brutto film?
(Continua su +eventi!)
Veri detective (in Andalusia)
13-12-2015, 15:36cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkIl franchismo è finito, la palude è rimasta. In paese ogni tanto qualche ragazza scompare, è normale: qui a parte la vendemmia e il contrabbando non c'è niente. Nessuno ne parla volentieri. Ogni tanto qualche ragazza ricompare, a pezzi, riaffiorando dalla laguna. Anche di questo nessuno parla.
Chi è già in crisi d'astinenza da True Detective potrà trovare un efficace placebo in La isla mínima, un thriller arrivato nelle sale spagnole l'anno scorso, che non fa nessun vero sforzo di sottrarsi al paragone con la serie americana uscita sei mesi prima. Persino i baffi del protagonista - l'accigliato Raúl Arévalo, un ispettore naturalmente in rotta di collisione coi superiori - sembrano ricalcati su quelli che si fa crescere Rust Cohle. Invece il suo collega (meno idealista e più praticone, ovviamente) è uno Javier Gutiérrez un po' troppo in forma per sembrare davvero un ex boia franchista cirrotico che cura i rimorsi e l'insonnia con l'alcool.
Il vero protagonista in questi casi è la cornice... (continua su +eventi!) quella foce del Guadalquivir che soffoca nei suoi miasmi tutto il pittoresco che ci aspettiamo dall'Andalusia. Le case coloniche abbandonate, le ville in mezzo al niente; il labirinto dei canali e delle strade sterrate su cui Seat e Diane si sfidano a sorpassare vecchi trattori. Tutto questo - se lo sai fotografare - funziona benissimo e costa anche poco. Ispirandosi a un reportage del fotografo Atín Aya, il regista ha fatto incetta di premi in patria, creando persino un'attrazione turistica: nei mesi successivi la regione andalusa ha creato una "Ruta Isla mínima", che porta nei luoghi del film.
Come fate a cascarci con Shyamalan?
09-12-2015, 15:39cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink |
| Uno di quei film in cui i ragazzini non spengono la videocamera neanche se i mostri se li mangiano? Sì, però fatto bene. |
Del resto è un film di M. Night Shyamalan, che dopo alcuni disastri produttivi si è ritrovato retrocesso nella serie B dei film horror a basso budget, in quella che però è la situazione più congeniale al suo cinema: senza più i divi capricciosi che gli hanno commissionato After Earth, senza effetti speciali, chiuso in una casa di campagna con due macchine finto-amatoriali, l'ex maestro del suspense contemporaneo dovrebbe riuscire a mostrare le sue vere qualità. Ce la farà?
Dei tanti modi in cui si possono dividere gli esseri umani, e in particolare gli spettatori al cinema, uno mi sembra più indicativo degli altri e riguarda M. Night Shyamalan. Vi sono infatti due gruppi: quelli che ultimamente erano molto delusi, ma che apprezzarono molto i suoi primi film, talvolta acclamandolo come un maestro e un innovatore del genere thriller, se non proprio il nuovo Hitchcock - e quelli che dopo cinque minuti avevano capito che Bruce Willis è un fantasma.
Insomma, in quel film nessun adulto gli rivolgeva la parola. Nessun adulto. Come fa uno a non accorgersene?
Io ai tempi mi arrabbiavo pure perché insomma - quando appartieni a quel gruppo di persone, tu rifiuti l'idea che il mondo si divida in due gruppi di persone. No, tu credi che ci sia solo un gruppo giusto - ovvero quelli che hanno gli occhi collegati al cervello - e che quelli che appartengono all'altro gruppo devano essere rieducati. E non importa se si intendono di cinema, ci dev'essere un equivoco perché come si fa a intendersi di cinema quando non ti accorgi nemmeno che Bruce Willis è un fantasma? Come fai a goderti un film se hai capito come va a finire dopo cinque minuti? Devi veramente avere voglia di cascarci (continua su +eventi!)
Col tempo ho capito che è davvero così. Chi ama il cinema è animato soprattutto da una grandissima Voglia di Cascarci. È quella magia che unisce tutti i cinefili, sia quelli dei Cahiers che hanno appena votato Mia Madre film dell'anno (sembra una presa in giro), sia quelli che stanno cambiando le pile alle loro spade laser per la prima di Star Wars VII. Se non hai Voglia di Cascarci, non riuscirai mai a prendere sul serio certe cose. Potrai studiare tanto ma non diventerai mai un cinefilo. Per esempio, se non hai Voglia di Cascarci, anche quest'ultimo film di M. Night Shyamalan ti lascerà freddo. Probabilmente anche questa volta dopo cinque minuti avrai già capito esattamente cosa non va nella situazione; tutti quei particolari dissonanti che dovrebbero metterti a disagio, li troverai piuttosto prevedibili (anche se qualche geniale traduttore ha deciso di rendere "rumours about the hospital" con "pettegolezzi dell'ospedale". Pettegolezzi).
Se non hai paura, che dinosauro sei
01-12-2015, 11:47animazione, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink"Colleghi, se siamo d'accordo direi che il coffee-break è finito".
"Non era la pausa pranzo?"
"Onestamente non saprei, che ora è?"
"Che ne so, il mio Rolex non ha i numeri... Pippo, tu lo sai che ore sono?"
"....ch.... ....ch"
"Ti è andato di nuovo di traverso il tovagliolo della brioche?"
".....ch"
"C'è per caso un dottore tra noi?"
"Io ho una laurea in scienze politiche".
"Vabbe' ma che c'entra".
"Stai mettendo in dubbio i miei titoli? Credi che io non sia qualificato per fare questo lavoro?"
"Già, a proposito, tu ti ricordi noi che lavoro facciamo?"
"Vagamente. Qui c'è scritto che siamo la Commissione Titoli".
"Ah. Cioè?"
"Siamo quelli che cambiano i titoli dei film stranieri, per renderli più appetibili al pubblico italiano".
"Giusto! Siamo quelli che convincono gli italiani ad andare in sala a vedere i film".
"Senza di noi non ci sarebbe più un cinema aperto in tutta Italia, colleghi! Non c'è bisogno di sottolineare quanto sia fondamentale il nostro..."
".....ch.......ch"
"Vabbe' ma è impossibile lavorare così. Me lo portate fuori per favore? Grazie. Stavamo dicendo?"
"Dunque, qui c'è un film della Pixar..."
"Quelli che fanno i cartoni per gli intellettuali, uhm... se riuscissimo a portarci anche le famiglie coi bambini, faremmo il botto. In originale come si chiama?"
"The Good Dinosaur".
"Sarebbe a dire?"
"Secondo la commissione traduttori il titolo significherebbe, approssimativamente... Il dinosauro buono".
"Ma allora è un film di dinosauri".
"Però c'è chi sostiene che invece significhi Il buon dinosauro".
"Vanno un sacco, i dinosauri".
"Sono sempre andati forte, ma quest'anno più del solito".
"Va bene colleghi. Il buon dinosauro o il dinosauro buono? C'è un po' di differenza, mi pare".
"Scusate, io ho un'idea".
"Spara".
"E perché dovrei sparare?"
"È un modo di dire".
"Non lo conoscevo".
"Ci vuoi dire la tua idea?"
"Ah già. Perché non togliamo la parola "dinosauro" dal titolo?"
"Cioè in un anno in cui i film di dinosauri stanno facendo milioni di dollari di incassi in tutto il mondo, tu proponi di togliere la parola "dinosauro" dalla locandina di un cartone animato".
"Proprio così".
"E saresti in grado di spiegarci il motivo?"
"No, credo di non essere in grado".
"Credi di non essere in grado?"
"Sono fatto così, a volte mi arriva un'idea... è come una lampadina che si accende, non so che farci, secondo me togliere "dinosauro" dal titolo è un'ottima idea".
"E al suo posto cosa ci mettiamo?"
"E che ne so, come si chiama il protagonista?"
"Arlo".
"E che vuol dire?"
"Non ne ho la minima idea".
"È un nome poco diffuso".
"Potremmo chiamarlo il viaggio di Arlo, per incuriosire lo spettatore".
"Soprattutto i bambini, che ricordiamo, sono il target".
"Cioè per incuriosire i bambini tu proponi di togliere "dinosauro" e mettere "Arlo"".
"Proprio così".
"E non sei in grado di spiegare il perché".
"No".
"Vieni qui, togliti il dito dal naso e fatti abbracciare".
"Eh, perché?"
"Perché sei un genio, un fottuto genio. Il viaggio di Arlo. Dio mio, ho i brividi. Sento che farà il botto. Il botto. Siete d'accordo? Allora direi che a questo punto possiamo fare la pausa per il pranzo".
"Ma non l'abbiamo già fatta?"
"Non lo so. Il viaggio di Arlo. Senti come suona bene. Il viaggio di Arlo. Ragazzi, vi immaginate se non ci fossimo noi a salvare il cinema?"
 |
| Un giocattolo di gomma in un mondo vero, freddo spinoso e tagliente. |
Il viaggio di Arlo (The Good Dinosaur, Peter Sohn, 2015)
Arlo è un dinosauro buono; non farebbe male a una mosca, tanto più che è vegetariano. Arlo non è un buon dinosauro: ha troppa paura. Fuori dal guscio, oltre il recinto della fattoria, c'è solo violenza, frane, diluvi, tempeste, e ovunque denti aguzzi e artigli appuntiti. Nell'anno del trionfo di Inside Out, a un mese da Natale arriva nelle sale un altro film della Pixar, che quasi sembra voler passare inosservato, come se si vergognasse di cavalcare la moda meno originale di tutte, quella ricorrente dei dinosauri. Nei trailer il protagonista è simpatico, sembra già il pupazzo di gomma che senz'altro andrà a ruba a Natale. Ha anche un cucciolo d'uomo per amico. Risultato: al giovedì pomeriggio la sala si riempie di bambini un po' più piccoli del solito; le luci si spengono e dopo un po' sullo schermo appare...
...il film più violento della storia della Pixar.
 |
| Ragazzino, se mi stai prendendo in giro... |
C'è quasi subito un lutto, raffigurato con un realismo brutale. A quel punto chiunque altro piazzerebbe una scena madre coi superstiti in lacrime; qui no, si volta subito pagina, la vita va avanti. (continua su +eventi!) Ma l'elaborazione del lutto è solo rimandata: lo spettatore adulto può intuire che sarà il tema di tutto il film, ma non può farci niente, ormai la trappola è scattata. Il lutto diventerà un trauma, e poi il trauma andrà superato, e i lacrimoni arriveranno come sempre a tradimento.
Dopotutto chissà che succederà da qui a vent'anni.
Alluvioni, carestie, non si sa mai.
Forse la Pixar ci sta preparando.
Buona visione e non abbiate paura, anzi no.
Colpo grosso in provincia di Barletta
23-11-2015, 12:38cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkTrani è in subbuglio, corre voce che il Grande Regista TV sia scontento. Sta scegliendo le location, le comparse, il catering. L'anno prima Barletta ospitò una fiction e il turismo registrò il 200% - insomma è un'occasione da non mancare. Il sindaco gli sta pagando l'albergo, frantoi e viticoltori litigano per invitare il Grande Regista a pranzo, persino la camorra locale ha da piazzare il suo raccomandato. E allora cosa c'è che non va? Forse che la città non è fotogenica abbastanza? "No, Trani è bella", dice. "Ma non so se funziona per l'action".
Il Grande Regista, in realtà, è un piccolo truffatore. Ma il colpo che mette in scena a Trani è talmente verosimile che una volta tornato a casa mi sono messo a cercarlo su google: "falso regista fiction". Per ora ho trovato solo un tizio che a Brindisi convinceva delle tizie a spogliarsi per dei falsi provini, una cosa abbastanza deprimente. Invece le avventure di Edoardo Leo e Marco Giallini nella ridente località pugliese sono l'episodio più scoppiettante del film - e anche quello più rivelatore. Se ogni film è una truffa, un film di truffe è sempre un gioco di specchi: non sei mai sicuro di ciò che stai guardando. È un buon film di truffe inverosimili, o è un film inverosimile e basta? Le ragazze che suonano in playback a un concerto rock stanno recitando male o stanno recitando bene la parte di chi suona per finta?
Alla fine ho deciso che lo compro - e se i registi mi hanno fregato, peggio per me (continua su +eventi!) Anche se lavorano nel cinema da una vita, Loro chi? è il loro primo vero lungometraggio; gli unici difetti che mi sembra di notare sono quelli che lamentava il Grande Regista TV a proposito di Trani: belle cartoline, ma l'action? Non puoi fare un film di truffe senza piazzarne almeno un po'. Inseguimenti, conflitti a fuoco: l'unica strada è girarli inverosimili e poi rivelare che erano falsi, tutta una truffa appunto. Pazienza se un film distribuito dalla Warner in più di 300 sale sembrerà un prodotto a basso budget.
Quel che funziona meglio in Loro chi? è il ritmo, che dopo una partenza indiavolata riesce a contenere le inevitabili cadute. Da Roma a Trento a Trani, poi di nuovo a Trento, Leo e Giallini si spostano da un set all'altro come in un film di spionaggio. Le stangate diventano via via più improbabili, ma ci si diverte. Bonifacci si conferma come uno degli sceneggiatori più interessanti in circolazione, anche solo per il coraggio con cui si allontana dai temi e dai luoghi più frequentati della commedia italiana.
E sì, Trento e Trani sono più cinematografiche di quel che ci aspettavamo.
Uno di questi week end, quasi quasi...
Divorzio all'israeliana
16-11-2015, 13:14cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, ebraismo, famigliePermalink
Viviane (Gett: Le procès de Viviane Amsalem, Ronit e Shlomi Elkabetz, 2013)
In Israele sposarsi è più difficile di quanto sembra: il matrimonio civile non è previsto. Il divorzio, poi, se sei membro di una comunità più osservante di altre, può essere quasi impossibile. Viviane vive separata dal marito da anni, in una dépendance nel cortile di casa. La vita col marito è impossibile, ma lui non vuole concedere il divorzio e la corte di rabbini a cui Viviane si rivolge non può costringerlo. La causa di separazione si trascinerà per più di cinque anni.
 |
| Simon Abkarian è una misuratissima, sublime faccia da schiaffi. |
Siccome il tribunale è veramente piccolo e dimesso, è impossibile non pensare agli spazi ancora più sacrificati del palazzo di giustizia iraniano di Una separazione, il grande film di Asghar Farhadi (continua su +eventi!) Lì per lì il paragone sembra impietoso: Farhadi è molto più sfumato, riesce a distribuire torti e ragioni con equilibrio acrobatico, mira più in altro della semplice denuncia: vuole mostrarci quanto è complessa la realtà e quanto è difficile raccontarla... anche perché Farhadi in Iran probabilmente un semplice film di denuncia non potrebbe farlo. Questa necessità di mirare un po' più in alto, o almeno un po' più a lato, che è una nota costante di tanto cinema iraniano, lo ha reso un po' più universale e commerciabile all'estero, ma ne ha senz'altro smussato i toni. In Israele invece ai fratelli Elkabetz era consentito mirare a qualcosa di concreto e ne hanno approfittato, costruendo un film che in patria ha creato un dibattito intenso su un argomento scottante, ma che al pubblico italiano non risulterà altrettanto interessante (peraltro i nostri tribunali civili riescono a essere lentissimi anche senza l'ausilio dei rabbini).
La delocalizzazione è un film già visto, davvero
10-11-2015, 11:32cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink |
| Me ne sto qui impalato, faccio finta di lavorare, magari a Cannes mi danno una palma. |
"C'è questa offerta che potrebbe interessarti".
"M'interessa di sicuro".
"C'è un regista che cerca un cinquantenne che abbia perso il lavoro a causa di una delocalizzazione".
"Non m'interessa più".
"Guarda che paga bene".
"Grazie, non sono disperato".
"Ma..."
"Non così tanto disperato, perlomeno".
"Guarda che non devi imparare a recitare, vuole solo seguirti con la cinepresa mentre..."
"...mentre cerco lavoro, mentre non trovo lavoro, mentre incontro gli ex colleghi e non andiamo d'accordo, quando vado in banca a chiedere un prestito, credi che non lo sappia? L'ho già visto un film così. L'hanno visto tutti un film così".
 |
| Uno spettatore si è addormentato in seconda fila, che faccio? |
"Lasciami indovinare. Alla fine trovo un lavoro ma per superare il periodo di prova devo far perdere il posto a qualcun altro, non è vero? Cioè è il film dei Dardenne dell'anno scorso, in pratica".
"Ma non è proprio come quello dei Dardenne, perché..."
"Mi aggiungono anche una sfiga peculiare? Qualcosa che mi dia uno spessore diverso? La tizia dei Dardenne soffriva di depressione, a me che sfiga affibbieranno?"
"Vorrebbero abbinarti un figlio, ehm..."
"Un figlio?"
"Handicappato".
"Ah però".
"Embè? Hai qualcosa contro gli handicappati?"
"Sì, quando servono a ricattare gli spettatori".
"Senti, non so se ti rendi conto della fortuna... non devi recitare. Devi soltanto vivere le tue giornate noiose mentre un tizio le riprende da qualche metro di distanza. Come un reality".
"La mia vita non è noiosa!"
"Ah no?"
(Continua su +eventi!)
"Ho un sacco di cose da fare dalla mattina alla sera! Inseguo il lavoro ovunque, giro per le corsie dei supermercati scartando le offerte speciali farlocche, la sera vado a ballare con mia moglie..."
Litigare con don Pasolini
08-11-2015, 09:29cinema, italianistica, PasoliniPermalinkAlla fine poi che colpa ne ha avuto lui. In qualsiasi altro periodo storico avrebbe trovato la sua nicchia abbastanza presto, e invece a causa di una guerra mondiale e altri equivoci si è ritrovato in una sezione bolognese del PCI invece che in seminario. Che prete ci siamo persi, ma soprattutto che vita da prelato si è perso lui. La sua passione per le dispute dottrinali gli avrebbe ispirato dotte dissertazioni teologiche che lo avrebbero reso uno dei protagonisti del concilio - vuoi mettere anche solo per un attimo, tra litigare coi lefebvriani o col Gruppo '63? Nel frattempo avrebbe potuto cullare la sua sensibilità decadente coltivando la poesia, la scrittura, l'arte, senza la necessità di impastoiarle con categorie marxiste che non c'entravano poi parecchio. Le periferie sottoproletarie, le avrebbe potute frequentare con molta più libertà, nessuno ci avrebbe avuto niente da ridire - son cose che a Roma si fanno da secoli e chi siamo noi per giudicare un alto prelato, un benefattore. Le sue naturali pulsioni avrebbero trovato molta più tolleranza in Curia che in certe sezioni di partito un po' retrograde. Le sue inchieste sulla sessualità degli italiani le avrebbe potuto condurre in modo assai più capillare nel confessionale. Nel frattempo avrebbe saputo diluire in comode omelie settimanali il suo presentimento dell'apocalisse, del genocidio culturale, della massificazione indotta dalla tv, dalla legalizzazione dell'aborto, dalle maschere di Halloween, le lucciole! cosa hanno fatto alle lucciole! Persino in Africa avrebbe più convenientemente potuto andarci da missionario; che prete sarebbe stato Pietro Paolo Pasolini, e invece gli è andata così. Eppure chi ancora si inginocchia al suo santino è sempre di un prete che sembra aver bisogno, uno che ti faccia le predica sulle false lusinghe della modernità, sul vuoto dei valori, uno che ti dica "io so", anche se non è chiaro come faccia a saperlo - ma già, il confessionale - in ogni caso i preti sanno sempre tutto, bisogna stare attenti, perché verrà un giorno... Don Pasolini, così come fra Lindo Ferretti, è uno di quei personaggi che in Italia abbiamo sempre avuto, forse addirittura il frutto dell'evoluzione, dell'adattamento a un certo tipo di ambiente; la novità è che seminari e conventi sono meno diffusi di una volta e così a gente che sembra nata per spiegarti il mondo da un pulpito capita di ritrovarsi scrittore, regista, cantante, comico, e non se la cavano neanche così male in verità. Sempre però un po' predicatori, se ci fai l'orecchio.
Per dire che Muccino un po' lo capisco.
Però poi ogni volta che vedo qualcuno cedere al mio stesso impulso, e di attaccare una tirata antipasoliniana, mi rendo conto che è vittima di un equivoco, se non di tanti. Ad esempio vedo in giro roba del genere.
E ci rido pure sopra, però intanto penso: ma uno che ha scritto una battuta del genere, l'avrà mai davvero sentito parlare, avrà letto qualcosa di Pietro Paolo Pasolini? Non solo il fatto che in realtà un film come Ricordati di me gli sarebbe davvero potuto piacere; una volta assorbito lo choc di un ritmo action che ai suoi tempi non esisteva nemmeno nei film di 007, figurati in un prodotto cosiddetto intimista, credo che avrebbe potuto vederci una conferma delle sue tesi sul vuoto della neoborghesia. Ma lasciamo stare: come fai a immaginare Pasolini che risponde "mi pulisco il culo"?
Se hai anche solo aperto a caso le Lettere Luterane, se hai ascoltato distrattamente la voce del corvo di Uccellacci e Uccellini, come fai? Ma neanche in una vignetta. Te lo immagini, boh, Hitchcock che dice la stessa cosa in una vignetta? Moravia? Viene il sospetto che nel modellare il feticcio PPP le giacche di pelle abbiano avuto più peso delle pagine di Empirismo Eretico dove Pasolini si permetteva eleganti frecciatine sul prognatismo di Sanguineti, ma non avrebbe mai usato il sintagma "pulisco il culo".
Forse funziona così: oggi la gente in giacca di pelle che va in tv a parlare di qualsiasi cosa è, boh, Scanzi? E così ci immaginiamo che Pasolini sia stato uno Scanzi dei suoi tempi; che di fronte a una provocazione si sarebbe comportato come lui: fanculo, stronzi, ecc. Di solito quando parliamo di lui non abbiamo la minima idea di quello di cui stiamo parlando. Anche quando lo citiamo, lo fraintendiamo; lui poi perlopiù parlava in una lingua che abbiamo messo via, il marxismo; una lingua che maneggiava un po' disinvolto, se non proprio alla carlona, perché gli era capitato di esser marxista per accidente, era semplicemente il clima culturale in cui era nato e aveva imparato a discutere - e di discutere aveva una gran voglia e un gran bisogno e non solo coi sottoproletari: anche e soprattutto coi suoi pari, intellettuali, artisti. Lui poi era convinto che i sottoproletari stessero per scomparire, parlava di genocidio, non si vergognava di scomodare Hitler per un po' di speculazione edilizia - ma non aveva previsto che anche il suo milieu culturale si sarebbe prosciugato nel giro di due decenni, al punto che oggi non c'è uno che mentre ti cita Pasolini ti dia la sensazione di aver capito quello che stava dicendo. Equivocano tutti, un po' perché devono tirare acqua al loro mulino (lui stava dalla parte dei poliziotti! Non è vero stava coi pankabbestia!), un po' perché davvero, leggerlo è troppo sbattimento.
Poi se la prendono con Muccino. Lui almeno ha una tesi: una volta il cinema italiano era un'industria, poi c'è stata una crisi strutturale, non sarà stato per caso Pasolini? Secondo me no, Pasolini in certi casi faceva un cinema di nicchia, "di poesia", insomma era un autore nel senso che la parola aveva già in quegli anni; in altri casi stava sperimentando soluzioni che oltre ad avere un successo immediato (il Decameron), aprivano le porte a nuovi linguaggi che sarebbero diventati di massa: in sostanza stava aprendo le porte al porno, col vecchissimo alibi dell'esotismo medioevale o terzomondista (da questo punto di vista certi stilemi amatoriali hanno un senso che Pasolini non vedeva e Muccino non coglie; il motivo per cui a lui piacevano gli attori non professionisti in pose discinte è simile a quello per cui noi digitiamo "amatoriale" in determinati siti). Però sia quando faceva Teorema per il pubblico dei festival, sia quando girava i Racconti di Canterbury - e in giro c'era una tale fame di nudità medievali che in sala era già uscito un seguito apocrifo al Decamerone - Pasolini era perfettamente organico all'industria cinematografica in cui lavorava - molto più di quanto se ne rendesse conto. Quando se n'è reso conto si è molto arrabbiato. Poi quell'industria è crollata per altri motivi - banalmente, la tv - e oggi non riusciamo nemmeno a capire che Teorema era pensato per un certo pubblico e Canterbury per un altro. Sono due film talmente diversi da quelli che vediamo nelle sale, che potrebbero averli girati i Lumière o Giotto di Bondone. È roba strana, da intellettuali. Niente che valga la pena rivedere - finché Muccino non ne parla male, allora guai a chi ce la tocca.
"Ma hai finito con l'aspirapolvere?"
"Perché?"
"È la seconda volta che lo passi in cucina".
"Scusa, ero sovrappensiero".
"Con chi stai litigando stavolta?"
"Con nessuno".
Muccino e la Pasoliniexploitation
05-11-2015, 02:58cinema, film italiani bruttini, italianistica, PasoliniPermalinkQuel che è successo poi potrebbe persino far storia: un'intera nazione di appassionati di cinema si è scossa dal torpore ipnotico dei trailer di Star Wars rallentati alla ricerca di qualche dettaglio rivelatore sul destino di Jar Jar Binks, e si è stretta intorno al suo maestro e ispiratore, il geniale cineasta Pietro Paolo Pasolini. A quarant'anni dalla sua scomparsa (e dalla distribuzione di Salò), l'amore del pubblico per il suo beniamino è tale che l'account facebook di Muccino sembra essere stato sospeso per eccesso di insulti. E io ho scoperto di vivere nell'universo dei miei sogni, dove le piattaforme sociali non servono per litigare sugli spintoni tra Valentino Rossi e Marquez, ma per dibattiti sull'estetica, perdio, sulla tecnica cinematografica! Vi rendete conto, possono bannarci mentre litighiamo sull'uso del carrello o del controcampo.
Ok, proviamoci.
Però facciamo finta di saperne qualcosa per favore - cioè davvero, potete avere mille motivi per odiare Muccino, ma per difendere Pasolini dovreste almeno aver visto un film suo. Sennò come potete essere sicuri che non ci abbia azzeccato? Definire Pasolini amatoriale non è cosa campata così in aria. Il suo primo approccio diretto con la macchina da presa fu abbastanza garibaldino. Era già uno scrittore affermato, aveva collaborato con Fellini, quest'ultimo intuisce del potenziale e gli propone di produrre Accattone - ma quando vede i primi tentativi blocca tutto, erano inguardabili. Pasolini comincia così, saltando a piedi pari tutto l'apprendistato del regista (anche se può contare da subito su un collaboratore preparato come Bernardo Bertolucci). E potendo contare sulla sua reputazione extracinematografica - tanto che quando alla fine Accattone arriva a Venezia, viene contestato da gruppi di estrema destra che gettano inchiostro sullo schermo. È appena il 1961: gli anni di piombo molto in là da venire; Pasolini è già in qualche modo un personaggio che attira l'attenzione qualsiasi cosa dica o faccia.
È interessante che nel suo primo comunicato antipasoliniano (poi prontamente cancellato da facebook), Muccino raccontasse di aver cominciato a detestarlo molto presto - è così che funziona, no? Se ti piace Pasolini (o Kubrick, o i Vanzina) te ne accorgi a 16 anni. Il resto della vita ti serve a trovare i motivi, le giustificazioni, le pezze d'appoggio. Muccino - chi sa un po' di cinema non ha nessuna difficoltà ad ammetterlo - è uno dei registi italiani più dotati della sua generazione, che è anche il motivo per cui in questo momento twitta dalla California. È facile risolvere la questione tracciando una retta: da una parte l'approccio amatoriale di Pasolini, che con scarsa o nulla conoscenza del mezzo riesce comunque a mettere in scena un'opera prima apprezzata in tutto il mondo; dall'altra la professionalità di Muccino, il campioncino nazionale dei carrelli circolari. Facile, no? Già, troppo facile.
Perché è vero anche il contrario: Pasolini arriva in regia sapendone poco o nulla, ma è determinato a fare del cinema la sua dimensione - tanto che si mette molto presto a teorizzare di semiotiche e di cinémi - quanto a Muccino, avrà fatto i suoi compiti, ma il modo in cui liquida Pasolini dimostra una scarsa conoscenza della storia del cinema italiano.
 |
| L'eredità di Pasolini. |
Ricapitolando: da una parte il cinema contemporaneo, professionale ma del tutto inconsapevole della storia che ha alle spalle. Un cinema senza tempo e senza luogo, che potrebbe farsi dovunque e infatti si fa in California. Dall'altra la visceralità di Pasolini, ma anche lo strutturalismo di Pasolini. L'ingenuità, ma anche la Cultura con la C. Il sottoproletariato urbano, ma anche l'intellettuale organico e/o declassato. Tutto quello che ci siamo lasciati alle spalle nel Novecento, dopo quella famosa frattura antropologica. Ma non è ancora troppo facile, così?
È da ieri che cerco ovunque un'intervista che sono sicuro di aver visto, una mattina, a un "montatore di Pasolini" (Nino Baragli?) Ormai mi sono convinto che sia in questa teca rai che non si riesce ad aprire. Mi ricordo questo signore mentre spiega in romanesco come si montava ai suoi tempi, con lo sputo: cioè prima di incollare i pezzi di pellicola con l'acetone, in un primo momento era sufficiente applicare un po' di saliva. E poi quando spiega che i raccordi di Pasolini li faceva un po' diversi da quelli degli altri film, perché sembrassero strani, perché sembrassero 'artistici': gli spettatori dovevano avere la sensazione di trovarsi di fronte all'opera sofisticata del poeta Pasolini, mica, chessò, la robaccia di Sergio Leone. L'artigiano della cabina di montaggio aveva perfettamente introiettato gli stilemi di quel Cinema di Poesia che secondo Pasolini stava sorgendo "contemporaneamente in tutte le cinematografie mondiali" ("l'alternarsi di obbiettivi diversi, un 25 o un 300 sulla stessa faccia, lo sperpero dello zum, coi suoi obiettivi altissimi, che stanno addosso alle cose dilatandole come pani troppo lievitati, i controluce continui e fintamente casuali con i loro barbagli in macchina, i movimenti di macchina a mano, le carrellate espressive, gli attacchi irritanti, le immobilità interminabili su una stessa immagine ecc. ecc.") (Il cinema di poesia, in Empirismo eretico).
Quando vidi per la prima volta il Decameron in cineteca a Bologna, approfittando del corso monografico del Dams, mi fu preventivamente spiegato che l'approccio di Pasolini era "poetico" - e già la cosa mi innervosiva, provenendo io da un altro corso di studi: perché mettere la poesia nel Decamerone, che è prosa? E l'approccio poetico, poi, consisterebbe nel fatto che i raccordi sembrano tutti sbagliati, gli attacchi irritanti, le immobilità interminabili, ecc. ecc? E aggiungi gli attori non professionisti sempre sul punto di mettersi a ridere. Cioè, insomma, "poetico" significa "fatto male apposta"? Probabilmente avevo la stessa età in cui Muccino cominciò a detestarlo.
 |
| I HAVE NO IDEA WHAT I'M |
Muccino è convinto che Pasolini abbia inferto un colpo mortale alla cultura cinematografica italiana - dopo di lui qualsiasi inetto avrebbe deciso che bastava munirsi di cinepresa e montare spezzoni a caso per fare cinema poetico ("improvvisati registi che non sapevano come comunicare col pubblico"). È andata così? Da qua non sembra. Sotto l'ombra del monumento che gli è cresciuto addosso in questi anni, sfugge forse quanto Pasolini fosse organico all'industria cinematografica che Muccino rimpiange - ricordiamo: comincia a lavorare con Fellini, esordisce con Bertolucci, all'inizio non ha ben chiaro che lenti montare ma si circonda di maestranze di primissimo livello: realizza film non convenzionali ma nemmeno assimilabili a quelli autoriali di Antonioni o Godard; film che fanno discutere, ottengono premi e - particolare cruciale - a volte riempiono le sale.
A Muccino forse manca un dettaglio: la trilogia della vita fu un successo al botteghino. Successo che imbarazzava Pasolini per primo, e che lo portò nel suo ultimo anno di vita a una tragica abiura. Oggi lo ricordiamo come un grande intellettuale fuori dagli schemi e dalle mode, ma l'effetto immediato del successo del Decameron fu precisamente la nascita di un vero e proprio filone, il cosiddetto decamerotico. Sono fenomeni difficili da indovinare oggi. che andiamo al cinema molto meno: nel giro di pochi mesi c'era già un Decameron II apocrifo in circolazione; quando l'anno successivo uscì I racconti di Canterbury, gli artigiani della pasolini-exploitation avevano già provveduto a confezionare Gli altri racconti di Canterbury, che arrivò nelle sale in contemporanea. Secondo Muccino senza Pasolini non avremmo avuto Nanni Moretti; mi sembra molto discutibile, invece è abbastanza pacifico che senza Pasolini non avremmo mai avuto Quel gran pezzo dell'Ubalda tutta nuda e tutta calda. Persino l'abiura totale di Salò, così disperata e senza compromessi... Persino Salò diede vita a una rapida vague di film di serie B a base di nazisti sadici.
Tornando al Decameron: è il film di Pasolini con cui ho più familiarità, per via della mia abitudine a proiettare in classe (con un certo sprezzo del pericolo) la novella di Andreuccio di Perugia. Non è che abbia fatto pace con gli attacchi irritanti e le immobilità interminabili, ma per mostrare uno scorcio di medioevo urbano non saprei trovare di meglio. È anche utile per fissare nella memoria le condizioni igieniche nel tempo - Ninetto Davoli che sprofonda nella merda è il miglior antidoto a qualsiasi visione fiabesca del medioevo. Ma soprattutto c'è qualcosa di arcaico, di irriconciliabile con la modernità, che è poi la sensazione che vorrei suscitare quando insegno storia.
Quando la primavera scorsa è uscito Il racconto dei racconti, sono entrato in sala con molte speranze. Basile è un altro autore che bisognerebbe affrontare alle medie - altrimenti quando? Per qualche minuto ci ho creduto davvero. Più o meno finché gli attori hanno aperto la bocca, dichiarandosi per quel che sono: attori di una fiaba in costume. Molto professionali, per carità.
In quel momento mi è venuta nostalgia di Pasolini, e di quei non-attori sempre sul punto di mettersi a ridere.
Perché stanno tutti ridendo, Mr Bogdanovich?
04-11-2015, 11:42cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink |
| Noccioline agli scoiattoli! |
Hai presente i vecchi amici, quelli con cui ti faresti volentieri una risata, ma ormai li vedi solo ai matrimoni e ai funerali; e ultimamente non si sposa più nessuno che conosci. Così quella risata finite per farvela fuori dai cancelli del cimitero, mentre la gente esce alla spicciolata coi fazzoletti stropicciati già riposti nelle tasche. Come stai? Da quanto tempo. Ma ti ricordi di quella volta. I ricordi si addensano in aneddoti, gli aneddoti scadono in barzellette. Chi vi passa vicino resta un po' perplesso: non è soltanto il fatto che stiate ridacchiando ai margini di un camposanto; è che niente di quello che raccontate è davvero così spassoso. I soliti equivoci, le solite figuracce, canovacci unti e bisunti, a chi volete raccontarla? Non vi state divertendo. I denti vi battono dal freddo, dall'angoscia, dalla paura.
Io invece per il giorno dei morti volevo andare al cinema a vedere qualcosa di davvero divertente. Mi avevano parlato bene di Tutto può succedere a Broadway. La premessa sembrava irresistibile - Wes Anderson e Noah Baumbach che decidono di produrre il film di un grande regista a cui devono tantissimo, Peter Bogdanovich, e quest'ultimo che sceglie di girare un film assolutamente inattuale, una screwball comedy, una pochade, una di quelle commedie di una volta dove tutti sono su di giri e si incontrano assurdamente tutti nel posto sbagliato - ristoranti, corridoi d'albergo, qui pro quo a non finire e un lieto fine con tanto amore per tutti. Ero andato al cinema per questo.
 |
| They laughed at me wanting you, said I was reaching for the moon |
Ma allora cos'è questo freddo che sento. Imogen Poots è l'ultima ragazza salvata dal regista pigmalione, ed è ovviamente adorabile. Lei sogna di recitare, e indovinate chi incontrerà al provino. Attenzione però: un suo cliente ossessionato - un anziano giudice! - la sta facendo pedinare da un detective altrettanto anziano, che è anche l'autore della commedia che il regista sta realizzando. Tutto qui? No: il giudice e Imogen Poots sono in cura presso la stessa analista, Jennifer Aniston - che è fidanzata con l'autore della commedia. Divertente, no? Immagina - che so - che il giudice inviti a cena l'analista ma che al ristorante si imbattano nell'autore che ha invitato Imogen Poots e nel regista che è uscito con sua moglie. Che scena ne verrebbe fuori, eh?
E allora perché non sto ridendo?
Continua su +eventi!
Lo trovate all'Aurora di Savigliano alle 21:15.
La fabbrica dei sogni che non crede ai sogni (ma crede alle fabbriche)
27-10-2015, 10:29animazione, cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalink"Ragazzi a chi? Ma come ti permetti?"
"È già lunedì!"
"Fantastico!"
"Peccato, un altra settimana se n'è andata".
"...e non abbiamo ancora visto un film per la provincia di Cuneo!"
"Evviva! Dobbiamo vedere un film!"
"No! È tardi! Non faremo più in tempo!"
"Sta' buono, Paura..."
"Penseranno che siamo inaffidabili! Ci toglieranno un contratto! Dovremo trovarci un lavoro!"
"Ce l'abbiamo già!"
Ed è bellissimo... ma perché non siamo andati a vedere un film, alla fine? Adoro guardare i film".
"È colpa di Paura".
"Che ha combinato?"
"Il solo pensiero di vedere The Walk lo ha gettato nel panico".
"Povero Paura, un po' lo capisco".
"Ma che povero e povero... è un maledetto imbranato che ci toglie ogni occasione di divertimento".
"Ha parlato l'anima di tutte le feste, ha parlato".
"Che cazzo vuoi? Io ci so stare in società".
"Legato. Ti leghiamo ogni volta che ci andiamo, in società".
"Che bel siparietto! Siete troppo forti! Sentite, ho un'idea. Recensiamo Inside Out".
"Ma sei scema?"
"Sono Gioia".
"Appunto. Hai notato che Inside Out è uscito un mese fa?"
"E allora?"
"Penseranno che non siamo più andati al cinema!
"Che siamo malati! Ci eviteranno come gli scabbiosi!"
"Paura, calmati, perdio".
"E chissà se non hanno ragione... non lo sentite anche voi il prurito?"
"Sì, è la voglia di mollarti due ceffoni".
"Quindi è deciso. Si recensisce Inside Out".
"Ma chi ha deciso che decidi tutto tu?"
"Non ci sono solo io. C'è anche Tristezza. A Tristezza è piaciuto tanto, vero?"
"..."
"Dai Tristezza, coraggio. A noi puoi dircelo".
"...sì, mi è piaaaaciuUUUUAAAAH È COSI' TRISTE! NON TORNERA' MAI PIU' IN MINNESOTA! MAI PIU'".
"Tristezza, nessun prepubere sano di mente ha mai voluto tornare in Minnesota".
"Snif".
"Vedete? A Tristezza è piaciuto, a me è piaciuto, e al Cinelandia lo programmano ancora. Siamo la maggioranza".
"Due su cinque non è la maggioranza".
"Lo è..."
"Nel mondo di Matteo Renzi, forse..."
"Anche in questo cervello, se voi tre non vi mettete d'accordo. E voi tre non vi metterete mai d'accordo".
"L'avete sentita?"
"Un po' ha ragione, Rabbia... voglio dire, di base io e te nemmeno ci parliamo".
"Renziani. Dappertutto. Anche in questo cervello di demente. Va bene, fate quel cazzo che vi pare".
Inside Out (Pete Docter, 2015)
La Pixar nel decennio scorso ci ha viziato. Soprattutto in quei tre anni in cui ci elargì, senza sforzo apparente, Ratatouille, Wall-E e Up. Tre film che non assomigliavano a nessun cartone animato già visto; che si prendevano rischi enormi e hanno lasciato segni nella storia del cinema non solo d'animazione. Inside Out ha le sue radici proprio in quel triennio d'oro: se ci ha messo ben sei anni ad arrivare in sala non è per una sola questione di perfezionismo, di progettazione, di rendering 3-D. Successe la stessa cosa con Ratatouille: ai film della Pixar capita di bloccarsi per anni nella fase di scrittura. L'idea era buona, anche se non originalissima - ma imbastirci sopra una storia ha richiesto quattro anni, sette canovacci diversi. E una passeggiata domenicale in cui il già acclamato regista di Monsters & Co. e Up, disperato, mentre meditava sul suo fallimento artistico e sulle dimissioni che avrebbe dovuto rassegnare, scoprì quasi per caso il vero protagonista del film. Quella notte al telefono tirò giù dal letto i suoi collaboratori: abbiamo sbagliato tutto, accanto a Gioia non c'è Paura. Quella al massimo è una spalla comica. Ma il segreto motore di tutto è Tristezza. Certo. Perché non lo abbiamo capito prima? Avevamo paura di far piangere il pubblico? Ma siamo la Pixar, siamo quelli di Up e Toy Story 3, si può dire che ormai la gente viene in sala apposta (continua su +eventi!)
(Sprofonderemo saturi) Suburra
19-10-2015, 10:41cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, RomaPermalink |
| Certe serate |
Sicuramente non dalla fotografia.
 |
| Certe cerette |
Forse è un buon film proprio per l'arroganza con cui arriva per ultimo nei luoghi tra più frequentati da cinema e tv, guarda tutti a grugno duro e fa capire che non pagherà nessun debito, anzi: tocca agli altri alzarsi e fargli spazio. Ci saranno feste danzanti e fogge cardinalizie - ma non ci sarà tempo per pensare alla Grande Bellezza. La folla circonderà Palazzo Chigi senza nessun riferimento al Divo o al Caimano. Se entri aspettandoti Gomorra - il film o la serie - dopo un po' ti accorgi che non ci stai pensando più. Anche Romanzo Criminale è in qualche modo lontano (continua su +eventi!)
Dovevate lasciarlo su Marte (ovvero: e se The Martian fosse il prequel di Interstellar?)
07-10-2015, 14:38cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, futurismiPermalink |
| Interstellar |
 Mark Watney sembra non avere dubbi. Lui ha il diritto di vivere, Marte non collabora ma dovrà adeguarsi. Nel suo diario di nove mesi non c'è spazio per la disperazione, né per la manifestazione di un minimo dubbio esistenziale: ma valgo davvero la pena? Cos'è alla fine la mia vita, perché i colleghi ne rischino molte di più per salvarmi? Perché la NASA sconvolga il suo programma spaziale, e la Cina rinunci ai suoi segreti scientifico-militari? Sul serio sono così importante? Così insostituibile?
Mark Watney sembra non avere dubbi. Lui ha il diritto di vivere, Marte non collabora ma dovrà adeguarsi. Nel suo diario di nove mesi non c'è spazio per la disperazione, né per la manifestazione di un minimo dubbio esistenziale: ma valgo davvero la pena? Cos'è alla fine la mia vita, perché i colleghi ne rischino molte di più per salvarmi? Perché la NASA sconvolga il suo programma spaziale, e la Cina rinunci ai suoi segreti scientifico-militari? Sul serio sono così importante? Così insostituibile?(continua su +eventi, sì! la rubrica cinematografica più ignorante della provincia di Cuneo è tornata!)
Se solo Interstellar fosse arrivato dopo The Martian – se il progetto avesse languito per qualche mese in più sulla scrivania di Spielberg prima di finire nelle mani di Nolan – forse oggi avremmo un elemento in più per amarlo: potremmo immaginarcelo come un sequel del film marziano di Ridley Scott, in cui Mark Watney si ritrova di nuovo solo, stavolta in una galassia perduta – e stavolta sbrocca davvero. La stessa ostinazione a vivere che lo ha portato a scaldarsi con gli isotopi del plutonio e mescolare la merda dei compagni, e a farsi saltare in aria su un razzo decappottato – non è la stessa forza cieca che nell’altro film lo spingerà a truffare i compagni, e l’umanità, per un banale istinto di sopravvivenza? Dopodiché, d’accordo, The Martian è un film più compatto e sicuro del film di Nolan – nonché scientificamente inappuntabile – però dopo due ore di umani che collaborano, che non si fanno mai prendere dalla disperazione, che prendono continuamente decisioni all’unanimità, e sono sempre le decisioni giuste – dopo due ore del genere, vien voglia davvero di rivalutare gli astronauti di Nolan che invece fanno errori su errori per rimediare ad altri errori: astronauti che litigano, che non vanno d’accordo, che nelle proprie equazioni non riescono a eliminare pulsioni come l’amore o il senso di colpa. Astronauti più simili a quelli quasi veri di The Right Stuff di Kaufman: superuomini non immuni da sentimenti come l’invidia o il panico.
Certo, se un giorno andremo davvero su Marte, ci farà molto comodo poter contare su uomini come Mark Watney: dei Fonzie interplanetari che trovano sempre una via di uscita e non se la prendono mai. Ma dovremo essere anche pronti a sacrificarli – ed e qui che The Martian svela la sua debolezza: è la ricostruzione molto realistica di uno scenario inverosimile. Un astronauta perso, è perso. Nello spazio ogni risorsa è incredibilmente preziosa, e la tua lotta per la sopravvivenza, per quanto eroica, non può costare milioni di dollari ai contribuenti. Al cinema, beh, al cinema è diverso.
The Martian (in italiano Sopravvissuto) è al Cityplex di Alba (20:45), al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (in 2D alle 20:30 e alle 22:35; in 3D alle 21); ai Portici di Fossano (in 2D alle 18:30 e alle 21:15); al Cinecittà di Savigliano (in 2D alle 21:30); all’Impero di Bra (in 3D alle 22).
Io robot, tu fatti da parte
04-08-2015, 08:49cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, futurismiPermalinkA volte i robot hanno gli incubi. Sognano di non essere più robot, ma esseri umani con un cuore e i vasi sanguigni. Si svegliano e cominciano a smontarsi, strato dopo strato, finché sotto la pelle sintetica non emerge il verde confortante della scheda madre.
 |
| Idee semplici e perfette. |
Negli anni Duemila la fantascienza al cinema era un genere innocuo e fracassone, ancora ingombro dei blockbuster catastrofici di Michael Bay e Roland Emmerich. Poi qualcosa è cambiato. Credo che sia tutto cominciato con Moon, il piccolo film di Duncan Jones del 2009 che affrontava il genere con un approccio minimale: una sola location, un solo attore, effetti speciali semplici e poco invasivi, un paio di idee veramente buone. Moon è piaciuto a tutti, è stato immediatamente scopiazzato da qualche grossa produzione di Hollywood, ma soprattutto è stato per la fantascienza quello che Paranormal Activity è stato per l'horror: ha mostrato a tutti che se l'idea è buona, il budget può anche essere piccolo. E se il budget è piccolo, non c'è più bisogno di piazzare combattimenti ed esplosioni per in grande pubblico quindicenne. Si possono fare film un po' più adulti, film che ragionano, film che ti turbano e ti lasciano un po' perplesso anche a mesi e anni di distanza.
 |
| NON HO IDEA DI COSA STO FACENDO. |
 |
| Ah, io farei la stessa cosa. |
Poi c'è la storia. Anche stavolta, quattro attori e una location, e un'idea semplice ma di sicura presa: il test di Turing. Benché abbia esordito come scrittore, Garland si è impadronito del mezzo cinematografico al punto che per portarci nel suo mondo non ha bisogno di una di quelle fastidiose "spieghe", i monologhi iniziali che affliggono quasi sempre i film di fantascienza. Non è che tutto funzioni sempre: l'eleganza della confezione nasconde diversi difetti di trama e di logica. Ma con tutte le sue magagne, Ex Machina ti lascia addosso un segno potente. Oscar Isaac è Nathan, l'imperatore di internet, una figura che fonde Jobs, Zuckerberg e i creatori di Google. Nel suo castello ai confini del mondo sta lavorando all'intelligenza artificiale, il gradino successivo dell'evoluzione, con la stessa incoscienza infantile con cui Pollock rovescia colori sulla tela. Non gli dispiacerebbe essere Dio, ma sa anche di non avere scelta: i robot prima o poi si evolveranno, non è più una questione di "se", ma di "quando". Domhall Gleeson, un anno dopo Frank, veste di nuovo i panni del nerd che pensa di essere più furbo di quanto non sia e combina grossi guai. Ex Machina arriva nelle sale italiane proprio nella settimana in cui gli scienziati lanciano un allarme contro lo sviluppo di intelligenze artificiali in campo bellico, ed è la più bella sorpresa di questa estate rovente. Lo trovate al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:10, 22:40) e al Multilanghe di Dogliani (21:30).
La spia che pesava
28-07-2015, 12:05cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020Permalink |
| Solo per i tuoi occhi |
Le spie vere, ci avete mai pensato? Chissà come sono fatte. Di sicuro non assomigliano a James Bond. Più facilmente a un'impiegata delle poste. E però devono avere competenze e riflessi eccezionali. Immaginati un'impiegata sovrappeso che all'improvviso salta il desk con un balzo e atterra tre clienti con una mossa di arti marziali. Ecco, quello sarebbe un film interessante, invece del solito 007. Che idea. Però l'ha già avuta Paul Feig. E ovviamente ha chiamato Melissa McCarthy.
L'attrice in Italia è conosciuta soprattutto come la migliore amica di Una mamma per amica. Due anni fa aveva già prestato le sue forme importanti alla commedia d'azione in un altro titolo di Feig, The Heat, (Corpi da reato). Là faceva la poliziotta cattiva, in coppia con Sandra Bullock. Qui si cala in un ruolo di spia, con risultati esilaranti. Spy però non è il film in cui ci si prende gioco della grassona - in fondo la McCarthy ha le dimensioni dello spettatore medio americano, quello che nei film non vediamo quasi mai ma che incontriamo appena attraversiamo il fiume Hudson. Il film è concepito come una rivincita della donna qualunque - la segretaria impacciata ma competente, che all'inizio della storia sbava per l'agente Jude Law, si dimostrerà nel corso della pellicola una vera macchina per uccidere. C'è almeno un paio di sequenze (un inseguimento e un combattimento) che funzionerebbe anche in un action serio, dove la stazza della protagonista scivola in secondo piano. Susan-Melissa cresce per tutto il film, non in peso ma in consapevolezza delle proprie capacità. Gli uomini che all'inizio le impedivano di esprimersi si riveleranno generalmente fatui e inaffidabili: quanto agli antagonisti seri, sono tutti donne come lei; una donna è anche il suo capo (Allison Janney) e il suo braccio destro (Miranda Hart) (Continua su
 |
| Product placement esilaranti |
Il successo di Spy è una buona notizia non solo per gli inevitabili sequel, ma per il prossimo progetto di Feig, quel famoso Ghostbusters con il cast tutto femminile che sta facendo impensierire gli appassionati. E invece sapete? Io che di Ghostbusters non ho mai voluto vedere il sequel, adesso che so che dirige la Feig e ci sono la McCarthy e la Hart, comincio a pensare che sarà un film interessante.
Da vedere a. Spy è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo alle 17:30, 20:10, 22:40; al Multilanghe di Dogliani alle 21:30.
Abbiamo tutti un mostro in cantina
21-07-2015, 10:16cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivoPermalinkSe un tipo sveglio sei, e ben vedere sai,
un amico speciale troverai,
un amico tuo e mio.
Un suono tonante e tre colpi secchi: babada dook! dook! dook!
che lui è lì così saprai, e lo vedrai se guarderai...
Abbiamo tutti un mostro nello scantinato, un libro sulla mensola più alta che nessuno deve aprire. Un calendario senza un giorno che per gli altri è un giorno qualsiasi. Un incubo che ci fa sentire in colpa se da un po' non lo sogniamo. E un debito di sonno che ci fa vedere i mostri dove dormono i nostri bambini. Girato e ambientato in un suburbio australiano simile a tutti i suburbi del mondo, Babadook è la storia di Amelia, che ha perso il marito e partorito nello stesso giorno. Ora il bambino ha sei anni e non è come gli altri bambini. Amelia un tempo scriveva; ora il figlio e il lavoro si contendono il suo tempo lasciando le briciole al sonno. Insomma il mostro potrebbe entrare da qualsiasi fessura: approfitterà di un misterioso libro per bambini.
 |
| Quando dico "insopportabile" so quel che dico. |
 |
| Si capisce che ho in mente Kubrick? Si capisce? Eh? |
Giovani non ci si improvvisa
15-07-2015, 02:25cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, invecchiarePermalink |
| Passa ai ruoli drammatici, dicevano. Si suda di meno, dicevano. |
Hai presente quel dolorino al ginocchio che non riesci nemmeno a ricordare quando è cominciato - quel dolore trascurabile che se ne sarebbe andato presto, e invece a un certo punto non sei più riuscito a salire in bicicletta, e il medico ti ha prescritto una medicina per l'artrite? L'artrite? C'è in giro una nuova generazione di artrite che colpisce i giovani? Ok, tu non sei tecnicamente più un giovane, ma l'artrite, suvvia, tuo padre soffriva di artrite. A quarant'anni... Perché, tu invece quanti anni hai?
Hai presente quel dolorino? Non se ne andrà mai più.
Giovani si diventa non è Duri si diventa, anche se sono usciti la stessa settimana. In Duri si diventa c'è Will Ferrell che deve imparare a fare il duro perché sa che andrà in prigione. Dirige Etan Cohen che non è Ethan Coen, occhio all'H. In Giovani si diventa c'è Ben Stiller che deve imparare a sembrare giovane perché improvvisamente non lo è più - cose che succedono soltanto nei film, per fortuna. Un attimo prima era un documentarista ribelle di belle speranze, un attimo dopo è un vecchio frustrato col cappello sullo sfondo di feste a cui non lo invitano.
 |
| Naomi che balla l'hip-hop però vale tutti i $ che è costata. |
Baumbach è uno dei registi più interessanti della
L'egiziano con la balalaika
12-07-2015, 18:05cinema, coccodrilliPermalinkIl casting del dottor Zivago è una cosa che fa girar la testa. Il laido Komarovski avrebbe potuto essere Marlon Brando (ma sarebbe stato meglio di Rod Steiger? Non ne sono così sicuro). Lara avrebbe potuto essere Sofia Loren - che era poi il motivo per cui Ponti si era preso i diritti del film, ma Lean temeva che non sarebbe stata credibile nei panni iniziali di giovane educanda, un anno dopo essere stata la madre dei tre figli di Filomena Marturano, Audrey Hepburn avrebbe potuto essere Tonya invece che Geraldine Chaplin. Paul Newman avrebbe potuto essere il dottore. Anche Michael Caine fece un provino - o forse aiutò soltanto l'amica Julie Andrews a fare il suo, poi vide quello di Sharif e disse a Lean di scritturarlo. Un grande attore egiziano, nei panni di un medico e poeta russo. Oggi nessun regista oserebbe fare qualcosa del genere in una grande produzione, ed è un peccato. O'Toole sarebbe stato più credibile, ma non so quanto avrei tremato per lui che si specchia assiderato nella dacia. Sharif regalò Zivago a tutto il mondo, è banale dirlo ma è così. Della manciata di Sharif che ho incontrato a scuola, almeno uno so che deve il nome proprio a lui.
Zivago è un film che guardo più o meno una volta all'anno - di solito a scuola. Il comunismo reale è uno degli argomenti più difficili da spiegare a gente che è nata più di dieci anni dopo la caduta del muro di Berlino. La difficoltà principale sta nell'immaginare un regime economico diverso, una cosa che oggi non esiste da nessuna parte nel mondo a parte isole o penisole esotiche. Dopo alcuni tentativi ho scoperto che i film che funzionano meglio sono Goodbye Lenin e Zivago (sì che Reds mi piaceva tantissimo, ma non regge). C'è nelle tre ore di Zivago almeno una trentina di minuti che sono una lezione di storia di terza media, pura e semplice: la scena dei disertori che diventano rivoluzionari, ovviamente, e quella altrettanto celebre in cui il dottore torna a casa e scopre che è stata collettivizzata (è anche notevole quel che riesce a fare Klaus Kinski con tre minuti a disposizione). Lì, e altrove, ho la sensazione che più di Pasternak sia merito di Robert Bolt, che riesce a dare allo spettatore anche digiuno di Storia tutti i riassunti necessari.
Ma nel film c'è tantissimo altro. Lara è una vittima di molestie, anche psicologiche (il laido Komarovski le fa credere di essere stata consenziente). Magari sugli stessi argomenti ci sono film più recenti e aggiornati, ma a volte mi domando se il melò non colpisca più in profondo, in territori preconsci. È pieno di Komarovski là fuori ed è tempo che le ragazze lo sappiano. I nomi poi sono difficili per cui invece di Komarovski lo chiamiamo Il Vecchio Porco. Ci sono frasi bellissime, che in realtà non so a memoria per cui magari le sbaglio: "non abbiate fretta", "canteranno meglio dopo la rivoluzione", "chi è felice non parte volontario", "è notato, il tuo atteggiamento è notato", "e comunque avevo ucciso uomini migliori di me", e ovviamente, "ci sono due tipi di donne" e "ci sono due tipi di uomo". Ora che ci penso, Sharif non ne pronuncia nessuna - e dovrebbe essere il poeta. È un'anima bella sballottolata dalla Storia in un paesaggio enorme. È un buon medico ma questo passa in secondo piano rispetto all'ingenuità con cui affronta tutto quello che gli succede. Mi capita di solito di calarmi nei panni di tutti i personaggi maschili tranne il suo. Siamo stati tutti idealisti come Antipov (per fortuna nessuna rivoluzione ci ha dato un'armata a disposizione), burocrati rassegnati come il fratello di Zivago, e invecchiando metteremo su la pancia e il cinismo del porco Komarovski (per poi rimbecillire come il papà di Tonya); siamo quell'altro tipo di uomo, quello che l'umanità finge di disprezzare ma in realtà produce in serie. Siamo fatti tutti di quella creta. Questo non ci impedisce di voler bene a Zivago, mentre porta a casa tre assi schiodate a uno steccato, e non è nemmeno in grado di mentire. Forse avremmo voluto ugualmente bene a O'Toole, ma... no. Doveva essere Omar Sharif.
Nel tempo si viaggia da soli
08-07-2015, 11:59cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, futurismiPermalink |
| Bisogna trovare quello che è tornato indietro nel tempo per impedire che quei cappelli andassero di moda e fermarlo (lei è bravissima comunque). |
Predestination è un film australiano tratto da un racconto di Robert Heinlein che fareste bene a non aver letto, o ad aver dimenticato. Un agente segreto (Ethan Hawke) viaggia nel tempo per sventare gli attentati di un terrorista che viaggia pure lui nel tempo e che riesce sempre a prevenirlo, e a questo punto o vi siete già distratti, o siete appassionati di paradossi temporali e avete già formulato il sospetto più ovvio.
Questo è il principale problema di Predestination e in generale di tutto il cinema di fantascienza, che pure in questi anni ci sta regalando soddisfazioni non piccole: il fatto di rivolgersi a un pubblico già selezionato ed esigente, che conosce i trucchi meglio di chi li mette in scena - non è come l'horror; in sala non sono tutti adolescenti a bocca aperta incapaci di rendersi conto che Bruce Willis è un fantasma anche se nessuno gli rivolge mai la parola. Anche se non conosci il racconto originale, persino se ignori Heinlein e la sua ossessione per i loop temporali, se ti piace la fantascienza hai l'occhio allenato per queste cose - e dopo dieci minuti di girato hai già capito quello che i gemelli Spierig vorrebbero rivelarti al novantesimo. (Continua su +eventi!)
Il film resta ugualmente godibile, un bell’episodio lungo di Ai Confini della Realtà. Gli Spierig non sono i Wachowski ma hanno mutuato qualcosa della loro follia, nel bene e nel male – una fascinazione per l’androgino e la metamorfosi del corpo che è ancora merce rara, ma che purtroppo anche qui come in Cloud Atlas non riesce a tradursi in forme cinematograficamente plausibili: anche se in questo film non ci sono trucchi altrettanto imbarazzanti, la pur brava Sarah Snook semplicemente non è abbastanza credibile nei panni maschili che si trova addosso per metà film. In compenso la macchina del tempo è la più minimal mai vista al cinema, e forse anche la più elegante e suggestiva. Il film si mantiene per una buona metà estremamente aderente al racconto di Heinlein, senza nemmeno correggerne il sessismo molto anni Cinquanta, a costo di disorientare lo spettatore meno esperto che si ritrova in un passato alternativo con cadetti spaziali che quando fu descritto era semplicemente un futuro prossimo. Poi, cercando di confondere le acque, i gemelli scelgono di raddoppiare l’intreccio già arzigogolato, aggiungendo riferimenti al terrorismo che invece di attualizzare la storia la sospendono ancora di più nello spazio e nel tempo: non è che torni tutto, e se vi ha innervosito la logica circolare di Interstellar forse è meglio che vi teniate alla larga. Se invece qualche volta vi viene di pensare a come dev’essere il Tempo visto da una quinta dimensione, Predestination è il film fatto per voi. O forse eravate voi fatti per lui. Probabilmente vi verrà voglia di vederlo e rivederlo, anche al contrario.
(Quando sono entrato in sala ero solo. Se c’è un film da guardare da soli, è questo. Dopo un po’ è entrato qualcun altro, qualcuno che ho evitato rigorosamente di osservare. Non so se era un uomo o una donna, ma ho avuto la sensazione che mi somigliasse).
Predestination è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo alle 20:30 e alle 22:45, e poi chissà dove andrà a finire.
La morte ti cerca su Skype
01-07-2015, 12:03cinema, Cosa vedere a Cuneo (e provincia) quando sei vivo, fb2020, internet, ragazziniPermalinkO ma t ricordi Laura???
Quella stronza ke poi a un certo punto qualcuno ha messo su youtube il video in cui fattissima si era cagata addosso??
E che lei dopo dalla vergogna si è sparata (ke COGLIONA)?
Ti ricordi quanto abbiamo pianto al funerale, e quando ci intervistavano dicevamo che era nostra amica e mai avremmo potuto immaginare e insomma eravamo sconvolti?
Ma il video invece ti ricordi ki lo aveva fatto?
Eri stata tu?
Ero stato io?
No io forse lo avevo solo postato.
Boh.
Unfriended è un piccolo film con un'idea fortissima - trasferire sul grande schermo il desktop di un computer portatile, e raccontare tutta la vicenda da una finestra all'altra, in apparente presa diretta. I personaggi dialogano su skype, la colonna sonora è una playlist su itunes, gli indizi si cercano su google, il passato galleggia su youtube e facebook - lo spettatore condivide il punto di vista della protagonista e a un certo punto la frustrazione di non riuscire a controllare il cursore col mouse (visto su un portatile dev'essere tremendo, anche al cinema viene costantemente la tentazione di aprire la posta o twitter o qualche altra minchiata).
Il tema ovviamente è il bullismo 2.0 - Gabriadze, regista di origine georgiana, sembra abbastanza persuaso che l'inferno siano gli altri, cioè internet. Classe '69, in un'intervista ha candidamente affermato che il nonnismo subito ai tempi del servizio militare nell'Armata Rossa non è nulla rispetto a quello che può capitare oggi ai ragazzini sui social network. Unfriended descrive questo mondo col candido cinismo che si può permettere un regista horror: i cinque personaggi, tutti variamente antipatici, saranno messi l'uno contro l'altro dal fantasma della loro vittima. Sì, il modo di raccontarla è finalmente un po' diverso, ma la storia è la più banale del mondo (continua su +eventi!) Gabriadze, che comunque ha avuto un colpo di genio, ha anche il pregio di non
Chi 16enne non è può lamentarsi dello spreco: le idee originali sono così rare oggigiorno. D'altro canto Gabriadze con un misero milione di dollari di budget ne ha già portati a casa 45: che gli vuoi dire? Magari i sequel avranno un approccio meno scontato. Il film è l'ennesimo colpaccio di Jason Blum, produttore specializzato nei film a bassissimo costo e altissimo rendimento: non sono mai capolavori (tranne il caso un po' particolare di Whiplash), ma sono sempre idee originali. Merce sempre più preziosa, anche a Hollywood.
Unfriended è al Cinelandia di Borgo San Dalmazzo (20:40, 22:40); all'Italia di Saluzzo (20:00, 22:15); al Cinecittà di Savigliano (22:30).


















































































































































































