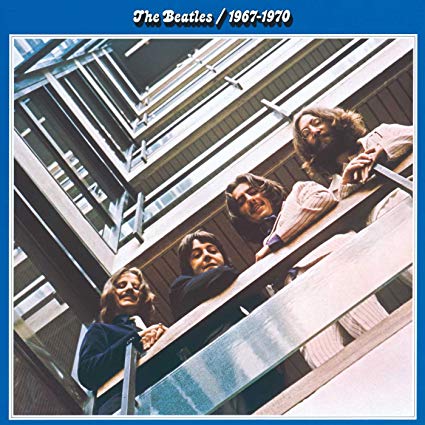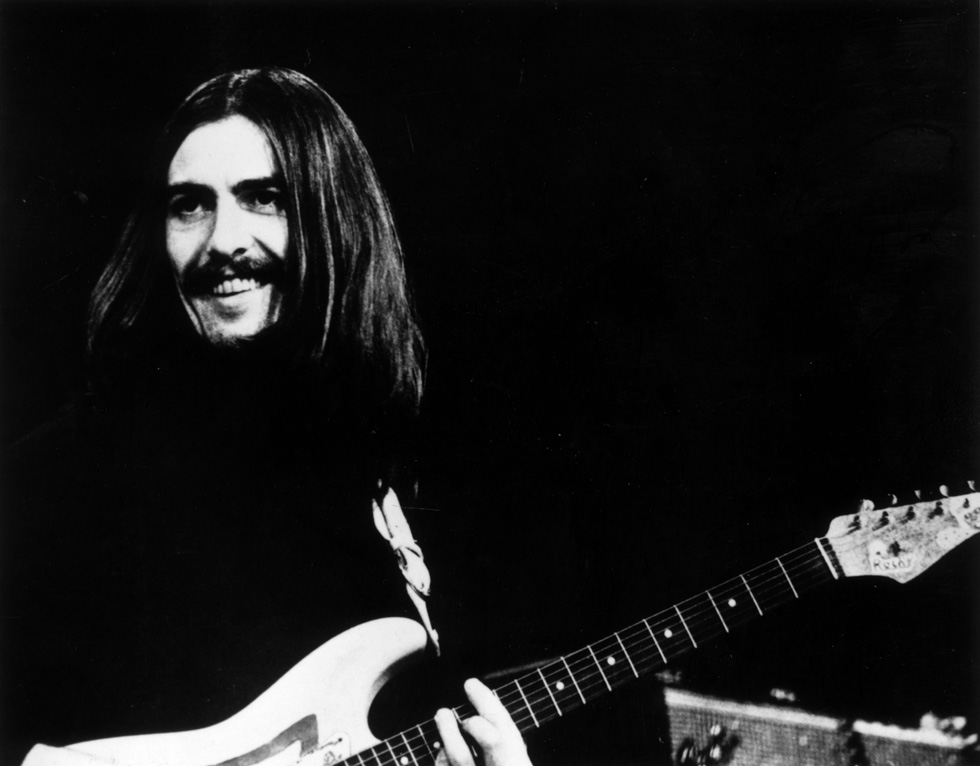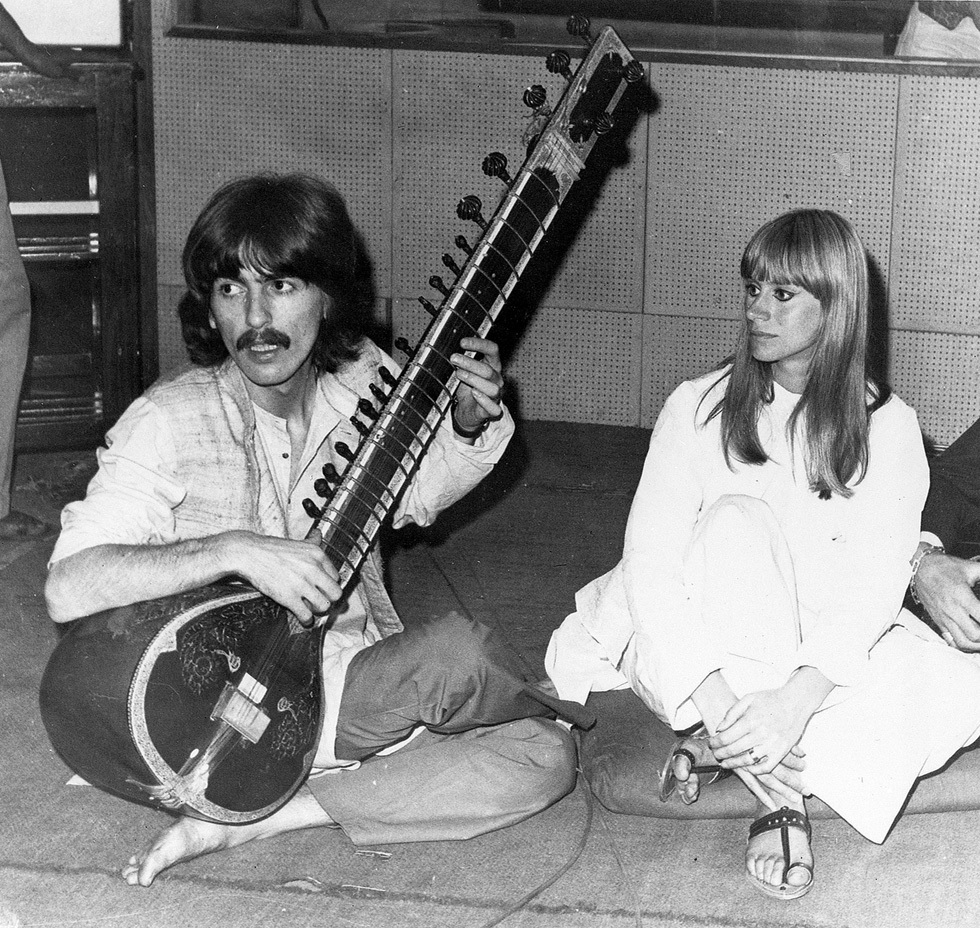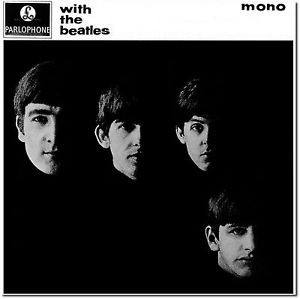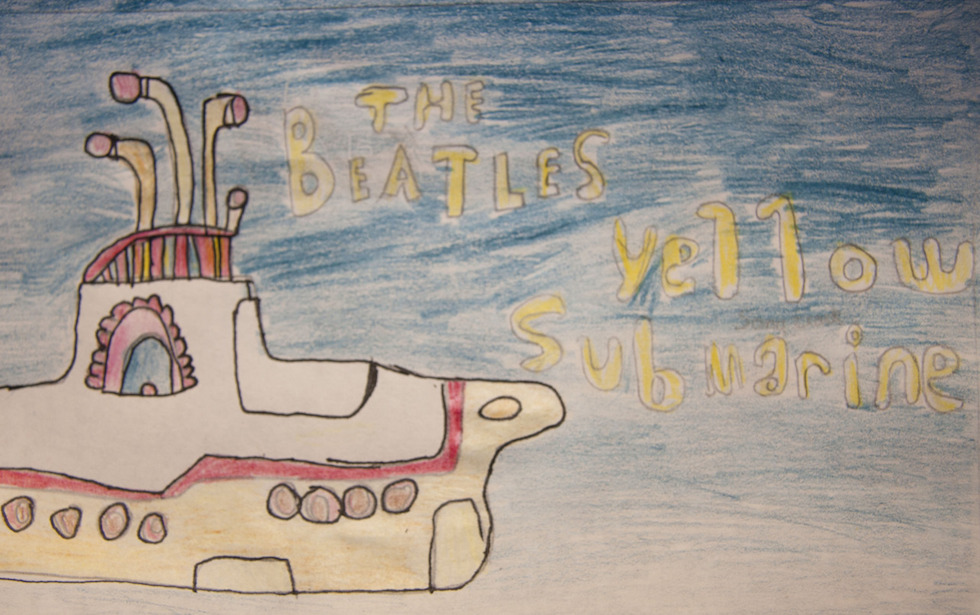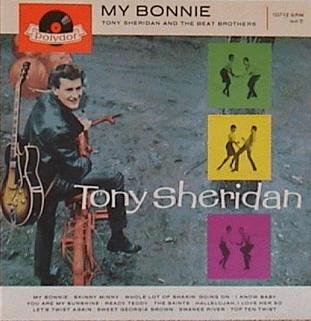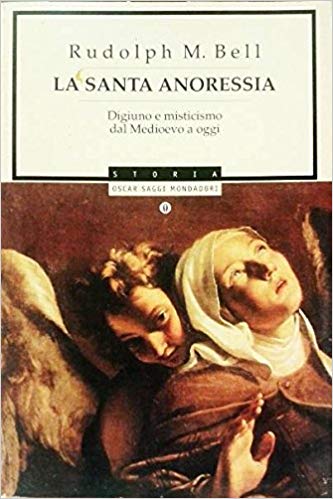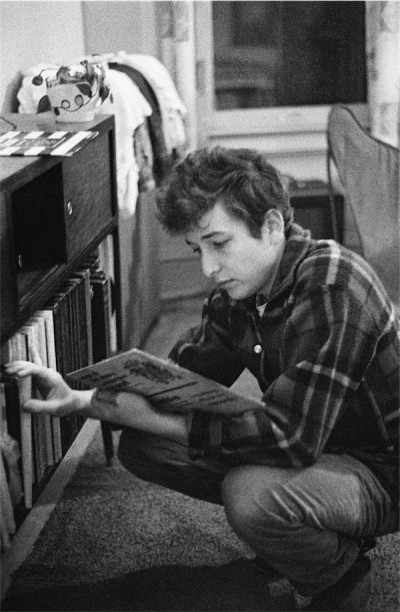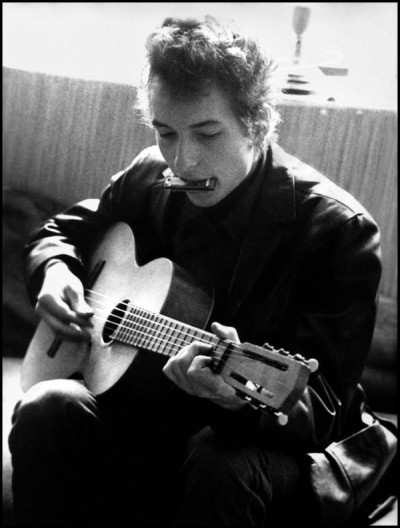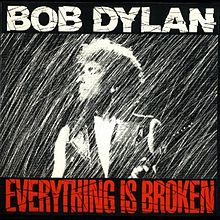Sant'Anna e il primo bacio
26-07-2024, 00:58Il Post, santi, sessoPermalink26 luglio: Santi Anna e Gioachino, nonni di Gesù
 |
| Hai capito i due vecchietti. |
Per molto tempo negli affreschi nessuno ha osato baciarsi; la pratica – pure attestata in letteratura sin dall'antichità – non sembra fosse ritenuta degna di raffigurazione. Troppo oscena? Se così fosse, probabilmente almeno un bacetto lo avremmo trovato sulle pareti dei bordelli di Pompei (in mezzo a scene più esplicite, che non è necessario rammentare ai lettori). Invece per vedere veri baci tra persone adulte bisogna a quanto pare pazientare fino alle soglie del secolo XIV, quando un artista già affermato come Giotto di Bondone passa da Padova per lavorare alla Basilica di Sant'Antonio ed Enrico Scrovegni gli propone di arrotondare affrescandogli una cappella di famiglia. Può darsi che il carattere privato dell'opera abbia contribuito ad allentare certe inibizioni, fatto sta che nella Cappella degli Scrovegni, Giotto piazza lì come se fosse niente i due primi baci della Storia dell'Arte, che sarebbero capolavori anche se non fossero i primi.
Uno dei due è il bacio di Giuda a Gesù nell'orto degli ulivi, il che ci indurrebbe a tutta una serie di considerazioni amarognole sul fatto che il primo bacio noto in pittura sia il suggello di un atroce tradimento; senonché sull'altra parete c'è un bacio ancora più interessante, tra due adulti consenzienti, coniugati e innamorati: Anna e Gioachino, i nonni materni di Gesù. Ancora per qualche secolo gli unici ad avere la licenza di baciarsi nei quadri e sulle pareti saranno loro, anche se non molti pittori mostreranno il coraggio di Giotto, persino nel Rinascimento. Più spesso, invece di dipingerli a labbra accostate, preferiranno fermarsi un attimo prima, quando i due volti non sono ancora troppo vicini; e sopra di loro aggiungeranno un angelo che con le mani li sollecita al gesto. Per quanto questo possa apparire un po' morboso alla nostra sensibilità, l'intenzione era esattamente l'opposta: alludere al concepimento carnale di Maria con un gesto che esprimesse affetto tra i coniugi ma il minimo di concessione alla sensualità. Il primo bacio non è in effetti un bacio qualsiasi. Durante il Medioevo aveva preso forma l'idea che Maria di Nazareth fosse stata concepita "per osculum", attraverso questo bacio.
La leggenda si intrecciava con la questione del peccato originale: secondo alcuni teologi (gli "immaculisti"), Maria era stata creata senza peccato originale, prima donna dai tempi di Eva. Ed evidentemente ad alcuni immaculisti – non a tutti – la sessualità risultava irrimediabilmente intrecciata col peccato di Adamo e di Eva. Dopotutto la punizione inflitta da Dio a quest'ultima prevedeva le doglie del parto ("partorirai con dolore"). Così poteva sembrare appropriato che Maria, in quanto Immacolata Concezione, non fosse stata concepita e partorita nel modo così crudo in cui veniamo alla luce noi peccatori.
 |
| Sacra Famiglia con Sant'Anna e San Giovannino (Bernardino Luini, da un cartone di Leonardo da Vinci) |
L'episodio del bacio, conosciuto come "incontro alla porta d'oro", è narrato nel protovangelo di Giacomo, il testo apocrifo che se non inventa Anna e Gioachino (mai nominati nei Vangeli) di certo li trasforma nei personaggi che per secoli avrebbero riempito lo sfondo delle pale d'altare. Che a Gerusalemme ci fosse una porta d'oro, dove i due coniugi si sarebbero incontrati dopo essersi temporaneamente separati, non risulta agli archeologi, ma non bisogna aspettare Freud per capire quanto sia prezioso per l'uomo quel varco finalmente aperto: è la breccia attraverso cui Adamo ed Eva uscirono dal giardino dell'Eden, la porta che dopo secoli viene riaperta attraverso il grembo di Maria. L'autore del protovangelo ha lavorato molto di fantasia, ma non era un contafrottole qualsiasi; rispetto ad altri pseudoevangelisti capisce la necessità di mantenere una coerenza narrativa col materiale evangelico. Dovendo raccontare l'infanzia di Maria a un pubblico che era curioso di conoscerla, e non disponendo probabilmente di una minima informazione utile sui suoi genitori, decide di riprendere due personaggi dell'Antico Testamento, i genitori del profeta Samuele, senza nemmeno preoccuparsi di cambiare nome al personaggio femminile. Anna e Gioachino sono l'ennesima coppia sterile della Bibbia, cui il Signore promette una discendenza in cambio di una serie di prove. In particolare Gioachino, che aveva sposato Anna già vedova, deve subire un'umiliazione (non gli viene concesso di partecipare a un sacrificio, in quanto considerato sterile) e ritirarsi nel deserto: lì lo raggiunge in sogno l'angelo custode per esortarlo a ricongiungersi con Anna, la quale dopo un sogno molto simile si reca alla Porta d'Oro per incontrarlo. Il bacio suggella quindi l'incontro dopo una separazione, la speranza dopo la disperazione, un patto con Dio e una promessa reciproca: tante cose che secondo Giotto di Bondone richiedevano una raffigurazione esplicita, e non c'è che da essergliene grati; anche se per qualche secolo baciarsi in pubblico continuerà a non essere una pratica così frequente.
Il successo di Anna nelle arti figurative non si limita alla scena del bacio, e dipende probabilmente dall'interesse dei committenti per un certo tipo di quadri che raffigurassero Gesù e altri personaggi evangelici durante l'infanzia o la giovinezza, e in contesti domestici. Siccome questi quadri spesso li pagavano i nonni, era opportuno accostare a alla giovane madre Maria una figura femminile più anziana e autorevole. Essendo uno dei pochi punti fermi del cerchio parentale di Gesù, Anna fu inevitabilmente coinvolta in altri legami da agiografi restii a inventarsi ulteriori personaggi: secondo alcuni dopo la morte di Gioachino si sarebbe sposata altre due volte, mettendo alla luce Elisabetta (madre di Giovanni Battista) e Maria Salomé, madre di Giacomo Minore: un tentativo di ribadire che il cosiddetto "fratello del Signore" ne era in realtà il cugino. Questa leggenda fu severamente censurata dal Concilio di Trento, ma non prima di aver permesso ai pittori di dipingere interni in cui Gesù ragazzino gioca con Giovannino e Giacomino o altri santi bambini, sotto gli occhi attenti di una matrona paziente, di solito vestita di verde.
San Luigi è uguale a noi (più o meno)
20-06-2024, 00:29cristianesimo, Il Post, santiPermalink |
| Consacrazione di San Luigi, patrono della gioventù (Goya) |
Una cosa bella del cristianesimo è che per la prima volta ha messo all'ordine del giorno l'uguaglianza. Non tanto il fatto che ci fosse un Dio – quello si pensava già prima – ma che davanti a questo Dio risultassimo tutti uguali, come... come davanti alla legge, salvo che questa idea di essere tutti uguali davanti alla legge non esisteva, prima che postulassimo di essere tutti uguali davanti a un Dio. Pensate alla Dichiarazione d'Indipendenza Americana, 1776: "Noi riteniamo certe verità autoevidenti: che tutti gli uomini siano stati creati uguali", insomma se avessimo chiesto a Thomas Jefferson, sì, ma perché dovrebbero essere tutti uguali? Lui non avrebbe avuto altro argomento che puntare verso il cielo, o verso il Vangelo (ne aveva una copia tutta ritagliata a piacere): siamo uguali perché Dio ci ha creato così, è autoevidente. Questo magari spiega l'importanza che ha Dio nella società americana, e le difficoltà che incontrano quando provano a farne meno: come se fosse ancora la chiave di volta di un edificio settecentesco che nessuno in seguito ha ritenuto di ricostruire.
Dunque se qualche autorità ci considera ancora tutti uguali lo dobbiamo a Gesù Cristo... senonché forse questa idea non è nemmeno sua: almeno in qualche passo del Vangelo dà là sensazione che Egli pure facesse qualche differenza, ad esempio tra ebrei e non circoncisi. Il postulato dell'uguaglianza nasce un po' più tardi, forse perché il cristianesimo si stava diffondendo tra gli schiavi e agli schiavi serviva una religione che rimettesse in discussione le gerarchie sociali. Quando iniziate a vederla in questo modo, è una specie di rivoluzione copernicana: Cristo ci avrà messo qualche idea (e il suo sacrificio), ma di messia e di religioni in giro ce n'erano tanti. Il cristianesimo ha vinto perché piaceva agli schiavi, e raccontava una storia di giustizia che serviva agli schiavi. E forse davvero ha messo in crisi la società antica perché gli schiavi erano troppi ed erano stanchi di sentirsi inferiori. Non è che il cristianesimo ha liberato gli schiavi, come si raccontava una volta. È la schiavitù che ha inventato il cristianesimo per liberarsi. Un messaggio di speranza, ma anche di giustizia. Molto bene. Viene quasi voglia di battezzarsi, se uno si era sbattezzato (in realtà lo sbattezzo non funziona).
Poi guardi il calendario, 21 giugno, San Luigi Gonzaga, e ti sale un po' la rogna. Un nobile figlio di nobili fatto santo dai nobili. Cos'ha fatto di importante nella vita? Non tantissimo, è morto quasi subito. Ma è morto Gonzaga, e i Gonzaga ad avere un santo ci tenevano.
Lo so che non ha senso prendersela, perché se c'è un luogo dove per secoli la povertà è stata apprezzata e valorizzata, questa è proprio la Chiesa. C'è fior di poveracci sul calendario cristiano: poveri nati e poveri per scelta. Però, certo, c'è anche un sacco di bella gente, principi conti e regine, perché anche il martirologio è diventato uno status col tempo, come qualsiasi cosa.
Non so dove l'abbia trovata Cattabiani (Santi d'Italia, Bur, 1993), ma una leggenda dice che Luigino Gonzaga, a quattro anni, fu portato da papà Ferrante alle esercitazioni militari per l'imminente spedizione contro i turchi. Luigino vestiva "una corazza in miniatura, un archibugetto a tracolla e un ciuffo di piume bianche", e questo abbigliamento una sera avrebbe confuso le guardie della polveriera, o più probabilmente dormivano, sicché Luigino riuscì a sgraffignare abbastanza esplosivo da caricare una spingarda e ustionarsi, "per fortuna leggermente, mani e guance". Ora, per quanto ai tempi i bambini potessero crescere più velocemente, è difficile immaginare un monello di quattro anni che se ne va in giro di notte da solo per un accampamento. E però se fosse successa davvero, questa che è l'unica bravata mai commessa da San Luigi, non sarebbe senza un senso. Da una disavventura del genere Luigi avrebbe potuto trarre una grande lezione: qualsiasi cazzata avesse fatto nella vita, non importa quanto grande e pericolosa, l'avrebbe fatta franca; perché imbecille o meno era pur sempre un Gonzaga, e i Gonzaga fanno quello che gli pare. Anche quelli dei rami cadetti, come Ferrante suo padre che era marchese, sì, ma di Castiglione delle Stiviere; e però era Gonzaga pure lui, e i Gonzaga hanno parenti in Austria e in Spagna, in cielo e sottoterra. Ecco, forse mentre piagnucolava e le lacrime gli salavano le ustioni sulle guanciotte, Luigi capiva questo: che non c'era nessun gusto nel fare birichinate, quando nessuno ti giudica; e così non ne fece mai più. Il resto della sua breve vita si potrebbe interpretare così: una sfida al bieco familismo del neofeudalesimo rinascimentale. Luigi evade dal suo destino di signorotto impunito nell'unico modo che la società gli consente: trovando Dio. Quattro anni dopo, quando Ferrante torna dalla guerra, constata con orrore che il suo primogenito, oltre alla tubercolosi, ha contratto una spaventosa vocazione religiosa: del resto un cugino della madre era un Dalla Rovere, vescovo di Torino.
Ci fa caso anche il cardinale Carlo Borromeo, che passando da Castiglione scopre che il novenne Luigi si confessa già da tre anni (chissà di che peccati), e decide, potendo deciderlo, di impartirgli subito il sacramento della prima comunione. Forse in Luigino il cardinale si era riconosciuto: anche lui aveva sofferto il dissidio tra vocazione religiosa e il ruolo imposto dalla primogenitura (dopo la morte del fratello maggiore). Il padre però non molla, forse anche perché il secondogenito, Rodolfo, non gli sembra una cima. Nel 1582 la famiglia è ospite a Madrid di re Filippo II; Luigi e Rodolfo hanno l'onore di essere convocati come paggi di un infante di Spagna, ma quando non è impegnato dai doveri mondani, Luigi studia metafisica e teologia. Studiando si avvicina a un ordine di recente formazione, la Compagnia di Gesù, che ha un approccio moderno ma anche rigoroso, a metà tra l'università degli studi e la caserma. Papà Ferrante cerca ancora in vari modi di recuperarlo alla vita mondana; lo manda ospite in tutte le corti dei parenti (Mantova, Parma, Torino, Ferrara), magari sperando che qualche cugina impietosita provi a sedurlo, ma è tutto vano; Luigi ha fatto voto di castità a dieci anni e ormai ha deciso che sarà gesuita. Alla famiglia non resta che raccomandarlo al generale dei gesuiti, a Roma. Luigi arriva con un sontuoso corredo 'da gesuita' di cui si disfa ben presto, preferendo gli abiti comuni: sembrava avercela fatta, tra i gesuiti non era più un Gonzaga, ma un uomo tra gli uomini. A Roma, Luigi resterà dal 1585 in poi, salvo un soggiorno a Napoli per curare la tubercolosi, e uno a Castiglione nel 1589 per risolvere un contenzioso tra il fratello Rodolfo – che aveva ereditato il feudo del padre alla morte di quest'ultimo – e il cugino Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova, che reclamava Solferino.
Luigi riesce a riappacificare i cugini, ma a questo punto scopre un'altra gatta da pelare: lo zio Alfonso Gonzaga preme perché Rodolfo sposi la sua unica figlia, quest'ultimo fa impazzire la famiglia opponendo un netto rifiuto. Luigi scopre che Rodolfo non può sposarsi perché è... si è già sposato, con la figlia di un artigiano della zecca di Castiglione di cui si era invaghito quando lei aveva quindici anni. Cosa faceva un signorotto del Cinquecento neofeudale quando si affezionava alla figlia di un dipendente? Rodolfo era un Gonzaga, faceva quello che gli pareva, e in questo caso l'aveva rapita e messa incinta. Però poi l'aveva sposata, ufficialmente la storia dice questo, anche se non osava dirlo in giro. Luigi riuscì a forzarlo a un imbarazzante coming out e grazie alla sua intercessione, la madre accettò in casa nuora e nipote. Rientrato a Roma, Luigi si tuffa anima e corpo nell'assistenza ai malati dell'epidemia di tifo, svolgendo incombenze decisamente non indicate a uno che aveva già i polmoni tormentati dalla tbc. In questi casi viene il sospetto che il santo abbia inconsapevolmente voluto anticipare i tempi della sua dipartita. Sulla terra, non importa quanti sacrifici e opere di bene, sarebbe rimasto per sempre un Gonzaga, un privilegiato. Solo davanti a Dio siamo tutti uguali, perlomeno in teoria.
In pratica forse no, perché una volta passato all'altro mondo, Luigino fu di nuovo oggetto di un trattamento di riguardo. Una prima richiesta formale di canonizzazione partì da un sinodo convocato a Mantova nel 1604; ora secondo voi come si chiamava di cognome il vescovo di Mantova che aveva convocato il sinodo? esatto, Gonzaga, Francesco Gonzaga, quanto è piccolo il mondo. L'anno dopo Luigino era già proclamato Beato, quattro anni prima del fondatore del suo stesso ordine, Ignazio di Loyola. Canonizzato definitivamente nel 1726, tre anni più tardi Luigi fu proclamato patrono della gioventù cattolica, e in quanto tale era un santo molto popolare ancora per la generazione di mio padre: almeno per lui "San Luigi" era una data importante, un pretesto per far festa. Ma immagino che prima di dar via alle danze il parroco ci tenesse a esortare i giovani fedeli a vivere santamente come San Luigi, che potendo scegliere tra fare il signore e il santo aveva scelto correttamente, meritandosi la santità. Perché il cattolicesimo è meritocratico, a modo suo.
Eliseo e le sue orse
14-06-2024, 01:19Bibbia, Il Post, santiPermalink14 giugno: Sant'Eliseo, profeta da non contrariare (IX secolo aC)
Quando Eliseo, dopo aver purificato le acque di Gerico, si mise in cammino verso il monte Carmelo, passando da Betel incontrò dei giovani che lo presero in giro: la strada era in salita e loro gli gridavano: "sali, calvo". Non l'avessero mai fatto. Non solo si prendevano gioco di un profeta di Dio, ma di quello probabilmente più permaloso. Insomma giudicate voi: Eliseo (dall'ebraico Elisha, "Dio è la mia salvezza") li maledisse nel nome del Signore e subito dal bosco uscirono due orse che li sbranarono tutti e quarantadue. E benché i glossatori in seguito abbiano tentato di dare al termine ebraico "ne'arim" ("giovani"), un significato più esteso ("disobbedienti"), è probabile che la versione originale sia la più sgradevole: non erano adulti, e se il profeta li ha maledisse si vede che se lo meritavano.
Di miracoli, Eliseo ne ha fatti parecchi: è la sua specialità. Isaia ha la poesia, Geremia le rampogne, Ezechiele le visioni, Elia i miracoli, Eliseo ancora più miracoli. Alcuni sono persino più cruenti, ma non è difficile capire perché questo è il più famoso. Erano 42 ragazzi: non offendevano il Signore servendo gli idoli, come facevano i re di Israele e dintorni che Eliseo periodicamente ammoniva e puniva. Avevano solo mancato di rispetto a un profeta, ecco, questo era già intollerabile.
Quando fece sbranare i 42, Eliseo era già abbastanza maturo da aver perso i capelli, ma come profeta si era appena messo in proprio. Il suo maestro, il grande Elia, era da poco salito al cielo su un carro di fuoco. Eliseo aveva avuto il privilegio di assistere all'evento coi suoi occhi, l'unico modo, secondo il maestro, di riceverne l'eredità. Eliseo aveva chiesto addirittura di "averne il doppio", richiesta molto ardita perché già Elia era conosciuto per i suoi prodigi spettacolari. Eliseo evidentemente sentiva di meritarselo; anni prima, quando Elia lo aveva fatto suo discepolo stendendogli il mantello addosso, Eliseo aveva abbandonato la sua casa senza quasi fiatare. Stava arando un campo, alla guida di un tiro di dodici buoi – un dettaglio che ci suggerisce che la sua famiglia fosse abbastanza benestante. A Elia chiese solo un momento per salutare i genitori; poi fece arrostire i buoi sul fuoco che appiccò agli aratri, sfamò i suoi servi e li congedò, il Signore lo chiamava. Non sappiamo se durante gli anni di apprendistato presso Elia abbia fatto dei miracoli; senz'altro, appena raccolse il mantello di Elia che era caduto dal carro di fuoco, divenne in grado di dividere le acque del Giordano e fare qualsiasi altra cosa. Un enorme potere nelle mani di un uomo un po' bizzoso, ma Eliseo era anche capace di atti di generosità e tenerezza.
Quando passava dal villaggio di Sunem era spesso ospite di una signora che aveva riconosciuto in lui "l'uomo di Dio", e aveva fatto costruire una stanza apposta per lui, senza nulla chiedere in cambio. Eliseo, non sapendo come sdebitarsi, le promette che entro l'anno aspetterà un bambino. La sunammita non vuole crederci, il che è pericoloso; chi reagiva con scetticismo alle profezie di Eliseo a volte finiva molto male. Un soldato che non aveva creduto alla vittoria promessa, era finito schiacciato durante i festeggiamenti. Ma il caso della sunammita è diverso: non dubita del profeta, ma ha paura del suo stesso desiderio. Il bimbo nascerà, crescerà, e un giorno cadrà in coma dopo aver lamentato forti dolori alla testa. Quel giorno la sunammita cavalcherà fino al monte Carmelo, per prendersela con il profeta: "Avevo forse domandato un figlio al mio Signore? Non ti dissi forse: non m'ingannare?" Così tutti noi genitori, quando scopriamo che l'ansia di perdere i nostri figli sorpassa la gioia di averli attesi, se avessimo nei pressi il profeta Eliseo, lo malediremmo. Ma il potente Eliseo, inflessibile coi re e i loro eserciti, quando la sunammita venne ad accusarlo, scese dal Carmelo e andò a rianimarle l'unico figlio, con una tecnica che somiglia alla respirazione bocca a bocca. Era un tipo così. Per fortuna che quel giorno nessuno gli fece notare che stava perdendo i capelli.
Il santo che perse la testa (e la raccolse)
23-05-2024, 00:05Il Post, santiPermalink.jpg.png) Desiderio è uno dei santi cefalofori, ovvero "portatori di testa": quei martiri che, una volta decapitati, raccolgono il capo con le mani e lo conservano per qualche tempo, di solito per portarlo nel luogo della sepoltura. Di santi così ce n'è parecchi: quando un secolo fa il folklorista Émile Nourry provò a contarli, ne trovò 134 soltanto nella letteratura agiografica di ambito francese. E per quanto non manchino esempi italiani (Emidio d'Ascoli, Donnino di Fidenza, Giusto di Novalesa), il cefaloforo più famoso è senz'altro Dionigi, vescovo di Parigi, decapitato a Montmartre, che con la testa in mano arrivò fino all'isola di Saint Denis. In questo e in altri casi, la leggenda può servire a conciliare due storie ambientate in luoghi diversi; a spiegare come mai certe ossa si trovavano in un certo luogo piuttosto che in un altro; e a ribadire che dovevano restare per sempre lì.
Desiderio è uno dei santi cefalofori, ovvero "portatori di testa": quei martiri che, una volta decapitati, raccolgono il capo con le mani e lo conservano per qualche tempo, di solito per portarlo nel luogo della sepoltura. Di santi così ce n'è parecchi: quando un secolo fa il folklorista Émile Nourry provò a contarli, ne trovò 134 soltanto nella letteratura agiografica di ambito francese. E per quanto non manchino esempi italiani (Emidio d'Ascoli, Donnino di Fidenza, Giusto di Novalesa), il cefaloforo più famoso è senz'altro Dionigi, vescovo di Parigi, decapitato a Montmartre, che con la testa in mano arrivò fino all'isola di Saint Denis. In questo e in altri casi, la leggenda può servire a conciliare due storie ambientate in luoghi diversi; a spiegare come mai certe ossa si trovavano in un certo luogo piuttosto che in un altro; e a ribadire che dovevano restare per sempre lì. Il caso di Desiderio sembra ricalcato su quello del vescovo parigino: nato a Bavari, che oggi è un municipio di Genova ma ai tempi era tutta campagna, Desiderio avrebbe fatto carriera a Langres, citta della Gallia lugdunense (la Francia orientale), diventandone il vescovo. Come tale gli spettava l'incombenza di cercare di trattare con il re vandalo che stava invadendo la Gallia, ma la trattativa non avrebbe avuto il successo sperato, e Desiderio sarebbe stato decapitato fuori dalle mura di Langres. Lui però intendeva essere sepolto dentro le mura, e quindi la leggenda ci racconta che raccolse la testa e rientrò, attraverso una fessura nella roccia che si aprì in quel momento (e che a Langres sarebbe tuttora esposta ai fedeli, anche se su internet non trovo niente).
La leggenda è poco attendibile, per una serie di motivi: ad esempio nel III secolo i Vandali erano già bellicosi sì, ma a centinaia di miglia più a est, sul Danubio; il loro supposto re, Croco, era in realtà re di altre tribù che effettivamente invasero la Gallia ma un po' più tardi; e infine è molto improbabile che un vescovo possa raccogliere la propria testa dopo la decapitazione. Siccome poi questo dettaglio è assente da una prima leggenda composta da un certo Varnacario nel VII secolo, il sospetto è che in questo come in altri casi la cefaloforia abbia un'origine per così dire didascalica, ovvero che si tratti di una storia nata per commentare un'immagine in cui il vescovo era ritratto con la testa in grembo: il che fino a un certo punto non significava che l'avesse raccolta davvero, ma che la mostrava ai fedeli e a Dio come segno del suo martirio, allo stesso modo in cui in certe raffigurazioni medievali e moderne i martiri esibiscono le loro mutilazioni, Lucia gli occhi, Agata i seni, Bartolomeo la pellaccia, eccetera: da questo punto di vista è coerente che un decapitato mostri la propria testa, anche se i più famosi (San Paolo, San Giovanni decollato) non lo fanno.
Queste raffigurazioni hanno un certo successo, più di pubblico che di critica, nel senso che nessun maestro del colore ha mai dipinto un cefaloforo interessante: è piuttosto quel tipo di immagine bizzarra che andava forte tra le guglie delle cattedrali gotiche, dove la gente cercava i mostri. A un certo punto qualche predicatore o guida turistica medievale deve aver cominciato a intrattenere i turisti/fedeli dando un significato storico a quella che in origine era un'immagine simbolica: non è un santo che mostra il suo martirio a Dio, ovvero sì, ma è anche un santo che davvero resse la sua testa in mano dopo che gliel'avevano tagliata.
Altre ipotesi sulla cefaloforia cercano di ricollegarla a miti precristiani, il che sarà pur vero per almeno qualche caso su centinaia; magari in Irlanda, dove le tribù celtiche avevano la sinistra fama di cacciatori di teste. Ma di teste tagliate che piangono e sussurrano ce n'è in tutte le mitologie, al punto che già Aristotele, nel suo trattato di zoologia (De partibus animalium) si sentiva in dovere di debunkare l'idea che una testa umana potesse continuare a parlare dopo essere stata mozzata – come pure si leggeva nell'Iliade, e nel mito di Orfeo. Probabilmente all'origine c'è un'immagine traumatica, uno shock ancestrale: una testa appena tagliata è soggetta a spasmi muscolari che danno l'impressione che sia ancora cosciente: le palpebre non si chiudono subito, e l'aria che entra dal foro della laringe può far vibrare le corde vocali e dare l'impressione che la testa voglia ancora dire qualcosa. E non è escluso che per qualche istante la testa voglia davvero dire qualcosa. Per tre, quattro secondi massimo. Poi basta.
La Madonna che veniva dal letame
08-05-2024, 12:43Il Post, madonne, santiPermalink8 maggio: Madonna di Pompei, immagine miracolosa
Le Madonne in giro per il mondo potrebbero dividersi in due fondamentali insiemi: le apparizioni e le raffigurazioni. Può essere difficile distinguerle perché il culto tende a eliminare la differenza: dove appare una Madonna, presto o tardi viene prodotta un'immagine, la quale in certi casi si lega all'apparizione al punto che i fedeli danno la sensazione di attribuire i miracoli più all'immagine che all'apparizione. Però in certi casi l'apparizione proprio non c'è, o viene inventata a posteriori (probabilmente è il caso della Vergine della Guadalupe): quello che all'inizio stimola il culto è una raffigurazione alla quale vengono attribuite proprietà miracolose. Una caratteristica peculiare di quasi tutte queste raffigurazioni è che sono in un qualche modo rovinate: a volte si tratta di relitti rinvenuti dal mare (come la Madonna Candelaria delle Canarie, o la Vergine dell'isola di Barbana). Si tratta di manufatti che sorprendono chi li trova, scolpiti o dipinti in stili sconosciuti che alludono a luoghi lontani e inimmaginabili – una madonna nera in Polonia, una bianca in Giappone. Il loro stesso rinvenimento ha qualcosa di miracoloso, un segno di Maria dallo spazio profondo. Questo spiega anche perché nell'età moderne questa tipologia di Madonne sia diventata più rara (senza sparire del tutto): man mano che il mondo si faceva più piccolo e interconnesso, scoprire madonne diverse e sconosciute diventava più difficile, tant'è che a partire dall'Ottocento Maria comincia a sentire l'esigenza di apparire direttamente ai fedeli. E però ogni tanto qualche Raffigurazione miracolosa continua a spuntare qua e là, sempre grazie ad avvenimenti fortuiti che scatenano un corto circuito: ad esempio a Sant'Anastasia (NA) un'immagine non molto riuscita della vergine si impone al culto dopo essere stata ammaccata da un giocatore di pallamaglio: un caso che sembra suggerirci che l'imperizia di un artista non basti. Perché un'immagine s'imponga alla venerazione deve intervenire qualche forma di danneggiamento più o meno volontario. Ed eccoci al caso della Madonna di Pompei.Una delle più famose madonne dell'Italia (e quindi della cristianità), ma anche di quelle più documentate: proprio alle pendici del Vesuvio, che è il vulcano più studiato del mondo, troviamo questa raffigurazione miracolosa di cui sappiamo apparentemente tutto: quando arrivò in loco (13 novembre 1875) e chi ne fondò il culto: il possidente Bartolo Longo, benefattore dai trascorsi bizzarri. Da giovane, ci raccontano gli agiografi, avrebbe aderito a una vera e propria setta satanica (o almeno satanica gli era parsa dopo essersene allontanato), diventandone un sacerdote e rimediandone una depressione causata forse anche dalla dieta che gli adepti si autoimponevano – sì, di tutti i satanisti al mondo Longo era riuscito a trovare quelli che digiunavano invece di gozzovigliare: che senso ha, vi chiederete, e forse se l'era chiesto pure lui, prima di incontrare i domenicani che lo avevano rapidamente convertito.
 |
| Dove scopriamo che il satanismo faceva almeno dimagrire. |
A Longo nel 1875 non mancava certo la liquidità, e a Napoli avrebbe sicuramente potuto trovare pittori in grado di produrre madonne di ottima fattura; persino a Pompei, dove la fame di souvenir dei turisti cominciava a richiamare artisti da tutto il regno, specializzati nel riprodurre gli affreschi antichi. Invece il domenicano padre Radente spinge Longo a bussare al Conservatorio del Rosario di Portamedina, dove suor Maria Concetta De Litala custodisce un vecchio dipinto che si rivela una crosta impresentabile: tarme, strappi, e inoltre la santa a cui la Madonna porge il rosario non è la domenicana Caterina da Siena, ma Rosa da Lima. Longo vorrebbe lasciarla lì, ma suor Maria Concetta insiste e così finisce per caricarla sul carretto. Questo carretto, gli agiografi ci tengono a ricordarlo, di solito trasportava letame: probabilmente trasportava qualsiasi cosa ci fosse da trasportare, ma in un qualche modo è importante ai fini della leggenda ricordare che la Madonna è arrivata a Pompei su un carretto del letame, quella cosa da cui nascono i fiori, comprese le rose (mentre dai diamanti non nasce niente). Una volta giunta a destinazione, Longo la fa restaurare da più specialisti: se ne avesse fatta fare una nuova gli sarebbe sicuramente costata meno, ma a questo punto abbiamo capito che è fondamentale che la Madonna venga da lontano, e abbia trascorsi misteriosi. Rosa da Lima diventa Caterina, e in breve la corona della Madonna comincia ad adornarsi di gioielli veri, donati dai pellegrini per grazia ricevuta. Nel secondo dopoguerra sono stati rimossi, perché contribuivano a deteriorare un dipinto che ormai è un palinsesto. Ma insomma: dal letame le rose, dalle rose i diamanti.
Intorno al volto incoronato della vergine compare un'aureola di dodici stelle, ripresa dal celebre passo dell'Apocalisse ("una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle"). Probabilmente l'autore dell'Apocalisse intendeva alludere alla Chiesa dei dodici apostoli o a Israele e alle sue dodici tribù; nel 1955 però una corona di dodici stelle viene proposta tra i bozzetti per il simbolo del Consiglio d'Europa: l'autore, Arsène Heitz, si dichiarerà in seguito fedele alla Madonna, ma probabilmente il richiamo alle dodici stelle era stato fortuito, se non pescato dall'inconscio. I membri del Consiglio d'Europa che approvarono il bozzetto ne ignoravano il riferimento mariano: e però per una coincidenza che delizia i commentatori cattolici, il bozzetto fu approvato proprio l'otto dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. Invece domani è il 9 maggio, festa dell'Unione Europea, che dal Consiglio d'Europa riprese la bandiera.
Lo stratagemma della vergine
12-03-2024, 22:45essere donna oggi, Il Post, italianistica, santiPermalink13 marzo: Sant'Eufrasia di Nicomedia, vergine astuta
Consegnata dai persecutori pagani a un boia che prima di tagliarne la testa intende stuprarla, Eufrasia promette al suo carnefice di preparare un unguento che lo renderà invulnerabile, come la pozione di Asterix; salvo che può essere preparato soltanto da una vergine. Il boia decide quindi di risparmiarla almeno finché il miracoloso unguento sarà pronto; credendo tuttavia di essere furbo, prima di spalmarselo chiede alla vergine di testarlo su sé stessa. Eufrasia obbediente si strofina l'unguento sul collo e dice al boia: prova a decapitarmi adesso, vedrai che non ci riesci. Il boia picchia più forte che può, ed Eufrasia perde la testa... ma non la propria verginità, che le era più cara.
 |
| Le strisce sono prese dal meraviglioso Orlando Furioso di Pino Zac, editoriale Il Corno 1975 (Credo sia fuori commercio). |
Now and Then, un falso d'autore
05-11-2023, 10:20arti contemporanee, beatles, Il Post, intelligenza artificiale, musicaPermalinkFuori concorso: Now and Then (Lennon 1977 / McCartney 2023)
Ogni tanto mi manchi. Se definisco Now and Then un falso d'autore, non è per litigare (ok, voglio anche litigare, su internet un po' di pepe è necessario) né per esprimere un giudizio di valore su una canzone che comunque ho negli orecchi da tre giorni, ce n'è di peggio in giro (ma anche di meglio). Non perché voglia discutere se due Beatles superstiti siano ancora "i Beatles", e sulla narrazione che hanno impostato per convincerci di questo (la storia la sappiamo: i nastri li ha regalati Yoko Ono a Paul, quindi John sarebbe stato d'accordo; George a dire il vero 26 anni fa ha rifiutato di completare Now and Then, però una minuscola particina di chitarra deve averla lasciata incisa, ecc.). Nemmeno voglio prendere una posizione sulla tecnologia adoperata per ricostruire la voce di John Lennon: la differenza tra voce recuperata da un vecchio nastro e voce ricostruita facendo ascoltare a un'AI migliaia di minuti di voce di John e chiedendogli "questa come la canterebbe" ormai è più filosofica che interessante. Niente di tutto questo, o un po' di tutto questo, ma soprattutto sento la necessità di valorizzarla, questa canzone. Come pezzo dei Beatles autentici se ne finirebbe credo sotto la centesima posizione della Grande Classifica (quella messa assieme sul Post, ehm ehm, dal sottoscritto); come falso d'autore, viceversa, è molto più intrigante, perché alla fine cos'è un falso d'autore? Un esercizio di stile, per prima cosa. Un artista decide di imporsi come limite lo stile di un altro artista.
Con Now and Then, Paul McCartney mette mano per la terza volta a un demo del suo antico compagno John Lennon. Nel primo episodio (Free as a Bird, 1995) aveva preso un ritornello di John e aveva aggiunto una sua strofa. Nel secondo (Real Love, 1996) non aveva aggiunto nulla. Nel terzo addirittura ha tolto qualcosa che John aveva composto: il ponte tra la strofa e il ritornello. Forse è questo l'indizio che cerchiamo per dimostrare che i Beatles originali non esistono più; quando ha composto la sua parte di Free as a Bird, Paul si sentiva ancora chiamato ad aggiungere qualcosa di creativo. Con Real Love già sembrava rassegnato a limitarsi a un restauro conservativo; con Now and Then invece si ritrova a dover eliminare quella parte lennoniana che non 'suona abbastanza Beatles', come fa un buon falsario, determinato ad autocensurare qualsiasi guizzo personale che minacci l'aderenza dell'opera allo stile che sta imitando. Il paradosso è che i Beatles, finché sono esistiti 'davvero', non hanno smesso di guizzare, senza troppo preoccuparsi di rispettare uno stile in continua evoluzione. Può darsi che Now and Then fili davvero meglio così, strofa-ritornello, strofa-ritornello, e poi uno stacco strumentale (effettivamente composto da Paul) che non esce dal seminato, anzi ne sviluppa le premesse. Certo, ha l'aria di una banalizzazione. Possiamo perfino immaginare che John avrebbe accettato il taglio proposto da Paul: nella storia della loro collaborazione ci sono anche casi in cui uno ha sforbiciato la canzone dell'altro. Dà comunque i brividi l'osservazione che nel ponte tagliato John cantasse "I don't want to use you or abuse you".
Quel che rende eccezionali i Beatles è proprio quello che rende discutibile un'operazione del genere, ovvero il fatto che non si siano mai riuniti davvero; che non abbiano mai avuto il tempo per diventare i falsari di sé stessi. Una sorte toccata a quasi tutti i loro compagni, e a tal proposito è fin troppo facile notare che qualche settimana fa è uscito un disco dei Rolling Stones. Ma se persino Jagger e Richards non hanno mai rinunciato del tutto ad aggiornarsi un po' (con risultati discutibili, ma umani), è lecito domandarsi: che musica farebbero oggi John e Paul, se il primo fosse vivo e il secondo non fosse preoccupato di dare al pubblico esattamente quello che il pubblico immagina di aspettarsi da lui e dall'amico fantasma? Prendi la strofa di Now and Then, così sospesa e irrisolta nella versione demo – dà veramente l'impressione che da qualche parte manchi un accordo. Un'incompiutezza assolutamente lennoniana, quel senso di vuoto che mi ha ricordato subito la prima sensazione provata davanti ad altre sue canzoni, Because, Across the Universe. È chiaro che da lì si può partire per imbastire la classica canzone beatlesiana; è chiaro che Paul si sentiva quasi obbligato, nel 1995 o nel 2023, a imbastire qualcosa del genere – ma se invece John si fosse detto ehi, facciamo una cosa alla Radiohead? Con una batteria campionata in stile Tomorrow Never Knows, con qualche synth buttato lì, perché no?
Se John fosse stato vivo, se lo sarebbe potuto permettere; e quella strofa si presterebbe. Anche il ponte. Il ritornello no, è veramente un richiamo all'ordine del Canone Pop Beatlesiano (che alla fine forse ci ricorda più gli ELO o i tardi XTC che i Beatles): però insomma da uno spunto come Now and Then si poteva partire per fare qualcosa di molto diverso dalla solita canzone strofa-ritornello che il pubblico si aspetta dai Beatles. Ingiustamente, perché i Beatles quel pubblico lo spiazzavano spesso e volentieri: Paul non osa più e non possiamo fargliene una colpa: ormai è di guardia a un monumento. La colpa è nostra, come sempre: cosa ci aspettiamo da uno spettro, se non che dica esattamente quello che vogliamo che ci dica? Now and then I miss you.
(È facile immaginare che si stia rivolgendo a Yoko, magari nella fase in cui si riconciliò con lei dopo il lost weekend. Ma è altrettanto facile, come in tante altre canzoni beatle, sovrapporre Paul a Yoko, e noi a Paul. Una delle prime cose che hanno capito quei due, quando erano ancora due ragazzini che improvvisavano pezzi in corriera, è che le canzoni devono parlare a tutti, devono parlare di tutti).
Il problema dei falsi è un falso problema. Se in casa tua c'è una riproduzione perfetta della Venere di Botticelli, in scala 1:1, tu e i tuoi ospiti possono vedere la Venere di Botticelli esattamente come se foste agli Uffizi. Se una canzone che imita i Beatles è bella come una canzone dei Beatles, che problema c'è se non l'hanno davvero scritta o incisa i Beatles, ma gli XTC? o i Rutles? gli Zombies? o Paul McCartney e Ringo col fantasma di John Lennon? (mentre il fantasma di George Harrison dalla cantina sibila "fuckin' rubbish", ma è sovrastato da una steel guitar ricostruita?) Se è una bella canzone – ma è una bella canzone? Eh, va' a capirlo. Coi Beatles di solito è facile, piacciono a tutti. Se però non sei sicuro che sia davvero dei Beatles, improvvisamente non sei più sicuro che ti piaccia. Se trovassi la Venere di Botticelli in scala 1:1, appesa nello spazio espositivo di un mobilificio, magari non ci faresti caso. L'hanno appena rubata dagli Uffizi e l'hanno messa lì: un nascondiglio perfetto, nessuno la degna di uno sguardo. Oppure l'hanno fatta dipingere a un'intelligenza artificiale col machine learning, ed è davvero uguale. E non interessa a nessuno, perché è solo una copia di Botticelli. Now and Then sembra veramente troppo una canzone dei Beatles. Il problema dei falsi è che devono somigliare ai veri. Questo limita molto le possibilità dei falsari, che a volte sono ottimi artisti – magari anche migliori degli autori degli originali. Oppure sono la stessa persona: capita a molti artisti di ridursi a diventare i falsari di sé stessi. Ai Beatles non era capitato – bella forza, stettero assieme soltanto una decina d'anni. Paul McCartney invece incide dischi da sessanta e probabilmente ha avuto tutto il tempo per rassegnarsi al fatto che una sola canzone incisa col fantasma di un vecchio amico verrà riprodotta e ascoltata milioni di volte più dei brani originali che continua a scrivere e incidere.
 |
| Ti sta piacendo questo pezzo? Lo sai che sulle canzoni dei Beatles ho scritto un libro intero? Non muori dalla voglia di impossessartene? |
Now and Then, come ci è stato ricordato in questi giorni, avrebbe dovuto uscire nel terzo volume dell'Anthology, quindi 26 anni fa, ma qualcosa andò storto. La spiegazione fornita in questi giorni da McCartney, che tutti danno per buona perché ormai contraddire McCartney è come offendere Babbo Natale, è che la voce di Lennon era registrata troppo male; mescolata a un pianoforte fastidioso e troppo compressa. Ragion per cui la canzone fu archiviata, finché una tecnologia più avanzata ha consentito di ricostruire una voce lennoniana separata dal pianoforte. Non voglio dire che McCartney ci stia consapevolmente mentendo – non oserei mai – ma non sarebbe la prima volta che ci fornisce una versione pacificata della realtà. Anche i primi due abbozzi erano registrazioni casalinghe, un aspetto che i singoli del 1996 non cercavano affatto di occultare. Anzi al tempo a funzionare era proprio questa dialettica tra la voce sgranata e appannata di John e gli arrangiamenti nitidissimi della produzione di Jeff Lynne – due sbiadite foto in bianco e nero messe in evidenza da due cornici smaglianti. Il risultato alla fine, per quanto macabro, non era diversissimo da un restauro conservativo: il morto faceva musica coi vivi, ma l'ascoltatore non poteva nutrire nessun dubbio su cosa cantasse il morto e cosa avessero aggiunto i vivi. Può veramente darsi che il demo di Now and Then fosse di qualità inferiore (non apparteneva alle stesse sessioni), così come può darsi, per esempio, che McCartney abbia dovuto rinunciare a lavorarci perché Harrison si era stancato (non sappiamo se il suo "fuckin' rubbish", si riferisse all'abbozzo di Lennon, al suo stato di conservazione, o all'arrangiamento a cui stavano lavorando). Fu l'ultima volta che Paul e George provarono a incidere una cosa assieme. George non lavorava volentieri con Paul.
Il passato non è una scala lineare: ci sono mesi che valgono decenni, e altri decenni che non sappiamo dove abbiamo buttato. Dà una certa vertigine constatare, ad esempio, che tra la pubblicazione di Now and Then e gli altri due brani postumi ci sono più anni di quelli intercorsi tra i due brani postumi e lo scioglimento dei Beatles. Nel frattempo non è cambiata semplicemente la tecnologia, ma anche il modo in cui (grazie alla tecnologia) possiamo interagire coi morti. Nel 1996 la voce sgranata di Lennon ci colpiva al cuore come una polaroid sbiadita recuperata dietro un armadio; un ricordo improvviso che per un attimo ci lasciava fantasticare su che musica avrebbero fatto i Beatles, se lui non fosse scomparso in quel modo così assurdo, se si fossero rimessi assieme. Nel 2023 ormai siamo assuefatti all'idea che Lennon sia ancora tra noi, come altri attori risuscitati in computer graphic: lo abbiamo visto al cinema in Yesterday, e ora lo sentiamo cantare, non più da un nastro gracchiante; si sente forte e chiaro, (perfino troppo chiaro: come fa notare Federico Pucci, Lennon di solito non lasciava la sua voce così diretta: la raddoppiava, la modificava). Il passo successivo, già adombrato in rete, è che si rimetta a scrivere canzoni. Forse in futuro Now and Then sarà considerata, più che l'ultima canzone dei Beatles vivi, la prima dei Beatles intelligenze artificiali. O magari l'anello di congiunzione tra le due fasi della loro carriera. Questo in parte potrebbe spiegare perché McCartney (e Ringo Starr) l'hanno voluta pubblicare – tanto prima o poi sarebbe uscita comunque, avranno pensato. Anche se la lasciassimo nel cassetto, prima o poi qualche nostro erede aprirà il cassetto, convocherà i nostri simulacri digitali e ce la farà suonare. Tanto vale farlo adesso, che siamo vivi. Magari per il resto del mondo non farà così tanta differenza; per noi sì. Come dar loro torto.
La barbuta crocifissa
19-02-2023, 23:31arti figurative, Il Post, miti, omofobie, santiPermalink20 febbraio: Santa Paola la barbuta, leggenda di Avila
 |
| Crocefisso di Santa Wilgefortis Museo diocesano di Graz By Gugganij - Own work, CC BY-SA 3.0 |
Una donna con la barba, quindi, è considerata più forte di una donna senza, ancorché indesiderabile. Che i digiuni scombinati intrapresi da alcune mistiche nei conventi potessero causare squilibri ormonali con annesse complicazioni tricologiche non è del tutto implausibile, ma la leggenda non sembra alludere a questo, né agli ermafroditi degli antichi miti (nessuna vergine barbuta risale a prima del 1200). La vergine barbuta potrebbe invece essere una di quelle leggende che nascono da un equivoco iconografico, ovvero in quelle situazioni in cui a un certo punto alcuni fedeli si trovano davanti un'immagine sacra che non riescono bene a spiegarsi: in questo caso una donna barbuta e crocefissa. Ma chi avrebbe mai crocefisso una donna barbuta, e perché?
 |
| Il Volto Santo di Lucca Di Joanbanjo - Opera propria, CC BY-SA 3.0 |
In questo caso l'equivoco potrebbe essere stato generato dalla circolazione di souvenir – sì, anche nel medioevo li fabbricavano e vendevano, ma nella maggior parte dei casi si trattava di riproduzioni di immagini sacre molto famose. Ad esempio i pellegrini che transitavano da Lucca (ed erano molti) avrebbero molto facilmente riportato a casa una piccola copia del Volto Santo, il crocefisso che è il vero simbolo della città, dall'origine piuttosto misteriosa. Secondo i lucchesi risaliva ai tempi di Gesù, e non era stato scolpito da mano umana: si tratterebbe invece di un'immagine acheropita, una copia 3D del corpo di Cristo ritrovata da San Nicodemo e in seguito salpata dalla Palestina su una nave senza marinai, e ritrovata presso il porto di Luni dai lucchesi. Per molto tempo abbiamo pensato che la leggenda coprisse un'origine orientale del crocefisso, che però resta tutta da dimostrare: lo stile è meno bizantino di quanto vorrebbe sembrare, e faceva propendere i critici per un rifacimento medievale di un oggetto più antico andato perduto. Nel 2020 un esame col carbonio14 ha messo in crisi questa ricostruzione: a quanto pare il Volto Santo è davvero un oggetto molto antico, risalente più o meno all'800. Può darsi che a quei tempi e in quei luoghi fosse normale scolpire un crocefisso completamente vestito dalla testa ai piedi, con una tunica dalle maniche lunghe: non ci sono rimasti molti crocefissi dello stesso periodo, mentre alcune immagini posteriori abbastanza simili sembrano proprio basate sul Volto di Lucca, che già prima del 1000 era diventato un'immagine molto famosa e diffusa. Perlomeno da questa parte delle Alpi, dove una riproduzione del Volto sarebbe stata facilmente interpretata come un crocefisso 'alla lucchese'.
Nel resto d'Europa invece questa immagine, emersa dalle tasche di qualche pellegrino, lasciava perplessi: la tunica sembrava più adatta a un corpo femminile. Questo avrebbe stimolato il fiorire di leggende, tra cui si sarebbe imposta quella della figlia cristiana di un re pagano che non volendo sposare il suo promesso sposo (pagano) avrebbe pregato fino ad ottenere da Cristo quella barba necessaria a sventare il matrimonio – per essere poi crocefissa dal padre deluso e disgustato. Messa in questi termini, la storia ha avuto un discreto successo fino al Cinquecento, quando le forme più estrose della religiosità popolare sono state messe al bando sia dalla riforma protestante che dalla controriforma cattolica: anche se Vilgefortis (invocata anche contro i mariti violenti) ha resistito in qualche martirologio fino al Concilio Vaticano II, e ad Avila Santa Paola si venera ancora.
Non è più tempo per i Rashomon
25-12-2021, 02:33cinema, essere donna oggi, Il PostPermalinkThe Last Duel, (Ridley Scott, 2021).
Normandia, 1386: si disputa l'ultimo duello giudiziario della storia francese. Il cavaliere Jean de Carrouges accusa l'ex compagno d'armi, Jacques Le Gris, di aver violentato sua moglie, Marguerite. Le Gris sostiene di avere avuto con la moglie di Carrouges un rapporto consensuale. La moglie invece sostiene... no, la moglie non 'sostiene': la moglie dice il vero. Fine. Non è che possiamo metterci lì a mettere in dubbio quel che dice una donna. Non siamo mica nel Medioevo...
 |
| Ma che ci vedono le donne in Adam Driver, bisognerebbe fare una ricerca seria su questa cosa |
Caro Babbo Natale, quest'anno vorrei la pace del mondo, la salute per tutti e un film sul Medioevo decente da proiettare in seconda media – prima di sbuffare, prova a dirmene uno. Visto? No, i draghi non valgono, no, nemmeno i cicli arturiani. Un film per mostrare ai ragazzi un mondo vero, che è esistito e che sicuramente era molto diverso dal nostro, ma in un qualche modo funzionava, coerente, verosimile: castelli, armature, servi della gleba, vorrei solo conservare in un angolo del loro immaginario un po' di arnesi medievali perché – non lo so neanche io il perché, ma in un qualche modo non mi sembra onesto lasciare che crescano senza. Non chiedo un capolavoro; anche solo un film a colori che abbia più senso delle Crociate di Ridley Scott, perché davvero lo so anch'io che fa acqua da tutte le parti: ma trovami qualcosa di meglio nella filmografia degli ultimi trent'anni. E lo so bene che Scott si intende poco di Medioevo – come d'altronde di qualsiasi evo: alla fine per lui è quasi sempre tutto un grande western con la Frontiera e i pistoleri che si vede che patiscono di non poter estrarre il revolver, di doversi vestire di ferro e sguainare ancora scomode spade – ma almeno sa mettere insieme uno spettacolo. Come dici?
Sì Babbo, lo so che ci ha riprovato anche quest'anno, l'ho visto l'Ultimo duello e mi dispiace che sia andato così male, in un qualche modo il Medioevo a Sir Scott porta sfiga ed è strano: di tanti posti dove ambientare un western sembra uno dei più congeniali al suo gusto per la meraviglia. L'abbiamo sempre saputo che per Hollywood la Storia è un fondale per mettere in scena in modo pittoresco i problemi di oggi: non è esattamente l'approccio storico che mi servirebbe, ma ha il pregio di tenere svegli anche gli spettatori che non siano patiti di cavalli e armature. Scott non dà l'aria di interessarsi di politica, eppure più i suoi film sono in costume, più le sceneggiature si ingombrano di ideologie. Il Gladiatore era il film perfetto per l'America imperiale post 11 settembre (è stupefacente che sia uscito l'anno prima); le Crociate per reazione s'intestardivano a immaginare un Regno dei Cieli multietnico e multiconfessionale. The Last Duel, vent'anni dopo, è un film su #meetoo e la rape culture così concentrato sul suo essere un film su #metoo e la rape culture che in certi punti lo spettatore esigente è portato a domandarsi: ma sul serio? Cioè mi stai davvero raccontando questo, in senso non ironico? Ecco: è un film senza ironia, una qualità che a Hollywood sta diventando merce sempre più rara e pericolosa.
The Last Duel vuole dire qualcosa di molto vero e attuale e vuole dirlo senza il minimo rischio di essere frainteso. Lo fa scomodando vicende di un secolo diverso, vissute da persone i cui valori erano molto diversi dai nostri – e pazienza: Hollywood si è sempre comportata così e forse è l'unico modo per portare nel Medioevo un po' di spettatori che non si farebbero attirare da un caso di cronaca medievale. Alla fine chiunque avrà imparato qualcosa: anche solo il fatto che a un certo punto del Medioevo i medici ritenessero l'orgasmo femminile necessario al concepimento ("It's science!": e tutto questo diversi secoli prima che altri medici, tra Sette e Ottocento, negassero la stessa esistenza dell'orgasmo femminile).
Dopodiché, caro Babbo, capisci anche tu che un film sullo stupro con un dibattito processuale sull'orgasmo, in seconda media, non lo posso mostrare. Ma sarei comunque contento di averlo visto. Il problema è un altro e te lo dico, caro Babbo, sir Scott stavolta non c'entra niente. Sì è più cupo del solito, certi tagli sono evidenti, il ritmo non è il massimo, ma gli perdonerei questo e altro. I colpevoli che non riesco a perdonare sono Ben Affleck e Matt Damon, che non paghi di aver voluto tirar fuori da un saggio di Eric Jager un blockbuster militante, hanno anche deciso di scomodare Rashomon. Proprio così, hanno voluto consegnarci il loro Rashomon, e magari sono persino convinti di esserci riusciti: il loro film problematico con tre versioni inconciliabili della stessa storia secondo i punti di vista di tre personaggi in conflitto. E i critici non si sono fatti sfuggire la cosa – anche perché ci sono persino le didascalie prima di ogni versione, insomma basta saper leggere le scritte grosse e alcuni sembra ne siano ancora in grado, sicché abbiamo veramente delle recensioni in cui The Last Duel è paragonato a Rashomon.
 |
| Lui però si ritaglia sempre la parte giusta |
Ora Babbo capiscimi, non si tratta di snobismo. Non ne faccio una questione tecnica, ma insomma Rashomon è un film che ci vuole dire che la realtà oggettiva non esiste, che ognuno ha la sua e che lo spettatore non necessariamente riuscirà a ricomporne una. È l'esatto contrario di quel che succede nell'Ultimo Duello, dove dopo aver sentito la campana del cavaliere Carrouges e quello di Jacques Le Gris, la didascalia ci avverte che tocca alla signora, e che la sua verità è "La Verità". Non lo dico io, Babbo, c'è proprio scritto così sullo schermo, affinché nessuno possa confondersi sulla morale del film: e la morale è che gli uomini si raccontano tante palle, per orgoglio o per invidia o persino per amore (ma più spesso per orgoglio e per invidia); le donne invece no, le donne dicono sempre la verità, tranne ovviamente quando non mentono per non finire sul rogo arrostite a fuoco lento. Dopodiché Scott può filmare castelli e armature con tutta la maestria che gli compete, ma l'impianto non funziona, e qui suggerisco a chi vuol vedere il film di non leggere oltre, perché... non so prendiamo Le Gris.
Il film ci spiega, con la sua manina leggera, che Le Gris è cresciuto in un sistema di valori che non gli consente di riconoscere uno stupro, nemmeno quando lo commette. Quando nella sua versione Marguerite fa resistenza, Le Gris è convinto che stia recitando un rituale di corteggiamento. E siccome in quel momento stiamo guardando la scena con gli occhi di Le Gris, dovremmo appunto vedere una Marguerite che vuole e non vuole, che civetta un po', una Marguerite cedevole che infine si concede all'amplesso. Se questo film fosse un vero Rashomon, dovremmo appunto assistere a questo: ma la vera notizia che porta al mondo il nuovo film di Ridley Scott è che i Rashomon in America non si possono più fare – e dire che fino a qualche anno fa erano quasi un tropo, molti telefilm avevano la loro puntata-Rashomon, House MD sicuramente ne ha una e persino Saranno Famosi – ma adesso no, adesso se vedessimo Marguerite concedersi e gioire potremmo equivocare. Qualche spettatore/trice sicuramente equivocherebbe, voglio dire, è statistica, e poi i Rashomon implicano appunto questo, che ognuno possa scegliere la versione che preferisce: ma ciò oggi è intollerabile, qualcuno twitterebbe che Ridley Scott ha girato un film che esalta la cultura dello stupro; che Affleck e Damon l'hanno scritto, che Driver l'ha recitato: insomma no, non si può fare, non è più tempo per i Rashomon, e così ci tocca guardare questa scena molto imbarazzante dove Le Gris vive il vertice della sua storia d'amore mentre ansima sulla schiena di una poveretta che nemmeno è riuscito a svestire. Non c'è nulla di veramente problematico qui, non c'è spazio per il dubbio che anzi va scacciato e al massimo individuato nei personaggi come una debolezza da debellare: le vittime sono serie, integerrime e sofferenti, i rei sono patetici. Alla fine il vero colpevole è il Medioevo: e la sua colpa è di non voler credere alle donne. E Babbo io non è che voglia difendere il Medioevo a ogni costo, lo so che era un periodo terribile per le donne, ma i film che condannano il passato in quanto passato ho sempre paura che servano a distogliere dalle responsabilità del presente.
Rashomon ci chiedeva di accettare che ogni Verità è parziale; l'Ultimo Duello ci nomina giudici onniscienti, davanti a due uomini che hanno deciso di scannarsi per contendersela. Alla fine, caro Babbo, quel che mi lascia è un po' di freddo amaro in bocca, per aver voluto controllare se davvero il cattivo viene punito come nel mio cuore avevo già desiderato. Ci sono anch'io sugli spalti, col sadico re di Francia. Mi dispiace Babbo, perché non è nemmeno un brutto film. Ma non è quello che mi serve.
Get Back sembra vero (ma non lo è)
03-12-2021, 02:46beatles, Il PostPermalinkC'è una scena del nuovo Get Back di Peter Jackson che ha già conquistato critici e spettatori: durante la prima puntata, mentre gli altri tre aspettano John Lennon cronicamente in ritardo, Paul si mette a improvvisare un brano su due accordi, che all'inizio non è niente e nel giro di qualche minuto diventa appunto Get Back. Il brano ci metterà ancora parecchio ad assumere la forma che conosciamo, passando attraverso numerose evoluzioni e ripensamenti (a un certo punto rischiò di diventare un brano 'politico' antirazzista, poi il timore di essere fraintesi mentre cantavano "want no Pakistani" li convinse a tornare a un più confortevole nonsense). Ma tutto sommato la melodia di Get Back è quella che prende forma in quei pochi minuti in cui Paul strimpella col basso e gli altri due lo seguono e annuiscono. Questo sembrerebbe fantastico anche se le immagini fossero quelle un po' sgranate della pellicola originale, e non rielaborate digitalmente per farci sembrare Paul George e Ringo veri come gli amici che abbiamo fotografato sabato scorso col telefono. Stiamo veramente vedendo dei geni al lavoro, mentre inventano qualcosa che prima non c'era e dopo sarà impossibile dimenticare. È tutto così vicino e limpido, è un miracolo.
È anche un trucco.
Non credeteci troppo.
Ovvero, sì: per una volta potrebbe davvero essere andata così: la melodia di Get Back potrebbe pure essere nata in quel momento. Anche in questo caso, la sensazione di essere lì con loro è del tutto illusoria. A un certo punto c'è uno stacco, la melodia prima non c'era, dopo c'è, in mezzo chissà quanti minuti sono passati. Get Back è un documentario lunghissimo e a quanto leggo i suoi meriti starebbero proprio nella sua lunghezza: si tratterebbe di una garanzia di autenticità. Quelli che vediamo dovrebbero essere davvero i Beatles catturati senza filtri, come in un reality show. Ma se i reality show ci hanno insegnato qualcosa è a diffidare di qualsiasi montaggio: la realtà è sempre più confusa dello show, nella realtà gli amici litigano e si riconciliano centinaia di volte, raccontando sciocchezze e ritrattandole immediatamente – nei reality sono i montatori a decidere quale sciocchezza diventa fondamentale, quale litigio diventa la frattura cruciale, chi è il buono chi è il cattivo e chi resta sullo sfondo. Nel gennaio del 1969 il regista Michael Lindsey-Hogg girò centinaia di ore di filmato, di cui solo pochi rulli fino a questo momento erano stati divulgati (su Youtube comparivano e scomparivano). Jackson ha selezionato cinquecento minuti: sono tanti, ma anche lui ha dovuto scegliere cosa salvare e cosa sacrificare od occultare. Inoltre, per realizzare il documentario ha dovuto ottenere il permesso dei Beatles viventi, e in particolare del Beatle che fino a quel momento si era sempre opposto a rimettere in circolazione il film del 1970: Paul McCartney. Il ri-montaggio dà a McCartney la possibilità di riscrivere un momento doloroso, se non traumatico, della sua carriera: negli studios cinematografici di Twickenham stava cercando di salvare i Beatles: non ci riuscì, anzi forse ne accelerò la disgregazione, e da allora con questa consapevolezza ha dovuto conviverci. Alzi la mano chi non approfitterebbe dell'opportunità di rimontare qualche episodio difficile del proprio passato, eliminando una parola di troppo, o un'intera frase, o un litigio, con la stessa artificiale facilità con cui qualche anno fa Paul ha tolto i violini da The Long and Winding Road.
Col tempo McCartney è diventato un sapiente narratore del suo passato. Ciò che lo fa sembrare attendibile è che riconosce i suoi limiti. Ha ammesso più volte di essere stato "bossy" in quegli anni, di aver tentato di prendere le redini del gruppo almeno per quanto riguardava la direzione artistica, dopo la morte del manager Brian Epstein. I giorni di Twickenham sono quelli in cui lui stesso fa i conti coi limiti di questo approccio. Non si capisce esattamente perché i Beatles si debbano rimettere a lavorare così presto – il Disco Bianco è uscito a ottobre – a meno che il divorzio non sia ritenuto ormai così imminente che ogni giorno è prezioso, ogni canzone potrebbe essere l'ultima e l'esibizione dal vivo, se davvero si farà, sarà sicuramente l'ultima. Persino Ringo, dei Quattro apparentemente il più rilassato, ha la sua carriera cinematografica a cui pensare: a fine gennaio comincerà a girare un altro film con Peter Sellers. Le prime sessioni vengono registrate e filmate proprio negli studi londinesi già prenotati per il film. A un certo punto si vede anche Sellers, sorridente ma visibilmente imbarazzato: tutto è filmato, qualsiasi battuta gli uscisse di bocca potrebbe finire nelle sale di tutto il mondo e la cosa non gli va, il grande comico fa scena muta. I Quattro sono più rassegnati a convivere con le cineprese ma forse si comportano in modo meno naturale di quello che crediamo. Per essere quattro ventenni milionari di Liverpool, è sorprendente quanto siano tutto sommato formali: solo a John scappa qualche parolaccia e qualche riferimento esplicito alle droghe.

Il gruppo sembra aver stabilito di usare le prime tre settimane di gennaio per mettere in piedi un'esibizione dal vivo con materiale per lo più originale: l'idea è invertire il metodo di lavoro del Disco Bianco, ripartire dal collettivo come Dylan che a Woodstock si è messo a incidere brani in cantina con la Band, George di recente è andato a trovarlo ed è rimasto estasiato. John però ha soltanto una canzone nuova da proporre, e persino George condivide il suo materiale di malavoglia. Paul da canto suo ha fin troppe idee e canzoni da parte: questo squilibrio rischia di far precipitare un progetto nato confuso e portato avanti con scarsa convinzione. In questa situazione, Paul a un certo punto potrebbe essersi messo a strimpellare il basso con due compari fino a tirarne fuori quel successo stratosferico che fu Get Back (in aprile avrebbe esordito al primo posto delle classifiche inglesi, negli USA avrebbe portato i Beatles a eguagliare il record di 17 singoli al primo posto della classifica di Billborard). Oppure il Paul 26enne potrebbe avere messo in scena questa 'invenzione' davanti agli altri due, fingendo di arrivare progressivamente a una melodia che in realtà aveva già chiara in testa chissà da quando – e il Paul quasi 80enne avrebbe tutto l'interesse a perpetuare l'illusione.
Mi è impossibile davanti a una scena così efficace non dubitare del montaggio e della messa in scena; non condividere lo scetticismo di James Alistair Taylor, quella volta che Paul mentre gli dava una lezione di composizione al piano improvvisò davanti a lui melodia e parole di Hello Goodbye: certo, potrebbe averla inventata sul momento... oppure potrebbe averla recuperata in quel momento per regalare allo spettatore un'emozione in più. Nel caso di Get Back, a Paul serviva una canzone che non sembrasse una "sua" canzone, qualcosa che gli altri non riconoscessero immediatamente come farina del suo sacco: anche John, che in quel momento non c'era e che nella versione finale suonerà l'assolo. Tutto sembra dire che Paul non voleva più essere il boss, che Paul stava volontariamente facendo un passo indietro, cercando la collaborazione dei compagni che sembrano per lo più svagati (John) e in certi casi ostili (George). Tutto vuole suggerire: vedete, io ci ho provato fino alla fine, ma loro non collaboravano più. Sembra tutto così vero, ma resta una ricostruzione di parte.

Era fin troppo prevedibile che McCartney avrebbe chiesto ai montatori di edulcorare l'amarezza di quelle sessioni che Harrison considerava "le peggiori di tutti i tempi" e Lennon addirittura definì un "inferno... le più miserabili sessioni al mondo". Eppure, come ha dichiarato Ringo, ci sono ore e ore in cui quattro ragazzi scherzano e suonano volentieri assieme: bastava scegliere di mostrare soprattutto quelle. Certo, nessun montatore avrebbe potuto eludere l'impressione di smarrimento e di confusione a Twickenham. Dopo la morte del loro manager nel 1967, i Quattro si stanno maneggiando da soli, almeno in teoria. In pratica sono circondati da professionisti assunti a vario titolo – di cui diffidano – che spingono per un finale con il botto, un concerto all'altezza della loro fama, magari in un anfiteatro africano. Tra di loro c'è il giovane regista Lindsey-Hogg, a cui non sembra vero di poter filmare la fine del gruppo più famoso del mondo (ha piazzato cimici persino nelle fioriere della mensa). Due dei quattro reagiscono con un'ostilità che nel documentario potrebbe sembrare più passiva di quel che non fu: Harrison continua a dire di no a tutte le proposte più impegnative. A un certo punto abbandona lo studio con un gesto che sembra inconsulto, ma che sarà risolutivo. Lennon appare più passivo, come se di fronte a una decisione ormai ineludibile abbia deciso di non scegliere, di lasciare che le cose intorno gli accadano. Mentre suona ha scelto la sedia che dà le spalle alla cinepresa; alla chitarra sembra collaborativo ma a parte Don't Let Me Down non ha molto da offrire, tanto che il gruppo decide di recuperare quella Across the Universe che dopo essere stata scartata come singolo era stata comunque pubblicata nel disco della WWF e quindi non era più un inedito.
Quel che il documentario di Jackson non dice – quello che Jackson sceglie di non dire – è che Lennon e Ono in quei giorni avevano una storia importante con l'eroina. Quando all'indomani della fuoriuscita di George, Lennon arriva come al solito tardi, e si giustifica spiegando che aveva un'intervista con un network canadese, ci fornisce un prezioso punto di riferimento: l'intervista in effetti è disponibile su Youtube con l'eloquente titolo Two Junkies Interview. I due rispondono alle domande con voce a tratti catatonica, fissando il vuoto: tra una sigaretta e l'altra Lennon lotta per resistere all'impulso del vomito. Qualche ora dopo lo troviamo seduto a scherzare tra Paul e Ringo e – potenza del restauro digitale – sembra persino in forma. Guarda dritto la telecamera, spara i suoi nonsense a raffica. Però quel giorno non si suona, e anzi i tre decidono di interrompere le riprese. Torneranno da George, che porrà come condizioni l'abbandono del freddo studio di Twickenham e delle ipotesi di concerti all'estero. Perlomeno questa era la ricostruzione più assodata fin qui, ma il documentario stempera anche questo dettaglio: nessun ultimatum, i quattro si ritrovano a casa di George e decidono assieme di cambiare rotta. Che George Harrison abbia costretto Paul McCartney a rinunciare a gestire i Beatles in un certo modo è una cosa che a distanza di più di 50 anni quest'ultimo non riesce ancora ad accettare. Il documentario resta un lavoro titanico e prezioso ma davvero, ogni volta che discutono, e litigano, o smentiscono di aver litigato, o inventano una canzone, godetevi tutto: il discorso, il litigio, e soprattutto la canzone – ma non credeteci troppo. Un reality non è la realtà, anche se ci suonano i Beatles.
Dieci anni in Paradiso
01-11-2021, 10:16anniversari, autoreferenziali, feste, Il Post, santiPermalink1° novembre – Tutti i Santi
A chi di voi legge abbastanza abitualmente il Post, può capitare ogni tanto di trovare in prima pagina un pezzo sul santo cattolico del giorno. Di solito li firmo io, e non parlano necessariamente del santo del giorno. A volte non è proprio il santo cattolico - a volte non è nemmeno un santo - a volte non parlano proprio di niente in particolare, ma insomma ormai sono una tradizione, da quand'è che sul Post escono questi pezzi? Da dieci anni. Auguri! Cioè in realtà il blog dedicato aprì dieci anni e quasi un mese fa (il primo pezzo era dedicato a Santa Teresina del Bambin Gesù), ma credo abbia più senso festeggiare nel giorno dedicato a tutti i Santi. Come passano in fretta dieci anni, ultimamente.
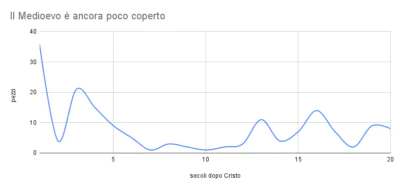 |
| Santi agiografati sul Post per secolo dopo Cristo. |
L'idea era molto più antica (ho degli appunti che risalgono al 2002) e ispirata, credeteci o no, all'oroscopo di Internazionale, sì quello di Bob Brezsny che in realtà credo di avere smesso di seguire proprio verso il 2002 quando ho capito, e mi ci è voluto pure un po', che non era ironico, che ci credeva davvero. Ma insomma il concetto era simile: decostruire una delle classiche rubriche da quotidiano, usarla come cavallo da Troia per scrivere tutto quello che mi andava. Ovviamente i santi non hanno l'appeal dell'oroscopo, ma non bisogna sottovalutare che ogni giorno è l'onomastico di qualcuno - certo, è un discorso che funziona finché si dedicano pezzi a Francesco o a Teresa, non ad Agabo o a Gwynllyw. In ogni caso il nome più gettonato fin qui è Giovanni: Giovanni Bosco, Giovanni Nepomuceno, Giovanni decollato, Giovanni da Copertino, Giovanni Paolo II, Giovanni Damasceno, Giovanni Evangelista e non dimentichiamo che anche Francesco d'Assisi in realtà si chiamava Giovanni (c'è anche un pezzo su Giovanni Lindo Ferretti, che però non è ancora esattamente un santo, anzi spero lo diventi il più tardi possibile). Tra i nomi femminili probabilmente vince Maria, non solo perché alla madre di Dio sono già stati dedicati nove pezzi, ma anche grazie a Maria Maddalena, Maria Goretti, Maria Egiziaca, Marguerite-Marie Alacoque e perché no? Jean-Marie Vianney.
 |
| Provenienza geografica (se i confini fossero sempre stati quelli del 2021). |
Ho messo un link al primo pezzo ma è molto difficile che funzioni - come notano gli esperti, Internet come archivio è una frana. In particolare dopo due o tre anni il Post fece un restyling generale e non vorrei che sembrasse una critica, insomma lo so che sono cose inevitabili, ma i link più vecchi non funzionano più e alcuni pezzi sono visibili solo parzialmente, perché erano divisi in pagine. A volte penso che dovrei mettere a posto tutto, un pezzo alla volta. Altre volte penso che si farebbe prima a ripartire da capo. Ho cominciato entrambe le cose e mi sono interrotto entrambe le volte. Sul mio vecchio blog personale ho ricopiato quasi tutti i pezzi, ovviamente modificando le cose di cui mi vergognavo di più e a volte smontando e rimontando cose qua e là e ora il risultato è che in giro per il web ora ci sono due o tre versioni dello stesso pezzo. Una cosa molto medievale, tutto sommato.
Ho detto medievale? Quando ho cominciato ero convinto che avrei parlato soprattutto di Medioevo, ma a quanto pare non è stato così. Anche se la media di tutti i pezzi (inclusi quelli dedicati ai patriarchi e ai profeti della Bibbia, la cui datazione è abbastanza incerta) mi dà come risultato il 745 dC, i secoli più visitati in assoluto sono il primo (una ventina di pezzi è dedicata a personaggi del Nuovo Testamento) e il terzo, il secolo ruggente dei martiri. Il personaggio più antico sarebbe Isacco: quello più recente, sia per età che per canonizzazione, Giovanni Paolo II, non a caso soprannominato "Santo subito". Il secolo medievale più frequentato è il Duecento, grazie agli ordini mendicanti. C'è un altro picco più difficile da interpretare nel Cinquecento. La contemporaneità (Otto e Novecento) si difende bene: una ventina di santi su... a proposito, quanti santi abbiamo coperto fin qui?
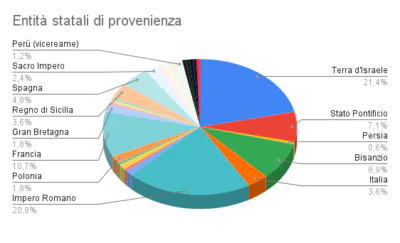 |
| Santi per cittadinanza, un grafico che non ha moltissimo senso. |
Il conto è difficile. Occorre detrarre i pezzi in cui davvero il santo era un mero pretesto, e i casi in cui ho voluto trattare da santo un personaggio che non lo è, o un santo che la stessa Chiesa ha riconosciuto come mai esistito (Simonino). Ma è capitato anche il contrario, ovvero che uscisse sul Post un pezzo su una santa che ancora non lo era (Angela da Foligno) e qualche anno dopo lo è diventata. Al netto di ciò il conteggio dice 10243, a cui bisogna evidentemente detrarre le diecimila vergini che secondo la leggenda sarebbero state martirizzate con Sant'Orsola (ma è probabile che si tratti di un errore di traduzione). Se evitiamo di contare anche i 40 martiri di Sebastea e i 26 compagni di Paolo Miki (questi ultimi purtroppo furono crocefissi davvero in Giappone, non è una leggenda) si arriva al comunque ragguardevole totale di 178: a questo punto l'obiettivo di farne almeno 365 non sembra poi così lontano. Speriamo che i prossimi dieci anni non scorrano ancora più veloci. Abbiamo 60 martiri (più i 40 di Sebastea), 42 vergini, 35 vescovi, 113 eremiti, sette monaci (per lo più benedettini), sedici frati (con una netta preponderanza dei francescani), 19 religiose, soltanto quattro gesuiti, 13 personaggi dell'Antico Testamento tra cui sette profeti; 14 teologi, 5 apostoli; l'unica categoria che si può dire chiusa è quella degli evangelisti, quattro su quattro.
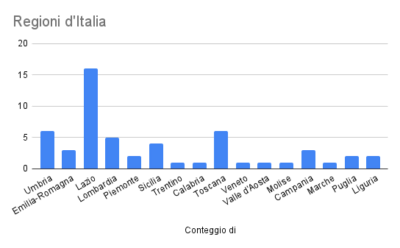 |
| Santi italiani per regione |
Da dove vengono i Santi di cui qui si è parlato? Qui il conto è complicato dal fatto che in duemila e più anni i confini sono cambiati e di molto, al punto che una delle nazioni più rappresentate sarebbe la Turchia: che però al tempo dei dieci santi in questione non si chiamava ancora così, dato che i turchi vivevano altrove. In ogni caso, se decidiamo di applicare arbitrariamente i confini di oggi a tutti i santi di tutte le epoche, scopriamo che un terzo del totale proviene dalla cosiddetta Italia. All'interno di quest'ultima, il Lazio è decisamente la regione più venerata, e in generale metà dei Santi proviene dal centro, tra Toscana e Abruzzo. La seconda nazione contemporanea, con un quinto del totale, sarebbe Israele, e non sorprende: al terzo la Francia, al quarto appunto la Turchia. Se invece proviamo ad assegnare a ogni santo la cittadinanza che gli sarebbe spettata alla nascita... entriamo in un ginepraio di questioni oziose; diciamo che prevale la nazionalità ebraica, da Isacco a San Pietro, sempre con un quinto del totale: al secondo posto l'Impero Romano classico, quello che crolla ufficialmente nel 476. Ma è un dato che non dice un granché. Più rilevante contare i santi per sesso: risulta che tre su quattro sono maschi, e se probabilmente sul calendario il rapporto è appena un po' meno sbilanciato in loro favore, mi sembra incredibile aver dedicato 42 pezzi a delle sante, insomma a delle donne: mai me ne sarei creduto capace. A proposito di sessi bisogna rilevare che anche in una categoria come quella dei santi, che non si segnala certo per fluidità, i casi di ambiguità sono meno infrequenti di quel che si potrebbe pensare: abbiamo almeno tre santi rivendicati come patroni dalla comunità LGBT (Sebastiano, Sergio e Bacco) oltre a tre crossdresser, se includiamo nella categoria oltre a Marina e Vitaliano anche Giovanna d'Arco, dato il peso che la scelta di vestire abiti maschili ebbe nella sua incriminazione.
 |
| Non riapriamo l'annoso dibattito |
Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno letto fin qui e scusarmi per tutte le volte che mi avete chiesto qualcosa e non vi ho risposto per ignavia o sbadataggine: prometto che d'ora in poi sarò più sollecito ecc. Ringrazio i redattori del Post, che mi hanno corretto tante cose, e il peraltro direttore che mi ha sempre lasciato libero di scrivere qualsiasi sciocchezza: un onore che ho ripagato scrivendone molte, e molte ancora spero di scriverne. Certo, lo sappiamo tutti, Brezsny è su un altro livello, ma si fa quel che si può. Alla prossima.
Sergio e Bacco: santi, sposi e gay?
07-10-2021, 02:36Il Post, omofobie, santiPermalink7 ottobre: Santi Sergio e Bacco, martiri e patroni dei matrimoni gay
 |
| Robert Lentz, 1994 Icona per il gay pride di Chicago |
Si sa che le torture delle storie di martiri si assomigliano un po' tutte, per via che gli agiografi si leggevano tra loro e si copiavano spesso. Di santi frustati e bastonati ce n'è tanti, ma di santi costretti a vestirsi da donna ci sono solo questi due graduati dell'esercito, la cui amicizia fraterna è spesso sottolineata nelle icone da un altro elemento inusuale: le due aureole appaiono intrecciate. Del resto è lo stesso Bacco, apparendo a Sergio la notte prima del martirio, a dare l'impressione di non poter salire in cielo senza di lui, tradendo una certa fretta che il sacrificio si completi. Insomma Sergio e Bacco – che in Oriente diventarono santi molto popolari dopo il quarto secolo – sembrano comportarsi come una coppia. Prima qualcuno avrebbe avanzato l'ipotesi: e se fossero quel tipo di coppia? E se questa fosse stata la loro vera colpa, taciuta dagli agiografi ma rivelata indirettamente dal bizzarro castigo escogitato dall'imperatore: la parata in vesti femminili, una parodia del matrimonio?
 |
| Santo Sergio (basilica di San Demetrio a Tessalonica) |
L'ipotesi di Boswell è stata più volte smontata, anche da studiosi che riconoscono il valore pionieristico delle sue ricerche: e però non è difficile capire perché sia stata abbracciata da molti militanti LGBT. Per Foucault, semplificando brutalmente, l'omosessualità come la intendiamo oggi è un costrutto sociale: esiste finché esiste la nostra società, che è tutt'altro che una società ideale. Per Boswell l'omosessualità è qualcosa di più vicino a un dato di natura: ne sono esistiti in qualsiasi società, e hanno sempre variamente cercato di ottenere un riconoscimento della loro condizione e delle loro relazioni. Per quanto labili siano le prove, la teoria ha il pregio di venire incontro alle aspirazioni di tanti desiderosi di conciliare la propria omosessualità con la fede cristiana; magari è solo una leggenda, ma non più di qualsiasi altra leggenda di santi: esiste perché qualcuno ne ha sentito il bisogno. Nel 1996 un pittore frate francescano (e gay), Robert Lentz, dipinse per il gay pride di Chicago un'icona dei Santi Sergio e Bacco che divenne immediatamente il pezzo più riprodotto del suo catalogo. I due santi di Lentz sono trentenni di aspetto atletico, com'è lecito del resto immaginare due ufficiali dell'esercito, ma molto diversi da quelli tramandati dall'iconografia bizantina, che invece ne sottolineava gli aspetti quasi femminei.
 |
| Il Cameo "Rothschild": ritratto di Onorio e moglie e (in seguito) di Bacco e Sergio |
A un certo punto gli stessi bizantini potrebbero aver cambiato paradigma e avuto problemi a interpretare le loro vecchie icone (magari tra una crisi iconoclastica e l'altra): capita così che a Costantinopoli un cameo che in origine raffigurava probabilmente l'imperatore Onorio e sua moglie venga ridedicato a Bacco – la figura maschile – e a Sergio: a quest'ultimo tocca la figura in precedenza femminile, più piccola. Chi incise i nomi dei due santi sul cameo forse aveva ancora più difficoltà di noi a riconoscere la sessualità di un personaggio che, pur ornato di orecchini, sfoggiava capelli insolitamente corti: oppure non ebbe altra scelta, se voleva salvare il cameo doveva trasformarlo in un'immagine di santi, e una coppia di santi maschio e femmina non esisteva, non era prevista. E siccome molte storie di santi non nascono prima delle immagini, ma per spiegare le immagini (vedi San Nicola), non è escluso che l'episodio del mascheramento dei sue santi sia stato inventato da un agiografo proprio per spiegare come mai in un mosaico o in un affresco i due venivano raffigurati in uno stile che già nel V secolo poteva sembrare troppo femminile.
Giona: ti sembra il caso di prendertela così?
20-09-2021, 17:54apocalittici e integrati, Bibbia, Il Post, santiPermalink21 settembre – Giona, profeta suo malgrado
La Bibbia, letterariamente parlandone, non è che sia questo capolavoro: ma quello che la rende più verosimile di tanti altri libri è l'incoerenza. Bel paradosso. Non c'è dubbio che Iliade e Odissea siano più armoniche – e se poi parliamo di coerenza narrativa, Il Signore degli anelli lascia piste a tutte e tre. Ma se in giro nessuno crede più all'esistenza di Achille o Ulisse, e nessuno ha mai per un attimo preso sul serio l'esistenza di Sauron, è proprio perché si vede benissimo che sono storie con un inizio, una fine, e quasi sempre una morale. La Bibbia, beh, non proprio. La Bibbia è evidentemente una raccolta di libri scritti da mani diversissime, rivisti da traduttori e compilatori che avevano idee talvolta opposte, e messi assieme da editori che avevano criteri ancora diversi, e a fare tutto questo potrebbe esserci voluto un millennio: per cui alla fine più che una storia è uno scrigno pieno di roba che per quanto stia lì da secoli lascia sempre questa impressione di materiale raccolto alla benemeglio da qualcuno che stava scappando da un incendio, un'alluvione, una scorreria dei Caldei. Se apri l'Iliade trovi sempre duelli e litigi; se apri la Bibbia puoi trovare a distanze di poche pagine teorie sulla creazione, pagine di censimenti, storiacce di donne e predoni, dibattiti sul senso della vita, poesie d'amore, cronache storiche, profeti preoccupati dalla corruzione dei costumi, e il Libro di Giona: il quale potrebbe essere anche solo una presa in giro.
 |
| Dio parla con Giona, seduto fuori dalla città di Ninive, salterio armeno del XVII secolo, immagine di dominio pubblico |
"Libro" poi si fa per dire, sono tre o quattro paginette, ma è come se mettessero tra virgolette tutto il resto della Bibbia: e se fosse tutto uno scherzo, di Dio o di chi racconta? I cristiani lo piazzarono verso la fine dell'Antico Testamento, perché Giona sembra il profeta più vicino a una certa concezione di Gesù, e Gesù stesso a chi gli chiedeva un "segno" aveva accennato al "segno di Giona" (Matteo 12,40): così come il profeta era rimasto nel ventre di un pesce per tre giorni e tre notti, così dopo tre giorni Gesù sarebbe riemerso dal mondo dei morti. Nella Bibbia ebraica invece la storia di Giona appartiene al libro dei Profeti Minori, di cui Giona sembra però una parodia. Mentre tutti gli altri libri profetici contengono, non sorprende, profezie, quello di Giona sin dalla seconda riga dimostra al lettore che vuole essere qualcosa di diverso: un racconto. C'è da dire che l'ipotetico del lettore della Bibbia a questo punto di profezie dovrebbe averne lette centinaia, per cui dopo aver ammirato lo stile di Isaia, la verve di Geremia, la visionarietà di Ezechiele, potrebbe essere subentrata una certa stanchezza – alla fine si tratta perlopiù di ammonizioni nei confronti di uno o più popoli che non amano Dio come dovrebbero; minacce, lamenti, prefigurazioni di sventura, non è che non ci siano variazioni sul tema ma insomma la canzone è quella.
Il libro di Giona parte appunto da questa saturazione. È una specie di pausa riflessiva organizzata da qualcuno che potrebbe essere vissuto anche parecchio più tardi e che questi profeti li conosceva bene, forse li leggeva di mestiere. In Giona le profezie sono date per scontate, stanno in due righe: quello che interessa all'autore è il contesto: come si comporta il profeta che le deve enunciare, e il pubblico che le ascolta? O meglio: come ci aspettiamo che si comportino? Ipotizziamo che si comportassero in un modo diverso: cosa succederebbe? E se il profeta non avesse voglia di fare il profeta? E se il popolo, che per definizione non ascolta mai il profeta e non si pente dei propri peccati, decidesse invece di farlo? Il libro di Giona è questo: un piccolo grande What If, un esperimento mentale e narrativo. Sarà anche per questo che a differenza di tutti i cartigli profetici che lo circondano, ci suona più contemporaneo. Gli altri profeti si lamentano, minacciano, vaticinano: l'autore di Giona racconta una storia e sorride.
1,1 Fu rivolta a Giona figlio di Amittai questa parola del Signore: «Alzati, va' a Ninive la grande città e in essa proclama che la loro malizia è salita fino a me». 1,2 Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore.
Vedete, bastano davvero i primi due versetti. Il primo sembra in tutto e per tutto il classico incipit del profeta minore: il Signore parla a un Tale figlio di un altro Tale e gli ordina di andare presso la tal città di peccatori, che sta per essere distrutta come Sodoma, Gerico, Babilonia... a questo punto lo sappiamo bene cosa succede alle città che continuano a dispiacere a Dio malgrado gli avvertimenti I nomi sono presi da altri libri della Bibbia, il che tradisce l'intento narrativo: un profeta di nome Giona è brevemente menzionato nel Secondo Libro dei Re (dovrebbe essere vissuto nel IX secolo aC), mentre Ninive era stata una capitale dell'impero Assiro. Il secondo versetto spiazza tutto l'impianto, perché stavolta il profeta in questione disobbedisce: Dio gli ha dato una missione, Giona preferisce di no. Fin qui i profeti hanno sempre detto di sì al Signore, però con dubbi e timori che ci autorizzano a pensare che dire di sì al Signore sia qualcosa di faticoso, di eroico: ma l'eroismo implica una libera scelta. Se chi dice di sì al Signore è un profeta, una persona eccezionale, ne consegue che non possiamo essere tutti eccezionali, e che dunque a un uomo non eccezionale dovrebbe essere concesso rifiutarsi a Dio. Perlomeno Giona decide di scappare; il che è buffo, dato che il Signore è dappertutto.
Ma perché Giona non vuole obbedire? Non è subito chiaro, il che ha alimentato interpretazioni molto diverse, compresa quella nazionalista: Giona non vorrebbe convertire i Niniviti perché sono nemici degli Ebrei, e non tollererebbe l'idea che Dio per mezzo suo dia loro una possibilità di redimersi. È un'idea di San Girolamo, che Martin Lutero riprende in chiave antisemita: Giona rappresenterebbe l'ebreo geloso del suo Dio e dell'esclusiva alleanza che ha stretto col suo popolo. E però da nessuna parte nel piccolo libro si legge che gli Assiri stessero attaccando Israele: certo, da altri libri sappiamo che è storicamente accaduto, del resto tutti gli altri popoli nella Bibbia ci stanno apposta per attaccare e opprimere Israele. Ma l'autore non spende una sola parola per accreditare questa interpretazione: Giona non sembra avere a cuore il suo popolo o qualcun altro a parte sé stesso. È un uomo solo a cui Dio affida una missione, e che non la vuole. Può l'uomo rifiutare questo a Dio? Esiste insomma il libero arbitrio? L'autore di Giona non sembra crederci troppo: il profeta riesce a imbarcarsi, ma la nave va incontro a una furiosa tempesta. I marinai capiscono subito che un Dio ce l'ha con loro, e per riconoscere quale tirano a sorte. Viene ovviamente estratto Giona, che capisce di non avere scampo e propone di essere buttato in mare. I marinai non accettano subito l'idea: ma siccome la tempesta non cessa, si rassegnano (non dopo aver pregato il Dio di Giona perché li perdoni, loro in fondo non fanno che quello che è richiesto dalla divinità o dall'autore del racconto). Il sacrificio funziona: il mare si calma, Giona va a fondo ma Dio manda un enorme pesce a inghiottirlo.
 |
| Giona viene buttato a mare, Catacomba di Priscilla, foto di dominio pubblico |
Nel ventre del pesce Giona intona un canto di speranza che è il vertice lirico del libro: "Nella mia angoscia ho invocato il Signore ed egli mi ha esaudito; dal profondo degli inferi ho gridato e tu hai ascoltato la mia voce". Giona sembra avere imparato la lezione: una volta rigurgitato dal pesce sull'asciutto, riceve di nuovo dal Signore l'ordine di servizio e si reca ubbidiente a Ninive.
La città è un incubo kafkiano, troppo grande per essere vera: per percorrerla tutta servono tre giorni di cammino, insomma Los Angeles, e Giona deve attraversarla continuando ad annunciare il preavviso di Dio: "Ancora quaranta giorni e Ninive sarà distrutta". Quante possibilità ci sono che i Niniviti lo ascoltino? Se abbiamo già letto un po' di Profeti lo sappiamo: nessuna. La punizione è troppo solenne, i peccati evidentemente troppo gravi, la popolazione immensa, Giona è un uomo solo, e di malavoglia. Non possono salvarsi, è troppo tardi.
Ma se invece decidessero di ascoltare il Signore? Perché per la prima volta in tutto l'Antico Testamento, l'autore sceglie di percorrere questa via. I Niniviti si pentono tutti, dal primo all'ultimo e persino gli animali; lo stesso re smonta dal trono e si affretta a emanare un editto in cui impone a cittadini (e persino gli animali) di astenersi dal cibo, vestire di sacco ed espiare i gravi peccati che, tra l'altro, nessuno ha ancora spiegato quali siano, sono soltanto un mcGuffin per fare andare avanti la storia. Del resto, se Dio ha mandato Giona, significa appunto che voleva dare ai Niniviti un'ultima possibilità; se i Niniviti approfittano della possibilità, Dio non può che "pentirsi del male che aveva minacciato di far loro" e revocare la distruzione. Tutto è bene quel che finisce bene – salvo che Giona preferirebbe di no. È offeso a morte.
Ma Giona ne provò grande dispiacere e ne fu indispettito. Pregò il Signore: "Signore, non era forse questo che dicevo quand'ero nel mio paese? Per ciò mi affrettai a fuggire a Tarsis; perché so che tu sei un Dio misericordioso e clemente, longanime, di grande amore e che ti lasci impietosire riguardo al male minacciato. Or dunque, Signore, toglimi la vita, perché meglio è per me morire che vivere!"
Che senso ha una scenata del genere? Se lo domanda persino Dio: "Ti sembra giusto essere sdegnato così?" Una spiegazione è sempre quella nazionalista: i Niniviti sono nemici degli Israeliti e per averli salvati Giona si sente ora un traditore dei suoi... ma non convince. Forse Giona è scontento perché il libero arbitrio sembra andare in una sola direzione: Giona non era libero di sottrarsi alla missione, mentre i Niniviti sembrano liberi di sottrarsi col proprio pentimento a una catastrofe che Dio aveva già predisposto per loro. Oppure, semplicemente, a Giona l'idea di una catastrofe non dispiaceva. In effetti anche dopo il perdono di Dio, che cosa fa? Esattamente quello che ci aspetteremmo dal classico profeta di sventura: esce dalle mura e resta a una prudente distanza, a osservare se per caso non arriva un terremoto o un diluvio o un fulmine. E intanto chiede a Dio la morte.
Questa posa querula e accigliata è la definitiva presa in giro dell'atteggiamento convenzionale del profeta: l'autore di Giona li conosce bene e forse ha cominciato a domandarsi se sotto le loro barbe non covi una certa ipocrisia. È davvero così affranto, il profeta-tipo, di vedere il popolo andare in malora? Non ci sta provando gusto, perché questo lo rassicura del suo essere migliore? E questo compiacimento interiore, la sicurezza di avere ragione mentre il popolo sguazza nel torto, sarà cosa davvero gradita a Dio? Lo stesso Dio, da che parte dovrebbe stare: col profeta che si sente l'unico uomo giusto, o con un popolo peccatore che riconoscesse i suoi errori?
 |
| Giona e la balena, di Pieter Lastman, riproduzione di dominio pubblico (non lo sta inghiottendo, lo sta rigurgitando). |
Dio ha salvato una città, anche grazie al lavoro di Giona: ma Giona avrebbe preferito di no. È stanco, ha la sensazione di avere lavorato molto senza ottenere quello che per un profeta è lecito attendersi: un bel disastro da contemplare sdegnato all'orizzonte. Fa anche un po' caldo, Giona cerca di ripararsi ma non c'è molta frasca nel deserto. Dio allora fa crescere per lui una pianta – non sappiamo di che specie, perché il suo nome, kikayon, compare solo qui in tutta la Bibbia. Spesso è tradotta come il ricino, ma non è così importante. L'importante è che questa pianta dà a Giona un po' di sollievo, addirittura di gioia. Allora Dio la uccide.
Sembra veramente che Dio se la prenda soltanto con Giona: tutti gli altri meritano il suo perdono, che siano marinai pagani o Niniviti peccatori. Solo Giona viene sempre tormentato, e quando ricomincia a lagnarsene, Dio ha la faccia tosta di chiederglielo: ma ti sembra il caso di lamentarti per una semplice pianta di ricino? Giona conferma di sì, che è sdegnato al punto di morirne: solo allora Dio gli svela di essere non essere che il protagonista di una parabola, un brontolone ideato apposta per servirGli su un piatto d'argento la risposta finale.
«Tu ti dai pena per quella pianta di ricino per cui non hai fatto nessuna fatica e che tu non hai fatto spuntare, che in una notte è cresciuta e in una notte è perita: e io non dovrei aver pietà di Ninive, quella grande città, nella quale sono più di centoventimila persone, che non sanno distinguere fra la mano destra e la sinistra, e una grande quantità di animali?»
L'Antico Testamento sta per cedere il passo al Nuovo: il Dio che nei primi libri sembrava una presenza terribile, gelosa e vendicativa sembra diventato un altro, una persona talvolta imprevedibile ma di buon senso, disponibile a rivedere le sue decisioni, più affezionato ai peccatori che a chi fa loro tutto il tempo la morale. Ama persino gli animali, il Libro finisce con questa precisazione che sembra un'inezia e non lo è: anche loro si sono pentiti, anche loro meritano il perdono. Tutti lo meritano, persino Giona che dovrebbe scendere dal suo piedistallo e capire che Dio sta facendo per Ninive quello che ha fatto per lui quando era nel pesce: offrire una seconda possibilità. Se i primi autori della Bibbia avevano chiaramente un rapporto complesso con padri autoritari e bizzosi, si intuisce che i tempi sono cambiati, i padri si sono addolciti o comunque si sente in giro la necessità di padri buoni, misericordiosi, persino un po' ironici, padri che abbiano creato il mondo perché questo li rendeva felici, come l'ombra ci rende felici quando siamo nel deserto.
Non sappiamo se Giona abbia imparato la lezione: l'importante è che l'abbia intesa il lettore. Subito dopo comincia il Libro di Michea, un altro rotolo di furenti minacce per le genti di Samaria e Gerusalemme che non ascoltano la Parola del Signore. Insomma è stata solo una pausa di riflessione. Molto utile, per me almeno. Spero anche per voi.
Gesù e i suoi fichi
23-08-2021, 16:47Bibbia, Cristo, Il Post, santiPermalink |
| Santi Giovanni e Bartolomeo (Dosso Dossi) (nessun fico rilevato) |
Natanaele (in ebraico Dio ci ha dato) è un apostolo di Gesù, perlomeno nel vangelo di Giovanni; nelle liste degli altri vangeli non compare, ma è tradizionalmente identificato con Bartolomeo. Natanaele è di Betsaida come gli apostoli Pietro, Andrea e Filippo: quando quest'ultimo comincia a parlargli del nuovo messia arrivato in paese ("Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti: Gesù da Nazaret, figlio di Giuseppe", Gv 1,45), Natanaele risponde sprezzante: da Nazaret non può venire niente di buono. Nazaret era in Galilea, Betsaida nella regione del Golan, entrambe zone molti periferiche per la mentalità giudaica del tempo, centrata sulla città del Tempio, Gerusalemme. Gesù però appena incontra Natanaele reagisce nel modo opposto: lo saluta come un "vero israelita in cui non c'è frode" (1,47). Natanaele perplesso domanda: come fai a conoscermi? La risposta è sibillina: "Prima ancora che Filippo ti chiamasse, ti ho visto sotto il fico" (1,48). Noi lettori non ci capiamo molto: cos'era successo di particolare sotto quel fico? Qualcosa di importante, perché Natanaele reagisce esclamando: "Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d'Israele" (1,49).
I miracoli del quarto vangelo sono un po' diversi dagli altri. Giovanni (se davvero fu lui l'autore) li chiama "segni" e li considera momenti fondamentali in cui Gesù si manifesta come Messia davanti a testimoni credibili. Alcuni studiosi pensano che l'evangelista abbia rielaborato una fonte precedente, il cosiddetto "vangelo dei segni", che avrebbe contenuto alcuni dei miracoli più spettacolari (le nozze di Cana, la resurrezione di Lazzaro). Accanto a questi però ci sono piccoli segni come il riconoscimento di Natanaele, che è il primo miracolo in assoluto e somiglia molto a quello che accadrà più tardi con la Samaritana: Gesù rivela al testimone qualcosa che soltanto lui può sapere. Di fronte a questo riconoscimento, le riserve del testimone crollano di schianto: non possono sussistere dubbi, Gesù è il Messia. Alla professione di fede di Natanaele, Gesù reagisce minimizzando: il meglio deve ancora arrivare. Credi in me solo perché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico? "Tu vedrai cose maggiori di queste. In verità, in verità vi dico che vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo" (1,50-51). Il primo capitolo finisce così, promettendo effetti speciali e un lieto fine spettacolare, e sappiamo che l'evangelista manterrà. Ma il piccolo interrogativo iniziale non sarà mai risolto: cosa era successo a Natanaele sotto il fico? Cosa sapeva Gesù di lui, che noi forse ignoreremo per sempre?
Il fico è decisamente l'albero più enigmatico dei vangeli. Addirittura è l'unica creatura che Gesù maledice, in uno degli episodi più controversi, Marco 11,12-14. Il giorno prima Gesù è entrato trionfalmente in Gerusalemme: ma siccome ha preso alloggio in un villaggio fuori dalle mura, Betania, ogni giorno gli tocca rientrare, scortato dagli apostoli. La mattina seguente, mentre rientra a Gerusalemme, si scopre affamato e "veduto di lontano un fico", cerca se tra le foglie per caso non ci sia un frutto. Il fico, si sa, è un albero generoso: anche molto prima della stagione, e molto dopo, se si ha pazienza qualcosa si trova. Eppure Gesù in quel singolo fico "non trovò niente altro che foglie", del resto Marco ha cura di annotare che non era ancora stagione. Spazientito, Gesù maledice il fico: "Nessuno mangi mai più frutto da te!" Entrato in città, Gesù manifesta in modo ancora più plateale il suo malumore: si reca nel Tempio e ne scaccia i mercanti con grande scandalo dei farisei (ma la folla sembra ammirarlo). L'indomani, ripassando sulla stessa strada, Pietro fa notare al maestro che il fico maledetto si è seccato. Gesù ne approfitta per spiegare che la fede in Dio può tutto, anche spostare le montagne. Gli apostoli di Marco sono i più perplessi dei quattro vangeli, e in questo caso la loro perplessità è la nostra: se Gesù era in grado di seccare un albero (e spostare una montagna), perché non ha semplicemente trovato un frutto di fico quando gli serviva?
 |
| Odifreddi is for boys, Bertrand Russell is for gentlemen (foto del 1954, pubblico dominio). |
La maledizione del fico è l'unico vero miracolo eseguito da Gesù con un fine punitivo; in tutti gli altri casi Gesù guarisce, resuscita, salva, riconosce, provvede di beni di prima necessità (o voluttuari, nel caso delle nozze di Cana). Solo in questo caso punisce un essere vivente, il che provocò l'indignazione, tra gli altri di Bertrand Russell che ne parla in Perché non sono cristiano. Per Russell l'episodio dimostrerebbe una certa inferiorità morale dell'uomo Gesù rispetto ad altri maestri dell'umanità come Buddha e, ehm, Socrate. A riprova che la morale è molto meno stabile di quanto si creda; Socrate che per Russell era un uomo più retto di Gesù, oggi si ritroverebbe di nuovo nei guai con le autorità per quel problemino coi minori che già impensieriva gli ateniesi. Oltre a sovrapporre all'episodio del fico una sensibilità ecologica completamente sconosciuta al primo secolo, Russell rifiuta qualsiasi lettura simbolica dell'episodio; inoltre sembra aver voluto trovare il passo evangelico in cui Gesù sembra più capriccioso e vendicativo. Non sorprende che si tratti del Gesù di Marco, il più arrabbiato e il meno conciliante con gli apostoli.
Quel che lascia perplessi i lettori di ogni epoca è che Marco afferma chiaramente che non si trattava della stagione dei fichi, insomma quel che Gesù chiedeva alla pianta era anch'esso un miracolo: o forse è la pianta l'unica, tra le creature di Dio, che rifiuta la grazia di Gesù, il quale può seccarla ma non vuole compiere il prodigio opposto: renderla rigogliosa di frutti se lei non li vuole. Il simbolismo abbastanza ovvio per i lettori del Vangelo (ma non per Russell) è col popolo di Israele, che i profeti avevano più volte descritto come un albero da frutto, una vite o un fico. Gesù dunque sembra voler fornire agli apostoli una parabola mimata, nello stile tipico soprattutto del profeta Ezechiele: gli apostoli dovrebbero imparare qualcosa non dalle parole, ma dalle azioni del Maestro. L'albero di fichi è Gerusalemme: Gesù vi ha cercato invano qualcosa di buono, ma non è evidentemente ancora tempo; non resta che mandare tutto all'aria; non a caso Marco prosegue con la cacciata dei mercanti che porterà i farisei a decidere la morte di Gesù.
 |
| Ramo, frutto, seme e fiore del fico, da Wikipedia |
Lo stesso episodio torna in Matteo, molto più stringato (21,18-22) malgrado degli evangelisti Matteo sia il più critico nei confronti del popolo ebraico dal quale pure proveniva. Matteo omette il riferimento alla stagione: nel suo racconto il fico si secca immediatamente dopo la maledizione, e gli apostoli se ne sorprendono subito. Ed eccoci all'eterno dilemma su quale sia il primo vangelo: è Marco che prende da Matteo o viceversa? È Matteo che attenua l'episodio di Marco, ne stempera la lettura antiebraica concentrandosi piuttosto sull'aspetto prodigioso? O viceversa è Marco che legge di un piccolo miracolo in Matteo e decide di trasformarlo in una metafora storico-religiosa?
Sia come sia, né il racconto di Marco né quello di Matteo convincono Luca, che in un Gesù maledicente le piante si rifiuta di credere. Luca non capisce la profezia mimata (che del resto è un unicum in tutti i vangeli) e decide di trasformare l'intero episodio in una parabola (13,6-9): non è più Gesù a cercare i fichi, ma un "padrone" ("Un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò"). Ma nemmeno a questo padrone l'ambientalista Luca concede di uccidere la pianta: intercede in suo favore il "vignaiolo": "Padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire; se no, lo taglierai". Il padrone accetta la proposta; il fico per il momento è salvo. Il che oltre a introdurre un dualismo tra un Dio-padrone stanco di essere tradito e un Cristo-vignaiolo incline all'intercessione, conferma terribilmente i miei sospetti su Luca, l'evangelista mansueto come il bue, quello che cerca in ogni atto o detto di Cristo la pietà, la dolcezza. Il che sarebbe magnifico; non fosse che quando questa pietà e questa dolcezza non le trova, Luca se le inventa. Trasformare in una parabola un episodio della vita di Gesù, attestato in due vangeli (uno dei quali Luca conosceva sicuramente) dimostra una certa disinvoltura con le fonti: a Luca non interessa più se il Cristo originale stava emettendo una sentenza nei confronti di un popolo. Luca ha deciso che il suo Cristo sarà misericordioso: i valori che vuole trasmettere vengono prima della fedeltà ai testi originali.
La maledizione del fico, già completamente stemperata in Luca, scompare in Giovanni: il quarto vangelo del resto è il più diverso dei quattro. Può darsi che l'episodio di Natanaele ne sia un'ulteriore rielaborazione: senz'altro è l'unico passo in cui un fico riveste qualche importanza, e come la maledizione descritta da Marco e Matteo, mantiene un'irrisolvibile ambiguità: cos'è successo sotto il fico? Ora che sappiamo che l'albero può rappresentare il popolo di Israele, possiamo meglio inquadrare il saluto di Gesù al nuovo apostolo: "Ecco un vero israelita in cui non c'è frode". La situazione di Marco e Matteo apparirebbe capovolta: Gesù ha controllato l'albero e ha scoperto almeno un frutto senza difetto. Dunque Israele non merita la distruzione - certo, per autorizzare un'interpretazione del genere, Giovanni deve tenere il fico più distante possibile da Gerusalemme, che al momento della composizione del quarto vangelo era già stata rasa al suolo dai Romani. Sappiamo che il testo è l'espressione di comunità cristiane-ebraiche dell'Asia Minore (Efeso e dintorni) che a differenza dei lettori degli altri tre vangeli avevano mantenuto forti legami con la religione originaria e festeggiavano la Pasqua nella data prevista dalla religione ebraica. Due secoli più tardi, un esegeta proveniente dallo stesso ambito culturale, Afraate il Siriaco, collegherà la maledizione del fico all'episodio della Genesi in cui Adamo, dopo aver peccato disobbedendo a Dio, usa foglie di fico per nascondere la sua oscenità. Seccando il fico, Gesù avrebbe annunciato l'espiazione del peccato originale: dopo di lui non ci sarebbe stata più vergogna, né più bisogno di nascondersi. Tornando a Giovanni, il suo Natanaele forse serve ad affermare il concetto: Dio ci ha dato ancora un frutto; non si è scordato del suo albero prediletto, Israele; non lo ha trovato sterile, non lo ha maledetto, non lo ha seccato.
C'è un'ultima leggenda a cui non si può non accennare parlando di fichi e di Gesù: a un fico si sarebbe impiccato Giuda, il traditore, secondo una tradizione antica ma non attestata nei vangeli ufficiali. Oltre alla simbologia ormai chiarita (il frutto del tradimento penzola dall'albero maledetto), può trattarsi di un tentativo dei primi interpreti di mettere d'accordo due versioni diverse e ugualmente attendibili: secondo Matteo, Giuda si impicca per disperazione quando si rende conto che i farisei hanno intenzione di consegnare Gesù ai Romani per farlo condannare a morte (27,1-10). Luca però ha sentito una versione diversa, e negli Atti degli Apostoli la mette in bocca a Pietro (1,18): "Egli dunque acquistò un campo con il salario della sua iniquità; poi, essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre, e tutte le sue interiora si sparsero". Come conciliare un Giuda impiccato con un Giuda squarciato dopo una caduta? Una possibilità è che Giuda avesse scelto per impiccarsi un albero che non avrebbe retto il suo peso: una pianta dai rami fragili, come il fico o un suo parente subtropicale, il sicomoro, che ha rami più spessi ma ugualmente soggetti a spezzarsi con poco sforzo. L'albero in questo caso è già simbolo di qualcos'altro: fragilità, incapacità di tenere fede alla promessa data (anche di reggere il peso della colpa), ipocrisia.
Zaccheo, l'esattore buono
20-08-2021, 10:12Bibbia, Cristo, Il Post, santiPermalink20 agosto ─ San Zaccheo pubblicano (I secolo)
 |
| Scendi che devi offrirmi un pranzo |
Zaccheo è il pubblicano che si arrampica su un sicomoro, a Gerico, per riuscire a vedere Gesù che è appena entrato in città circondato dalla folla. In mezzo a tanti curiosi, Gesù lo riconosce e lo chiama per nome: "scendi subito, Zaccheo, perché oggi devo fermarmi a casa tua". L'episodio è attestato soltanto nel vangelo di Luca (19,1-10). E qui devo confessare una cosa: sto perdendo un po' la mia fiducia in Luca, man mano che invecchio. Fu il primo evangelista di cui abbozzai un profilo, all'inizio di questa cosa: ne ero entusiasta, era il mio evangelista preferito quasi da sempre (vabbe', la cotta giovanile per Giovanni è uno scotto inevitabile, è un po' come i Pink Floyd). Luca è un vero cronista, scrivevo, Luca fa le ricerche e cerca di organizzare il materiale, di non annoiare il lettore con dettagli inutili. Ma avvertivo anche che Luca è un liberal, con un'attenzione particolare per i deboli, gli oppressi e le donne: un tratto incredibilmente moderno, così moderno che a un certo punto ha cominciato a insospettirmi: è come se Luca riuscisse a trovare in ogni situazione l'angolazione perfetta per me. La santa più importante della cristianità, Maria, è un personaggio di Luca: è lui che racconta l'episodio dell'annunciazione (Matteo fa parlare l'angelo a Giuseppe); e lui che le mette in bocca le sublimi parole del Magnificat. Luca fa dire al suo Gesù: "beati i poveri". Non "beati i poveri in ispirito", come Matteo, no: per Luca devono essere beati i poveri, è di loro il Regno dei Cieli: un luogo dove evidentemente è previsto un minimo di giustizia sociale, Matteo non si poneva il problema, Luca lo inventa. Luca è l'evangelista che sente il bisogno di correggere la parabola dei talenti di Matteo, livellando completamente il budget concesso ai servi: i talenti diventano "mine", dal valore molto più modesto, e il padrone prima di partire li divide tra i servi in parti uguali, modificando così il significato di quella paginetta del vangelo che pare fosse l'unica a interessare davvero Margaret Thatcher. Ma come fa insomma Luca a conoscermi così bene?
La spiegazione più semplice è che Luca mi conosca perché è lui che mi ha fatto così. L'attenzione per i deboli, l'interesse per le figure femminili che si sforza di far uscire dal cono d'ombra, il sogno della comunione dei beni prospettato negli Atti degli Apostoli, non sono cose moderne che riconosco in Luca: sono cose che Luca ha descritto, ed è anche grazie a lui che duemila anni dopo ne parliamo ancora. Ma le ha descritte dal vero o le ha proprio inventate? Quanto Cristo c'è davvero nel vangelo di Luca, quanto Luca c'è nel Cristo che ci piace?
Insomma dieci anni dopo non lo definirei più uno scrupoloso cronista. Che sia un liberal invece non c'è dubbio, è una cosa che traspare ad ogni confronto con gli altri tre autori e soprattutto con quello dei tre che aveva una vera ossessione per il denaro, al punto che tradizionalmente è identificato con Matteo, l'apostolo che faceva lo stesso mestiere di Zaccheo: ed è una coincidenza molto curiosa. L'episodio di Zaccheo è uno dei non pochissimi esempi in cui Luca sembra non volersi accontentare di quello che gli hanno raccontato su Gesù: come se l'episodio della conversione del pubblicano Matteo non lo convincesse del tutto. Luca la conosce, l'ha riportata (anche se chiama Matteo "Levi", come del resto fa l'altro evangelista Marco), però è come se l'obiezione dei Farisei ("Perché mangiate e bevete con quelli delle tasse e con persone di cattiva reputazione?" lo mettesse in imbarazzo. Eppure il suo Gesù ha la risposta pronta: "Quelli che stanno bene non hanno bisogno del medico; invece ne hanno bisogno i malati. Io non sono venuto a chiamare quelli che si credono giusti, ma quelli che si sentono peccatori, perché cambino vita". Tutto giusto, ma è come se Luca sentisse che non basta, perché il suo Levi dopotutto è una comparsa, non torna più: come può essere sicuro il lettore che la vita l'abbia cambiata davvero? Così, per questa esigenza più didattica che biografica che Luca ha di essere chiaro, di non alimentare dubbi nel suo lettore, ecco che decide di far incontrare al suo Gesù un altro esattore, che la vita l'ha già cambiata: il piccolo Zaccheo, che è un pubblicano, certo, ma il meno esoso di tutti: come spiega al Salvatore a pranzo, "io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto".
Possiamo immaginare le obiezioni che avrebbe mosso Matteo, che il denaro lo conosceva in modo meno astratto di Luca: un pubblicano che desse metà del suo gettito ai poveri, quanto ci metterebbe a fallire? E chissà come erano delicati gli occupanti Romani con i rei di insolvenza. Oppure dovrebbe alzare le tasse a tutti, altra cosa rischiosa e in fin dei conti insostenibile. Cosa significa poi "se ho frodato, restituisco quattro volte tanto": truffi i tuoi debitori e poi ti penti subito? Gesù invece approva tutto: "Oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio d'Abramo", e subito dopo racconta la parabola delle mine. Insomma l'episodio di Zaccheo è uno dei tanti in cui Luca sembra non volersi accontentare di quello che gli hanno raccontato su Gesù: sembra volerlo interpretare, spiegare, conciliare con una sua idea di Cristo che poi ha avuto una straordinaria fortuna e tutto sommato è anche la mia idea: e però corrisponde molto di più alle idee di Luca che a quello che su di lui raccontano gli altri tre evangelisti. Questa cosa che Gesù frequentasse la feccia della società, come gli esattori, lo infastidiva: l'unico modo per farla rientrare nel suo quadro di Gesù era immaginare un pubblicano diverso da tutti gli altri, un campione di onestà e generosità.
Zaccheo è l'esattore generoso: molto più raro di una prostituta virtuosa, per cui ammetto di fare un po' più fatica a credere che Gesù l'abbia incontrato davvero. Poi, siccome si arrampica sul sicomoro che è un parente subtropicale del fico, potrebbe essere stato ripreso da Giovanni per creare la figura di Natanaele. Ma di quanto siano importanti (e ambigui) i fichi nei vangeli riparleremo presto.
Perché perdiamo tempo con l'Invalsi, nel 2021?
19-07-2021, 13:14epidemia 2020, Il Post, scuolaPermalinkChe anno è, che giorno è? È il momento di discutere dei risultati Invalsi, come se fossero una cosa seria. Malgrado l'interruzione dell'anno scorso, la liturgia ormai si è consolidata: a metà luglio, quando ormai la scuola è un ricordo lontano, l'Invalsi si fa vivo e pubblica quelli che chiama "i risultati", e che in realtà poi non dicono un granché. Il momento è cruciale: se c'è un torneo internazionale di calcio, è appena finito; un'eventuale Olimpiade non sarà ancora cominciata. Sui giornali insomma potrebbe esserci un po' di spazio da riempire: peccato che i "risultati" Invalsi siano mortalmente noiosi: le primarie tengono, nelle secondarie inglese è stabile e matematica e italiano sono un po' in calo... non c'è sugo, non c'è spezia, per cui si fa intervenire il titolista apocalittico, quello che di mestiere, quando il meteo dice che piove, titola SENTENZA FINALE, SPAVENTOSA BOMBA D'ACQUA.
Tu dici: vabbe', esagera. La tale Testata Prestigiosa ci informa che "Crollano le competenze degli studenti" – il che in sostanza significherebbe che non solo non hanno imparato niente, ma non sanno nemmeno più fare quel che sapevano fare un paio d'anni fa. (L'Invalsi però è un banale test a scelta perlopiù multipla: che sia uno strumento efficace per certificare le cosiddette competenze è discusso e discutibile). Il collega di un'Altra Testata Prestigiosa ci terrorizza: "Alla Maturità competenze da Terza Media". Per fortuna questa spaventosa lacuna per cui cinque anni di istruzione superiore sarebbero spariti nel nulla non risulta dai dati Invalsi: è solo un titolo acchiappaclic, ma è anche l'unica cosa che la maggior parte dei lettori leggerà. Dai titoli partiranno poi per tutta una serie di osservazioni sulla scuola, sulle sue criticità, ecc. – anche in buona fede, vedo commentatori già pronti a spiegare perché secondo loro la scuola sta funzionando male, cosa bisogna fare per intervenire. Sono discorsi in parte condivisibili, ma io vorrei fermarmi un po' più a monte.
Non voglio discutere dell'Invalsi come insegnante, stavolta. Non voglio discutere dell'Invalsi come l'esperto di didattica che tra l'altro non sono. Rivendico un punto di vista molto più limitato, ma a fuoco: voglio parlare delle prove Invalsi da tecnico di laboratorio, visto che è quello che faccio nella mia scuola media da quando le prove sono diventate computer based. E da tecnico di laboratorio dico: non è il momento di discutere dei risultati Invalsi come di una cosa seria.
Nel documento c'è scritto, in un italiano teoricamente comprensibile anche ai giornalisti, che il 44% non raggiunge "risultati adeguati, ossia non in linea con quanto stabilito dalle Indicazioni nazionali". Non significa che non hanno "conoscenza minima italiano". https://t.co/RXXmmWuhkw
— Leonardo Blogspot (@LeonardoBlog) July 16, 2021
Non discuto la bontà dei test, la didattica che sottendono, eccetera. Non discuto la professionalità degli esperti che li hanno messi a punto, o la serietà dei miei colleghi che li hanno somministrati. Per far funzionare una somministrazione non bastano gli esperti, i pedagoghi e gli insegnanti. La somministrazione funziona se gli studenti decidono di farla seriamente, e non credo che sia successo.
Parto dalla mia esperienza (ovviamente limitata, ma diversamente da tutti i commentatori io i test li ho visti fare): le prove Invalsi richiedono massimo 90 minuti. I miei studenti consegnavano mediamente dopo 60, molto prima del solito. O erano tutti geni, o le prove erano troppo facili, o non avevano nessun interesse a farla bene. Vi è mai capitato di fare un questionario al computer? Magari quando iniziate siete curiosi, poi vedete che è un po' più difficile di quel che sembrava, pensate che tutto sommato avete di meglio da fare, e scrollate avanti. La mia supposizione è che molti studenti abbiano fatto la stessa cosa. Non credo che le prove Invalsi di quest'anno vadano prese sul serio, perché i ragazzi che dovevano farle non le hanno prese sul serio.
E perché mai avrebbero dovuto farlo? Tornavano tutti da un lockdown, chi di un mese (elementari e medie) chi di tre mesi o più (superiori). Avevano appena ricominciato a interagire dal vivo coi compagni e con gli insegnanti – certo, in aule distanziate, senza scaffali per tenere i banchi a dieci cm di distanza in più; senza laboratori; senza intervallo in aree comuni: però ce l'avevano fatta, erano tornati a scuola. A questo punto arriva il tecnico e spiega che bisogna recarsi tutti nell'aula computer per quel famoso test a crocette che comunque, nessuno si preoccupi, non influisce in nessun modo sulla loro valutazione finale. I ragazzi sbuffano e vanno. Magari alla spicciolata, perché anche lo spazio in laboratorio è contingentato. Un laboratorio che contiene 30 computer probabilmente può farne lavorare soltanto 15, per garantire il distanziamento. Quindi bisogna fare i turni. Quindi dopo mesi di didattica a distanza una volta tornati a scuola bisogna interrompere il lavoro di classe per andare un po' alla volta in un laboratorio a fare un noioso test a crocette che dal loro punto di vista non ha la minima importanza.
Sì, proprio in quel laboratorio in cui abbiamo smesso di portare i ragazzi dall'anno scorso perché bisognava in tutti i modi mantenere il distanziamento, mantenere la bolla, evitare che i droplet della terza A fossero inalati dai ragazzi della terza C. È il motivo per cui i ragazzi non fanno più l'intervallo tutti assieme nei corridoi, e ciononostante (e malgrado il ministero spergiurasse che le scuole erano sicure) abbiamo dovuto comunque chiudere in marzo e a Pasqua abbiamo portato i ragazzi delle terze medie e delle quinte superiori in laboratorio per fare un noioso test a crocette. Ora: è così strano che l'abbiano fatto in fretta, rispondendo sbrigativamente alle domande che sembravano più facili e scrollando quelle che non capivano al volo? In tutta sincerità: al loro posto avreste fatto diversamente? Vi ricordo che la prova Invalsi non fa più media, i ragazzi sanno perfettamente che non saranno valutati per le risposte che danno. A volte sentono dire che saranno i loro insegnanti a essere valutati, e la scuola nel suo insieme: ecco, provate un attimo a figurarvi la cosa. Voi al loro posto vi sareste attardati su un computer forse non del tutto disinfettato, a compilare coscienziosamente un test per far fare bella figura ai vostri insegnanti? Chi ha immaginato una situazione di questo tipo sarà anche esperto di didattica, ma non di preadolescenti e adolescenti. O più facilmente la sua priorità non era ottenere buoni risultati. L'unico motivo per somministrare le prove Invalsi in un anno disastrato come questo era ottenere cattivi risultati. La cosa incredibile è che tutto sommato i risultati non sono nemmeno così cattivi. Prevedibili, ma non così pessimi.
La scuola ha dei problemi? Altroché se ne ha. L'Invalsi ce li mostra? L'Invalsi è un dito che mostra la luna. Ma la mostra davvero? Sta puntando davvero verso la luna o semplicemente la luna è l'unica cosa interessante che si trovi vagamente sulla traiettoria? E inoltre: quanto costa quel dito? Siccome non fa che indicare quello che indicano tutti, siccome non ha mai cambiato posizione in tanti anni, vale ancora la pena di mantenerlo? Mi pongo questo tipo di problemi perché io quel dito l'ho sorretto sin dall'inizio, non con le mie idee ma col mio lavoro. Da quando c'è l'Invalsi, io a scuola ho somministrato l'Invalsi. Quando qualche mese fa i miei dirigenti mi confermarono che le prove si sarebbero fatte, ero piuttosto incredulo. La scuola dell'obbligo era appena entrata nel suo secondo lockdown, che sarebbe durato più o meno un mese. In quel momento non sapevamo nemmeno se avremmo finito l'anno in presenza, e ciononostante il Ministero ci chiedeva di predisporre i laboratori informatici per la somministrazione della prova. Bisognava assolutamente capire se i ragazzi ne sapessero più o meno di quelli degli anni scorsi.
Ma bisognava davvero? Cioè, dopo un quadrimestre di DAD completamente improvvisata; dopo un altro quadrimestre in presenza in classi distanziate, con continui stop and go imposti ogni volta che in una classe scoppiava un focolaio, c'era davvero tutta questa esigenza di scoprire se i ragazzi avessero imparato più o meno? Non era una domanda retorica? Voglio dire, potevate chiederlo a me. Ve l'avrei detto io. Gratis? No, gratis no, ma sarei costato senz'altro un po' meno. Oppure potevate chiedere a chiunque. Lo sappiamo tutti che la scuola non ha funzionato al meglio nel 2020-21 – come qualsiasi altra cosa del resto.
Invece abbiamo sentito l'esigenza di formulare questa domanda retorica a due milioni di studenti. Non sarebbe bastata, per una volta, un'indagine a campione? In tante scuole d'Italia, questo era complicato anche prima del Covid e delle procedure di distanziamento. Tre prove da 90 minuti sono 270 minuti per studente – se lo studente dovesse farli tutti assieme, ma ovviamente non è così: ogni 90 bisogna dargli il cambio, e questo significa altri minuti preziosi per aerare e igienizzare la postazione (per quanto si possa sanificare una tastiera, l'oggetto forse meno igienizzabile inventato dall'uomo). Comunque fingiamo che tutto si possa fare in 10 minuti, diciamo che ogni Invalsi ruba allo studente 300 preziosi minuti di presenza (senza restituirgli niente: le prove Invalsi servono un po' al ministero, un po' ai giornalisti, ma a lui a che servono? era meglio stare in classe a studiare l'assonometria cavaliera). Se una scuola media ha otto terze, e a ogni terza servono 300 minuti, abbiamo 40 ore da gestire: 40 ore in cui è previsto che l'insegnante sia coadiuvato da un assistente, qualcuno che in teoria la scuola paga: le prove Invalsi costano. Sempre che esista quel famoso laboratorio con 25-28 postazioni cablate e funzionanti. Magari nel 2019 esisteva, ma ora c'è il distanziamento, ricordate? Non è che si possa espandere la cubatura del laboratorio. Si potrebbe fare un altro laboratorio (altri soldi), o più facilmente raddoppiare i turni, per cui le 40 ore diventano 80. Questo è successo alle medie e alle superiori: alle primarie, dove la prova è ancora cartacea, i risultati sono stati migliori. Questo ovviamente può significare che le primarie funzionano meglio. Perlomeno sulla brochure dell'Invalsi c'è scritto così. Oppure che i bambini delle primarie davanti a un fascicolo cartaceo hanno più motivazioni a fare bene che i preadolescenti davanti a un computer – preadolescenti plasmati da anni di videogioco domestico, per cui se sbagli puoi sempre ricominciare e fare meglio.
(A volte davvero alla fine della prova ti chiedono se potrebbero ripeterla ed è un piccolo choc per loro scoprire che no, per la prima volta della vita non si può imparare dai propri errori. Che tra l'altro sarebbe l'unica cosa didatticamente interessante, per loro).
Che anno è, che giorno è? Nessuno in particolare. Le prove Invalsi non ci dicono niente che non sapessimo già. Come al solito sono in linea con le rilevazioni Ocse-Pisa. Le scuole delle regioni più ricche funzionano meglio delle scuole delle regioni più povere, chi l'avrebbe detto. Per farci dire quel che sappiamo benissimo, abbiamo disturbato due milioni di studenti che erano appena tornati in classe. Li abbiamo portati in un laboratorio benché fino al giorno prima sostenessimo che il laboratorio fosse un luogo a rischio. Non abbiamo fornito loro nessuna motivazione particolare: dovevano soltanto finire quei maledetti test. Li hanno finiti al volo, sono tornati in classe, e ora i giornali possono dire che le scuole italiane fanno schifo e la DaD non funziona.
Perché prima non potevano?
Beh, in luglio è più difficile, le scuole sono chiuse, manca un gancio con l'attualità. Insomma non ci dirà mai niente di interessante o nuovo, ma almeno questo gancio ai giornalisti l'Invalsi ogni anno lo offre. E probabilmente è tutto: anche perché io in tanti anni tutti questi interventi mirati per risolvere le criticità individuate dall'Invalsi sinceramente non li ho visti. Ecco perché abbiamo organizzato 80 ore di laboratorio in aprile, sottraendoli alla didattica, e io mi sono pure preso un virus (per fortuna non era il Covid): per sentirmi dire anche in luglio che faccio schifo, che è tutto da rifare. Grazie, e arrivederci al prossimo anno.
Cinque leggende per sette fratelli
18-07-2021, 01:44ebraismo, Il Post, miti, santiPermalink18 luglio – Santa Sinforosa e i suoi sette figli martiri (II secolo), leggenda
Sette figlioli sette, di pane e miele, a chi li do? Il 18 luglio si celebra il martirio di Sinforosa e dei suoi sette figli, ma io non ci credo molto: sette figli? Tutti martiri? Ma andiamo. Racconta un anonimo agiografo che l'imperatore Adriano voleva inaugurare una bella villa a Tivoli, ma l'oracolo gli disse: ma cosa pensi di inaugurare, non lo sai che la vedova Sinforosa e i suoi sette figli ogni giorno ci tormentano invocando il loro Dio? Convincila a sacrificare, allora sì che faremo tutto quello che vuoi.
 |
| Felicita e i suoi sette figli (non li sta sgozzando in una volta sola: li esibisce con orgoglio accanto alla spada, che è il simbolo del martirio). Dalle Cronache di Norimberga. |
Adriano non perse tempo ad arrestare i figli con la madre, che però di sacrificare ai falsi dei non voleva saperne. La torturarono, e niente: allora la buttarono nell'Aniene con una pietra al collo, magari presso la pittoresca cascata. E i fratelli? Adriano fece innalzare sette pali intorno al tempio di Ercole Vincitore, e siccome non capita tutti i giorni di avere sette vittime consanguinee, ne volle approfittare per uccidere tutti in un modo diverso: a Crescente fece tagliare la gola, a Giuliano pugnalare il petto, a Nemesio il cuore, a Primitivo l'ombelico, a Giustino la schiena, a Stratteo il fianco, mentre Eugenio fu segato in due. I corpi furono gettati in una fossa che divenne nota come la fossa dei sette biothanatos, parola greca che veniva usata sia per i suicidi che per i cristiani che sceglievano il martirio. Qualcuno però andò a recuperare i corpi e li seppellì sulla Tiburtina, a otto miglia da Roma. Il corpo della madre invece sarebbe stato sepolto fuori dalle mura di Tivoli. Così dice la leggenda, e io non credo a una parola: sette figli?
Il Martirologio geronimiano (che malgrado il nome non fu scritto da Girolamo) conferma che erano sette, ma li chiama con nomi diversi. Invece ricorda sette fratelli che di nome fanno proprio Crescente, Giuliano, Nemesio, Primitivo, Giustino, Stratteo ed Eugenio, ma il 27 giugno. Può darsi che qualcuno a un certo punto si sia confuso. Può darsi che i sette non siano i figli di Sinforosa, che Sinforosa non abbia mai avuto sette figli (ognuno dei quali potrebbe rappresentare una patologia riguardante una parte del corpo, come secoli più tardi i quattordici ausiliatori). Può darsi che non sia nemmeno mai esistita, tanto è simile la sua storia a quella più diffusa di Santa Felicita.
Santa Felicita (da non confondere con la serva di Perpetua) era una ricca vedova romana che fu accusata di cristianesimo ai tempi di Antonino Pio (il successore di Adriano). Siccome il prefetto non riusciva a farla confessare, decise di arrestare i figli Gennaro, Felice, Filippo, Silano, Alessandro, Vitale e Marziale, e di ucciderli ognuno con un supplizio diverso, finché non avrebbe ceduto. Non cedette e fu uccisa anche lei. Fu sepolta coi figli in una basilica sulla Salaria, e in suo onore furono dedicate chiese e monasteri ai Sette Fratelli o ai Sette Frati... ma probabilmente è un falso anche questo. Sette fratelli, sul serio? Condannati a morte da un imperatore famoso per la sua tolleranza (come del resto Adriano)? È una favola, e come tutte le favole assomiglia a un'altra. Per una volta sappiamo anche quale, e forse abbiamo addirittura il nome dell'autore. Giasone di Cirene.
 |
| Antonio Ciseri, Il martirio dei Maccabei (1863). |
«Figlio, abbi pietà di me che ti ho portato in seno nove mesi, che ti ho allattato per tre anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti; tale è anche l'origine del genere umano. Non temere questo carnefice ma, mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia».
 |
| I sette fratelli Govoni |
Il figlio non se lo fa ripetere due volte e ottiene un martirio persino più doloroso dei fratelli maggiori; dopodiché Antioco, folle di rabbia, uccide anche la madre. Un episodio del genere, scritto evidentemente per spronare gli ebrei a resistere contro i prevaricatori, non poteva che esaltare i lettori cristiani dei secoli delle persecuzioni. A un certo punto la Chiesa di Roma rivendica di custodire le spoglie dei "Sette Santi Maccabei", in San Pietro in Vincoli. Probabilmente la gemmazione di nuove leggende sui sette fratelli nasce da qui, e dal fatto che molto spesso i racconti non si diffondevano in forma scritta e nemmeno orale, ma attraverso le immagini; sicché talvolta un predicatore poteva trovarsi sulle pareti o sulle vetrate la storia di sette fratelli morti ammazzati, e se non conosceva la storia dei Maccabei gli toccava improvvisare, magari ambientando la storia in una cornice più locale e interessante per gli ascoltatori, come nel caso di Tivoli. Alla fine gli elementi sono gli stessi: un imperatore stronzo, sette fratelli uccisi male, una madre che assiste e muore pure lei... e non è che dobbiamo crederci per forza. Se l'agiografo di Santa Sinforosa ha copiato quello di Santa Felicita che ha copiato il compendiatore di Giasone di Cirene, anche Giasone potrebbe avere ripreso la leggenda da qualche parte. Ormai lo abbiamo capito, no? Dove c'è un tiranno malvagio e sette fratelli uccisi, meglio diffidare.
 |
| La famiglia Cervi |
Mettiamo che tra qualche secolo ci sia ancora qualche storico curioso del nostro. Su che libri potrà mettere le mani? Probabilmente uno di quelli stampati in più copie, che ne so, il Sangue dei vinti di Giampaolo Pansa. Da bravo studioso non prenderà tutto per oro colato; ad esempio quando Pansa parla dei sette fratelli Govoni trucidati dagli uomini della Garibaldi ad Argelato, penserà: ma questo è un calco, figurati. Sette fratelli pestati a morte in una volta sola? Non la bevo, è chiaro che l'autore si è ispirato a una leggenda pre-esistente. Magari a quella dei Cervi, i sette fratelli di Campi Rossi di Gattatico, fucilati a Reggio Emilia. Oppure ai sette figli di Santa Sinforosa, o di Santa Felicita, o ai sette santi Maccabei (che non erano nemmeno Maccabei, ammesso che siano esistiti, e probabilmente no). Se c'è una cosa che ogni storico coscienzioso dovrebbe sapere, è che la mitologia può ispirarsi alla realtà, non il contrario: e quindi se mai sette fratelli furono uccisi, questo deve essere successo tantissimo tempo fa, di sicuro non al tempo dei nostri nonni. Sette fratelli? Impossibile.
(In un documento della sezione fascista di Reggio Emilia c'è scritto proprio così: sotto la lista dei Cervi, un appunto: Sette fratelli? col punto interrogativo e sottolineato in rosso. Come a dire: ma davvero lo abbiamo fatto? Siamo noi la leggenda, siamo noi Adriano, Antonino, Antioco Epifane? Forse chi lo scrisse per un momento sentì che la realtà gli cedeva intorno, che la fantasia prendeva il sopravvento coi suoi demoni invisibili, inguardabili; e ne ebbe vertigine).
Bonaventura, il cancellatore di San Francesco
15-07-2021, 19:27Il Post, santiPermalink15 luglio – San Bonaventura da Bagnoregio (1220 ca – 1274): filosofo, teologo, reinventore di Francesco d'Assisi.
 |
| Francesco riceve le stimmate, Basilica Superiore di Assisi (comunemente attribuito a Giotto e alla sua officina). |
Buongiorno dalla rubrica ufficiosa dei Santi del Post, che ridi e scherza sta per compiere dieci anni! Anche se nell'estate del 2011 mi stavo già preparando, alla fine cominciai ai primi di ottobre, sbattendo immediatamente nella ricorrenza del santo più difficile di tutti: Francesco d'Assisi. E siccome su di lui sono state scritte biblioteche di libri che non avevo letto, me la cavai buttandomi sulla cultura pop (il rifugio accogliente di ogni rubrichista ignorante): San Francesco scrissi, "è uno di quei personaggi così popolari che ormai mille narrazioni diverse ne hanno levigato l'immagine fino a farla diventare una superficie specchiante", insomma anche se avessi provato a guardarlo avrei soltanto visto una copia angelicata di me stesso, in particolare la copia angelicata del me stesso cresciuto negli anni Ottanta col materiale agiografico del decennio precedente: Zeffirelli, Forza venite gente e così via. La sfangai così, ma mi rimase il dubbio e forse è rimasto anche voi: chi era davvero Francesco, prima di diventare uno specchio dei nostri slanci mistici e dei nostri sensi di colpa?
Dieci anni dopo e qualche ottimo libro in mezzo, ancora non l'ho capito. Anzi forse ho capito che è una domanda che ci tormenta da ottocento anni, e se a questo punto non abbiamo trovato risposte soddisfacenti forse dobbiamo arrenderci: noi non conosceremo mai Francesco. Molte cose che sappiamo su di lui, che diamo quasi per scontate, sono il frutto di elaborazioni postume anche molto sofisticate. Non solo, ma molte cose che non sapremo mai di lui sono state cancellate deliberatamente, proprio nel momento cruciale in cui i testimoni oculari stavano scomparendo. Il principale responsabile di questa cancellazione è un nome illustre (e santo): Bonaventura da Bagnoregio, teologo e filosofo di primo livello. È a lui, frate francescano, che Dante mette in bocca nel Paradiso un elogio a San Domenico; una compensazione per l'elogio di San Francesco che aveva fatto recitare al domenicano Tommaso d'Aquino nel canto precedente.
 |
Il XIII non è né un secolo buio, né appartiene alla fase oscurantista in cui la Chiesa cattolica rientrerà con la Controriforma. Non esisteva ancora un Indice dei Libri Proibiti, anche perché i libri si copiavano ancora a mano e la circolazione era molto più faticosa (e controllabile). Non è che non si cancellassero anche allora, anzi succedeva assai spesso proprio perché il materiale su cui venivano trascritti, la pergamena, era relativamente costoso: il più delle volte non si cancellavano per occultare argomenti spiacevoli, ma perché serviva pergamena per scrivere cose più utili. E poi ogni tanto qualche rogo di libri si faceva, di solito quando un concilio sanciva che il tal predicatore era un eretico: nel 1140 per esempio era toccato ad Arnaldo da Brescia e a Pietro Abelardo. L'esempio di quest'ultimo doveva essere ben chiaro a Bonaventura, che due secoli dopo insegnava nella stessa università. Eliminare la circolazione dei testi non autorizzati significava liquidare come eretica ogni altra versione di Francesco, e rendere l'Ordine responsabile dell'unico Francesco accettabile. Ma quanto doveva essere diverso il Francesco originale, per rendere necessaria agli occhi attenti di Bonaventura un'operazione così drastica? Ecco, non possiamo saperlo.
 |
| Stigmatizzazione di Francesco (Giotto, Pala del Louvre). |
Dagli indizi che siamo riusciti a recuperare intuiamo che il Francesco storico, negli ultimi anni, si era ormai separato dall'Ordine la cui fondazione gli veniva pure attribuita, ma in cui non riusciva più a riconoscersi. Sin dai difficili esordi Francesco aveva pensato a un gruppetto di laici itineranti, lavoratori e predicatori ma senza libri che non fossero il Vangelo; già negli ultimi anni della sua vita aveva osservato con perplessità la crescita del fenomeno: aveva visto schiere di frati entrare nelle scuole, benedetti da cardinali e papi che premevano per farli entrare nelle università, dove avrebbero recuperato il terreno perso nei confronti degli insegnanti laici. Nel processo non poteva che essersi perso l'ideale di povertà radicale che aveva portato il giovane di Assisi a ribellarsi alla sua famiglia e alle autorità. Può anche darsi che Francesco fosse un predicatore escatologico, come altri prima e dopo di lui: un uomo venuto ad annunciare la fine del mondo e la conseguente vanità di tutti i beni materiali; in quel caso la censura di Bonaventura dovette funzionare molto bene, perché non ci è rimasta una sola parola sua o dei biografi che autorizzi un'ipotesi del genere: e ciononostante l'idea che Francesco annunziasse la fine dei tempi continuava a circolare e stimolava narrazioni alternative, che di lì a poco avrebbero portato alla nascita di una corrente rigorista, i cosiddetti francescani spirituali.
Può persino darsi – ma non abbiamo vere prove – che negli ultimi anni di vita Francesco fosse un sorvegliato speciale, guardato a vista dai fratelli che lo accudivano: può darsi che questi ultimi fossero interiormente scissi tra l'affetto che provavano nei suoi confronti e la necessità di evitare che Francesco dicesse o facesse in presenza di altri testimoni qualcosa di sconveniente, qualcosa di eretico. Dopotutto era il Folle di Dio: chi lo conosceva bene sapeva quanto fosse caratterialmente predisposto a gesti inconsulti e soggetto a sbalzi d'umore. Lui stesso sapeva di avere bisogno di aiuto. Non tutto quello che gli succedeva si poteva spiegare facilmente, né raccontare a chicchessia.
Francesco morì nella piccola chiesa della Porziuncola, la sera del 3 ottobre 1226, dopo mesi o anni di agonia. Furono i confratelli che si presero cura delle spoglie a scoprire cinque piaghe che il moribondo aveva nascosto fino alla fine: alle mani, ai piedi e al costato. Frate Leone, uno dei più intimi, provò la sensazione di avere davanti "un uomo crocefisso appena deposto dalla croce". Spettò a frate Elia, vicario generale dell'Ordine, comunicare la notizia dell'"incredibile miracolo" in una lettera circolare: "Non molto tempo prima della morte, il fratello e padre nostro apparve crocifisso, portando nel suo corpo le cinque piaghe che sono veramente le stimmate di Cristo".
 |
| Stigmatizzazione di Francesco (Giotto, Cappella Bardi). Per la prima volta Francesco è sorpreso dal serafino alle spalle: in questo modo le piaghe non corrispondono più in modo speculare, ma diretto: la mano destra nella mano destra, eccetera. |
Il miracolo, che dopo tante riproposizioni medievali e moderne oggi potrebbe avere un po' stuccato il pubblico, era al tempo così nuovo e di difficile interpretazione che la testimonianza di Elia non fu presa in esame nel processo di canonizzazione. Nessun santo, prima di Francesco, aveva mostrato sul suo corpo le ferite di Cristo: fino a quel momento nessun lettore aveva immaginato, leggendo la lettera di San Paolo ai Galati (6,17: "io porto le stimmate di Gesù nel mio corpo") che l'apostolo non parlasse in senso figurato. Lo stesso Francesco, da vivo, si era ben guardato di esibire le piaghe che una volta morto cambieranno più volte forma e significato. Frate Elia aveva parlato di "punture di chiodi": un paio d'anni dopo nella prima biografia ufficiale Tommaso da Celano sente la necessità di correggerlo: "non i fori causati dai chiodi, ma i chiodi stessi formati dalla carne": le piaghe sarebbero escrescenze.
Tommaso forse voleva allontanare il lettore dal sospetto che Francesco, in una fase in cui il trasporto mistico si alternava a fasi di prostrazione, non si fosse autoinferto quelle ferite con chiodi veri. Un brutale tentativo di imitazione di Cristo che non ne avrebbe più denunciato la santità, ma la follia (e l'eresia). Tommaso non aveva visto il corpo di Francesco, ma sapeva molto meglio di noi che i miracoli medievali non lasciavano cicatrici: quindi decise che dovevano essere escrescenze. Le escrescenze però aprono la porta a un dubbio diverso: anni prima, quando non era ancora un modello di vita ma una scheggia impazzita della Chiesa, Francesco aveva trascorso diverso tempo in un lebbrosario, assistendo i malati con più entusiasmo che esperienza. E se in quell'occasione avesse contratto la lebbra? Questo avrebbe spiegato le piaghe, la ritrosia di Francesco sull'argomento e la sua agonia. Ma avrebbe mai potuto morire di lebbra il santo fondatore dei Frati Minori? Dopo aver praticato tante guarigioni miracolose, sarebbe morto di un morbo contratto durante il suo apostolato?
Persino il più grande sostenitore di Francesco e del suo ordine, Ugolino dei Conti di Segni, mantenne per molto tempo un atteggiamento scettico. Da cardinale, Ugolino era stato il grande sponsor dei francescani presso la curia romana; per primo aveva intravisto la potenzialità di un piccolo movimento di laici appassionati della povertà. Rapidamente lo aveva plasmato in qualcosa di profondamente diverso, qualcosa che avrebbe attirato intellettuali come Antonio da Padova e lo stesso Bonaventura. Pochi mesi dopo la morte di Francesco, Ugolino era stato eletto papa, col nome di Gregorio IX. La rapidità con cui portò a termine in pochi mesi il processo di canonizzazione di Francesco non esprimeva soltanto gratitudine: in una fase in cui il ricordo di Francesco era ancora vivo, soprattutto nell'Italia centrale, Gregorio/Ugolino sentiva la necessità di ribadire che fino all'ultimo Francesco era rimasto fedele alla vera Chiesa e all'Ordine che aveva fondato: che i suoi comportamenti, anche i più bizzarri, potevano tutti essere ricondotti alla variegata casistica prevista dalle leggende dei Santi. Francesco era stato in vari momenti della sua vita un mistico, un taumaturgo, un eremita, un predicatore, un missionario, un aspirante martire: come prima di lui vi erano stati mistici, taumaturghi, eremiti, predicatori, martiri. Le stimmate invece erano una cosa nuova e Gregorio ci mise dieci anni prima di menzionarle in un testo ufficiale. Alla fine giustificò la sua esitazione con un miracolo: Francesco gli sarebbe apparso in sogno, porgendogli una fiala del suo sangue affinché non dubitasse più. Dovette poi tornare spesso sull'argomento, ammonendo gli scettici che evidentemente non si rassegnavano: persino tra i francescani c'era chi trovava l'episodio in un qualche modo sacrilego. Ci furono stimmate cancellate dai dipinti, e monaci condannati per aver dubitato pubblicamente del miracolo. Tutto sommato la venerazione per le stimmate di Francesco si impose più faticosamente di quella per le analoghe ferite di Pio da Pietrelcina, rilevate in un secolo apparentemente più razionale. A fornire la descrizione finale del miracolo, quella omologata su cui poi si baseranno tutte le successive sarà proprio Bonaventura. Quest'ultimo potrà poi contare su un interprete figurativo d'eccezione: Giotto da Bondone.
Sulla falsariga del primo resoconto di Tommaso da Celano, Bonaventura collega la comparsa delle stimmate a un'apparizione angelica. Sul monte della Verna, durante un momento difficile, Francesco era stato visitato e confortato da una creatura a sei ali: un serafino. I serafini, spiegava Isaia, usano due ali per volare, e le restanti per coprire la testa e il resto del corpo. Sono gli angeli più vicini a Dio, e come Dio non possono essere visti direttamente dall'uomo. Tommaso aveva accennato a una relazione di causa ed effetto tra il serafino e le stimmate; Bonaventura va oltre. Il suo particolare pensiero teologico lo autorizza a vedere nel serafino una manifestazione del Cristo: sotto le ali, l'angelo nasconde il corpo di Cristo e le sue ferite, che durante l'apparizione si riproducono miracolosamente sul corpo sofferente del santo, "come il sigillo nella cera". È un'immagine che chiarisce finalmente la natura delle stimmate: non cicatrici di chiodi, non escrescenze carnose, ma impronte di un miracolo. L'idea sarà poi resa dai pittori attraverso la raffigurazione di raggi luminosi, secondo una iconografia che parte dalle Storie di San Francesco sulle pareti della Basilica Superiore di Assisi. Se anche non fosse stato Giotto a dirigerne i lavori, certo fu lui a riprendere e perfezionare la scena nella tavola dipinta per la chiesa di San Francesco a Pisa (oggi al Louvre) e in quella per la Cappella Bardi della chiesa di Santa Croce a Firenze. È un'interpretazione coraggiosa, che da parte di una fonte meno titolata e autorevole avrebbe potuto destare più di un sospetto di eresia: Francesco sofferente come nuovo Cristo, o immagine specchiata del Redentore. Con le parole di Chiara Frugoni (Vita di un uomo: Francesco D'Assisi, 1995):Facendo assumere alle stimmate il marchio divino, Bonaventura rese quella perfezione irraggiungibile: da una parte, Francesco rimaneva il santo da venerare, e sempre di più, perché portava nella sua carne le ferite di Cristo, ma dall'altra, proprio per questo motivo, i frati non erano obbligati ad imitare il fondatore, a rimanere fedeli alle sue scomode parole, al suo progetto di vita cristiana. La santità di Francesco era diventata inaccessibile e inimitabile. I frati, pur continuando a tributare un'estrema devozione a Francesco, dovevano seguire altri modelli, copiare la condotta di vita di altri uomini dalle virtù più semplici e accomodanti. Quella di Bonaventura fu un'operazione politica dettata dalla necessità di fare cessare le discordie, ma che mutò profondamente l'eredità di Francesco.
Sul calendario San Bonaventura si festeggia il 15 luglio, anniversario della sua morte, a Lione, nel 1274. Fu canonizzato nel 1482 e proclamato Dottore della Chiesa nel 1588. È patrono dei facchini e dei fattorini, non ho la minima idea del perché; dei teologi e dei tessitori, forse per l'abilità mostrata a disfare il textum della vita di Francesco e ritesserlo da capo, in una foggia più adatta al suo secolo: sotto la quale si cela qualcosa che cerchiamo di indovinare da allora, inutilmente.
Inginocchiarsi per chi, per cosa
23-06-2021, 00:08calcio, Il Post, razzismiPermalinkLe foto sono strumenti potenti, ma non dicono necessariamente la verità. Le foto che immortalarono il podio olimpico dei 200 metri all'Olimpiade del 1968 mostrano due atleti neri col braccio alzato e il pugno chiuso – anche se non sappiamo ancora quanto il gesto costerà a entrambi, intuiamo di trovarci davanti a un gesto forte di protesta. A rendere l'immagine così potente è soprattutto il contrasto col terzo atleta, bianco e apparentemente indifferente: è lui a creare l'asimmetria necessaria. Il bianco guarda avanti, i neri protestano. Per innalzare quelle mani guantate serve così tanta forza di volontà che a Tommie Smith e John Carlos non ne resta per alzare la testa: sanno di essere vittime sacrificali ma fanno quel che è giusto fare, e poi sia quel che sia. Dopo aver visto queste foto è facile provare un moto d'odio per Peter Norman, il velocista australiano medaglia d'argento che guarda avanti e pare inconsapevole. È inevitabile ma è anche un errore: Norman non solo simpatizzava coi due colleghi e collaborò alla loro protesta (pagando anch'egli un prezzo alto); ma fu proprio lui a suggerire a Smith e Carlos di alzare in quel modo i pugni che, se ci fate caso, sono complementari: uno alza il destro e uno il sinistro.
 |
| John Carlos, Tommie Smith, Peter Norman (pubblico dominio). |
In effetti l'idea originaria era di alzare insieme pugni destri e sinistri, in una posa che avrebbe potuto essere scambiata per quella dell'atleta trionfante: a rendere esplicita la protesta nei confronti del segregazionismo USA sarebbero stati i guanti neri – oltre alla coccarda del movimento che promuoveva la protesta, l'Olympic Project for Human Rights. Carlos però si era scordato i guanti al villaggio olimpico. Fu Norman a suggerire a Smith di prestargli uno dei suoi: forse da australiano gli sfuggiva l'ostilità del pubblico mainstream americano nei confronti della gestualità del pugno chiuso, da decenni associata all'antagonismo di sinistra. Quello che invece Norman colse al volo è che mostrare i pugni spettava solo ai due colleghi: la loro protesta era giusta, ma era la loro protesta. Un pugno bianco e non guantato l'avrebbe soltanto annacquata. Norman si accontentò di indossare la coccarda dell'Olympic Project: tanto gli bastò per essere squalificato dalla federazione australiana. Ma perché mi sono messo a raccontare di un episodio di protesta sportiva di più mezzo secolo fa?
Molti lettori potrebbero averlo già capito (in fondo sono lettori del Post). Magari l'intento è confrontare le epiche e iconiche proteste del passato – quando alzare un pugno ti costava la carriera – con la situazione presente in cui ogni azione diventa immediatamente standardizzata e pigra, al punto che agli Europei non si capisce nemmeno più se il gesto veramente politico sia inginocchiarsi o no. Ecco, sì, forse volevo scrivere un pezzo del genere, ma come la metto con Colin Kaepernick? Come faccio a definire 'pigro' il gesto che ha inventato e che gli è costato una carriera professionistica nel football americano, non nel 1968 ma dal 2017 in poi? Quando Kaepernick smise di alzarsi durante l'inno nazionale Trump si era appena insediato alla Casa Bianca e i media stavano documentando una inquietante recrudescenza degli episodi di violenza delle forze dell'ordine nei confronti dei cittadini afroamericani (chi ricollega il gesto al più tardo assassinio di George Floyd sta già facendo della mitologia). In una prima fase Kaepernick rimaneva semplicemente seduto: un gesto di rottura molto forte nei confronti di una ritualità particolarmente consolidata negli USA, dove vige tuttora un rispetto religioso per simboli unificanti come l'Inno e la Bandiera. Ai giornalisti che glielo domandarono rispose senza mezzi termini: "Non mi alzerò per mostrare orgoglio per la bandiera di un Paese che opprime la gente nera e la gente di colore. Per me questo è più importante del football, e sarebbe egoista da parte mia guardare da un'altra parte. Ci sono morti nelle strade e gente stipendiata che uccide e la passa liscia". In seguito, dopo una serie di discussione con colleghi e veterani, Kaepernick decise di non restare seduto durante l'inno, ma di inginocchiarsi.
Il gesto nasce quindi da un compromesso: Kaepernick non intendeva offendere chi serve con orgoglio la sua nazione, ma continuava a far presente che questo orgoglio non poteva condividerlo. Così codificato, il gesto cominciò a essere imitato da alcuni colleghi, ma soprattutto divenne un'ossessione per Trump, che a più riprese chiese il licenziamento per chi lo praticava. Kaepernick probabilmente passerà alla Storia, proprio come Carlos e Smith: nel frattempo però ha smesso di giocare; nessuna squadra l'ha più cercato. Protestare è ancora un gesto rischioso, quando la causa è controversa e il pubblico non è pronto – ovvero, in tutti i casi in cui protestare ha veramente senso. Ecco, forse ora è chiaro dove sto andando a parare: quello che è nato negli USA all'interno di un movimento preciso (Black Lives Matter) con richieste precise (eliminare la violenza poliziesca soprattutto nei confronti della comunità afroamericana), forse in Europa è arrivato un po' di rimbalzo, più che per emulazione che per una reale esigenza sociale. Sto veramente arrivando lì? Perché non è molto lontano da quel che potrebbero dichiarare Orban e Salvini sull'argomento. Faccio ancora in tempo a correggere un po' la rotta?
A quanto pare i primi a inginocchiarsi in Europa sono stati i calciatori della Premier League – come sempre la Gran Bretagna è il filtro da cui ci arriva la cultura americana, un filtro tutt'altro che neutro. Inginocchiarsi su un campo di calcio inglese è un gesto irrituale, ma senza quella punta di blasfemia e vilipendio che veniva percepita sugli spalti degli stadi americani; la pratica si ispira esplicitamente al movimento Black Lives Matter, ma spostando l'obiettivo verso un più generico antirazzismo. Se è comunque abbastanza chiaro per cosa si stiano inginocchiando i calciatori inglesi, è un po' più difficile capire contro chi. Il bersaglio polemico non sembra più l'autorità costituita e le sue forze di polizia; in molti casi sembra che l'avversario sia il pubblico, le frange di tifosi che in effetti talvolta reagiscono fischiando. È uno scenario molto più vicino a quello degli spettatori italiani: la tensione tra squadre sempre più meticce e tifosi sempre più identitari o razzisti. A ogni contestazione, il sindacato dei calciatori professionisti ribadisce che i suoi iscritti continueranno a inginocchiarsi e che il pubblico questa cosa la deve accettare; insomma inginocchiarsi è un modo di chiedere al pubblico: da che parte stai? Anche in questo caso dietro al successo di un gesto di protesta c'è una negoziazione: inginocchiarsi è un gesto semplice, non rovina lo spettacolo e crea senz'altro meno tensioni e strascichi di altri (pensate ai casi in cui un calciatore o un'intera squadra reagisce ai cori razzisti ritirandosi dal campo e incorrendo in una squalifica).
Più che un gesto di protesta, in Europa l'inchino diventa un gesto identitario: appoggiare il ginocchio significa dichiarare rapidamente il proprio antirazzismo. Ed eccoci agli Europei, dove – contrariamente a quello che si sente in giro – nessun organo ufficiale ha chiesto ai calciatori di inginocchiarsi. I calciatori inglesi hanno fatto sapere che lo avrebbero fatto, gli scozzesi hanno scelto di farlo in occasione di Inghilterra-Scozia; altre nazionali sono andate in ordine sparso; la UEFA si è limitata a chiedere rispetto per chi decideva di inginocchiarsi. Nel frattempo però l'argomento ha raggiunto le prime pagine, forse perché la fase a gironi non è così eccitante (se a Cristiano Ronaldo basta spostare una bottiglietta per far discutere un paio di giorni). Con un'inversione tipica delle guerre culturali contemporanee, la scelta identitaria è diventata quella di non inginocchiarsi: persino Orban ha dedicato un po' del suo tempo a spiegare perché i calciatori ungheresi non sono tenuti a farlo. In effetti chi si inginocchia sta ancora protestando, o si sta limitando a citare in favore di videocamera un gesto ormai estrapolato dal contesto originario? La forza del movimento Black Lives Matter risiedeva anche nel modo in cui circoscriveva la sua protesta. Non un generico antirazzismo, ma le Vite dei Neri Contano: uno slogan che non a caso gli avversari hanno cercato di scimmiottare per depotenziarlo, con lo slogan All Lives Matter. La standardizzazione dell'inchino pre-partita corre forse lo stesso rischio: chi si inchina rischia di non sapere perché lo fa. Senz'altro non per chiedere il taglio dei fondi alla polizia americana, come chiedono gli attivisti BLM: e allora per cosa? Se è un gesto che si limita a definire un'identità, il rischio è che si trasformi in una ritualità vuota, l'ennesima pratica di virtue signaling un po' fine a sé stessa; col non trascurabile effetto collaterale di far emergere, per contrasto le posizioni di chi rivendica a voce alta il rifiuto dell'inchino, l'insofferenza per un antirazzismo imposto dall'alto più con la pressione mediatica che con la forza degli argomenti.
Spero di non essere frainteso (ma è inevitabile): sono contento se molti calciatori si sentono antirazzisti e vogliono testimoniarlo sul campo; ovviamente preferirei che avessero obiettivi chiari e non un generico antirazzismo d'importazione, visto che anche in Italia c'è molto da fare (pensate se qualche calciatore italiano s'inginocchiasse per le vittime delle forze dell'ordine italiane o per le vittime del razzismo italiano: pensate che scandalo vero sarebbe). Mi dispiace che tutto debba sempre essere importato acriticamente dall'America, non perché gli americani non abbiano ottimi motivi per protestare come protestano, ma perché sono motivi che non capiamo e comunque non sono i nostri. Ho la sensazione che l'inchino in Italia venga percepito come il blackface, cioè una cosa che non si è capito come funziona tranne che se ti sbagli tutto il resto del mondo ti dà del razzista e quindi anche chi non capisce prima o poi si adegua – laddove capire sarebbe sempre la cosa più importante. Trovo controproducente la pressione mediatica che sospinge giornalisti e politici a etichettare come razzisti i calciatori che rimangono in piedi e che magari semplicemente hanno le idee confuse (anche i calciatori a volte possono averle confuse). I gesti di protesta dovrebbero fare scalpore e generare emulazione, come successe a Carlos, Smith e a Kaepernick; se invece diventano divisivi, rischiamo che un sacco di gente si ritrovi sul lato dei razzisti semplicemente perché erano in piedi quando abbiamo fatto le squadre. Quando vedo un gruppo di calciatori un po' in ginocchio e un po' no, cerco di combattere l'impulso a dividerli in buoni e cattivi; lo stesso impulso che mi faceva odiare Peter Norman, quando ancora non conoscevo la sua storia e l'equilibrio con cui seppe stare dalla parte dei giusti senza togliere loro l'onore della ribalta.
(Quasi dimenticavo: oggi 23 giugno ricorre la festa dei 1003 Santi Martiri di Nicomedia, che si presentarono davanti all'imperatore Diocleziano per testimoniare la loro fede, e Diocleziano li fece ammazzare tutti e 1003. Giusto per ribadire che protestare è sempre stato pericoloso. Chi non rischia qualcosa non sta protestando davvero. Vale per tutti noi, in ginocchio o dritti in piedi).
Marina e l'invidia del saio
17-06-2021, 23:38Il Post, omofobie, repliche, santiPermalink |
| Non so di chi sia, è convenzionale ma è la rappresentazione più androgina che ho trovato. |
L'episodio un po’ boccaccesco fece il giro del mediterraneo e ci è arrivato in dozzine di versioni diverse. In sostanza, il giovane Marino/Marina, già stimato da tutti i confratelli per la rettitudine e le virtù eccetera, viene inviato da qualche parte insieme con una delegazione di monaci. Nella locanda dove pernottano, un soldato giunto nottetempo stupra la figlia dell’oste. Quando i genitori se ne accorgono è troppo tardi, il soldato è già tornato alla tenebra donde è venuto, e la fanciulla è disonorata per sempre. L’unica è incolpare qualcun altro; in questo sono fortunati, perché Marino, l’irreprensibile Marino, denunciato davanti al suo superiore, non osa difendersi. Anzi, a un certo punto confessa la sua impossibile colpa. In questo possiamo ravvedere il masochismo tipico del folle di Dio, che decide di caricarsi delle colpe degli altri, ma anche un atteggiamento più prosaico: Marino aveva ben altro da temere che un’accusa di violenza sessuale, robetta. Al risarcimento ci avrebbe pensato il monastero. Quello che rischiava veramente, Marino/a, era il rogo per travestitismo: indossare indumenti non confacenti al proprio sesso era peccato mortale, e mille anni dopo sarebbe stato ancora il cardine di tutto il processo-farsa a Giovanna d’Arco. Marina insomma è una peccatrice, che diventa santa proprio in quanto peccatrice: una contraddizione che si spiega soltanto se immaginiamo la sua storia all’incrocio tra due civiltà diverse.
Il Vangelo di Tommaso prometteva il Regno dei Cieli a “ogni donna che si farà uomo” – ma fu escluso abbastanza presto dai testi canonici. Quando la storia di Marina comincia a diffondersi nel Mediterraneo, il cristianesimo è già una cultura egemone che aspira prima d’ogni cosa all’ordine: donne e uomini se ne stiano al loro posto. Ma il nocciolo della storia contiene ancora l’anima del cristianesimo degli inizi, una setta di folli che in attesa di una fine imminente avevano abolito la proprietà e le differenze di ceto e di genere. Marina nel frattempo deve abbandonare il monastero, ma pazienza: basta trasferirsi lì nei pressi, vivere rettamente e aver pazienza, prima o poi l'avrebbero riaccolto/a – figurati se lo bandiscono a vita per uno stupro, uno stupro solo? figurati.
Nove mesi dopo, la sorpresa.
Marino/a si trova un fagotto davanti alla porta di casa. Non le resta che improvvisarsi padre. Con che latte? Qui le versioni divergono: chi s’immagina una miracolosa montata lattea nella vergine-monaco, chi suggerisce che il latte glielo portassero i pastori. Preferisco quest’ultima: mi lascia il sospetto che una storia del genere possa essere capitata davvero. Marina cresce il figlio non suo come un padre, avviandolo ovviamente alla carriera monacale; e ovviamente se lo porta con sé quando i confratelli decidono di riammetterlo, a tre anni dal fattaccio. Continuerà a mostrarsi un esempio di rettitudine e virtù per il resto della sua esistenza; il suo segreto sarà scoperto soltanto quando i monaci ne spoglieranno il cadavere per pulirlo. Questo aspetto della storia a un certo punto divenne un po’ scabroso (monaci scoprono vagina in un cadavere), sicché nacque la variante del biglietto: prima di morire Marina avrebbe lasciato scritto: “sono una donna, ciao, non fate troppi pettegolezzi”, o qualcosa del genere. Noi ovviamente preferiamo la scena in cui i monaci si trovano davanti alla vagina di un cadavere:
“Ehi, aspetta, ma l'affare dov'è?”
“Non capisco. Forse è molto piccolo”.
“Pure pare lo sapesse usare”.
“Zitto! Cerca bene, dev’esserci”.
“Ma succede così quando muori? Ti si ritira?”
“Miracolo!”
“Ma sta’ zitto! Questa è una vagina”.
“Che cosa?”
“È una vagina, ti dico”.
“Fratello, non può essere!”
“Invece è così”.
“Io non sarei così sicuro, fratello, di quel che hai visto da ragazzino in un bordello a Tessalonica”.
“Ehi, ritira quello che hai detto”.
Segue rissa. Per cercare di disbrigare il bandolo, i monaci tornano alla locanda fatale. L’oste cade dalle nuvole; la figlia invece confessa durante una crisi isterica, o come si diceva allora, esorcismo. San Marina è patrona delle gravidanze difficili, dei genitori non standard, e si invoca per far sgorgare l’acqua o il latte. Il nome l’ha resa molto popolare tra i marinai, i monaci del mare, anche loro spesso inclini a favoleggiare di fanciulle travestite, compresse in abiti da mozzo. Dopo il crollo dell’Impero Bizantino, Venezia ne volle a tutti i costi le spoglie e le trovò, ma non fu sempre un’ospite all’altezza.
La figlia di San Pietro, o forse no
30-05-2021, 18:17Il Post, pontefici, Roma, santiPermalink31 maggio – Santa Petronilla martire, I secolo
Di tanti santi non ci resta che un nome sul muro. È comunque notevole quante storie siamo riusciti a inventarci, con quel nome e poco altro. L'esempio limite sono sempre le undicimila vergini di Sant'Orsola, nate tutte e undicimila da un errore di trascrizione; quanto a Santa Petronilla, a un certo punto si ritrovò su altari importanti semplicemente perché il suo nome ricordava quello di Pietro: e in seguito, per lo stesso motivo, fu accantonata. Sic transit gloria coeli.
 |
| L'affresco della matrona, nella Catacomba di Domitilla. |
Il nome Petronella mart[yr] si legge in quello che forse è il più antico affresco cristiano che si sia conservato, risalente al IV secolo, presso la Catacomba di Domitilla, sulla via Ardeatina. Petronilla è raffigurata mentre indica alla matrona Santa Veneranda una pergamena (le Scritture?) e forse la conduce in cielo. Tutto qui. "Petronella" però è un nome curioso. L'origine non è difficile da rintracciare: la gens Petronia era una delle più importanti famiglie Romane nel periodo repubblicano e imperiale. Oggi la ricordiamo soprattutto per quello scrittore sconcio, ma fior di senatori e latifondisti hanno portato il nome Petronius. Prima che ironizziate sulla scarsa fantasia di uno di questi Petroni che avrebbe chiamato sua figlia "Petronilla", cioè piccola Petronia, vi devo rammentare che non funzionava così, cioè i Romani non davano un vero nome alle loro figlie – o forse lo davano, ma era talmente privato che non veniva mai divulgato agli estranei, né registrato dai documenti, e quindi non lo conosciamo. In società le donne venivano chiamate col femminile del nome gentilizio del padre, che in periodo imperiale assume spesso la forma diminutiva: per cui se nascevi figlia di un Domizio eri Domitilla; se invece ti dava la vita un Petronio, eri Petronilla e stop. Se poi avevi sorelle, per distinguerti potevano chiamarti "Prima", "Secunda", "Tertia", a seconda dell'ordine dell'arrivo. Possiamo trovare l'usanza un po' barbara (in realtà furono i barbari ad abolire l'usanza), ma senz'altro ha risparmiato a generazioni di genitori quei nove mesi di discussioni. Di Santa Petronilla, assente dai più antichi martirologi, si conosceva insomma soltanto la famiglia d'origine, e nient'altro: ma a partire dal V secolo anche questo dettaglio fu rimosso, in favore di un'ipotesi più suggestiva accreditata a partire dalla Passione dei martiri Nereo e Achilleo: che il nome "Petronilla" cioè non discendesse da "Petronio", bensì da "Pietro", il primo tra gli apostoli nonché fondatore della Chiesa di Roma. Proprio a Roma, mentre esercitava il suo apostolato, Pietro avrebbe avuto una figlia, che sarebbe morta martire come lui. Ovviamente non ci sono prove, ma se è per questo anche quelle che collegano Pietro Apostolo a Roma sono molto labili.
Ne abbiamo già discusso: non c'è un solo versetto del Nuovo Testamento che affermi esplicitamente un passaggio di Pietro a Roma. Viceversa è proprio Pietro a concludere la sua Prima Lettera porgendo i suoi saluti da Babilonia. "Babilonia" ai tempi di Pietro era ancora uno dei nomi di una città reale, ovvero Seleucia-Ctesifonte sul fiume Tigri; per estensione poteva indicare tutta la regione mesopotamica, dove davvero Pietro potrebbe essersi spinto dopo dopo il suo soggiorno ad Antiochia di Siria, questo sì attestato dagli Atti degli Apostoli. E allo stesso tempo "Babilonia" potrebbe essere un riferimento in codice a Roma in quanto tronfia capitale del peccato, immediatamente decifrabile per tutti i cristiani e appassionati lettori di Isaia. Così almeno hanno voluto leggerlo nei secoli successivi i cristiani romani e in generale tutti gli autori a cui premeva insistere sul primato petrino. Certo, è curioso che Luca, l'autore degli Atti, a un certo punto abbandoni completamente Pietro e si concentri soltanto su Paolo di Tarso, che nel finale del libro arriva a Roma ed è messo agli arresti domiciliari. Se in quel periodo anche Pietro fosse già stato a Roma, Luca ce lo avrebbe detto: a meno che Pietro non fosse in quel periodo un clandestino, un ricercato, ed è possibile anche questo.
Comunque tutte le successive avventure di Pietro nell'Urbe sono contenute in testi che già la Chiesa dei primi secoli liquidava come apocrifi. La presenza di Pietro a Roma era però necessaria per giustificare il principio del primato del vescovo di Roma su tutti gli altri presuli della cristianità: ogni indizio in tal senso era prezioso. Si può immaginare quanto avrebbero apprezzato, i successori di Pietro, una sola iscrizione di epoca imperiale recante il nome dell'Apostolo: ma non la trovarono. In compenso trovarono una Petronella mart.: meglio che niente.
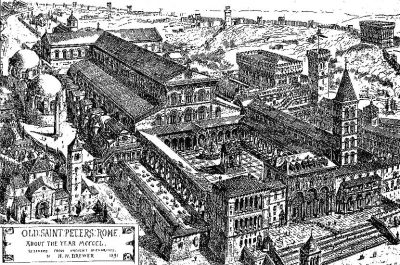 |
| L'antica Basilica di San Pietro in un'incisione rinascimentale: il primo edificio a pianta circolare dall'alto era la Cappella di Santa Petronilla, già mausoleo di Onorio. |
La necessità di accostare Petronilla a tanto padre portò alla produzione di ulteriori leggende in cui San Pietro guariva la figlia da questo o quel male. Nell'ottavo secolo papa Stefano II decide che Petronilla deve riposare nei pressi del padre, sulla cui supposta tomba già in epoca costantiniana era sorta l'Antica Basilica. La traslazione viene effettivamente ordinata dal successore, papa Paolo I: le ossa attribuite a Petronilla martire vengono spostate dalla catacomba a un edificio che sorgeva a fianco della Basilica. Si trattava dell'ultimo mausoleo imperiale di Roma, quello dell'imperatore Onorio (V secolo), da lì in poi conosciuto come Cappella di Santa Petronilla.
Nel frattempo sta finendo l'ottavo secolo. Il papato deve scegliere da che parte stare tra Franchi e Longobardi, e questi ultimi danno meno affidamento, anche solo perché a Roma li conoscono meglio. Quando Carlo non-ancora-Magno arriva a Roma la prima volta, papa Adriano lo porta in visita anche alla tomba di Petronilla, la cui cappella viene ora dedicata ai re Franchi. È un piccolo gesto di enorme significato: il regno dei Franchi è adottato come un figlio dalla Chiesa, così come Petronilla è figlia di Pietro. E siccome sulla tomba di Petronilla pare fosse inciso un delfino, questo simbolo entrerebbe a far parte dell'araldica imperiale, dove sarebbe stato associato soprattutto alla contea di Vienne sul Rodano, dal XIV secolo in poi destinata all'erede al trono di Francia, conosciuto fino all'Ottocento come il "Delfino".
Petronilla insomma ha le carte in regola per diventare la patrona di uno dei più importanti regni della cristianità: e invece dal decimo secolo in poi la sua fama si eclissa. Nessun re Franco e poi francese viene effettivamente tumulato nella cappella; il nome "Petronilla" resiste ancora in quanto associato all'edificio, finché nel Rinascimento gli umanisti non decidono che doveva trattarsi di un antico Tempio di Apollo e non cominciano a chiamarlo così. Nel 1519 viene comunque demolito senza troppi rimpianti per far spazio al complesso architettonico della nuova Basilica. Nel frattempo Petronilla era tornata a essere poco più di un nome inconsueto su qualche antico documento. Cos'era successo? In breve, l'idea che Pietro avesse avuto una figlia era ormai diventata imbarazzante.
La cosa in sé non era scandalosa: nei vangeli di Marco e Luca, Gesù guarisce la suocera di Pietro, che quindi come minimo era sposato. Nella sua Prima Lettera, proprio mentre saluta da Babilonia, Pietro cita un Marco come "suo figlio", quindi non era impossibile che ne avesse avuto altri. Impossibile no, ma poco edificante per i suoi successori che dall'Anno Mille in poi insistono sempre di più sul celibato sacerdotale. È una fase in cui papi importanti come Leone IX e Gregorio VII cercano di recuperare la credibilità di un clero sempre più corrotto. I mali del secolo si chiamano simonia e nicolaismo: il primo è la compravendita di titoli ecclesiastici, molto ricercati dalle nobili famiglie che dovevano piazzare i figli non primogeniti esclusi dall'asse ereditario. Il risultato è che molti seggi vescovili anche importanti erano occupati da figli di papà non esattamente portati al sacerdozio, con una conseguente rilassatezza dei costumi che è facile immaginare. Eppure il nicolaismo era una piaga anche peggiore, e consisteva nell'abitudine dei sacerdoti a prendere concubine o addirittura a sposarsi, lasciando dunque eredi, malgrado già da secoli vescovi e padri della Chiesa lo sconsigliassero fortemente, quando non lo vietavano proprio. Questi divieti venivano troppo spesso ignorati e i preti continuavano a far figli a cui spesso cercavano di intestare parte dei propri benefici, il che minava alle fondamenta tutta l'istituzione.
 |
| Gregorio VII, al secolo Ildebrando di Soana |
Non si trattava tanto di una questione di castità (i sacerdoti non fanno voto di castità, ma appunto di celibato): a scandalizzare i laici di ogni classe sociale era il modo in cui questi chierici sposati amministravano i beni della Chiesa, badando più agli interessi famigliari che a quelli della diocesi o della parrocchia. Gregorio VII reagì alla questione con intransigenza, pretendendo che i vescovi rispettassero e facessero rispettare il principio: con il suo papato, la Chiesa fece un passo definitivo verso la trasformazione in quella gerarchia di celibi che è tuttora, un'enorme organizzazione che assorbe benefici e donazioni in ogni continente senza doverne mai cedere una parte a nessun erede legale. Ma a quel punto l'idea che il primo degli Apostoli e il primo dei Pontefici romani avesse avuto una figlia diventava scomoda da gestire. Di questa Petronilla nulla di certo si sapeva, tranne che aveva il nome del padre e in virtù di questo si era meritata una cappella tutta sua di fianco alla Basilica più importante: non un buon esempio per una Chiesa che volesse respingere il nicolaismo e il nepotismo. Già in qualche leggenda più tarda Petronilla è soltanto una figlia adottiva, o una convertita che assume il nome dell'Apostolo in modo non dissimile da come gli schiavi affrancati derivavano il loro nome da quello dell'ex padrone che li aveva liberati. La stessa Francia si dota col tempo di Santi più blasonati e storicamente attestabili come Re Luigi IX o Giovanna d'Arco. Quest'ultima rischia per un soffio di sovrapporsi a lei anche nel calendario, dove Petronilla è festeggiata nell'ultimo giorno di maggio. Giovanna invece fu bruciata a Rouen il giorno prima, il 30 maggio del 1431.
Dylan vive, Dylan sogna
23-05-2021, 23:47Bob Dylan, Il Post, musicaPermalinkRough and Rowdy Ways (2020)
Cavaliere Nero, Cavaliere Nero, dimmi quando e come,
se è mai stato il momento, fa' che sia adesso.
Lasciami andare, apri la porta,
la mia anima è angosciata, la mia mente è in guerra.
Non abbracciarmi, non lusingarmi, non fare il pagliaccio:
Prenderò una spada e ti taglierò il braccio.
Morire è già di per sé una faccenda penosa: ma immagina di essere una celebrità. Immagina tutti i necrologi e le retrospettive che dovrà leggersi il tuo fantasma prima di riposare, tutte quel fiume di lusinghe inutili e sassolini cavati da scarpe stagionate di cinquant'anni, immagina la rottura di coglioni. Finché sei vivo puoi semplicemente cambiare canale e non leggere il giornale, ma chissà se una volta morto funziona così, chissà se una volta abbandonato questo groviglio mortale ti lasciano il telecomando a portata di mano. Magari no, chi può dirlo con certezza, magari nell'Oltretomba ti tocca pure ascoltare i rilievi di Red Ronnie, t'immagini? Vien quasi voglia di non morire più. È questo lo scrupolo che dà alla sventura una vita così lunga. Andate avanti voi, Dylan si ferma un altro po' a Key West, a guardare l'orizzonte. È una posa un po' scontata, indubbiamente: è più o meno quello che gli vediamo fare da Not Dark Yet in poi (un quarto di secolo fa, vertigine!), ma che altro può fare, finché non ripartono i concerti?
 |
| Il punto più a sud degli Stati Uniti (continentali), su un molo di Key West, in Florida. CC BY-SA 3.0 |
A un certo punto della vita, Dylan deve aver deciso che morire non gli interessava. Attraversatelo voi il Rubicone, quel fiume che per noi italiani profuma di Trebbiano e Sangiovese e per gli americani è rosso ("ruby") di sangue, il confine tra Roma e Gallie, tra Repubblica e Impero. Ogni volta che si è imbattuto nel Cavaliere Nero, Dylan ha sempre trovato un motivo per dire di no. Sul Glasco Turnpike, in moto a 25 anni; a fine Settanta, quando era ridiventato una rockstar inseguito da groupie, spacciatori e avvocati divorzisti, finché in un qualche corridoio d'albergo non s'imbatté in Gesù. A metà anni Ottanta, quando anche Gesù aveva preso le distanze dalla sua discografia e lui si aggirava sul palco come un pugile suonato e fradicio. A fine Novanta, quando una brutta istoplasmosi rischiò di fare di Time Out of Mind un disco postumo (e che gran disco postumo sarebbe stato). Quante volte Dylan se l'è visto davanti, il Cavaliere; quante volte si sarà sentito dire che era il momento buono, che è dovere delle Leggende morire relativamente presto e lasciare un bel cadavere, che lassù c'era già Jimi, Janis, Elvis, c'era John, insomma ancora un po' e rischi di perdere il posto. Finisci in seconda fila nel limbo delle rockstar, pensaci, hai presente dove ti misero in USA For Africa? Una cosa del genere ma per l'eternità. Non è meglio se muori prima dei tuoi critici più affezionati, quando è ancora in giro qualcuno che sappia scolpirti un monumento decente? E tutte le volte Dylan ha trovato un motivo per rispondere: grazie, no. Ho la mia vita, i miei dischi, i miei concerti, a posto così.
Come se fosse facile, e non una scelta quasi impossibile per un maschio adulto di una certa età e di un certo successo. Voglio dire, è più facile scrivere Blowing in the Wind o smettere di bere a cinquant'anni quando chiunque ti sia abbastanza vicino da farti un rilievo puoi licenziarlo in tronco? Quanta impressione fa riprendere in mano una biografia degli anni '90, come Jokerman, e ritrovare nelle pagine finali l'immagine di un rudere prossimo alla pensione. A un certo punto Dylan si è sbloccato, non abbiamo mai capito il perché e neanche lui è riuscito davvero a spiegarcelo: e sì che ci ha provato. Da fuori l'impressione è che lo abbia salvato la musica: i concerti soprattutto. Lui che si era già stancato di suonare dal vivo nel '66, dal 1987 è partito per fare un po' di date ed è come se non fosse più tornato a casa. Le stagioni si alternavano inesorabili, i presidenti si alternavano ogni quattro o otto anni, dichiaravano guerre e le dichiaravano vinte, e Dylan continuava a suonare. Quando a Stoccolma volevano consegnargli il Nobel, lui aveva delle date prenotate a Las Vegas e andò a Las Vegas, ché l'Accademia di Svezia mica ti paga le penali. Nulla lo avrebbe fermato, terremoti, uragani, epidemie. No, in realtà l'epidemia lo ha fermato, e a quel punto abbiamo cominciato a preoccuparci. Cosa farà Bob Dylan senza i suoi ottanta concerti all'anno? Reggerà la mancanza di stress, i pomeriggi vuoti ad ascoltare dischi che sa a memoria, a cominciare libri di cui si stanca a metà?
Qualche giorno fa qualcuno è riuscito a fargli una foto mentre entra in un bar e insomma, pare che un anno di Covid abbia fatto a Bob Dylan meno danni che a me. Quando ha smesso i concerti, si è rimesso a incidere canzoni, come fosse la cosa più naturale del mondo. Un filo di parole che sembrava tranciato netto otto anni fa, lui l'ha ripreso con apparente naturalezza e si è rimesso a raccontarci le sue serie di sogni, scombinati come i sogni sono sempre. Quelli dei vecchi forse sono un po' più elaborati perché contengono moltitudini: gli anziani devono smaltire più ricordi (i sogni a questo servono), e più cultura. Da un po' abbiamo scoperto che Chronicles I, un libro di memorie, era in realtà un libro di ritagli di altri libri. Ormai non c'è più una sola parola, nelle canzoni di Dylan, che non rimandi certamente a qualche altra canzone o poesia o testo. Quando Dylan nella strofa successiva spiega al Cavaliere Nero che "le dimensioni del tuo uccello non ti porteranno da nessuna parte" ("the size of your cock won't get you nowhere") Alessandro Carrera ci rimane un po' male, gli sembra una caduta di stile; poi però si mette a cercare finché non trova un il riferimento, e questo in parte lo consola: sarà anche una caduta, ma è una citazione da Giovenale, Satira IX, dai, ci può anche stare. Si capisce che in questo modo potremmo perdonare a Dylan qualsiasi testo senza capo né coda – non è in fondo quello che facciamo da sempre? I sogni vanno presi per quel che sono: mentre ci sei dentro credi che abbiano una trama coerente, ma quando ti svegli capisci che la verità si fa vedere solo a sprazzi, qua e là, senza avvisare e senza salutare. Se c'è un buon verso (e ce n'è parecchi), teniamocelo per detto e ringraziamo: che altro vorremmo chiedere al Sognatore, più coerenza strutturale, più trama? Per queste cose c'è Netflix. Magari My Own Version of You all'inizio era un vecchio film in bianco e nero, magari Dylan all'inizio era Frankenstein, se non direttamente il mostro di Frankenstein deciso a fabbricarsi una compagna. E già qualcosa si sta sfilacciando, la "mia versione di te" è diventata una "versione di me", e nel frattempo le parole per associazione ne hanno evocate altre e Dylan non sa più cosa sta raccontando, ma che importa, "mica mi perderò in dettagli insignificanti".
Non è un procedimento consapevole, è semplicemente il modo in cui un anziano pensa e sogna. Se si trova sulla spiaggia di Key West, il punto della Florida più vicino a Cuba, gli viene in mente il presidente McKinley, che Cuba la conquistò agli spagnoli e ai soldati americani (tra cui Theodore Roosevelt) che si imbarcavano da lì; e che McK fu assassinato nell'anno in cui le onde radio arrivarono negli USA; ma a quel punto gli vengono anche in mente Radio Luxembourg e le altre emittenti radio pirata che cambiarono la storia della musica (però in Europa); intanto McKinley è diventato un profeta e un pirata, magari anche per allitterazione; e il suo assassinio non può che condurre Dylan a rimuginare sul ben più traumatico assassinio di Kennedy. È tutta una serie di sogni, il profeta non può uscirne. Key West è un posto dove andare in attesa dell'immortalità.
Dal Vangelo di Giovanni, 21,21-23: Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: «Signore, e lui?». Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che rimanga finché io venga, che importa a te?».
Insomma Dylan è vivo e continua a scrivere buone canzoni, le solite elegie e i soliti bluesacci, con testi sconnessi ma non più del solito. Ma anche in caso contrario, che motivo avevamo di stare in pensiero per lui? In qualsiasi momento arrivasse il Cavaliere Nero, non sarà già abbondantemente in ritardo? ("I’ve already outlived my life by far", riconosce in Mother of the Muses). Chi può dire di aver vissuto una vita altrettanto avventurosa e ricca di soddisfazioni. quanti altri dischi/capolavori abbiamo il diritto di aspettarci da un ottantenne? Ok, eppure è in giro da così tanto tempo, il vecchio Bob, che ormai sembra ingiusto privarcene. Secondo un'antichissima leggenda – già attestata in Gv 21,21-23 – San Giovanni Evangelista in realtà non è mai morto; è ancora da qualche parte che aspetta di assistere al Secondo Avvento di Gesù nella gloria. Questo potrebbe spiegare come mai in My Own Version of You Dylan lo inserisca in una serie di pianisti celebri, tra Leon Russell e Liberace. I critici americani restano perplessi, ci informano che ai tempi di Giovanni Evangelista il pianoforte ancora non esisteva: grazie critici americani, se non ci foste voi. Ma se l'Apostolo Che Gesù Amava non fosse mai morto, dove potrebbe essersi nascosto per tutti questi secoli? Un tizio che a cent'anni scriveva l'Apocalisse, cosa potrebbe fare a duecento, cinquecento, eccetera? È lecito immaginare che abbia scritto qualche apocalisse in più. Appena ha potuto si è messo a imparare qualche strumento, di sicuro quando hanno inventato il pianoforte aveva già qualche secolo di esperienza con le tastiere occidentali, e anche la chitarra elettrica per lui sarà stata una robetta. Solo la voce l'ha sempre tradito per quel matusalemme che era. E così eccoti qua, Giovanni Apostolo. Come dobbiamo chiamarti? Ebreo errante, Robert Zimmerman, Jimmy Reed?
Abito in una strada che ha il nome di un santo, le donne nelle chiese hanno addosso cipria e fondotinta. Qui pregano ebrei, cattolici e musulmani, ma so riconoscere un protestante da un miglio. Arrivederci Jimmy Reed, Jimmy Reed, proprio te: dammi la cara vecchia religione, è quella di cui ho bisogno...
Un altro esempio di come Dylan può far impazzire gli esegeti americani, che qui insorgono: cosa c'entra Jimmy Reed con la "old time religion", cosa c'entra l'ubriacone autore di Bright Lights, Big City con Gesù? Sono domande che è inutile porre all'inconscio, e in particolare all'inconscio di Dylan dove da sempre "cristianesimo protestante" e "blues" sono corridoi paralleli e comunicanti. Se aggiungi che "religion" nei vecchi brani blues e folk può essere la magia nera (e quindi il blues), capisci come tutto possa significare sempre il contrario di tutto, e il senso vada cercato proprio in quell'opposizione. Dylan ha nostalgia del vecchio blues come della vecchia America protestante: tutto questo multiculturalismo che vede trionfare nel suo quartiere non è che lo scandalizzi, ma a volte lo stanca; ognuno idealizza la sua infanzia e ai suoi tempi le chiese erano ancora segregate e le cartolerie, vi ricordate? vendevano cartoline delle impiccagioni. Era un mondo di contrasti, ma erano contrasti che Dylan ancora riusciva a capire. Senz'altro la vecchia religione dei predicatori e la vecchia musica dei bluesmen non sono la stessa cosa, ma Dylan le rimpiange assieme, nello stesso sogno che è la stessa canzone. Ed è un rimpianto senza velleità apocalittiche, Dylan non le rivuole davvero indietro, sta soltanto intonando un addio, l'ennesimo. Che altro dovrebbe fare.
Questo pezzo è l'appendice di un lungo viaggio che intrapresi sul Post quattro anni fa: ogni settimana raccontavo un disco di Dylan, dal primo all'ultimo che a quel tempo era Tempest (sui dischi di cover confidenziali, chiedo scusa, non ho ancora trovato niente da scrivere). Quando è uscito Rough and Rowdy Ways non sapevo bene cosa dirne, ho preferito aspettare. Non sono molto bravo ad ascoltare i dischi nuovi, ci metto mesi a separare il grano dal loglio, nel frattempo qualcuno avrebbe deciso per me se era un capolavoro o un'opera senile; qualcuno mi avrebbe aiutato a risolvere gli indovinelli. Non è andata così. I critici per lo più lo hanno trovato buono, ma con accenti entusiasti che mi fanno dubitare della loro oggettività, e del resto come si fa a giudicare oggettivamente un disco di Dylan, che ormai è in una categoria a sé? La cosa più saggia è confrontarlo a Tempest, un disco meno compatto ma forse più avventuroso. Rough and Rowdy Ways in linea di massima è una raccolta di canzoni più riuscite, cantati con più raccoglimento da una voce che negli ultimi anni si è assestata – alla fine i dischi di cover sono stati un'ottima palestra – e non oscilla più pericolosamente tra il guaito e la tosse grassa. Dylan canta un po' meglio del solito, ma non è la prima volta che succede e non è la prima volta che ci fa rimpiangere certi brani assurdi che oggi non comporrebbe più, incisi con una voce a brandelli che oggi non ha più. Mancano i guizzi, insomma, gli alti e i bassi che ci tenevano svegli in altri dischi; è del tutto scomparso quello swing sui generis che aveva rianimato la sua carriera da "Love and Theft" in poi, insomma un brano come Duquesne Whistle nel nuovo disco non c'è e un po' lo rimpiango; non è che posso pretendere un'altra Visions of Johanna da un compositore ottantenne, ma un'altra Duquesne sì, non mi sarebbe dispiaciuta.
Dylan non è più lo scavezzacollo settantenne che le prova tutte, e quando gli va male scrive una litania interminabile come Tempest (la canzone), ma quando gli va bene azzecca un numero ipnotico e teatrale come Tin Angel. Sulla soglia degli ottant'anni sembra aver tirato i remi in barca: è ritornato ai vecchi blues in dodici battute ma se li fa cucinare dalla sua band più sporchi del solito, grezzi e chiassosi ("rough and rowdy"), con qualche incertezza ritmica che ci ricorda i suoi esordi elettrici. Tra un bluesaccio e l'altro una ballata: qua e là (soprattutto in Key West) si sente un'eco lontana delle atmosfere scoperte collaborando con Daniel Lanois. L'unico numero eccezionale è il finale, che nella versione CD sta su un disco a parte: l'interminabile elegia per Kennedy, Murder Most Foul, che uscì in anteprima l'anno scorso e di cui qui si è già parlato. E quindi? È un capolavoro questo Rough and Rowdy Way, o siamo tutti semplicemente inteneriti dallo spettacolo di un ex folksinger, ex rockstar, ex simbolo generazionale, che è sopravvissuto a ogni ondata che doveva travolgerlo, al punto che ormai gli perdoniamo qualsiasi caduta di stile, qualsiasi incoerenza e ripetizione, qualsiasi cosa ci canti, purché ci canti ancora?
Non saprei. Cioè è un buon disco, tutto sommato, però... mi lascia insoddisfatto, credo che in seguito lo considereremo un disco di transizione. Puoi sognare di meglio, vecchio Dylan, non fermarti. Ah, e buon compleanno.
Gli altri dischi di Bob Dylan: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan, New Morning, Another Self Portrait, 1971: Greatest Hits II, 1973: Pat Garrett and Billy the Kid, 1974: Planet Waves, Before the Flood, 1975: Blood on the Tracks, Desire, The Rolling Thunder Revue, 1976: Hard Rain, 1978: Street-Legal, At Budokan, 1979: Slow Train Coming, 1980: Saved, 1981: Shot of Love, 1983: Infidels, 1984: Real Live, 1985: Empire Burlesque, Biograph, 1986: Knocked Out Loaded, 1987: Down in the Groove, Dylan and the Dead, 1988: The Traveling Wilburys Vol. 1, 1989: Oh Mercy, 1990: Under the Red Sky, Traveling Wilburys Vol. 3, 1991: The Bootleg Series Vol 1-3 (Rare and Unreleased), 1992: Good As I Been to You, 1993: World Gone Wrong, 1994: MTV Unplugged, 1997: Time Out of Mind, 2001: “Love and Theft”, 2006: Modern Times, 2008: Tell Tale Signs, 2009: Together through Life, Christmas in the Heart, 2012: Tempest, 2020: Murder Most Foul.
Il terzo (o il quarto?) segreto di Fatima
12-05-2021, 22:10Il Post, madonne, pontefici, repliche, santiPermalink |
| www.vetrateartistiche.com |
13 maggio - Madonna di Fatima.
[2012]. 31 anni fa oggi, a Piazza San Pietro Mehmet Ali Ağca sta per sparare il terzo colpo (o il quarto), quando una suora e un addetto alla sicurezza del Vaticano lo atterrano. Stacco. Dieci giorni prima, un monaco trappista dirotta un Boeing 737 in Normandia e minaccia di dar fuoco all'aeroplano se non gli viene rivelato il Terzo Segreto di Fatima. Stacco. Il Papa Buono dietro una scrivania tiene in mano una busta. C'è scritto, in portoghese: per ordine di Nostra Signora aprire nel 1960. La mano trema. Stacco. Una folla radunata in un villaggio: siamo nell'ottobre 1917, quindi le immagini sono in bianco e nero, tranne che all'improvviso il sole esplode in una supernova arcobaleno. Stacco. Karol Wojtyla parla dal balcone, la sua voce fuori campo annuncia: "gli oceani annegheranno intere sezioni della terra... da un momento all'altro milioni di persone periranno... però non abbiate paura". Dissolvenza incrociata: la statua della Madonna di Fatima, zoom sulla corona, una voce fuori campo: "Perché il Papa non ci volle consegnare la terza pallottola? Oggi magari sapremmo che Ağca non era il solo killer". Zoom sulla corona dorata, ehi, ma quella... sembra proprio una pallottola! Dissolvenza incrociata. Un uomo in bianco sale su una montagna cosparsa di cadaveri, dispensando benedizioni con fare allucinato. Una voce simile a quella di Joseph Ratzinger, fuori campo, dice: "Chi leggerà con attenzione... resterà presumibilmente deluso o meravigliato". Titolo: IL QUARTO SEGRETO DI FATIMA. PERCHÉ LA CHIESA NON VUOLE RIVELARLO? Ecco. Io una puntata di Voyager sulla Madonna di Fatima la lancerei così. E voi probabilmente avreste già cambiato canale da un pezzo. Va bene, ricominciamo.
Il terzo segreto di Fatima è stata l'apocalisse Maya della mia generazione - il solo nominarlo causava a preadolescenti di educazione cattolica autentici brividi di terrore. Considerate le coincidenze: Ali Ağca (in seguito preferì accreditarsi come "Gesù Cristo il Messia") sceglie per sparare a Papa Wojtyla, di tutti i giorni possibili, il 13 maggio, anniversario della prima apparizione della Madonna ai bambini di Fatima. Un anno dopo (12/5/1982) il Papa, salvo per miracolo, si trova appunto a Fatima, quando il sacerdote spagnolo don Juan María Fernández y Krohn tenta di trafiggerlo con una baionetta. Per don Juan, Wojtyla era un agente di Mosca. Per molti ancora oggi l'uomo di Mosca era Ali Ağca - con o senza intermediazione bulgara. I russi, ma anche la CIA, i Lupi Grigi, i cardinali invidiosi, qualsiasi ente tirato in ballo da Cristo-Ağca nelle settecento versioni che ha fornito. Tutte dotate di qualche grammo di verosimiglianza: i Lupi Grigi erano terroristi laici, senza pregiudiziali, che per soldi potevano far lavoretti per chiunque. Per conto loro avevano messo su un fiorente traffico di stupefacenti che li aveva messi in contatto con tutte le criminalità organizzate d'Europa.
 |
| Suor Letizia, quella che ha buttato giù il Lupo Grigio. Alla grande, sorella. |
La guerra fredda, nella sua fase finale: il rush della corsa agli armamenti, gli euromissili sepolti sotto le nostre biolche di onesti coltivatori padani, puntati anche verso la Bulgaria. Per chi cresceva negli anni Ottanta, l'apocalisse nucleare era un'opzione. Non dico che ci pensavi tutti i giorni, ma ci pensavi. A scuola ti mostravano The Day After. A catechismo ti parlavano della Madonna di Fatima. Dei meravigliosi doni che aveva fatto ai tre pastorelli portoghesi: per esempio, aveva mostrato loro l'inferno. E consegnato informazioni riservate sulla fine del mondo, con una speciale attenzione per l'Unione Sovietica. Poi li aveva richiamati a sé, due su tre, facendoli morire ancora bambini durante un'epidemia, in modo piuttosto doloroso. La terza viveva semisepolta in qualche convento iberico, e conservava l'immagine specchiata di cose di là da venire.
 |
| Lucia dos Santos (dieci anni) tra Jacinta Marto (7) e Francisco Marto (10), al tempo delle apparizioni (1917). Francisco sarebbe morto di spagnola nel 1918, Jacinta due anni dopo. |
Però la cosa che davvero mi agghiacciava era il matto che aveva dirottato il Boeing 737. Si era cosparso di benzina ed era andato a trovare i piloti con un accendino in mano. All'inizio aveva chiesto di farsi scaricare in Iran - era un volo Dublino-Londra, figuratevi, il posto più vicino all'Iran a disposizione era il primo aeroporto di qua dalla Manica. Quando atterra, ai negoziatori chiede che gli sia rivelato il Terzo Segreto, quello che solo pochi alti prelati conoscono. Dieci ore dopo i francesi mandano le teste di cuoio. È facile immaginare che nel frattempo fosse stata consultata la Santa Sede, la quale doveva aver risposto: meglio di no. Cosa c'era di così orribile in quelle quattro paginette scritte a mano, da rischiare piuttosto l'esplosione di un Boeing 737 pieno di passeggeri? È chiaro che un ragazzino di quell'età si fa subito venire in mente cose tremende. Poi crescendo uno all'apocalisse smette di pensarci tutto il tempo - si diventa razionali, direte voi - in realtà no, il contrario, a un certo punto gli ormoni cominciano a pompare e dei dieci anni successivi ho vaghi ricordi, mi sembra di aver pensato al sesso tutto il tempo. Quando hai 16, 17 anni, anche se ti dicono "fine del mondo", tu non pensi più agli euromissili e al segreto di Fatima, tu pensi Dai, è la volta che si scopa. Cioè, se non stavolta vuol proprio dire che mai.
Questa fase diciamo endocrinosofica della mia esistenza era già in gran parte terminata quando nel 2000 fu finalmente svelato il segreto che mi aveva terrorizzato da bimbo. Come aveva previsto Joseph Ratzinger (allora prefetto della Congregazione per la Difesa della Fede) rimasi deluso. Ma neanche tanto, in fondo è come vedere Belfagor da adulti, o ritrovare lo scivolo altissimo che ti terrorizzava all'asilo, in tutti i suoi due metri di orrido splendore. Tutti i brividi che hai provato ti lasciano giusto una punta di malinconia, come sentire il freddo sotto un'antica otturazione. Ormai sei grande, se ti dicono "fine del mondo" pensi Dai, allora stasera non correggo i compiti... Il terzo segreto di Fatima è il seguente.
Dopo le due parti che già ho esposto, abbiamo visto al lato sinistro di Nostra Signora un poco più in alto un Angelo con una spada di fuoco nella mano sinistra; scintillando emetteva fiamme che sembrava dovessero incendiare il mondo; ma si spegnevano al contatto dello splendore che Nostra Signora emanava dalla sua mano destra verso di lui: l'Angelo indicando la terra con la mano destra, con voce forte disse: Penitenza, Penitenza, Penitenza! E vedemmo in una luce immensa che è Dio: “qualcosa di simile a come si vedono le persone in uno specchio quando vi passano davanti” un Vescovo vestito di Bianco, “abbiamo avuto il presentimento che fosse il Santo Padre”. Vari altri Vescovi, Sacerdoti, religiosi e religiose salire una montagna ripida, in cima alla quale c'era una grande Croce di tronchi grezzi come se fosse di sughero con la corteccia; il Santo Padre, prima di arrivarvi, attraversò una grande città mezza in rovina e mezzo tremulo, con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena, pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino; giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della grande Croce venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce, e allo stesso modo morirono gli uni dopo gli altri i Vescovi Sacerdoti, religiosi e religiose e varie persone secolari, uomini e donne di varie classi e posizioni. Sotto i due bracci della Croce c'erano due Angeli ognuno con un innaffiatoio di cristallo nella mano, nei quali raccoglievano il sangue dei Martiri e con esso irrigavano le anime che si avvicinavano a Dio.
 |
| Chissà poi perché tanta paura. |
Tutto qui? Tutto qui. Per carità, c'è di che stare in ansia: massacri, martiri, un Papa assassinato, innaffiatoi di sangue. E allora perché non fa più paura? Perché, dopo anni di speculazioni, appena lo abbiamo letto ce lo siamo dimenticato? Forse perché nel frattempo siamo cresciuti. O forse non fa più paura proprio perché adesso lo conosciamo; la cosa veramente terrorizzante era quella busta chiusa, quell'avvertimento: non aprire prima del 1960. Un segreto ben custodito fa paura, una profezia divulgata dopo pochi minuti suona già falsa come l'oroscopo di ieri. Fu Umberto Eco il primo a far notare che il "segreto" era un collage di immagini dall'Apocalisse di San Giovanni: e in fondo, notava lo stesso Eco, Ratzinger con molto tatto aveva scritto la stessa cosa. Sopra Ratzinger però c'era Wojtyla, e Wojtyla aveva fatto incastonare la terza pallottola di Ağca nella corona della Madonna di Fatima. Un modo per sottrarla alle attenzioni degli inquirenti? Forse, però se davvero avesse voluto occultarla, non avrebbe scelto una posizione così in vista. Prima o poi qualcuno andrà lì con qualche strumento di ultima generazione e riuscirà a capire se la pallottola è uscita o no dalla pistola di Ağca. E se avesse avuto un complice? Cambia qualcosa? C'è un mafioso che a Borsellino ha detto di aver seppellito la sera stessa un terrorista turco in un orto fuori Milano, che due compagni avevano prelevato a Roma per ordine di un mafioso bulgaro per fargli poi fare "la fine dell'asino", che "si usa fino a che serve, dopo, quando non serve più, si uccide!" Salvo che il cadavere non si è mai trovato. C'è che in cella ci si annoia e allora si leggono i classici, ognuno il suo: San Giovanni per suor Lucia, Mario Puzo per il mafioso, e fuori c'è sempre qualcuno vuole sapere se hai studiato e ogni tanto ti fa interrogare.
 |
| La pallottola è nella corona, dicono. |
I tre segreti di Fatima sono in realtà un'unica rivelazione che suor Lucia ebbe il 13 luglio 1917, a dieci anni, durante il terzo degli incontri con la Signora di bianco vestita. Quando su invito dei superiori decise di metterli per iscritto ne aveva quasi quaranta. Il sole rotante e tutti i prodigi di quegli anni dovevano essere ormai un ricordo al di là della nostalgia, come lo scivolo dell'asilo o Belfagor, o la paura degli euromissili. È impossibile per me parlare di queste cose senza mescolare i labili ricordi originali con tutto quello che ho letto e ascoltato e visto negli anni successivi - tutta la cultura che ho ammucchiato sopra i miei choc d'infanzia. Belfagor, per dire, non sono nemmeno sicuro di averlo visto. Qualsiasi cosa suor Lucia vide veramente, non è rimasta indenne dal contatto dei libri che ha letto negli anni del convento - del resto era stata la stessa Signora a ordinarle di studiare. Suor Lucia infatti ha studiato, e si vede. Il primo segreto - la visione dell'inferno - è Teresa d'Avila. Il secondo segreto, col quale la Madonna di Fatima si dà alla politica internazionale prevedendo con tre mesi d'anticipo la rivoluzione d'Ottobre e chiedendo la consacrazione della Russia al suo Sacro Cuore - è Santa Margherita Maria Alacoque, roba da intenditori. La veggente francese nel Seicento aveva disperatamente tentato di raggiungere il Re Sole per chiedergli la consacrazione della Francia intera a una cosa che a quel tempo non si capiva ancora bene cosa fosse, una pompa cardiaca raffigurata in modo ormai anatomicamente corretto, sormontata da una croce e aggrovigliata da una corona di spine: il Sacro Cuore di Gesù che sanguina per i peccati dei francesi. Il Re Sole non aveva mai dato udienza e così Gesù dopo un secolo aveva mandato la Rivoluzione Francese. Sostituisci alla Francia la Russia zarista, il cuore di Maria al cuore di Gesù, e il Secondo Segreto si scrive da solo. Comunque:
Avete visto l'inferno dove cadono le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al Mio Cuore Immacolato. Se faranno quel che vi dirò, molte anime si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire; ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di Pio XI ne comincerà un'altra ancora peggiore. Quando vedrete una notte illuminata da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà che sta per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame e delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e la Comunione riparatrice nei primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà e avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa.
Immaginare una guerra "ancora peggiore" della prima mondiale non doveva essere così difficile, nel 1941. La "notte illuminata da una luce sconosciuta", lo affermava Lucia stessa, era un riferimento all'eccezionale aurora boreale nella notte tra il 25 e il 26 gennaio 1938. Tuttavia la veggente, con tutto che s'impegna, non è un'esperta di geopolitica e commette un errore imbarazzante, che in seguito cercherà di emendare. Dal suo convento del profondo Portogallo salazarista probabilmente la guerra in corso le sembra davvero un'iniziativa della Russia demoniaca contro il mondo: la Storia però la scrivono i vincitori, e noi oggi abbiamo di quella guerra un'opinione ben diversa, che vorremmo condivisa anche dalla Madonna di Fatima. E infatti più tardi, molto più tardi, suor Lucia scriverà che il secondo segreto riguardava
lo scoppio di una guerra atea, contro la fede, contro Dio, contro il popolo di Dio. Una guerra che voleva sterminare il giudaismo da dove provenivano Gesù Cristo, la Madonna e gli Apostoli che ci hanno trasmesso la parola di Dio ed il dono della fede, della speranza e della carità, popolo eletto da Dio, scelto fin dal principio: "la salvezza viene dai giudei".
Sono parole commoventi, soprattutto nei confronti dei giudei, salutati come il popolo eletto. Magari se le avesse messe per iscritto nel 1941 - e non in un documento pubblicato postumo nel 2005 - Pio XII avrebbe avuto qualche motivazione in più per contrastare il genocidio in atto. Invece, purtroppo, il secondo segreto di Fatima racconta di una seconda guerra mondiale scatenata dalla Russia e non fa nessun cenno al genocidio degli ebrei. Il fatto è che con le profezie bisogna andarci piano, anche quando sono divulgate post eventum, e la Congregazione della Fede lo sa. Suor Lucia aveva già toppato col secondo segreto, quante possibilità c'erano che ci azzeccasse col terzo? Probabilmente la busta chiusa "da aprire solo dopo il 1960" se ne sarebbe rimasta in un archivio per sempre, e a parte qualche ufologo flippato tutti ce ne saremmo dimenticati presto - se Ali Ağca, di tutti i giorni del calendario, non avesse scelto proprio quel 13 maggio. Wojtyla era già devotissimo alla Madonna prima, dal 14 in poi fu Tutto Suo. Nel corso di pochi anni i due veggenti morti bambini furono canonizzati, la Russia fu consacrata al Sacro Cuore di Maria secondo le indicazioni di Suor Lucia; la corona della Madonna di Fatima si adornò di una pallottola; e Wojtyla divenne il papa più famoso di tutti i tempi, con uno slogan ("non abbiate paura") che a me a dire la verità ha sempre fatto un po' paura.
Non metto in discussione la trovata geniale: quando Wojtyla si mise a dire che bisognava Varcare la Soglia della Speranza, molta gente in giro per il mondo non si ricordava neanche più cosa fosse quel peso sullo stomaco, quella morsa alle tempie: ecco cos'era, finalmente qualcuno non aveva paura di ricordarcelo: avevamo paura. Vivevamo nella paura, e ci era così familiare che ormai la davamo per scontata come una tabe ereditaria, io da bambino guardavo il cielo e ogni scia chimica per me era un potenziale SS20 con testata innescata. Wojtyla non mi ha mai veramente convinto, però posso capire quanta forza potesse avere un messaggio del genere: non abbiate paura. Ma perché non dovevamo averne? Su questo il Santo Padre non era mica tanto chiaro, al punto da farmi pensare al genere di persone che gridano "niente panico" alla folla. Per esempio, il personale di volo durante un disastro. Forse il "non abbiate paura" di Wojtyla era esattamente questo, un professionale "niente panico" rivolto ai passeggeri di un mondo che stava precipitando nelle fiamme della terza guerra mondiale: non abbiate paura, tanto andrà così e non c'è nulla che possiate fare.
 |
| Il quadro raffigurante il Terzo Segreto approvato da suor Lucia. |
C'è un'intervista tedesca, pubblicata nell'ottobre del 1981 (dopo l'attentato) ma che sarebbe stata rilasciata nel 1980 (prima dell'attentato): il perché ci sia voluto un anno a pubblicarla non lo so. Comunque in quest'intervista un Giovanni Paolo di fresca nomina commette un'imprudenza che in seguito non ripeterà più: richiesto di parlare del Terzo Segreto, spiega: "Se c'è un messaggio in cui si dice che gli oceani annegheranno intere sezioni della terra, e che da un momento all'altro milioni di persone periranno... non c'è veramente nessun motivo di voler pubblicare questo messaggio. Molti vogliono conoscerlo per pura curiosità, o per il gusto del sensazionalismo, ma dimenticano che "sapere" implica anche per loro una responsabilità. È pericoloso soddisfare una curiosità se sei convinto che non possiamo fare nulla per una catastrofe che è stata predetta". La traduzione dall'inglese è mia, miei i corsivi: sono veramente contento di non aver mai letto a 12 anni questa intervista in cui il mio Papa, miracolosamente sopravvissuto a un attentato, diceva papale papale che se sei convinto che l'aereo è spacciato e non puoi farci nulla, è inutile mettersi a soddisfare le morbose curiosità dei passeggeri. Negli anni successivi anche il più prudente Ratzinger confermò il carattere apocalittico della rivelazione. Però quando nel 2000 Wojtyla decise di divulgarlo, Ratzinger lo scrisse: molti si sentiranno delusi. "Nessun grande mistero viene svelato; il velo del futuro non viene squarciato".
 |
Alla fine è la stessa delusione che ti assale alla fine di un film horror: la locandina ti terrorizzava, pensavi che non avresti retto la visione... poi a un certo punto le luci si accendono, ti guardi intorno, hai perso un'ora e mezza per vedere cinque fotogrammi imbrattati di sangue finto e qualche maschera di gomma, e in tasca hai diecimila lire in meno. La delusione di vedere Belfagor da grandi: ma come faceva a far paura? E lo scivolo dell'asilo, eccetera. Molti non ci stanno. Non è vero. Questo non è il vero scivolo, è stato sostituito. Questo non è il vero film di paura che mi avevano detto gli amici, l'avrà censurato qualcuno, maledetta censura. Questo non è il vero Belfagor, andate a cercare negli archivi Rai perché quello vero mi faceva venire gli incubi. C'è un complotto, un'organizzazione segreta che modifica l'arredamento degli asili e censura i film e sostituisce gli sceneggiati francesi nelle teche Rai. E il terzo segreto di Fatima non è il vero terzo segreto. È stato censurato, sostituito. Quello vero fa ancora paura. Quello vero è davvero indicibile. Questo tipo di voci comincia a girare già nel 2000, facendo sdegnare un giornalista di provata fede come Antonio Socci. Però col tempo il dubbio di insinua in lui come un tarlo. Possibile che sia tutto qui, il terrore della mia infanzia? E come si spiega quella vecchia intervista a Wojtyla? E quella frase al termine del Secondo Segreto, "In Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede, ecc.", che non è ripresa all'inizio del Terzo? E il foglietto originale, non era in quattro facciate? Perché quello pubblicato sembra un foglio solo. Eccetera. Tutto sembra portare verso una sola conclusione: Ratzinger e Wojtyla hanno truccato le carte. Esasperati dal dover sempre rispondere alle stesse domande sul Terzo Segreto, a un certo punto ne hanno "divulgato" una parte, ma non quella fondamentale. Così, insomma, il segreto della nostra infanzia è salvo! E possiamo anche cominciare a terrorizzare i nostri figli, se ne abbiamo.
Peraltro io sono abbastanza d'accordo - non su terrorizzare i nostri figli, no, ma sul fatto che il testo del terzo segreto abbia subito un robusto lavoro di editing. La frase con cui probabilmente iniziava, "in Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede", è lessicalmente infelice: la fede non è propriamente "un" dogma, e di "dogmi di fede" ne esistono tanti. Insomma, suor Lucia faceva quel che poteva, ma era una veggente, non una teologa omologata. Che gusto c'è a dirigere la Chiesa cattolica se non puoi rieditare le profezie dei tuoi fedeli? E c'è un'altra possibilità, alla quale Socci e i gli altri fatimiti complottardi non hanno pensato - probabilmente perché non sono programmati per farlo. Forse il terzo segreto autentico rimane indicibile per il semplice motivo che non si è realizzato - così come non si era realizzato il secondo. Mettiamo che fosse una profezia di fine di mondo, come ai veggenti piace fare. Mettiamo che Wojtyla, dopo tre pallottole e un attacco alla baionetta, fosse incline a crederci, mentre invece Ratzinger no. A me viene già in mente la data perfetta: il 13 maggio dell'anno che più di tutti da bambino mi terrorizzava: il 2000. Quei due a un certo punto si saran detti: se il mondo deve proprio finire nei termini verbalizzati da suor Lucia, non diciamolo a nessuno, tanto è inutile. Ma se quel giorno non succede niente, prepariamoci un piano B. Il 13/5/2000 il mondo non è effettivamente finito: lo stesso giorno però Wojtyla ha beatificato Francisco e Jacinta Marto, e ha divulgato il terzo segreto cattolicamente corretto.
Nella sua versione del 2000, il Segreto è inattaccabile: parla di una futura persecuzione del clero cattolico, forse in parte già iniziata. Nessuno pensa più alla terza guerra mondiale, ormai, tutti hanno in mente l'offensiva laica mondiale contro il diritto alla vita, la sana famiglia eterosessuale eccetera. Ratzinger stesso lascia intendere che la Chiesa potrebbe essere punita per i propri peccati, per la "sporcizia" che il pontefice ha esplicitamente stigmatizzato, alla terza o quarantesima accusa di coprire i preti pedofili. In sostanza il terzo segreto può significare qualsiasi cosa, come una quartina ben tornita di Nostradamus, o l'oroscopo di domani. E anche questa idea che non tutto sia stato detto, che da qualche parte ci sia un quarto segreto... a suo modo torna utile. Pensate quando saremo a gennaio 2013, e nessuno potrà più rivendersi la profezia Maya: l'industria della fine del mondo avrà bisogno di qualche nuovo spunto. Magari Giacobbo ci sta già lavorando. Ecco, magari tra sei mesi fateci caso, se su Voyager o Mistero non passa un filmato simile a quello che vi ho raccontato io all'inizio. E se lo vedete - se la mia profezia si avvera - voi non cambiate canale, ma ditelo subito ai vostri bambini, che il terzo o il quarto segreto di Fatima non vogliono dire nulla, che è solo una favola riciclata in mancanza di meglio da gente che vuole venderti un libro o un altro film sulla fine del mondo. Diteglielo subito, non aspettate che siano i bambini a chiedervelo, perché i bambini a volte si vergognano, non vi dicono niente, hanno degli incubi per anni, se li tengono per sé. Lo scivolo dell'asilo ci mette decenni a rimpicciolire, Belfagor è ancora da qualche parte nell'ombra dietro un comodino, e sotto le nostre case di onesti coltivatori, dormono pazienti gli euromissili, per svegliarli basterebbe premere un pulsante. Ma va tutto bene, non c'è nulla di cui aver paura. Accendete la luce, diteglielo, dategli un bacio.
Hai mai visto il mio ippopotamo?
10-05-2021, 08:00Bibbia, Il Post, repliche, santiPermalink| Ci conosciamo? |
La trama la sapete, no? No? Cioè l'Odissea sì, i promessi sposi sì, e Giobbe no? C'è qualcosa che non va nella nostra educazione. Poi per carità, Omero è ok, ma non è che ti capiti così spesso di organizzare massacri di Proci, né di volerti sposare contro la volontà di un signore feudale; mentre un'imprecazione alla Giobbe prima o poi sfugge a tutti, e l'Unica Domanda ce la poniamo più o meno tutti i giorni. Per dire, negli ultimi tre anni gli americani lo hanno riciclato in un paio di film, entrambi molto apprezzati (A Serious Man e The Tree of Life). Certo, se la mettiamo su questo piano i fumetti della Marvel battono Giobbe 5 a 2, ma per un prodotto di nicchia non è comunque un risultato da buttar via. La trama, dicevamo.
Nel paese di Uz (deserto del Negev?) Giobbe è un uomo giusto che fa tutto quello che deve fare un buon ebreo. (Il fatto che non sia identificato come un ebreo secondo alcuni è un modo per evitare la censura, visto che tra lui e Dio accadranno eventi spiacevoli: un'altra ipotesi è che dietro a Giobbe ci sia un mito più antico, di origine mesopotamica). Nel frattempo, alla corte di Dio... ecco, già questo è incredibile. Non si è mai vista la corte di Dio fin qui nella Bibbia: si sono visti roveti ardenti, carri rotanti, ma un Dio che tranquillo riceve i suoi cosiddetti "figli" (angeli?) è un unicum, solo in Giobbe assistiamo a scene così. Non solo, ma tra questi "figli" c'è Satana, nella sua prima apparizione pubblica. Non è ovviamente il Satana cristiano con le corna o la coda, non è visto come un nemico di Dio (anzi prende ordini da lui). Al limite è l'unico in grado di reggere una conversazione con l'Ente supremo. Da dove vieni, gli chiede infatti l'Ente, e Satana: Me ne sono andato a spasso per la terra. "Hai visto Giobbe? Lui sì che mi vuol bene, eh?" "Per forza ti vuol bene, gli hai dato tutto: una casa, una famiglia, gli affari vanno bene... prova a togliergli qualcosa, e vedrai se non ti maledice". L'Ente accetta la scommessa: "Vai pure, levagli quel che vuoi". Satana insomma è una specie di pubblica accusa che punta il dito sull'umanità (la parola forse in origine significava avversario, accusatore); più che il diavolo, l'avvocato del diavolo, con la missione di mostrare a Dio quanto gli uomini facciano schifo. Per questo bazzica la terra, mentre gli altri angeli se ne vanno per i cieli. Dunque Satana prende il migliore degli uomini, e in pochi minuti gli toglie la famiglia, il raccolto, la casa, tutto... tranne la moglie. La moglie gliela lascia (qui io ci sento un'ironia fortissima, ma forse sovrainterpreto).
 |
| "Allora il Signore rispose a Giobbe dal seno della tempesta..." (A Serious Man) |
Giobbe reagisce come un vero santo: quel che il Signore mi ha dato, il Signore me lo può togliere, sia benedetto il Signore. Nell'alto dei cieli Dio gongola: visto che avevo ragione io? Non è male questa umanità, dopotutto. Satana non fa una piega, anzi rilancia: in realtà, dice, non lo abbiamo ancora toccato. Sì, gli abbiamo tolto tutto, ma gli abbiamo lasciata salva la pelle, l'unica cosa che agli umani interessi realmente. Dammi il permesso di rovinargli la salute, e vedrai se non ti maledice. Dio accetta, e Satana si affetta a coprire il sant'uomo di piaghe dalla testa alla punta dei piedi. Da uomo ricco e potente, Giobbe si ritrova nudo nella polvere a grattarsi le pustole con un coccio di terracotta, e in più la moglie che gli dice: Ma che aspetti a morire bestemmiando? Taci cretina, dice più o meno Giobbe; e non bestemmia.
Questo è l'antefatto in prosa, e sta in due paginette. Secondo alcuni è il nucleo iniziale della storia, a cui si ispirò il poeta (o i poeti) del poema successivo. Secondo altri è un'aggiunta posteriore, il che cambierebbe tutto, perché, per esempio, Satana nel resto del libro non compare più, e della scommessa nessuno fa più menzione. Se togli il prologo, il libro inizia con questo Giobbe, uomo giusto che non ha fatto nulla di male, che giace nella polvere cosparso dalle piaghe, domandandosi il perché. Il perché lo sa il lettore - c'è una scommessa in ballo - ma forse la scommessa è un'aggiunta posteriore, il tentativo abbastanza romanzesco di un copista di razionalizzare lo scandalo di un libro che comincia con un uomo che non maledice Dio, no, ma maledice il giorno in cui è nato. Oggi possiamo leggere Giobbe come il libro in cui Dio scommette sull'uomo, ma forse c'è stato un periodo in cui Giobbe era semplicemente il libro che si chiedeva: perché esiste il male? Perché comportarsi bene, visto che Dio non ti premia, anzi? Un problema molto attuale, come si vede.
 |
| Tante coccole |
Si sa come lo risolsero i cristiani: inventarono la vita eterna, come ricompensa per tutta le sofferenze che ci capita di espiare nel mondo. In un certo senso Dio scommette davvero su di noi (e Satana tiene banco): ci manda delle prove, e noi dobbiamo tener duro. Per la verità ai tempi di Gesù l'idea circolava già da qualche secolo, la difendevano per esempio anche i farisei. Pare che non ci credessero invece i sadducei, la fazione legata alla casta sacerdotale, più tradizionalista (e infatti in Luca 20 cercano di prendere in castagna Gesù domandando cosa succede nel Regno dei Cieli alle vedove risposate: la risposta del messia, devo dire, non è troppo convincente). Ma nei libri più antichi dell'Antico Testamento, di vita eterna non si parla se non per vaghissimi accenti. Lo stesso Giobbe sembra dare per scontato che la vita sia una sola, al punto che si ritrova a invidiare una pianta, che "se viene tagliata ributta, e continua a gettare polloni... L'uomo, invece, quando muore, giace inerte: quando un essere umano spira, non esiste più". Ma se non c'è una ricompensa in un altro mondo, ed evidentemente non ce n'è una neanche in questo, che senso ha comportarsi bene? Il dibattito era acceso. Il grosso del libro di Giobbe è esattamente questo: un dibattito. Inconcludente, come è giusto che sia. I capolavori, fateci caso, sono tutti inconcludenti: i grandi scrittori non hanno nessuna pretesa di ficcarti in testa le loro idee, mica sono dei distributori automatici di idee. Al massimo costruiscono un congegno, te lo fanno provare, e tu magari con quel congegno alla verità ci arrivi da solo.
 |
| (William Blake) Silenzio, non si sente la Saggezza. |
Il nucleo centrale del libro ha un ritmo molto meno concitato: niente più angeli o demoni o scommesse divine, ma una lunghissima contesa dialettica tra Giobbe e tre saggi, Elifaz, Bildad e Zofar, che uno si aspetta all'inizio siano venuti a consolarlo, e invece no: vengono a fargli la morale, perché Giobbe, ehi, se ti è andato tutto così male, un motivo sotto sotto ci sarà. Ognuno di loro pronuncia tre discorsi, per un totale di nove (alcuni forse andati persi), magnificando Dio e la sua onnisciente giustizia, e Giobbe replica ogni volta, mandandoli a quel paese mentre si gratta le pustole. Il libro di Giobbe è anche l'antenato dei flame su internet: i saggi blandiscono, insultano, rigirano frittate, continuano a ribadire gli stessi argomenti fino alla noia, e tutto il repertorio che potreste immaginarvi se a una certa ora della notte su facebook un vostro amico scrivesse: "aiutoooooo o xso la kasa la famiglia la salute ma xkEEEEEEEEEE'? DOVE' DIO ALL'ORA????"
 |
| Entità onnipotenti che fanno una scommessa sulla natura dell'uomo, mi ricordano qualcosa. |
Secondo alcuni i tre saggi rappresenterebbero tre diverse scuole di pensiero dell'epoca, ma per un orecchio moderno la differenza è impercettibile, sembra che ripetano tutti la stessa cosa: soffri? Devi aver offeso Dio in qualche modo. Magari non te ne sei accorto. Magari stavi per farlo e Dio ti ha fermato in tempo. Magari sono stati i tuoi figli, ecco perché Dio li ha fatti fuori. Magari sono stati i tuoi antenati, sì, c'è chi pensa che Dio punisca i figli per le colpe degli antenati, anche se al riguardo i profeti non sono d'accordo. Tu comunque sei fortunato, poteva andarti peggio, raccomandati a Dio e vedrai che tutto si sistema. Giobbe è famoso per la pazienza, ma questi tre lo fanno uscire di testa. "Perché non tacete?", dice a un certo punto, "quella sì che vi sarebbe contata come sapienza". Rendetevi conto. Giobbe fa parte di una famiglia di libri dell'Antico Testamento definiti "sapienziali", che contengono tutti i suggerimenti per vivere una vita pia e benedetta dal Signore. Il prototipo dei libri sapienziali è il noiosissimo Libro dei Proverbi, una sequela di saggi consigli del tipo, non dire il falso, guardati dalle donne malvagie... che forse tremila anni fa non suonavano così banali, ma a differenza di Giobbe sono invecchiati malissimo. I Proverbi avevano avuto svariati tentativi di imitazione nei secoli successivi, ma Giobbe è un'altra categoria: è un libro antisapienziale, un testo che ospita le tirate sapienziali dei tre dotti personaggi solo per il gusto di replicare a tutti e tre: non avete capito niente, la vita non va come vorreste voi, l'unica cosa veramente saggia nei vostri sproloqui è il silenzio tra una parola e l'altra.
Comunque vanno avanti per trenta capitoli, con Giobbe che ribadisce la sua innocenza. A un certo punto c'è una specie di intervallo, un elogio della sapienza un po' spiazzante, forse inserito in un secondo momento. Poi, mentre Giobbe continua a professarsi innocente, ecco che appare dal nulla un quarto sapiente, di cui nessuno fin lì aveva parlato. È un giovane, si chiama Elihu, e sostiene di esserci stato sin dall'inizio, ma di non aver parlato fino a quel momento per rispetto nei confronti della maggiore età dei tre insopportabili. Ma dopo aver visto che né Elifaz, né Bildad, né Zofar, sono in grado di smontare la sicumera del pustoloso Giobbe, Elihu prende la parola e se la tiene per altri cinque capitoli che, ve lo dico, non sono il migliore argomento in favore del ricambio generazionale: Elihu è ottuso quanto gli altri tre, ma in più ha pure l'arroganza del maestrino con tanta teoria in testa e poco rispetto per la pratica. Giobbe non capisce, Dio è misericordioso, chiunque glielo può dire, lo sanno tutti, eccetera eccetera. Giobbe tace. Immagino che continui a grattarsi, ma non c'è modo di saperlo, il libro non contiene repliche a Elihu. In effetti nessuno risponde a Elihu in tutto il testo: nemmeno Dio che nel finale rimprovererà gli altri tre, ma di Elihu non dirà niente. Il sospetto, insomma, è che l'intervento del quarto saggio sia un'aggiunta posteriore, di un giovane scriba che ricopiando il testo deve aver pensato: questi tre vecchi sbabbioni avrebbero anche ragione, ma non riescono a difenderla! Ci penso io. Benedetta gioventù.
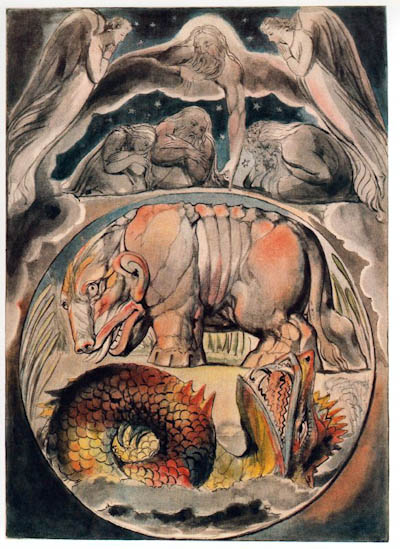 |
| William Blake - Giobbe, l'ippopotamo e il coccodrillo |
Quando Elihu cessa di parlare - nell'indifferenza totale - la parola passa a... Dio. Sul serio. Di punto in bianco, senza complimenti, il Signore esce dalla tempesta e parla a Giobbe. A questo punto uno si aspetta una specie di premiazione per aver fatto vincere una scommessa contro Satana: sbagliato, di scommessa non si parla più, forse Dio un po' si vergogna, ma più probabilmente la scommessa non c'è mai stata, è un'aggiunta posteriore, un pretesto. Va bene, pensa allora il lettore, comunque visto che siamo nella Bibbia, e che qui parla Dio direttamente, forse finalmente avremo una risposta alla Unica Domanda Che Valga Veramente La Pena: perché l'uomo giusto soffre? Col cavolo. Dio non perde tempo a rispondere. È passato soltanto a ribadire la sua incommensurabile superiorità: cos'è che chiedi, Giobbe, cosa pretendi di voler capire? Vuoi interrogarmi, sei forse il mio maestro? Vai, cingiti i fianchi, fammi le domande, dai. Tu senz'altro conosci le misure della terra, sai come si fanno girare le stelle durante la notte, e dov'è il deposito estivo della neve... Giobbe capisce che l'ha fatta grossa e chiede scusa, ma ormai Dio è un fiume in piena: Giobbe, ma tu hai un'idea di quante cose ci sono in cielo e in terra, tutte fatte da me? Sei tu che cacci la preda per la leonessa, che sazi i leoncini? Hai mai visto, che so, il coccodrillo? Hai mai visto l'ippopotamo? All'inizio per la verità si traduceva col misterioso termine "Behemoth", ma nelle versioni più recenti Behemoth è sempre più chiamato semplicemente "ippopotamo". Ecco, questo è il punto in cui secondo me poteva anche finire il libro di Giobbe. Ogni volta che ci chiediamo perché esiste il male, perché Dio lo consente, sapete come vi risponde Dio nella Bibbia? Con un'altra domanda: hai mai visto l'ippopotamo?
Giobbe viveva nel Negev, è ovvio che non ne ha mai visto uno. E allora cosa vuole, cosa pretende? Uno che non ha mai visto un ippopotamo, né un tranvai o un'equazione di Maxwell, pensa di poter interrogare Dio sul segreto della Creazione? L'universo è complesso ed evidentemente non gira intorno all'uomo: perché poi chi l'ha detto che l'universo sia fatto su misura per l'uomo, che l'uomo sia il figlio prediletto di Dio? Ah, la Genesi? Il Dio di Giobbe sembra vederla in un modo diverso. Invita a considerare gli ippopotami. Sono effettivamente bestie meravigliose. Quando sono sott'acqua sono morbide e aggraziate: quando ne escono sono terribili, leoni ed elefanti si guardano bene dal disturbarli. I cuccioli sono adorabili, gli anziani sono maestosi; vivono nella Rift Valley più o meno da quando nella stessa zona una sottospecie di scimmie è scesa dagli alberi, e se non si sono molto evoluti nel frattempo, forse è perché erano già perfetti così. E anche Dio, perché dovrebbe creare a sua immagine e somiglianza questi scimpanzè mal addestrati? Se uno ci pensa, la terra sembra più fatta per gli ippopotami che per gli uomini. Magari è l'ippopotamo che Dio ha creato a sua immagine e sua somiglianza, forse insomma Dio somiglia un po' più all'ippopotamo che all'uomo, e per farti un'idea di Dio un documentario sugli ippopotami in Kenya è più utile di tutta quanta la Bibbia. Forse Dio ha creato la terra per gli ippopotami, affinché l'ippopotamo ne godesse ogni giorno della sua santa vita. E l'uomo?
 |
| Esatto, sono l'essere perfetto, il fine ultimo della creazione. Altre domande? |
Magari è solo un effetto collaterale. Una sottospecie di scimpanzé con una straordinaria manualità. Dio potrebbe averlo creato affinché producesse splendidi documentari sugli ippopotami: ma bisognava prima inventare il cinema, fare la rivoluzione industriale, le manifatture, l'artigianato, la fusione del ferro e prima del bronzo, e l'agricoltura: nella mezzaluna fertile servivano buoni agricoltori come Giobbe, disposti a sopportare i rovesci della fortuna, affinché millenni dopo Dio potesse guardarsi un documentario sugli ippopotami ben montato e illuminato. Però questa cosa a un contadino come Giobbe non gliela puoi spiegare, è un possidente dell'età del bronzo, i suoi bisnonni avevano ancora parenti sugli alberi. Come spiegare a una formica perché stiamo dando il veleno sul battiscopa del terrazzo, senti, niente di personale, ma tu sei meno di nulla per me, non vali neanche la pena di schiacciarti con un dito. Giobbe questa cosa la capisce, e china la testa. Anche se sul significato del suo ultimo versetto (42,6) non c'è consenso tra i critici: forse si cosparge di polvere in segno di umiltà, sta chiedendo scusa, forse sta rinnegando JHWH. Ognuno traduce a modo suo.
Ma il Libro non finisce qui. C'è un'aggiunta in prosa, in cui Dio riabilita totalmente Giobbe, sbugiardando i tre insopportabili barbogi, e raddoppiando le sue ricchezze: nuove terre, nuovi figli e figlie (bellissime), nuova fiducia in un mondo migliore. L'ex pustoloso campa 140 anni e conosce i suoi bis-nipotini. Dovrebbe essere un finalino rassicurante, ma per il lettore moderno l'effetto è strano, sembra tutto un capriccio di Dio, un mettersi a giocherellare con una formica sul terrazzo. Perché Dio si comporta così? Forse perché Giobbe, nella sua totale e riconosciuta inadeguatezza, è comunque riuscito a sostenere una conversazione con Dio? Più probabilmente perché il Giobbe degli ultimi versetti non è più il Giobbe inquietante di 42,6. È invece lo stesso Giobbe del prologo, quello che ha fatto vincere a Dio una scommessa un po' puerile, rivoltandosi nella polvere per giorni e giorni senza mai bestemmiare Dio. Così alla fine prologo e finale si rivelano per quel che sono: una cornice rassicurante, che pretende di spiegare quello che Dio si guarda bene da dettagliare agli umani: il giusto soffre perché Satana lo tenta, ma basta tener duro. Il vero Giobbe, il Giobbe del poema centrale, su una cornicetta così ci avrebbe sputato. Ma probabilmente senza la cornicetta rassicurante Giobbe nella Bibbia non ci sarebbe mai arrivato, tantomeno nel calendario cattolico, e io non vi avrei mai raccontato la sua storia, che contiene la risposta di Dio all'Unica Vera Domanda Che Valga La Pena (perché il giusto soffre?) E la risposta è (ricordatevene quando vi capiterà di subire qualche malanno palesemente ingiusto): Hai mai visto l'Ippopotamo?
Il poeta preferito di Gesù
09-05-2021, 11:36apocalittici e integrati, Bibbia, Cristo, ebraismo, Il Post, santiPermalink9 maggio – Isaia, profeta e poeta

Sappiamo che Gesù sapeva leggere (Luca 4,16). Conosciamo anche il suo scrittore preferito. Basta ascoltare quel che dice, basta ragionare su quel che fa: Gesù è un lettore di Isaia. Lo conosceva bene, lo citava spesso, a volte forse gli usciva di bocca senza neanche che se ne accorgesse. Si vede che lo aveva letto molto. Un lettore laico e spassionato potrebbe aggiungere: lo aveva letto troppo. Isaia potrebbe avergli fatto l'effetto che Chateaubriand e Balzac facevano a Emma Bovary; potrebbe averlo ridotto nel modo in cui i poemi cavallereschi ridussero Don Chisciotte. I Profeti avevano descritto il mondo, ma ora si trattava di cambiarlo: dopo aver letto Isaia, meditato Isaia, sognato Isaia, il carpentiere di Nazareth a un certo punto decise di vivere Isaia. Questo significava anche vivere poco, cosa di cui forse non si rese conto che in seguito.
 |
| Don Chisciotte e Sancio Panza (Honoré Daumier). |
Del resto di che autore ci si poteva appassionare, nella Galilea del primo secolo? Parlando di poesia, la Bibbia non è che ne trabocchi. Qualche salmo ispirato (i migliori assomigliano proprio allo stile di Isaia), qualche proverbio azzeccato, un paio di libri che ancora oggi ci sorprendono (Qohelet, Giobbe), e il resto è prosa. La poesia del resto non era lo scopo iniziale dei redattori e dei compilatori. In principio c'era soprattutto da fare storytelling, world building, mettere insieme un po' di leggende e raccontarle in modo non troppo romanzesco e non troppo infantile, tagliando le contraddizioni, gli errori di continuity. Poi – siccome si parla di un contratto tra Dio e il suo popolo – c'è tutto il capitolato, le leggi e le norme e persino le risultanze di un censimento. Sono le pagine meno eccitanti, ma danno un tocco di realismo. Ai primi cinque libri, attribuiti a Mosè e chiamati Torah, "insegnamento", seguono i Neviìm, i Profeti, una raccolta che all'inizio sembra voler proseguire il racconto storico. Documentano l'invasione della Terra Promessa (Libro di Giosuè), il successivo periodo anarco-tribale (Libro dei Giudici), la nascita di una monarchia unitaria (Libro di Samuele), il momento di massima gloria con l'erezione del tempio di Salomone, la secessione tra regni di Israele e Giuda, la decadenza e le ripetute sconfitte belliche, fino alla deportazione degli ebrei in Babilonia (Libro dei Re), il vero momento cruciale di tutta la Bibbia: l'esodo al contrario.
Qui si interrompe la storia del passato e comincia quella del futuro. La seconda parte infatti ospita i libri più propriamente profetici: Isaia, Geremia, Ezechiele, i Minori. E anche se questi profeti testimoniano da punti di vista diversi la stessa storia contenuta nella prima parte, la descrivono come se dovesse ancora accadere e i migliori ci restituiscono proprio questa sensazione: che tutto debba ancora accadere. Gli ebrei non sono ancora in Babilonia, i cantori del Tempio devono ancora appendere le cetre alle fronde dei salici. Persino gli Assiri devono ancora devastare il Paese da nord. Tutto è già scritto, eppure tutto deve ancora succedere e attenzione: potrebbe ancora non succedere. Dipende dal Popolo Eletto, nel quale il lettore tende a identificarsi, non fosse altro perché come accade nei romanzi di formazione egli è il prediletto di Qualcuno ma ha un'inveterata tendenza a non seguirlo e cacciarsi nei guai. Se solo smettesse di sacrificare a idoli falsi, se solo riconoscesse il Signore come unico Dio, se solo cominciasse a onorarlo come si onora un buon padre, e rispettasse i suoi insegnamenti... e mentre leggiamo sappiamo che non succederà; non quella volta almeno; ma capiamo anche che stavolta tocca a noi.
Come notava un lettore attento come Girolamo, lo stile di Isaia è così lucido che il suo futuro sembra già un passato. Come ha suggerito qualche critico in seguito, questo potrebbe dipendere banalmente dal fatto che le profezie di Isaia sono profezie post eventum, ovvero scritte (o rieditate) dopo i disastri che illustrano. Questo è probabilmente vero per tante pagine in cui si dà conto delle scorrerie degli Assiri e poi della dominazione Babilonese, e persino del successivo periodo Persiano (c'è persino un cantico in onore di Ciro scià di Persia, liberatore di Israele). Sappiamo che Isaia, chiunque fosse, viveva in un piccolo regno destinato a cadere come un vaso di coccio tra i vasi di ferro del tempo, gli imperi che in una fase di crisi tendevano a estendere il loro controllo sulle zone periferiche. Così succedeva ciclicamente da secoli: poco a est di Gerusalemme si potevano vedere le rovine di misteriose città già millenarie come Gerico; fantasticare sul Dio terribile che doveva averle distrutte e sui peccati immondi che gli antichi cittadini dovevano avere commesso per meritare tanta vendetta. La raccolta di Isaia comincia con uno dei brani più scioccanti, dando voce a un Dio letteralmente stomacato dal fumo di sacrifici che non può apprezzare.
"Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi; il sangue di tori e di agnelli e di capri io non lo gradisco. [...] Smettete di presentare offerte inutili, l'incenso è un abominio per me; noviluni, sabati, assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io detesto, sono per me un peso; sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano sangue!" (Isaia 1,11-15).
 |
| L'Isaia di Michelangelo, con quei piedoni impressionanti (Cappella Sistina). |
Questo Dio deluso e arrabbiato, al lettore della Bibbia ormai è familiare. Eppure nessuno gli ha prestato la voce così bene come il profeta-poeta Isaia, al punto da avvalorare il sospetto che sia lui ad averlo immaginato per primo, nell'VIII secolo avanti Cristo, in un luogo e in un tempo in cui il più rigido monoteismo era ancora in fase di formulazione. Gli idoli di pietra legno e gesso (Isaia 44), sono ancora divinità stimate e adorate da gran parte della popolazione; l'idea di rigettarli come manufatti, distruggerli e imporre un unico Dio non rappresentabile è promossa dalla corte di Gerusalemme, presso la quale l'Isaia storico dovrebbe avere avuto un ruolo ufficiale. Se fosse nato nel 765, avrebbe potuto assistere direttamente o indirettamente alla catastrofe del 722: l'invasione assira che pose termine al Regno di Israele di Samaria e Galilea e alla deportazione delle Dieci Tribù Perdute. In seguito gli assiri si sarebbero spinti fino a Gerusalemme; ma proprio le preghiere di Isaia e del pio re Ezechia avrebbero sgominato l'esercito invasore, causando 185mila morti in una notte (38,36). Se questo dettaglio appare poco verosimile, in compenso gli archeologi hanno scoperto che negli anni seguenti all'invasione Assira la popolazione di Gerusalemme e dintorni crebbe drasticamente, probabilmente perché molti ebrei dei territori occupati a nord si erano riversati a sud. Le distruzioni che Isaia immagina, potrebbe averle viste davvero, o essersele fatte raccontare da qualche profugo. Non sono ancora immaginazioni apocalittiche e macchinose come nei profeti più tardi: sono papiri impestati di lacrime sincere, dolore autentico e autentica angoscia perché Isaia e i suoi seguaci hanno la sensazione che tutto possa succedere di nuovo, se Israele non capisce la lezione.
In quel giorno, sette donne afferreranno un uomo e diranno: "Noi mangeremo il nostro pane, ci vestiremo delle nostre vesti; facci solo portare il tuo nome! Togli via da noi il disonore!" (4,1).
Dopo il ritiro degli Assiri, Isaia fa ancora in tempo ad avvertire re Ezechia che Gerusalemme sarà preda dei Babilonesi (39,5); Ezechia però ormai è anziano e si addirittura si rallegra – tratto dissonante e verosimile – perché ci vorrà ancora qualche generazione e lui non ci sarà più (39,8).
Il profeta invece va avanti, anche se non è più l'Isaia storico (secondo una leggenda il successore di Ezechia, l'empio Manasse, lo avrebbe fatto segare in due nel tronco dove si era nascosto). Metà del suo libro in effetti è da attribuire a una "scuola di Isaia", un seguito di discepoli che condivide col maestro non solo il monoteismo rigoroso e l'angoscia per il futuro, ma anche lo stile. I discepoli riprendono anche il concetto messianico, l'idea che le sorti di Israele dipendano da un prescelto. Il maestro aveva previsto che nascesse da una vergine, lo aveva chiamato Emanuele ("Dio con noi"), (7,14) e lo aveva collegato alla dinastia reale di Giuda (il "tronco di Iesse", padre di David, 11,1). Nei papiri dei successori il Messia diventa una figura più drammatica, assume il titolo di "Servo del Signore" e assume i tratti di una vittima sacrificale. "Si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità" (53,4-5).

Le profezie del libro si estendono per tre secoli, fino al ritorno degli ebrei da Babilonia consentito dallo scià Ciro il Grande a partire dal 538 aC. E anche in seguito, perché mentre i libri storici fanno il loro tempo, un buon libro di poesia è per sempre: cinque secoli dopo ancora Gesù ci trovava qualcosa di fresco e interessante. Sarebbe mai uscito da Nazareth, avrebbe mai abbandonato la stabile attività di carpentiere, se a un certo punto non si fosse lasciato conquistare dall'idea di un Regno di rettitudine dove l'agnello riposerà col leone? Se in lui non avesse iniziato a serpeggiare il sospetto di essere lui il Servo del Signore, il prescelto che doveva essere schernito e flagellato prima di portare la giustizia sulla terra? Persino quella scelta discutibile di consegnarsi alle guardie del Sinedrio; di farsi processare davanti a un procuratore Romano senza dire una parola a sua difesa, assume un senso se si rilegge Isaia 53. Gesù potrebbe aver semplicemente amato così tanto le profezie di quel libro da decidere di realizzarle – a prezzo della sua vita, certo, i lettori veramente affezionati queste cose le fanno.
E se fosse davvero andata così, questo cosa ci insegnerebbe: che la Bibbia è un equivoco? Un profeta del settimo secolo scrive una serie di messaggi per mettere in guardia politici e credenti da una possibile invasione da nord e sulla necessità di stringersi intorno al monarca di una dinastia blasonata; però li scrive così bene che secoli dopo la gente continua a leggere i suoi versetti completamente decontestualizzati, continua ad aspettare un Messia anche se la stirpe di David si è estinta, e a sognare la caduta di Babilonia – Babilonia nel frattempo è effettivamente caduta, ma Isaia è così bravo a scriverne che speriamo tutti che si riferisca a qualche altra città tronfia e arrogante, speriamo tutti che ancora si realizzi, lo speriamo così tanto che ogni tanto succede, e ogni volta che succede è la prova che Isaia non sbagliava. Il suo libro è una profezia che si autoavvera.
 |
| Gabriele "D'Annunzio" Rapagnetta |
I poeti hanno spesso ragione. Suona un po' retorico e molto crociano, ma se ci riflettete. Tutto quello che a distanza di secoli riconosciamo come poesia, è sempre qualcosa di talmente lucido che riusciamo a specchiarci. Noi in teoria non abbiamo più nulla in comune con Publio Virgilio Marone, ma agnosco veteris vestigia flammae sappiamo tutti cosa vuol dire, sappiamo tutti che è vero e lo è per tutti noi, e lo sarà ancora per qualche generazione. E se non piangi, di che pianger suoli? Di me medesmo meco mi vergogno. Ô vraiment marâtre Nature. The bustle in a house the morning after death. E l'infinita vanità del tutto. I poeti dicono la verità, tranne ovviamente D'Annunzio. No, in realtà la maggior parte dice sciocchezze (come D'Annunzio), e infatti smettiamo di leggerli, perché dopo un po' le pietre colorate ci stancano, mentre di quelle che ci specchiano non ci liberiamo mai. Per distinguere il diamante dal coccio di vetro, più che occhio e gusto ci vuole tempo, tantissimo tempo. È peggio che piantar datteri: tu verga pure i tuoi versicoli e spera che ogni tanto qualcuno li ristampi, ma già sai che ci vorranno secoli per capire se hai eretto davvero un monumentum aere perennium, o sottoscritto tonnellate di carta da macero.
Isaia ce l'ha fatta. Anche se non avete mai aperto una Bibbia in vita vostra: ugualmente qualche suo verso lo conoscete, e vivete in un mondo cambiato dai lettori di Isaia. Oppure avete visto Matrix, o qualsiasi altra saga che abbia per protagonista il Prescelto, ecco: quella è un'idea di Isaia. Potrebbe essere il poeta più antico che conoscete: se la gioca con Omero. Quest'ultimo è senz'altro un miglior narratore, un più attento osservatore, soprattutto quando c'è da descrivere fatti di sangue cui deve avere assistito direttamente. Isaia è meno trucido: la violenza non lo attira, preferirebbe che i nemici fossero annientati direttamente da Dio nel modo più astratto e pietoso possibile, senza spargimenti di sangue. Insomma non ha fatto il militare, Isaia; ma ci ha regalato in fondo a tanti papiri intrisi d'angoscia l'immagine di un mondo di pace e soprattutto l'ipotesi che quel mondo non sia un ricordo di un passato perduto – come per i Greci e poi per i Romani – ma qualcosa che può ancora avvenire: un seme che darà frutto, un regno di rettitudine.
"Certo, ancora un po' e il Libano si cambierà in un frutteto, e il frutteto sarà considerato una selva. Udranno in quel giorno i sordi le parole di un libro; liberati dall'oscurità e dalle tenebre, gli occhi dei ciechi vedranno. Gli umili si rallegreranno di nuovo nel Signore, i più poveri gioiranno nel Santo di Israele. Perché il tiranno non sarà più, sparirà il beffardo, saranno eliminati quanti tramano iniquità, quanti con la parola rendono colpevoli gli altri, quanti alla porta tendono tranelli al giudice e rovinano il giusto per un nulla" (29,17-22).
È un'idea per cui vivere, anche se spesso si tratta di vivere tragicamente e poco. Ma è un'idea. Isaia l'ha immaginata, Gesù l'ha vissuta, i suoi seguaci hanno continuato a imitarlo per secoli, ed eccoci qui. Babilonia può cadere da un giorno all'altro, Dio lo ha già fatto più volte, può rifarlo. Dipende solo da noi. Il Signore ha già spezzato la verga degli iniqui, il bastone dei dominatori, di colui che percuoteva i popoli nel suo furore, con colpi senza fine, che dominava con furia le genti con una tirannia senza respiro. Riposa ora tranquilla tutta la terra: ed erompe in grida di gioia.
Geremia, e altre geremiadi
30-04-2021, 21:22apocalittici e integrati, Bibbia, ebraismo, Il Post, santiPermalink1 maggio – Geremia, profeta (650-580 aC)
A Geremia capitò, nel quinto mese del quarto anno di Sedecia (ultimo re di Giuda), di essere contestato pubblicamente da un altro profeta, Anania figlio di Azzùr, da Gàbaon. Nel tempio di Gerusalemme, sotto gli occhi dei sacerdoti e del popolo, Anania annunciò che la dominazione babilonese aveva i giorni contati; nel giro di due anni i deportati a Babilonia sarebbero tornati a casa, gli arredi saccheggiati restituiti al Tempio. Ora Geremia da anni non faceva che spiegare il contrario: contro i Babilonesi di Nabucodonosor II ogni resistenza era inutile, e soprattutto contraria al volere dell'unico Dio. E siccome alle sue parole nessuno sembrava volersi rassegnare, Geremia aveva tentato con il linguaggio degli oggetti; si era fatto montare sul collo un giogo (Geremia 27,2), come una bestia di soma, e con quel giogo sul collo, emblema dell'egemonia babilonese, si recava nel Tempio a testimoniare la volontà del Signore. Finché non arriva questo Anania da Gabaon e non osa spezzargli il giogo davanti a tutti, gridando: "Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Io romperò il giogo del re di Babilonia!" (28,2). E Geremia?
 |
| Il Geremia di Michelangelo (Cappella Sistina). |
E Geremia non oppone resistenza, anzi, per un attimo sembra lasciarsi convincere. "Così sia! Così faccia il Signore! Voglia il Signore realizzare le cose che hai predette", risponde ad Anania (28,5). Credo sia l'unico caso un tutta la Bibbia in cui profeta afferma che preferirebbe aver torto, che si verificassero le profezie di qualcun altro. Geremia aggiunge però un'obiezione. Da sempre, spiega ad Anania, i profeti annunziano sventure: "guerra, fame e peste". Un profeta di cose buone è una relativa novità e quindi "sarà riconosciuto come profeta mandato veramente dal Signore soltanto quando la sua parola si realizzerà" (28,8): insomma circostanze eccezionali (la pace, la vittoria contro i nemici) richiedono prove eccezionali. Poi Geremia "se ne va per la sua strada" (28,11), magari in cuor suo sperando che il Signore queste prove le fornisca, che il Signore per una volta confermi il profeta di pace e sbugiardi lui e tutti i colleghi uccelli del malaugurio. Niente da fare: appena il Signore gli rivolge la parola è per rivolgere un messaggio ad Anania: "Tu hai rotto un giogo di legno ma io, al suo posto, ne farò uno di ferro" (28,13). Anania muore di lì a poco, e nel giro di qualche anno Nabucodonosor, innervosito dalle tresche di Sedecia con gli Egizi, rimanda le sue truppe a Gerusalemme, distrugge il Tempio, completa la deportazione. Geremia non sbagliava mai. Ma ecco, non ci provava gusto. È un dettaglio importante.
"Da grande penso che farò il profeta", Linus avverte Charlie Brown in una striscia del 1970. "Dirò verità profonde, ma nessuno mi ascolterà". "Se nessuno ti ascolterà, perché parlare?" "Noi profeti siamo molto ostinati" ("stubborn"). Tutt'altro che digiuno di Scritture, Linus ha un'immagine ben precisa di che tipo di profeta vuole essere. Non un'autorità sacerdotale come Samuele, né un supereroe come Elia. Non un detective sagace e integerrimo come Daniele, non un poeta ispirato come Isaia né allucinato come Ezechiele. Per Linus essere profeti significa soprattutto essere "ostinati": significa essere Geremia. È lui il profeta tipo. Gli altri sono troppo lirici, o visionari, o protagonisti di storie epiche o edificanti. Geremia non è un personaggio, è un uomo. Dio lo ha scelto per recare notizie perlopiù cattive, senza riguardo per la salute del messaggero. Malgrado sia predestinato dalla nascita ("Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo... ti ho stabilito profeta delle nazioni", 1,5), Geremia sin dall'inizio si schermisce ("Ahimè, Signore Dio, ecco io non so parlare, perché sono giovane", 1,6). Ma non c'è niente da fare. "Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; mi hai fatto forza e hai prevalso. Sono diventato oggetto di scherno ogni giorno; ognuno si fa beffe di me" (20,7). Per forza: ogni volta che parla, deve proclamare: "Violenza! Oppressione!", ed è il primo a stancarsene. Dio gli invia profezie non solo per Giuda, ma per tutte le nazioni grandi e piccole: e sono tutti oracoli di sventura, tutti messaggi pericolosi. Non può nemmeno sposarsi. "Così la parola del Signore è diventata per me motivo di obbrobrio e di scherno ogni giorno" (20,8).

Geremia ha una verità dura da consegnare: il popolo di Giuda sarà punito per i suoi peccati. Esso ha abbandonato l'unico Dio, rivolgendosi a idoli osceni come Baal, che talvolta pretendono ancora sacrifici umani (19,5). Il Signore non li ha mai richiesti, anzi ne è orripilato. Se il popolo non ascolta Geremia, l'invasione da nord sarà inevitabile. "Ecco, io porrò per questo popolo pietre di inciampo, in esse inciamperanno insieme padri e figli; vicini e amici periranno" (6,21). È chiaro che con un messaggio simile Geremia rischiava di passare per un agitatore al soldo dell'invasore ("Tu passi ai Caldei!", 37,13). Il suo libro non si dà molta pena di confutare questa impressione: più volte arrestato e fustigato dai funzionari del re di Giuda, gettato in una cisterna dove rischia di morire di sete e fame (38,6), Geremia viene liberato proprio dai Babilonesi ed è lo stesso Nabucodonosor a fornirgli una scorta armata (39,12). Mentre re Sedecia viene imprigionato a Babilonia (l'ultima cosa che vede, prima di essere accecato, sono i suoi figli sgozzati dal boia), a Geremia è risparmiata anche la deportazione in Mesopotamia, dove fu condotta gran parte della classe dirigente del regno di Giuda. Geremia scrisse loro di non preoccuparsi, di far figli e accettare la nuova situazione, comunque transitoria: anche Babilonia sarebbe caduta, nel giro di settant'anni. Non sbagliava nemmeno su questo, ma è forte il sospetto che questa e altre profezie siano ritoccate a posteriori dagli scribi. Il suo libro, uno dei più disordinati della Bibbia, mescola gli oracoli a episodi di vita vissuta, con enormi lacune e vistose ripetizioni. Proprio questo disordine ci dà la sensazione che quella di Geremia sia storia, ambigua e incompleta com'è sempre la storia, e non una favola a lieto fine. Elia è probabilmente un mito, Isaia il nom de plume di più poeti, Giona un racconto edificante: ma Geremia dev'essere esistito davvero. La cisterna in cui viene gettato sembra molto più vera di quella già traslata in fiaba in cui i figli di Giacobbe gettano il fratello Giuseppe; o l'immaginosa fossa dei leoni, in cui un imperatore di fiaba getta il profeta Daniele. Geremia potrebbe essere il modello umano di tanti eroi biblici, compreso Mosè che come lui è scelto da Dio anche all'inizio se non sa parlare. Anche Giobbe, che brontola il suo destino in una discarica di fango e cenere, gli somiglia un poco; così come il profeta Osea a cui Dio dà però il permesso di sposarsi (purché con una prostituta). Giona invece è già una parodia.
Geremia era il mio profeta preferito, da ragazzino – affermazione patetica, mi rendo conto, ma a qualcuno potrebbe essere utile sapere che i bambini pensosi che cercano ruoli modello nell'Antico Testamento non sono soltanto una fantasia di Charles M. Schulz; che per esempio io a dodici anni mi misi a leggere la Bibbia, così, perché Harry Potter non era ancora stato pubblicato, per provare a me stesso che ne ero capace, e perché a dire le solite preghiere mi annoiavo. La lessi tutta un paio di volte e mi annoiai comunque molto – specie coi Numeri e i Profeti, che con i loro annunci di sventure sono parecchio ripetitivi. Perfino il sublime Isaia, letto a dodici anni nel dopopranzo in attesa di DJ Television, non rendeva quanto avrebbe dovuto. Ma in generale lo potrei dire per quasi tutti i libri migliori che ho letto: li ho letti troppo presto, troppo in fretta, senza capirci troppo; però almeno li ho letti. Geremia era il mio preferito perché mi sembrava davvero solo contro tutti, con una verità catastrofica ma necessaria, da somministrare a un popolo ottuso. È imbarazzante, ma in lui mi riconoscevo. Bastava accendere la tv – e l'accendevo subito dopo – per trovarmi davanti a un'umanità garrula che rideva, ballava inconsapevole su una polveriera di euromissili. Poveri stolti, mi dicevo, e avrei voluto come Geremia recarmi da tutti i potenti della Terra con un calice di amare rivelazioni, da ingollare fino alla feccia (4,28). "Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: Bevete e inebriatevi, vomitate e cadete senza rialzarvi davanti alla spada che io mando in mezzo a voi. Se poi rifiuteranno di prendere dalla tua mano il calice da bere, tu dirai loro: Dice il Signore degli eserciti: Certamente berrete!"
 |
| Poi posavo il Libro, accendevo la tv e c'era lui, il sacerdote del Serpente. |
Quel che più mi faceva infuriare è che anch'io, anch'io avrei dovuto pagare le conseguenze dello sconsiderato ottimismo della generazione che mi precedeva: "i padri mangiarono l'uva acerba e i denti dei figli rimasero allegati", avrebbe detto Geremia (31,29). È il concetto di colpa collettiva, che il profeta mette nero su bianco sui suoi papiri; la causa delle disgrazie dei contemporanei è sempre l'empietà dei genitori. Dio non tratta con gli individui, ma coi popoli: la condanna è collettiva e cosi è il perdono, che può subentrare soltanto se tutta la collettività muta il suo comportamento. Nessuno si salva da solo, nemmeno il prescelto Geremia, che solo una volta si permette di obiettare a questo atteggiamento divino ("Tu sei troppo giusto, Signore, perché io possa discutere con te; ma vorrei solo rivolgerti una parola sulla giustizia") ed è un passo importante (12,1), il primo dell'Antico Testamento in cui si pone la domanda fondamentale: "Perché le cose degli empi prosperano? Perché tutti i traditori sono tranquilli?" Tutto il libro di Giobbe non sarà che una variazione sulla domanda complementare: perché invece i giusti soffrono? Tutto il Vangelo, volendo, non è che un tentativo di risposta. Oggi il concetto di colpa collettiva è respinto dal diritto, eppure il debito che ci schiaccia è sempre quello che accumularono i nostri genitori; l'inquinamento che ci surriscalda è la conseguenza di due secoli di scelte sventate che prima o poi ci presenteranno il conto. Di Geremia ce n'è ancora tanti in giro, tutti con qualche seguace e molti più detrattori. Anch'io devo dire li tollero sempre più a fatica: vuoi perché su questa polveriera nel frattempo ci sono invecchiato, scavandomi per quel che potevo un cantuccio confortevole; vuoi perché in loro riconosco alcuni tratti discutibili di me stesso, e non posso che diffidarne: vuoi perché per la maggior parte sono davvero cialtroni che scambiano qualsiasi congiuntura politica o economica per un segno della fine dei tempi: e nella foga di ammonirci con le loro geremiadi finiscono davvero per prestarsi alla propaganda straniera, scambiando il primo Putin che trovano per un novello Nabucodonosor.
 |
| Lei invece mi sta simpatica. |
Lo stesso Geremia non mi fa più tutta questa impressione. Ormai riconosco il personaggio, il predicatore professionista con un'agenda politica. Che possa davvero aver lanciato anatemi a tutte le nazioni senza protettori importanti, mi sembra sempre meno probabile; nel frattempo ho acquisito qualche nozione sul contesto, tutte quelle congetture che inevitabilmente erodono i monumenti dei profeti e degli eroi. Geremia compare sulla scena in uno dei momenti più ambigui e cruciali della storia di Israele: il regno di Giosia, nella seconda metà del VII secolo. È un periodo di crescita demografica per Giuda, il piccolo Stato intorno a Gerusalemme, un fenomeno che le cronache bibliche non registrano ma che gli archeologi collegano alla fine del più settentrionale regno di Israele, invaso dagli Assiri nel 720. Gli Assiri secondo la Bibbia avrebbero deportato altrove gran parte della popolazione ebraica: le famose Dieci Tribù Disperse. L'ipotesi degli storici è che invece molti profughi si siano trasferiti a sud, nel piccolo regno di Giuda, creando una tensione sociale che la Bibbia descrive come un'interminabile guerra di religione. Si contrappone una popolazione idolatra – che accanto a JHWH riconosce altri Dei tra cui una "regina del cielo" che forse è sua moglie – e una fazione monoteista di origine settentrionale che predica un monoteismo integrale, riconosce soltanto JHWH e liquida ogni altra divinità come superstizione, e durante l'infanzia del re Giosia (intronato a otto anni) prende il potere, forse con un colpo di Stato. Gli idoli vengono distrutti, i sacerdoti non ortodossi eliminati: durante i lavori per il restauro del Tempio, viene scoperto un misterioso Libro (il Deuteronomio?) che chiarisce i termini di una dimenticata alleanza del popolo ebraico con l'Unico Dio. Giosia dedica il suo regno alla riforma religiosa, ma il suo è pur sempre un piccolo regno tra le potenze del Medio Oriente. Quando muore in battaglia, durante un'incursione egiziana, il potere passa al figlio Ioacaz, che (probabilmente su pressione degli invasori) pone termine alle persecuzioni religiose: il popolo è di nuovo libero di adorare gli idoli degli invasori e magari di mescolarsi con loro.
 |
| Nabucodonosor II, che in tutti i quadri ostenta una lunga barba e in questa incisione no. |
Geremia proviene evidentemente dalla classe dirigente che ha creduto nel progetto teocratico di Giosia e ora deve farsi una ragione del suo fallimento. In questo gli intellettuali sono straordinariamente creativi, anche se alla fine tendono a raggiungere la stessa conclusione: la colpa non è mai del leader che si erano scelti, quanto del popolo che in lui non ha creduto abbastanza. Nel frattempo l'impero Assiro ha conosciuto una rapidissima decadenza e ora le due potenze egemoni sono l'Egitto e la (Neo)Babilonia di Nabucodonosor. Il regno di Giuda si trova proprio in mezzo ai due, in un passaggio obbligato strategicamente necessario per entrambi. Negli anni della predicazione di Geremia Giuda è già vassallo di Babilonia, ma la tentazione di ribellarsi e passare dalla parte degli Egizi è molto forte. C'è chi parla di trasferirsi direttamente in Egitto, e creare là un nuovo focolaio per la comunità ebraica. Geremia è assolutamente contrario, o meglio lo è il Signore che parla attraverso la sua bocca: chi si recherà in Egitto verrà spazzato via e assimilato (42,15-18), chi si ribellerà verrà massacrato. Solo chi si arrende a Babilonia potrà sperare di sopravvivere al disastro. Le accuse di essere al soldo dell'oppressore babilonese colpivano il segno: forse anche per smentirle il profeta acclude nel suo Libro l'atto di acquisto di un terreno (4,6-15), un investimento voluto ovviamente da Dio per dimostrare che ci sarà un futuro per gli ebrei in Israele, ma anche un modo per dimostrare che non intendeva rifugiarsi a Babilonia. Alla fine Geremia continua a essermi simpatico: era un uomo del suo tempo che vedeva inevitabile una rovina e si sforzava di renderla il meno disastrosa possibile. Resistere ai Babilonesi avrebbe solo complicato le cose; gli Egizi non davano nessun affidamento: meglio arrendersi, accettare la deportazione, cercare nel disastro un'opportunità. Invece di chiamare i contemporanei all'ennesima rivolta fallimentare, Geremia si guarda intorno, trova la soluzione meno peggiore e l'addita a chi ha la pazienza di dargli retta. Agli Ebrei che si arrendono, il profeta deve garantire che la resa è onorevole, e che la deportazione non è la fine della storia di Israele, anzi un nuovo inizio. E in effetti fu così, anche qui Geremia non si sbagliava. Senza più Tempio, senza più re, coi libri sacri ancora in fase di elaborazione, Geremia deve trovare una nuova dimensione per un popolo che non sa come esprimere la sua identità, e contribuisce a inventare qualcosa che stiamo usando ancora adesso: l'interiorità, il "cuore". "Non si vanti il saggio della sua saggezza e non si vanti il forte della sua forza, non si vanti il ricco delle sue ricchezze. Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere me" (9,22-23). I nuovi Israeliti non si riconosceranno dai sacrifici e dalle pratiche esteriori, ma da come meditano e riconoscono la volontà del Signore. Alla circoncisione fisica, Geremia sovrappone o contrappone una circoncisione del cuore (9,24).

Geremia lo lessi troppo presto, come la Bibbia e tutti i libri che vorrei ricordare meglio oggi. Sapete come funziona a quell'età: mi sembrava di vivere in mezzo a una folla di gente che non vedeva il disastro a cui andava incontro. Avrei voluto metterli in guardia e al contrario di Geremia ero anche convinto di avere le parole giuste: così mi misi a scrivere, ma poi rileggendo dopo un po' mi accorgevo di risultare pretenzioso e antipatico e buttavo via, e ricominciavo con un altro stile e poi buttavo via di nuovo e a furia di buttare via sono arrivato fin qui, sulla rubrica dei Santi del Post. Non mi ricordo neanche bene qual era il disastro che trovavo imminente – forse la guerra termonucleare, o il buco dell'ozono. Comunque sono qui. Di parlare di Violenza e Oppressione mi sono stancato da un pezzo, e se qualcuno ogni tanto si prendesse la briga di affrontarmi in pubblico e spezzarmi questo giogo che porto sulle spalle, io gli sarei molto grato: e volentieri me ne andrei per la mia strada.
Un consiglio a chi odia lo schwa
21-04-2021, 01:24contro la lingua italiana, Il Post, santiPermalink22 aprile – Santə Alessandra, Apollo, Isacco e Cordato, martirə in Nicomedia nel 303.
Alessandra è una leggendaria moglie di Diocleziano, che avrebbe tentato di difendere i cristiani presso l'imperatore persecutore per eccellenza; quest'ultimo, dopo averla torturata un po' con le sue mani l'avrebbe fatta decapitare. Non sono poi tanti i casi in cui il torturatore-persecutore della martire è il marito (che in una versione alternativa non è il solito Diocleziano, ma il re persiano Damazio). Alessandra non solo ha le carte in regola per essere considerata patrona delle vittime dei mariti violenti, ma si trova anche tradizionalmente inserita in un gruppo di martiri dell'altro sesso (Apollo, Isacco e Cordato dovrebbero essere dei funzionari o dei servi che avevano cercato di difenderla). I martirologi a questo punto dovrebbero recare la dicitura "Santi Alessandra, Apollo, Isacco e Cordato", con il maschile plurale che è il genere tradizionalmente adottato nel caso un insieme contenga elementi di entrambi i generi grammaticali (è il cosiddetto "maschile sovraesteso"). Io qui invece ho usato lo schwa, perché volevo vedere che effetto faceva.Lo schwa (che in italiano si può anche scrivere scevà) è "una vocale centrale media, che nell'alfabeto fonetico internazionale viene indicata con il simbolo ə". Da qualche mese sta circolando in alcuni ambienti on e off line la proposta di utilizzarlo in tutti i casi in cui l'italiano preveda il maschile sovraesteso. La prassi vuole che in questi casi si usi il genere maschile (che in fondo non esiste, è un "non femminile"); ma appunto, la prassi si può sempre cambiare. All'esigenza di stabilire una parità tra i due generi grammaticali si sovrappone (e in certi casi si confonde) la messa in discussione del binarismo di genere, che nei Paesi anglofoni ha ispirato la proposta di pronomi personali "gender neutral", come "they" al singolare, per indicare qualcuno che potrebbe essere sia "he" sia "she" ma anche non riconoscersi in nessuno dei due. Rispetto ad alcune proposte avanzate negli ultimi 30 anni, come l'asterisco, Lo schwa introduce un'evoluzione importante: lo schwa non viene proposto soltanto come un segno grafico, ma anche fonetico. Non si tratta di una semplice convenzione grafica, ma di modificare effettivamente la fonetica della lingua italiana. Negli ultimi giorni il comune di Castelfranco Emilia ha fatto parlare di sé annunciando che da qui in poi lo userà nei documenti pubblici.

Per quel che vale il mio parere – non molto – lo schwa non mi sembra una soluzione efficace a un problema che comunque c'è. Le mie ragioni sono abbastanza banali: è un simbolo scomodo. Scomodo da trovare sulla tastiera (ma quello si potrebbe risolvere, anche € all'inizio era introvabile) e scomodo soprattutto da leggere: da lontano sembra troppo simile a una a minuscola, e molte volte mi è già capitato di percepirlo come una a, prima di rendermi conto che lo stavo leggendo male. Quando provi poi a scriverlo su un foglio o su una lavagna, ti rendi conto che è oggettivamente difficile tracciare uno schwà che non si possa confondere con una a – in effetti il relativo successo di una proposta del genere è anche un segno di tempi in cui la scrittura è sempre più digitale e sempre meno manuale. Non escludo che parte del mio fastidio derivi da un'incipiente presbiopia, ma insomma a me lo schwa non piace, come non piacciono tutti i simboli poco leggibili perché poco distinguibili da altri più usati. Capisco comunque e rispetto le ragioni di chi lo usa, e capirei e rispetterei anche chi non lo vuole usare, se soltanto riuscisse a spiegarsi civilmente e non brandisse armi inesistenti o citasse regole grammaticali che conosce spesso per sentito dire.
I motivi per cui lo schwa non mi piace sono anche quelli per cui fino a qualche giorno fa pensavo che non avrebbe mai vinto la sua battaglia (a questi motivi però ne va aggiunto un altro, credo decisivo, che rivelerò soltanto in fondo al pezzo). Che lo schwa fosse diventato materia di dibattimento lo avevo scoperto leggendo gli interventi della sociolinguista Vera Gheno. All'inizio lei stessa ne parlava come di un'ipotesi scherzosa e forse si limitava a includerla in un elenco di soluzioni possibili (l'asterisco, il punto, lo spazio, la "u", ecc.), ognuna delle quali presentava pregi e difetti. In questo come in altri casi comunque non dipende dal linguista decidere chi vincerà: la Gheno non si è mai stancata di ricordarci che la lingua la fanno i parlanti, che insomma dipende tutto da noi e dalla nostra volontà di innovare o no. Sempre a lei, in un secondo momento, mi pare che si debba l'osservazione che lo schwa stava prendendo piede, seppure in ambienti molto circoscritti, proprio a causa dei suoi limiti, proprio perché era un simbolo difficile da trovare e da pronunciare: questa difficoltà richiedeva impegno, e questo impegno finiva per gratificare gli attivisti che lo usavano. A questo punto se siete ingegneri un po' state soffrendo (oppure, se state soffrendo, sapete che siete un po' ingegneri dentro); se invece avete una formazione più umanista, può darsi che stiate già annuendo mentalmente, perché gli umani spesso seguono queste strade tortuose e non previste dagli ingegneri: invece di passare dalla via comoda, un sacco di gente si affolla su quella difficile, e lo fanno esattamente perché è difficile, perché richiede disciplina e sancisce il tuo ingresso in una comunità di iniziati che ti riconoscono anche dalle vocali che adoperi. I motivi per cui non credevo che la schwa non avesse una chance sono diventati i motivi per cui potrebbe invece farcela. Però.

Però un conto è vincere il derby con l'asterisco e con altri astrusi simboli non pronunciati: un altro conto è ritrovarsi sulla carta intestata di un comune italiano. Può davvero lo schwa uscire dalla nicchia, e diventare il ventisettesimo carattere del nostro alfabeto? Dipenderà da molte cose, più sociali e politiche che linguistiche perché alla fine davvero la lingua si adatta a chi la parla: ok alle elementari non ve lo spiegavano così... ma alle elementari avevate bisogno di sicurezze. Dipenderà molto da quanto se ne parla, e questo mi sollecita un consiglio a tutti gli odiatori dello schwa: non lo sopportate, vi sembra un brutto scherzo, volete che scompaia? E allora non usatelo, non leggetelo, ma soprattutto non prendetevi gioco dello schwa. Lo so che sembra uno zimbello perfetto: ma più lo prenderete in giro, più lo spargerete in giro. Più la gente lo vedrà, più lo riconoscerà, e troverà sempre meno strana l'idea che qualcuno lo usi davvero. Se davvero quel che vi preme è la purezza della lingua italiana e del suo vocalismo, lo schwa dovete fare voto di non pronunciarlo mai: e di proibire ai vostri cari di pronunciarlo non solo in vostra presenza.
Se invece la vostra priorità è sfottere il politically correct, presto o tardi il politically correct vincerà, e i vostri figli vi chiameranno genitorə. Non è davvero la prima volta che un fenomeno linguistico si impone grazie all'avversione di una parte dei parlanti – forse è uno dei motivi per cui a un certo punto abbiamo smesso di parlare latino. Pensate a quanti concetti storici o estetici hanno adottato un nome che all'inizio era considerato uno sfottò: il barocco, l'impressionismo, i macchiaioli, il cubismo, i fauves, il punk, i no global: tutti nomi coniati per prendere per il culo minoranze che dopo un po' li hanno rivendicati come bandiere, e adesso stanno sui libri. Per fare l'esempio più vicino a noi (così vicino che riguarda di nuovo Vera Gheno), pensate cos'è successo a "petaloso". La parola non esisteva; una collaboratrice della Crusca si limitò a osservare che era ben formata, e che il successo della parola dipendeva come sempre dalla disponibilità dei parlanti a farla propria. Si vide presto che i parlanti non avevano tutta questa necessità di usare la parola "petaloso", salvo un ristretto ma agguerrito circolo di attivisti di destra che si mise a rovesciare sull'innocuo neologismo una carica polemica degna di fenomeni ben più interessanti, arrivando a coniare il concetto di "sinistra petalosa". Da un punto di vista linguistico, il risultato è che oggi "petaloso" esiste, (per esempio su treccani.it) soprattutto grazie a loro. Ecco, se volete che lo schwa resti all'ordine del giorno, non avete che da seguire lo stesso sentiero.
Se invece non volete che prenda piede, rimanete immobili. I neologismi son come le vespe, agitarsi è controproducente. Mentre fate il vostro esercizio di immobilità, magari provate a indagare sulle ragioni della vostra aggressività, perché davvero, anche quando litighiamo per un accento, sotto quell'accento c'è sempre qualcosa di più interessante. Parlo per me: ogni volta che infierisco contro la barbara usanza di togliere l'accento da sé stesso, io lotto contro una concezione elitaria della lingua, che difende i suoi privilegi tendendo ad accumulare nei manuali di ortografia eccezioni su eccezioni, non importa quanto astruse. Voi, invece, quando reagite con tutto questo fastidio a un banale grafema, cosa state difendendo realmente? La superiorità del genere maschile sul femminile? Faccio fatica a crederci, manco Pillon o Adinolfi secondo me ci credono più davvero. La vostra infanzia, le 26 lettere appese a quella parete che sosteneva le vostre certezze elementari? E scusate se ve lo chiedo: siete per caso del nord Italia? Perché lo schwa, diciamolo: suona un po' troppo napoletano.
Ecco, questo credo sia il vero motivo per cui potrebbe non farcela. Se vuoi lanciare un fenomeno linguistico prima o poi devi prendere Milano, e a Milano lo schwa non è che suoni alieno, anzi. Suona heimlich, diremmo in quella lingua in cui la stessa parola può significare sia "domestico" sia "inquietante". Smorzare i plurali con una vocale muta o quasi muta significa rinnegare una settentrionalità acquisita col benessere, accettare il proprio destino di capitale della diaspora meridionale, di Seconda Napoli, e abbracciare finalmente la lingua rimossa dei nonni e degli zii. Forse sarà inevitabile, ma come si dice: ha da passare una nottata.
Il santo che puzzava
15-04-2021, 19:58Il Post, santiPermalinkBenedetto Giuseppe Labre (di Antonio Cavallucci, 1795)
(niente aureola, non era ancora tecnicamente santo).
16 aprile – San Benedetto Giuseppe Labre (1748-1783), mendicante e modello.
Certi Santi hanno vite da romanzo, altri hanno vite che al massimo ci fai una fiction su Rai1. Quella di Benedetto Labre somiglia più a un segmento di Chi l'ha visto.
[Ora torniamo a occuparci di un caso che seguiamo da qualche anno... anche perché continuano ad arrivarci numerose segnalazioni... stiamo parlando di Benoît-Joseph Labre, un bel ragazzo francese che qualche anno fa è stato espulso da un convento dei certosini e ha fatto perdere le sue tracce. Ecco, in questi anni sono stati in molti a riconoscerlo sulle vie dei pellegrini, in particolare nei pressi della Casa Santa di Loreto, ma se torniamo sul suo caso è perché abbiamo scoperto qualcosa di eccezionale, che dimostrerebbe che davvero Benoît si trova a Roma, come molti telespettatori che hanno telefonato sospettano... ma prima vediamo la scheda].
Benedetto è un ragazzo inquieto come ne nascono in tutti i secoli – compreso il Settecento, che per loro fu uno dei più complicati. Nato nell'Artois, Francia settentrionale, in una famiglia numerosa che tira a campare, Benoît-Joseph è allevato da uno zio canonico che gli insegna i rudimenti della fede e della carità, senza sottrarsi dal fornire esempi fin troppo pratici, al punto che durante un'epidemia di tifo muore soccorrendo gli infermi. A diciott'anni Benoît sembra avere già chiara la vocazione alla vita contemplativa, ma i conventi certosini e i monasteri in cui prova a rinchiudersi lo allontanano tutti, spaventati pare dal suo rigore ascetico. Il ragazzo è troppo angosciato, scrivono. "Le sue pene spirituali fanno temere per la sua testa", scrivono i cistercensi di Sept-Fons, dove veste per qualche tempo la tonaca di novizio. Siamo nel secolo dei lumi, persino i monaci restano scettici davanti a un così ligio imitatore di Cristo. Un'altra possibile spiegazione – che non compare nelle agiografie – è che la famiglia non potesse permettersi da pagargli un vitalizio; né il malaticcio Benoît-Joseph dava l'impressione di potersi guadagnare la vita monastica sobbarcandosi delle mansioni più umili. Anche la vita contemplativa è per chi se la può permettere e forse non era il caso di Benoît. Il quale a un certo punto, non sapendo più a che santo votarsi, comincia semplicemente a mettere un piede dietro l'altro, e non smette di camminare finché ne muore.
 |
| Illustrazioni del "Lamento del Buon San Labre", canzone di Maurice MacNab, raccolta tra le Chansons du Chat Noir (il locale in cui nacque il cabaret). |
 |
| Monumento funebre a Benedetto Giuseppe Labre, di Achille Albicini (1892), in Santa Maria ai Monti. Foto di Pareloup, CC BY-SA 4.0 |
 |
| E insomma Benedetto, qui già aureolato, incontra questo poveraccio più nudo di lui, e comincia a regalargli i suoi preziosi vestiti – ma strofa dopo strofa, il poveraccio continua a tremare e San Benedetto non sa più di che svestirsi. |
Un'altra cosa che si dice è che i santi emanino un profumo soave – l'"odore di santità" – da morti e in certi casi persino da vivi. Benoît invece puzzava, su questo le fonti concordano. Pare che dopo aver transitato da un santuario avesse fatto il voto di non lavarsi più, un dettaglio che nel secolo precedente sarebbe quasi passato inosservato (e anche la puzza, forse sarebbe stata considerata niente più che un odore più pungente di altri). Ma il Settecento ormai volgeva al termine, acqua e sapone erano tornati di moda e persino i suoi più sfrenati ammiratori non potevano negarlo, Benoît puzzava. Può darsi che persino il cattivo odore lo abbia aiutato a mantenere un minimo distanziamento da un popolo che a un certo punto cominciò a trattarlo da santo, a chiedere consigli e veri e propri miracoli, ma ecco, senza affollarsi troppo intorno al suo giaciglio pulcioso; senza accalcarsi, stroncando sul nascere qualsiasi sospetto sul trasporto dei fedeli e delle fedeli per quel bel ragazzo che si poteva guardare (da lontano) ma toccare no. Sia come sia, la vita di strada è la più breve in ogni secolo, e quella di Benoît terminò a trentacinque anni, mentre partecipava a una liturgia quaresimale in Santa Maria dei Monti. La folla che accorse al grido "È morto il Santo" rese necessario l'intervento delle guardie pontificie.
 |
| Dopo essersi completamente denudato, il Santo chiede al povero: ma com'è che tremi ancora? E lui risponde: perché da che sono nato ho il ballo di San Vito. Sipario. |
Agabo, il grillo parlante
08-04-2021, 03:47Chiesa, economie, Il Post, santiPermalink8 aprile – Sant'Agabo (I secolo), miniprofeta di sventure
 |
| Anche Collodi si serve due volte del Grillo nel suo vangelo (anche se l'aveva già fatto uccidere da Pinocchio, e gli tocca resuscitarlo). |
Auguri a tutti gli Agabi, che nome buffo avete. Suona greco ma probabilmente deriva dall'aramaico Hagab, "grillo", nome non inadeguato a un minuscolo profeta che compare soltanto in un paio di versetti degli Atti degli Apostoli. In entrambi i casi Agabo si rivela sia menagramo sia funzionale alla storia che l'evangelista Luca sta raccontando, al punto dal farci sospettare che più che un profeta vero sia una di quelle comparse molto pratiche, che in un film dicono esattamente quello che gli spettatori devono sapere per capire cosa sta per succedere.
Nella sua prima comparsa (Atti 11,28) Agabo risulta essere il membro di un gruppo di profeti "scesi da Gerusalemme" ad Antiochia in uno dei momenti più cruciali della storia del cristianesimo. Dovremmo essere intorno al 45 dopo Cristo: il Vangelo è ancora un racconto orale che circola quasi esclusivamente in alcune comunità ebraiche tra Palestina e Siria. È un mondo di piccoli centri mercantili, orbitanti attorno a una delle tre metropoli del Mediterraneo: Antiochia di Siria (oggi Antiochia in Turchia). Qui per la prima volta i credenti in Gesù vengono chiamati "cristiani", e qui soprattutto, nel più importante crocevia del Medio Oriente, il loro messaggio comincia a spargersi anche tra i gentili non circoncisi, su iniziativa non si sa bene di chi ("cittadini di Cipro e di Cirene"). Quando la notizia arriva alla comunità di Gerusalemme, quella manda a verificare un emissario di prim'ordine, Barnaba, già molto attivo a Damasco. Quest'ultimo ha l'idea di portarsi con sé un personaggio già noto e controverso nell'ambiente, Saulo detto anche Paolo, che dopo essere sfuggito a qualche tentativo di omicidio da parte degli oppositori dei cristiani che si sentivano traditi da lui (non a torto), si era momentaneamente rifugiato a Tarso, la città dei genitori. Ad Antiochia, Saulo inizierà la sua opera di missionario tra i gentili ed è abbastanza suggestivo che quest'opera coincida con la prima operazione di fundraising: quando Saulo e Barnaba torneranno a Gerusalemme a far rapporto, non si limiteranno a parlare della nuova comunità multietnica di Antiochia, ma porteranno una generosa offerta in denaro.
 |
| Antiochia oggi |
Sembrerebbe insomma che il diritto a fregiarsi del titolo di Chiesa di Cristo, i fedeli di Antiochia se lo siano pagato in moneta sonante, anche se Luca spiega che la colletta era stata ispirata da una profezia, appunto: la prima profezia di Agabo.
E uno di loro, di nome Agabo, alzatosi in piedi, annunziò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grave carestia su tutta la terra. Ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i discepoli si accordarono, ciascuno secondo quello che possedeva, di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea; questo fecero, indirizzandolo agli anziani, per mezzo di Barnaba e Saulo.
Notate quel "per mezzo": Luca ha premura di spiegare che Barnaba e Saulo non erano che i latori della donazione; che non l'avevano in nessun modo sollecitata. L'episodio resta comunque abbastanza ambiguo: perché raccogliere fondi proprio per la Giudea, se la carestia ci sarebbe stata "su tutta la terra"? E a proposito: la carestia poi ci fu? È difficile dire. Qualche cenno a una crisi nell'approvvigionamento delle provviste compare, ad esempio, nelle Antiquitates di Giovanni Flavio, un testo che però potrebbe essere stato interpolato in questo e in altri casi, da copisti antichi e medievali desiderosi di conciliarlo con gli eventi descritti nel Nuovo Testamento. Bisogna dire che erano fenomeni abbastanza ciclici in un'epoca in cui Roma si era trasformata nel ventre del Mediterraneo, un buco nero che ogni anno risucchiava una parte consistente della produzione cerealicola dalla Spagna all'Egitto. La carestia descritta da Luca dovrebbe avere un carattere universale, eppure l'evangelista l'accantona subito dopo averla evocata, un mero pretesto per una raccolta di fondi.
 |
| Corinto sotto la neve |
Quasi dieci anni più tardi, ritroviamo qualche traccia di un'analoga raccolta nelle due lettere ai cristiani di Corinto. Le scrive Saulo, che tutti ormai chiamano Paolo, nome che gli spetta in quanto cittadino romano. Corinto non è una metropoli come Antiochia, ma è una città con una spiccata identità mercantile e addirittura turistica: i suoi giuochi rivaleggiano con quelli di Olimpia, e in generale si avverte una rilassatezza dei costumi che impensierisce l'Apostolo. Il quale tra un rimbrotto e un'ammonizione non dimentica mai di accennare a questa cosa importante che è la colletta – riuscendo in entrambe le lettere a specificare che non è lui che la sollecita e non sarà lui a passare a raccoglierla:
Quanto poi alla colletta in favore dei fratelli, fate anche voi come ho ordinato alle Chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno metta da parte ciò che gli è riuscito di risparmiare, perché non si facciano le collette proprio quando verrò io. Quando poi giungerò, manderò con una mia lettera quelli che voi avrete scelto per portare il dono della vostra liberalità a Gerusalemme. (1 Corinti 16,1-4)
La colletta è settimanale ed è destinata ai "Santi", che in questa primissima fase del cristianesimo non sono quelli della nostra rubrica, ma i membri ancora in vita della comunità cristiana di Gerusalemme: apostoli e altri testimoni della predicazione e del martirio di Cristo – e non c'è dubbio che in una fase in cui il Vangelo era ancora orale, la loro vita fosse un patrimonio prezioso. In un primissimo momento il gruppetto guidato da Pietro aveva messo in pratica una rigorosissima comunione dei beni. Lo stesso Barnaba, sembra di capire, si era guadagnato una posizione preminente devolvendo il ricavato di un suo podere (Atti 4,37). Vent'anni dopo, quella che era sembrata una cellula proto-comunista si è già evoluta in un ente benefico fondato sulla generosità dei suoi adepti, ben disposti a scambiare ricchezza in cambio di Grazia. Paolo, che pure ci tiene nelle epistole a non passare per un mero esattore, conosce l'importanza di motivare i contribuenti volontari e non si fa scrupolo di approfittare di quel senso di competitività che i Corinti dovevano nutrire nei confronti dei vicini Macedoni. Questi ultimi, Paolo li tratta esplicitamente da poveracci, notando che pur nella loro indigenza "hanno dato secondo i loro mezzi e anche oltre, spontaneamente" (2 Corinti 8,3). Possono i Corinti, che primeggiano in ogni cosa ("nella fede, nella parola, nella scienza, in ogni zelo") perdere proprio la gara della carità? "Conosco infatti bene la vostra buona volontà e ne faccio vanto con i Macedoni dicendo che l'Acaia è pronta fin dallo scorso anno, e molti sono stati stimolati dal vostro zelo" (2 Corinti 9,2). Questo zelo va tuttavia stimolato costantemente, onde evitare una figuraccia proprio coi confinanti ("non avvenga che, venendo con me alcuni Macedoni, vi trovino impreparati e noi dobbiamo arrossire, per non dire anche voi, di questa nostra fiducia... perché essa [l'offerta] sia pronta come una vera offerta e non come una spilorceria "(2 Corinti 9,4-5).
Qui e altrove Paolo dimostra quell'approccio pragmatico alle questioni economiche che lo avvicinano più all'evangelista Matteo (che probabilmente non lesse mai) che a Luca. Quest'ultimo è visibilmente a disagio, quando si parla di denaro. Nella sue mani la parabola dei talenti raccontata in Matteo (25,14-30) perde ogni accento turbo-liberale: il budget destinato dal padrone ai servi viene molto ridotto (non è più misurato in talenti ma in "mine", che valevano assai meno) e soprattutto è diviso in parti uguali tra i servi (Luca 19,12-27). Se Gesù deve proprio intrattenersi con un esattore delle tasse, soltanto Luca sente la necessità di avvertire il lettore che l'esattore in questione, Zaccheo, "donava la metà dei suoi beni ai poveri" (Luca 19,8). Lo stesso Luca non perde l'occasione di descrivere la Chiesa delle origini come un'utopia comunista ("Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune", Atti 2,42), né indietreggia quando si tratta di edulcorare i lati oscuri di un'utopia del genere: quando un adepto, Anania tenta di tenere per sé parte del suo patrimonio, Pietro se ne accorge e Anania... cade stecchito all'istante. Per Luca è un miracolo. Anche la moglie muore subito dopo: doppio miracolo. Malgrado queste morti soprannaturali, a un certo punto l'esperimento comunitario si interrompe, o comunque rimane confinato al carattere eccezionale della comunità di Gerusalemme – che però molto presto per sostenersi deve sollecitare la generosità dei cristiani periferici. Questa cosa forse Luca non l'accetta del tutto, al punto da inventare la profezia di Agabo: la donazione di Antiochia, che pure c'era stata (Luca non poteva negarla), era da considerare un evento eccezionale, causato da una carestia.
Tra Luca e Paolo, compagni di viaggio, è già lecito intravedere lo scontro di due concezioni economiche della Chiesa che non smetteranno più di contrapporsi: quella tratteggiata da Luca negli Atti continuerà a ispirare i più svariati esperimenti comunitari, dai francescani ai quaccheri. Ma a vincere sarà quella di Paolo: la Chiesa come un enorme dispositivo di raccolta fondi. Un modello che la renderà una struttura particolarmente competitiva nell'economia tardo-imperiale, che non prevedeva altre forme di welfare che non contemplassero la generosità dei cittadini.
 |
| Papyrus Oxyrhynchus 1597, il più antico frammento degli Atti pervenutoci. |
Agabo ritorna più tardi negli Atti degli Apostoli (21,10-11), in una fase in cui, usando la prima persona plurale, Luca lascia intendere di aver assistito direttamente ai fatti che racconta. Lui e Paolo stanno facendo tappa a Cesarea, ma sono diretti a Gerusalemme: e Agabo di nuovo viene da lì, con una nuova profezia. Luca lo presenta di nuovo, senza ricordarsi di averlo menzionato in precedenza – il che potrebbe anche significare che la seconda parte degli Atti, dove racconta dei suoi viaggi con Paolo, l'ha scritta un po' prima; mentre la prima parte, quella sulla Chiesa eroica degli esordi, l'ha ricostruita a posteriori. Anche stavolta Agabo è una comparsa strumentale al racconto: arriva, spiega cosa succederà, scompare:
Eravamo là da molti giorni, quando scese dalla Giudea un profeta, di nome Agabo. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: «Questo dice lo Spirito Santo: "A Gerusalemme i Giudei legheranno così l'uomo a cui questa cintura appartiene, e lo consegneranno nelle mani dei pagani"». Quando udimmo queste cose, tanto noi che quelli del luogo lo pregavamo di non salire a Gerusalemme. Paolo allora rispose: «Che fate voi, piangendo e spezzandomi il cuore? Sappiate che io sono pronto non solo a essere legato, ma anche a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù»
Si capisce che senza Agabo che profetizza l'arresto, Luca e gli altri amici non potrebbero esortare Paolo a evitare il pericolo, e Paolo non potrebbe mostrarsi pronto al martirio. Agabo sembra davvero il tipico profeta "post eventum", quello che le azzecca tutte semplicemente perché è una pedina dello scrittore, che il futuro lo conosce già perché ormai è già passato. E infatti si limita a profetizzare l'imminente arresto di Paolo: non il martirio vero e proprio, che Luca non si sente di anticipare perché quando scrive gli Atti (60?), Paolo è ancora vivo, sebbene prigioniero a Roma.
Gwynllyw, un pirata e un signore
29-03-2021, 01:52Il Post, santiPermalink29 marzo – San Gwynllyw (450-529), re e rapinatore, patrono dei pirati gallesi.
 |
| Cattedrale di Newport, dove un tempo sorgeva il santuario di Woolos the Warrior. CC BY-SA 2.5. |
Il primo quesito di ordine metodologico che incontriamo accostandoci alla pia figura di San Gwynllyw è: come caspita si pronuncia Gwynllyw? Esiste anche una trascrizione del nome in latino (Gundleius), per cui avremmo potuto anche scrivere San Gundleio, ma sarebbe stato meno divertente di immaginare una specie di piratesco ruggito gutturale, hgvüündüüv. Gli anglo-sassoni lo chiamavano "Woolos the Warrior", che è senz'altro un nome ad effetto, e ci fa capire come tutte le loro "W" iniziali, più di un millennio fa, fossero anticipate da una dura "G": che è poi il motivo per cui dal longobardo "werra" è saltato fuori l'italiano "guerra", mentre William the Conqueror in Francia veniva chiamato Guillaume (e da noi Guglielmo). "Gwynllyn" però non è germanico, è gaelico. Credo che "Gwyn" in gallese significhi "bianco".
Gwynllw non è probabilmente mai stato un pirata, come si cominciò a raccontare secoli più tardi. È probabile che quando i pirati del canale di Bristol sentirono l'esigenza di affidarsi a un santo locale e non francese o inglese o irlandese come gli equipaggi delle navi che depredavano, la scelta cadde su questo autoctono re manigoldo del sesto secolo. Un periodo in cui la differenza tra istituzione monarchica e gang di razziatori doveva essere molto labile: in sostanza regnare su una regione significava detenere la liberta di scorrazzarvi in lungo e in largo coi tuoi uomini armati, chiedendo il pizzo alla popolazione in cambio di protezione dalle incursioni di qualche altro manigoldo con qualche altro uomo armato. Questo in parte può spiegare come mai le due fonti che abbiamo sulla sua vita si contraddicano: la Vita di San Cadoc, compilata intorno al 1100, lo descrive come un irresistibile furfante – a maggior gloria del figlio Cadoc che sarebbe poi riuscito a convertirlo. Viceversa la Vita di San Gwynllw, scritta una trentina d'anni dopo, insiste sul fatto che anche prima di convertirsi fosse un sovrano giusto e pio. C'è gente che proprio dei re non riesce a parlar male, neanche di quelli di reami minuscoli e sepolti da secoli – ma in effetti tra essere un buon sovrano per i propri sudditi e un razziatore dei sudditi altrui non c'era tutta questa incompatibilità.
 |
| Il Monmouthsihire, tra Galles e Inghilterra (tra 1600 e 1800 su molti documenti ufficiali compariva la definizione "Galles e Monmouthshire". Malgrado l'intento fosse rimarcare come questa contea facesse parte del Galles, ne uscì rafforzata l'opinione che la contea non fosse più esattamente Galles, ma già Inghilterra. Oggi è generalmente considerata una contea del Galles). |
Gli storici britannici li chiamano "petty kingdoms": regnucoli, regnetti: quelli che si spartivano le Isole prima dell'unificazione nel X secolo. Gwynllw ad esempio era re del Gwynllwg, che aveva ereditato dal padre Glywys, fondatore a sua volta del regno del Glywysing, e a tal proposito sempre sia lodato il copia-incolla. Siccome Gwynllyw aveva due fratelli, il già non esteso Glywysing era stato diviso in tre parti e più o meno copriva un'area tra le due contee storiche più tardi note come Glamorgan e Monmouth, affacciate sul Canale di Bristol. Dall'altra parte del Canale c'è il Devon, su cui avrebbe dovuto regnare il fratello, San Petroc, patrono dell'intera Cornovaglia; uso il condizionale perché Petroc più che un re fu un abate e un missionario, uomo di cultura e leggendaria umiltà.
Gwynllyw invece era un furfante. La sua vittima preferita era Brychan, re del Brycheiniog, che forse anche a causa delle ripetute razzie non era incline a consentirgli di fidanzarsi con una dei 24 figli che aveva, la bella Gwladys: da non confondere con Gwawl, che era la madre di Gwynllyw, e d'altro canto se tuo padre si chiama Glywys e tua madre Gwawl e incontri una bella ragazza che si chiama Gwladys, capisci che è tutto scritto nel libro del destino, magari in rune celtiche incomprensibili, ma è scritto. Così un bel giorno Gwynllyw si presentò a casa di Brychan con 300 uomini armati e la portò via, perdendone 200 nella scaramuccia che ne seguì. Il conflitto terminò con la scesa in campo di una guest star di assoluto rilievo: Re Artù, che schierandosi dalla parte di Gwynllyw rese possibile il matrimonio e qui per la prima volta compare menzionato in una vita di santi. Si tratta della Vita di San Cadoc, perché l'autore della successiva Vita di San Gwynllyw insiste sul fatto che non ci fu nessun ratto e nessuna guerra, bensì una meravigliosa cerimonia che vide unirsi nel sacro vincolo del matrimonio consensuale due sposi fortunati e benedetti dalle rispettive famiglie, sì, sì, ma non si diventa patroni dei pirati in questo modo. La gente vuole le avventure, i ratti delle vergini, i festini con la strage sul più bello.
 |
| San Cadoc in un bassorilievo bretone. CC BY-SA 3.0 |
In seguito, per festeggiare la nascita del primogenito Cadoc, Gwynllyw avrebbe portato un po' di amici a rapinare il monastero di Caerwent. Al tempo però il monastero era gestito da San Tathan o Tatheus (erano tempi fortunati, rigogliosi di santità), che inseguì i predoni e chiese loro la restituzione in particolare di una mucca. Gwynllyw rimase così impressionato dalla flemma dell'abate che non solo restituì il capo di bestiame, ma vi aggiunse un bonus: il primogenito. Decise infatti che Cadoc sarebbe stato educato dai monaci di Caerwent, insomma la mucca presa come bottino fu riconvertita in borsa di studio. Cosa non si fa per togliersi i figli dai piedi, sul serio. Sia come sia, Cadoc ebbe la possibilità di crescere in un contesto molto diverso da quello del padre: studiò, viaggiò (Irlanda, Scozia, secondo alcune fonti fece anche un pellegrinaggio a Roma), e una volta adulto non solo rifiutò l'eredità militare del padre, ma ne causò la conversione.
Bisogna dire che è un tratto comune di diversi re-santi, figure tipiche delle terre europee in cui era più radicata l'istituzione monarchica. Oltre al privilegio per ogni famiglia reale di vantare almeno un santo o una santa nell'albero genealogico, c'era anche la necessità di normalizzare la venerazione di alcuni personaggi che avevano fondato luoghi di culto importanti. In questo e in altri casi, la santità molto spesso sopravviene in un secondo momento, è una specie di pensionamento: stanco di regnare (e di razziare) Gwynllyw decide di ritirarsi in campagna con la fedele Gwladys, e in effetti in quanto a campagna c'era solo l'imbarazzo della scelta: ma avendo sognato un bue con una macchia nera sulla fronte, Gwynllyw decise che avrebbe costruito il suo eremo nel luogo dove avesse visto un bue simile. Ne trovò uno dove oggi sorge Newport, la terza città del Galles: la sua costruzione in legno sarebbe stato il nucleo della futura cattedrale di San Woloos, poi distrutta credo dai Normanni. Vi visse ancora diversi anni, mangiando verdure, bevendo acqua da un pozzo miracoloso e beandosi della compagnia della fedele Gwladys. La quale a dire il vero a un certo punto lo piantò per andare a fondare un altro eremo a Pencarn, non troppo lontano (ma neanche troppo vicino). Gli agiografi ci suggeriscono che la separazione fosse necessaria al raggiungimento di un ulteriore livello di santità; noialtri del XXI secolo crediamo di saperla più lunga e non riusciamo a non pensare che forse Gwladys si era stancata del marito vecchio e santo; dopotutto lei aveva sposato un pirata.
Simonino, il martire che non c'era
24-03-2021, 03:54antisemitismo, Il Post, santiPermalink24 marzo. Simonino da Trento (1472-1475), fake news antisemita
| Martirio del Beato Simonino, di Francesco Oradini (XVIII secolo), Palazzo Salvadori, Trento. Foto di Andreas Caranti, CC BY-SA 2.0 |
Simonino non aveva ancora tre anni quando viene ritrovato morto dagli ebrei della piccola comunità askenazita di Trento, nel canale adiacente alle loro abitazioni. È Salomone di Norimberga, il capo della comunità, ad avvertire le autorità del ritrovamento del figlio di Andrea Lomferdorm, il conciapelle, che aveva denunciato lo smarrimento due giorni prima, la sera del Giovedì Santo. Salomone non sospettava evidentemente la sciagura che stava per attirare su di sé e sui correligionari, che di lì a poco sarebbero stati arrestati, torturati e costretti ad autoaccusarsi di aver rapito e ucciso il bambino. I rei confessi sarebbero poi stati arsi sul rogo, tranne quelli che accettarono di convertirsi al cristianesimo, che furono più umanamente decapitati.
I moventi e i dettagli del crimine seguono uno schema che si era via via definito dal Medioevo, arricchendosi da un processo all’altro dei dettagli aggiunti dall’immaginazione dei torturati e dei torturatori-suggeritori. Ciò che rende particolare l’episodio di Trento è che qui tutto viene verbalizzato con una minuzia agghiacciante: della passione di Simonino (parodia di quella di Gesù, secondo la volontà dei suoi sedicenti torturatori) conosciamo dettagli minimi, di un realismo insostenibile. I verbalisti addirittura si adoperano a trascrivere le maledizioni in yiddish che uomini e donne avrebbero pronunciato durante il rito. Si tratterebbe insomma di un documento di straordinario interesse antropologico, se fosse vero e non il prodotto della fantasia di aguzzini fanatici e vittime disperate. Certo qualsiasi fantasia contiene una sua verità, almeno da un punto di vista psicanalitico, e il massimo di verità che possiamo ricavare dalle confessioni estorte a Salomone e ai suoi correligionari è la spaventosa diffidenza reciproca tra cristiani ed ebrei, in cui le accuse di infanticidio si rifrangono come in un gioco di specchi deformanti. I cristiani erano convinti che gli ebrei immolassero ogni anno a Pasqua un bambino cristiano, prima circoncidendolo per renderlo più simile a Gesù e poi crocifiggendolo come era stato crocifisso Gesù; impastando poi il suo sangue nei pani azzimi della Pasqua, e conservando parte dello stesso sangue, essiccato in polvere anche per scopi medicinali. Gli ebrei dal canto loro provavano probabilmente un sacro ribrezzo alla sola idea di mangiare il sangue, qualcosa che andava contro i più severi divieti delle Scritture; ma pungolati a compiacere la fantasia sanguinaria dei loro torturatori, recuperavano dalle loro leggende le scene più granguignolesche, come l’immagine (conservata in molti codici) del Faraone che si cura la lebbra in una vasca di sangue di bambini ebrei. Così con la forza della disperazione corredavano il fatto di sangue con una serie di dettagli raccapriccianti che l’immaginario occidentale non avrebbe più dimenticato, fino al pieno Novecento, ai libelli nazisti e al cinema horror.
E i verbalisti prendevano nota. Si capisce che la crisi stavolta non è gestita da una folla di linciatori impressionabili, ma da una regia sapiente con priorità precise. Il vescovo-principe di Trento Giovanni Hinderbach non vuole semplicemente scacciare gli askenaziti da Trento (e incamerare i loro beni): è determinato a creare un precedente importante, a fissare per iscritto un episodio cruciale a cui effettivamente si rifaranno da lì in poi tutti i casi di infanticidi rituali a sud e a nord delle Alpi. Per ottenere questo risultato non esita a sfidare l’autorità degli Asburgo e quella del Papa, che a fasi alterne cercano di bloccare il processo: perché il caso di Simonino non si verifica negli anni foschi della Controriforma, ma in un secolo più aperto in cui ecclesiastici e governanti risultano generalmente tutt’altro che inclini ad assecondare una caccia alle streghe (e sensibili al lobbying delle comunità ebraiche, che cercavano con ogni mezzo di contrastare il propagarsi di leggende nere pericolosissime). Quando però il processo sarà terminato, e i testimoni arsi vivi o decapitati e gli atti pubblicati, anche le autorità dovranno fare un passo indietro nei confronti del risultato ottenuto dal vescovo: nel 1588 (in piena Controriforma) papa Sisto V autorizza la venerazione di San Simonino martire. A Trento vengono costruite in suo onore due cappelle, una nel luogo del rapimento e l’altra nel luogo dell’uccisione. Ancora nel nel 1760 il cardinale Lorenzo Ganganelli, poi papa Clemente XIV, cita il processo Simonino come uno dei rarissimi casi in cui gli ebrei non potevano essere scagionati dall’accusa di omicidio rituale: un evento assolutamente eccezionale, che non doveva diventare il pretesto per accuse generalizzate, ma pur sempre un evento storico reale. Bisognerà attendere la seconda metà del Novecento, perché le autorità ecclesiastiche, stimolate dagli studi di Gemma Volli, riprendano gli incartamenti e giungano alla conclusione che oggi ci appare come scontata: si era trattato di un processo farsa, Salomone e i suoi compagni erano le vittime sacrificali di un rito antisemita. L’ultima processione ufficiale a Trento si svolse nel 1955; la venerazione per Simonino fu ufficialmente abolita dalla Chiesa nel 1965, al culmine della stagione conciliare.
Martirio di Simonino da Trento, chiesa di Santa Maria Rotonda, Pian Camuno (BS). Foto di Di Luca Giarelli – CC BY-SA 3.0. |
Oggi viviamo in una stagione molto diversa, anche se forse la sensazione che esista un movimento vetero-cattolico che sfida papa Francesco da destra è ingigantita da internet, e dalla prospettiva che ci offre su tutti i mattoidi in circolazione – c’è gente che vende libri sulla Terra Piatta e organizza manifestazioni sulle scie chimiche; vuoi che non ci sia anche qualcuno che crede ancora ai pani azzimi impastati col sangue dei bambini? Qualcuno dev’esserci, se ha commissionato a Gasparro almeno un quadro.
Prendiamo un sito – non lo linkerò, ma è uno dei primi risultati se si cerca il quadro di Gasparro on line. Leggiamo che l’opera avrebbe scatenato l'”ira degli ebrei” (e vorrei anche vedere) che si sarebbe concretizzata in diverse “minacce di morte” che però non vengono esibite, a differenza del crimine infamante reso da Gasparro nel suo tipico stile da madonnaro allucinato. Leggiamo ancora: “Diversi storici ebrei ritengono attendibile l’omicidio rituale ebraico dei bambini cristiani, da parte di ebrei aschenaziti e sefarditi. Teoria sostenuta in primis dal professor Ariel Toaff, figlio dell ex capo rabbino di Roma Elio Toaff, nella prima edizione del libro, censurato subito dopo la pubblicazione: “Pasque di Sangue”.
Quante inesattezze in una frase sola? Si fa prima a trovare quel poco che c’è di vero. Per esempio Ariel Toaff è davvero figlio di Elio Toaff e ha realmente pubblicato nel 2007 un volume dedicato all’omicidio di Simonino e più in generale alla leggenda dell’omicidio rituale. La prima edizione del volume (Il Mulino, 2007) non è stata “censurata”, ma ritirata dal commercio dopo un’aspra polemica che vide confrontarsi diversi storici. Il libro fu ristampato poco dopo con una prefazione che doveva chiarire la posizione dell’autore – e forse non si è mai chiari abbastanza, quando si affrontano argomenti tanto delicati. Toaff ritiene “attendibile l’omicidio rituale ebraico dei bambini cristiani, da parte di ebrei aschenaziti e sefarditi”? Per quanto riguarda i sefarditi, assolutamente no: anzi uno degli argomenti da lui esibiti è che di queste leggende non sussistesse alcuna traccia nei luoghi abitati da ebrei sefarditi, o italiani, od orientali. Solo nelle zone raggiunte dagli askenaziti periodicamente gli ebrei venivano accusati di macellare un bambino che quasi sempre dopo qualche giorno si ritrovava vivo e vegeto. Quasi sempre, ma a volte no. Del resto tuttora, appena scompare un bambino in una spiaggia, la prima cosa che si fa è arrestare i soliti sospetti: venditori ambulanti, nomadi, immigrati. Nel Quattrocento si cominciava dagli ebrei.
Dando forse per scontato che l’ostilità nei confronti degli ebrei fosse uniforme in tutta l’Europa cristiana, Toaff era portato a concludere che la leggenda nera sugli infanticidi non potesse che scaturire da qualche particolarità della cultura askenazita, e di conseguenza a ricercare negli archivi tutti i dettagli che avrebbero potuto giustificare un’evoluzione così truculenta e contraria ai più basilari costumi dell’ebraismo. Poi si sa come va con gli storici: se si mettono in testa di cercare qualcosa, prima o poi la trovano: e la quantità di dettagli scovata da Toaff nel suo libro è impressionante, e restituisce l’immagine di una comunità chiusa su sé stessa, portata a diffidare anche delle altre comunità ebraiche, ispirata da un anticristianesimo fanatico temprato dalle violente persecuzioni subite nei secoli precedenti in Europa centrale. Non solo, ma Toaff non può impedirsi di scrivere quello che abbiamo in tanti pensato a un certo punto, ovvero che gli psicopatici esistono, e che se il loro immaginario è fatto di bambini sgozzati prima o poi qualche bambino ci resta secco davvero. Possiamo escludere che a Trento o altrove non sia successo qualcosa del genere? Che qualche psicopatico magari esacerbato dal recente passaggio di un predicatore antisemita come Bernardino da Feltre non abbia deciso di calarsi nel ruolo che i cristiani avevano predisposto per lui?
L’altro argomento invocato da Toaff è la minuziosità dei verbali. Toaff sembra a tratti soggiogato dalla generosità della documentazione che il vescovo mise a disposizione, e nota più volte come esso contenga dettagli preziosi sui riti ebraici che i torturatori non potevano certo conoscere: il che secondo lui proverebbe che gli imputati non parlavano sotto dettatura, ma stavano realmente condividendo con gli inquisitori la loro negletta cultura. Persino le parolacce in yiddish, in un processo a Trento! Qui è facile obiettare come ogni confessione mendace, ogni depistaggio, perché funzioni davvero debba sempre contenere verità e finzione, in dosi non troppo squilibrate. Nel suo entusiasmo – che poi è quello prezioso del ricercatore quando ha la sensazione di ritrovare un tesoro di testimonianze credute perse o neglette – Toaff si dilunga senza risparmio sui dettagli del crimine e non si preoccupa pagina dopo pagina di premettere quali gli sembrino plausibili e quali inventati.
Si sa che mille indizi non fanno una prova – in giurisprudenza, almeno. In storiografia la situazione è diversa: tanto per cominciare, non si rischia di condannare nessun vivente; e poi al massimo quello che si consegna all’editore è un’ipotesi interessante, non la Verità. Mentre accumulava i suoi indizi, Toaff aveva in mente un pubblico di studenti e accademici, dai quali giustamente pretendeva lo sforzo di recepire una tesi provocatoria ma degna di discussione. Gli sfuggiva forse che un tema così controverso avrebbe interessato un pubblico assai più vasto, composto di lettori meno tecnici che davvero avrebbero potuto scambiare alcuni capitoli di Pasque di sangue per un agile sunto moderno di tutti i libelli antiebraici; al punto che non è difficile pensare che Gasparro abbia usato proprio il libro di Toaff come fonte per il suo quadro. Alla fine l’errore forse è stato credere che tra adulti si possa discutere serenamente di tutto, compreso di bambini scomparsi e forse uccisi. Non era così, fino al 2007 almeno – vediamo come va nel 2021.
Non Dea Madre, ma madre di Dio
01-01-2021, 19:24feste, Il Post, madonne, santiPermalink1 gennaio – Maria, madre di Dio
Non avevamo distrutte tutte da millenni? Non avevamo dichiarato ufficialmente i loro adoratori dei malati di mente ("dementes") già a Tessalonica nel 380? In un certo senso sì. Eppure... date un'occhiata alle bandiere in giro per il mediterraneo. Sono tutte di origine settecentesca, illuminista, razionale, vero? In Europa dodici stelle, nei Paesi arabi la mezzaluna (anche se quest'ultima viene spesso associata alla religione islamica, la sua presenza sugli stemmi ottomani diventa sistematica nel Settecento). E se vi dicessi che rimandano entrambe alla stessa divinità, e che questa divinità ha meno in comune con Cristo o Allah che con qualche antica Madre? Probabilmente esagererei. Mettiamola così: con certe divinità il cristianesimo è dovuto venire a patti. Non è cosa di cui andare fieri, e in effetti su questo genere di compromessi i teologi preferirebbero tacere, o almeno spostare la discussione su un campo più astratto.
 |
| Forse la più antica raffigurazione che ci sia arrivata del simbolo della luna crescente associato con una stella (più probabilmente il sole), in un sigillo di epoca neosumera (2000 avanti Cristo). |
È quel che succede per esempio nel 428, quando Nestorio, patriarca di Costantinopoli, solleva l'obiezione: come possiamo chiamare Maria "Madre di Dio" (Theotókos)? Come può un essere umano a essere genitore di una divinità? Non è che l'obiezione non avesse un senso. Nestorio non aveva problemi ad accettare che Gesù fosse sia uomo che Dio; ma non accettava che Maria potesse essere considerata madre di entrambi. In quel grembo vengono ad annodarsi tutte le contraddizioni di una religione ormai egemone ma ancora in fase di assestamento dottrinale: il problema trinitario (se Dio è uno solo, può Maria essere madre del suo creatore?), quello cristologico (in che senso Gesù è sia Dio sia uomo?), quello mariano: come raccontiamo ai fedeli questa cosa che Dio ha reso gravida una ragazza, in modo che non ricordi assolutamente quei vecchi miti bavosi sugli Dei che vanno in giro a molestare giovani e giovincelle? Meglio insistere sulla verginità della ragazza in questione, non solo prima ma addirittura dopo: certo, ne soffre un po' la verosimiglianza, ma è il prezzo da pagare per allontanare l'idea che Dio-Padre sia un padre di carne che feconda come fanno gli altri padri. A questo punto è chiaro che Maria non può essere una donna qualsiasi, ma Madre di Dio? Nestorio preferiva chiamarla "madre di Cristo" (Christotokos). Ai suoi oppositori la cosa sembrava sospetta, per motivi forse non sempre confessabili. Perché per quanto gli avversari di Nestorio si siano affannati a trasformare la questione in un complesso meccanismo neoplatonico comprensibile soltanto agli addetti ai lavori, il sospetto è che dietro a questo complesso paravento si celasse una realtà molto più terra-terra: "Madre di Dio" era un compromesso, un modo per dire e non dire "Dea madre".
Nel giro di una generazione la piccola Bisanzio era diventata la Nuova Roma immaginata da Costantino: una metropoli fungata sul Corno d'Oro. I nuovi abitanti, accorsi da ogni parte dall'impero non avevano tradizioni in comune. La città, in quanto rifondata da Costantino dopo la conversione, non poteva nemmeno vantare martiri importanti. Ma al di là del Bosforo il paganesimo continuava a pulsare, in quel subcontinente che aveva sempre opposto la sua massa critica al razionalismo ellenico: l'Asia Minore, o Anatolia.
 |
| Efeso, Turchia: il sito si trova in quello che un tempo era l'estuario del fiume Kestros. Comprende insediamenti ellenici e romani. A Efeso fu costruito il tempio di Artemide, una delle sette meraviglie del mondo antico, di cui oggi rimane ben poco.[/caption] |
Buona parte della manovalanza che aveva costruito la città e ci era rimasta ad abitare veniva là, e non avrebbe rinnegato così presto Artemide, la grande Madre degli Efesini, cinta di innumerevoli mammelle (secondo alcuni sono testicoli di toro: insomma simboli di fecondità, irrimediabilmente pagani). I discendenti degli antichi bizantini non avrebbero dimenticato volentieri Ecate, antica protettrice della città, che durante l'assedio del 340 aC, spuntando dalle nuvole con la sua luna crescente aveva protetto la città dall'incursione notturna di Filippo il Macedone. A Nestorio non si poteva rispondere così: e però il concilio che si riunì nel 431 per sconfessare le sue idee fu convocato da Costantino proprio a Efeso, di tutte le città disponibili. I seguaci di Nestorio si rifugiarono oltre il confine orientale dell'impero, riuscendo a imporre le proprie idee (più estreme di quelle del loro patriarca) sulla Chiesa persiana. La Nuova Roma, sempre più conosciuta come Costantinopoli, si consacrò alla Madre di Dio. Nessuna reliquia era venerata come il Maphorion, il manto della vergine (ma i costantinopolitani conservavano anche qualche goccio del suo latte materno). Le basiliche più importanti non furono dedicate a martiri in carne e ossa, come nella Roma occidentale, ma a concetti personificati e di sesso femminile: la "Santa Pace" (Sant'Irene) e soprattutto la Sapienza di Dio: Santa Sofia.
 |
| L'interno della basilica di Santa Sofia, il 2 luglio 2020 (Chris McGrath/Getty Images) |
Il fatto che questa Quasi Divinità femminile non somigliasse molto alla Maria di Nazareth storica tratteggiata nei vangeli era stato superato includendo nel Nuovo Testamento un testo ben poco simile agli altri: l'Apocalisse attribuita a San Giovanni. La "donna rivestita del sole, con la luna sotto i piedi e una corona di dodici stelle sul capo", che "grida per le doglie e il travaglio del parto", destinata a partorire "un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro" è un'immagine di maternità regale che ci è possibile ritrovare anche a due millenni di distanza, e non soltanto nelle raffigurazioni mariane. Lo Pseudo-Giovanni del resto scriveva nel mediterraneo già globalizzato del secondo secolo, mescolando simboli già rimasticati. Una donna abbinata alla luna non poteva che rammentare una dea lunare, non una in particolare ma un po' tutte: Artemide (luna crescente), Selene (luna piena), Ecate (luna calante, anch'essa di origine anatolica e spesso raffigurata una e triplice: celeste, terrestre e marina). La posizione della luna sotto i piedi lascia immaginare che la Donna abbia sostituito la stella del mattino in un simbolo già frequente sulle monete persiane e anatoliche. Lo Pseudo-Giovanni aggiunge però sul suo capo dodici stelle, chiaro riferimento alle dodici tribù del popolo d'Israele. Si incontrano così nella sua visione tre immagini che avrebbero proseguito i loro percorsi fino ad arrivare alla contemporaneità: la mezzaluna protettrice di Bisanzio, rivendicata dai conquistatori ottomani, sulle bandiere moderne delle nazioni musulmane; le dodici stelle, sulla bandiera del Consiglio d'Europa (e poi dell'UE). Persino la Donna del cielo è stata sventolata almeno una volta su una bandiera, durante la rivoluzione messicana. Ma in generale preferisce riapparire nelle visioni mistiche, soprattutto da Lourdes in poi. Buon anno a tutti (ma soprattutto a tutte).
Lennon voleva vivere. Ci stava riuscendo.
07-12-2020, 13:25anniversari, beatles, coccodrilli, Il Post, miti, musica, santiPermalinkI posteri si domanderanno se John Lennon abbia veramente posato i piedi sulla nostra stessa terra. Dopotutto Edipo è un mito; Buddha e Gesù Cristo sono personaggi più leggendari che storici; ma un figlio di un marinaio nato sotto i bombardamenti, squartato emotivamente da un padre che lo vuole in Nuova Zelanda e una madre che lo affida alla sorella; cresciuto da donne, poi orfano; ragazzo terribile in pantaloni attillati; giovane padre, chitarrista cantante e compositore pop, idolo delle teenager e del suo manager omosessuale; tossicomane, poi artista concettuale, leader pacifista sotto inchiesta federale, poeta maledetto, avvistatore di Ufo, rockstar in congedo permanente, morto per mano di un fan? Nessun mitografo o evangelista o romanziere postmoderno sarebbe riuscito a inventarsi un personaggio così. Eppure, alla fine era soprattutto un ragazzo che diceva quel che provava, come noi evitiamo di fare il più delle volte perché proviamo cose orribili o anche solo imbarazzanti... (Da Getting Better, un libro sulle canzoni dei Beatles che i lettori del Post hanno potuto osservare mentre si stava scrivendo).
8 dicembre: John Lennon, musicista, profeta e martire
Buongiorno a tutti, mi chiamo Leonardo e sono l'orgoglioso titolare di un blog sul Post in cui tratto i santi del calendario come se fossero rockstar e le rockstar come se fossero santi del calendario. Nell'imminenza del quarantennale dell'omicidio assurdo che ha concluso la storia dei Beatles, posso esimermi dallo scrivere un pezzo in cui definisco John Lennon un martire, una figura addirittura cristologica, il divo che muore per i peccati dei babyboomer? Ho anche un libro in uscita, tengo famiglia, eccetera. E allora perché esito? Cosa mi trattiene? È complicato.
O forse no. C'è che fino a un certo punto era abbastanza facile incasellare i morti illustri del rock, geni vittima della loro sregolatezza. Quasi sempre si tratta di droga, per cui il coccodrillo si scrive da solo: ha voluto vivere troppo intensamente, la candela più grande brucia più rapidamente ecc. ecc. Con Lennon questo appiglio non c'è. Di sostanze fu un appassionato sperimentatore, ma oltre a essere spesso tra i primi a farne uso, fu anche tra i primi a lasciarsene alle spalle. Di vivere intensamente gli era capitato per qualche anno e aveva capito abbastanza presto che non gli piaceva. Il che non significa che la sua morte sia più assurda di altre. È anzi molto facile darle un senso. Ma è più o meno il senso che voleva dargli il suo assassino. È possibile scrivere dell'omicidio di Lennon senza tributare un omaggio a quell'individuo, che alla fine voleva semplicemente scribacchiare il suo nome sul Libro del Novecento, a costo di farlo col sangue, e c'è riuscito?
Riguardando al passato di Lennon, la sua fine tragica non stupisce, sembra quasi ineluttabile: a stupire è la lentezza con cui si compie. Quindici anni prima, davanti a una giornalista che lo era andato a trovare nel suo villino fuori Londra, il ventenne all'apice della fama si era lasciato sfuggire che i Beatles stavano diventando più popolari di Gesù Cristo. Era quel classico tipo di battuta lennoniana, paradossale ma non troppo, che i lettori inglesi ormai si aspettavano da lui: in patria passò quasi inosservata. Quando qualche settimana fu ripresa dalla stampa americana, causò uno di quei fenomeni che oggi chiamiamo shitstorm, e che sì, scoppiavano anche nei beati giorni pre-social network. Negli USA la battuta doveva suonare tanto più insopportabile quanto nascondeva un germe di verità: anche nelle comunità rurali il cristianesimo stava declinando, soppiantato da un consumismo globalizzato di cui Lennon e colleghi erano i profeti più rassicuranti e subdoli. Il consumismo avrebbe unificato l'occidente, gettando radici anche in alcuni Paesi dell'estremo oriente dove Cristo non era mai attecchito. Lennon aveva detto una verità, improvvisando: forse non diversamente da Gesù di Nazareth quando aveva annunciato la distruzione del Tempio: e come Gesù, per aver detto la verità, doveva morire.
 |
| Una foto dei Beatles viene bruciata per protestare contro John Lennon che nel marzo del 1966 aveva detto alla rivista Evening Standard che i Beatles erano più famosi di Gesù. Alcune radio degli Stati Uniti si rifiutarono di passare la loro musica e vennero organizzati piccoli falò dei loro dischi e delle loro foto, come questo fatto da Chuck Smith, un ragazzino di 13 anni, a Fort Oglethorpe, in Georgia, il 12 agosto del 1966. |
Come capita quasi sempre in questi casi, l'indignazione collettiva nasconde uno choc culturale: Lennon, che a quel punto vendeva molti più dischi in America che in Europa, credeva forse attraverso il r'n'r di aver capito la cultura americana, ma ne ignorava alcuni tabù. Scherzare su Gesù Cristo era concesso in Inghilterra: non nell'America profonda, dove furono segnalati roghi dei dischi dei Beatles. Malgrado le scuse pubbliche, recitate da un John sinceramente contrito, il tour americano si trasformò un incubo logistico: è il momento in cui il fanatismo suscitato dai Quattro svela il suo lato minaccioso. Brian Epstein si accorge che garantire la sicurezza dei Quattro in un'America ancora più armata di quella di oggi è praticamente impossibile. Prima o poi era scritto che un fan più scoppiato o deluso degli altri avrebbe estratto una pistola. Cosa che inevitabilmente successe: e se non fu subito ma ben quindici anni più tardi, fu soltanto per l'insospettabile testardaggine con cui Lennon scelse di sopravvivere, ogni volta che gli fu possibile scegliere tra diventare un mito e restare tra i vivi.
Due anni dopo, un Lennon già molto diverso, consumatore ormai abituale di LSD, ha un'illuminazione e la confessa immediatamente al vecchio amico Pete Shotton. "Penso di essere Gesù Cristo. No, aspetta, sono Gesù Cristo". All'inizio Pete crede a uno scherzo, ma Lennon è serio. Ha già calcolato mentalmente quanto gli resta da vivere: se Cristo è morto a 33 anni... "Mi uccideranno, sai? Ma ho ancora quattro anni, quindi devo fare cose". Lo stesso giorno convoca i colleghi a una riunione di emergenza. "Sono Gesù Cristo", avverte. "Sono tornato. Questo è quanto". Nessuno è molto sorpreso. "Va bene", risponde Ringo sospirando (o sbadigliando?) "Riunione aggiornata, andiamo a pranzo". Quella sera, per una delle coincidenze incredibili della sua biografia, Lennon invita Yoko Ono a casa sua. Si frequentavano già, ma quella notte è diversa. La passano a urlare: registrano Two Virgins. Non si lasceranno praticamente più.

Come il Cristo dell'Ultima tentazione di Scorsese, che quando la croce è già allestita dice no, e si rifà una vita con Maria Maddalena: dopo aver flirtato con l'autodistruzione (e introdotto sin dal 1964 un argomento tabù come la morte nei testi di un gruppo pop da classifica), quando il destino comincia a bussare Lennon fa tutto quello che gli è consentito per eluderlo. Quando i concerti diventano troppo rischiosi, Lennon smette di farli. Il sodalizio affettivo e artistico con Yoko Ono gli consente di distruggere la sua immagine pubblica di beatle, emotivamente insostenibile. Trova asilo a New York, nell'America libertaria che forse si illudeva avrebbe trionfato sul Midwest rurale che lo aveva respinto, in quella palingenesi rivoluzionaria che a fine Sessanta tutti ritenevano imminente. Quando diventa chiaro che la rivoluzione non si fa, Lennon capisce di nuovo di essere troppo esposto (la FBI ha aperto un fascicolo su di lui) e rinuncia anche al suo status di artista rivoluzionario. Si prende, col consenso della moglie, una vacanza dalla vita: è il cosiddetto lost weekend, trascorso a bere e scopare come la rockstar decadente che dopotutto aveva il diritto di essere. Avrebbe potuto restarci secco così: sarebbe stata una fine che tutti avremmo percepito come inevitabile, e invece no; anche stavolta Lennon riesce a fare un passo più lungo. Torna da Yoko, e vive con lei gli anni tranquilli e misteriosi del buen ritiro nel Dakota Building, l'ultima tappa di una lunga fuga cominciata dieci anni prima. A quel punto Lennon non era più una rockstar, né un profeta, né un rivoluzionario, né un artista: forse per la prima volta nella sua vita un uomo libero, un casalingo con un figlio da crescere. Il tragico destino che aspettava il successore di Cristo sembrava essersi allontanato per sempre – e invece era lì, paziente, acquattato all'uscita. Sarebbe stato sufficiente cedere a un richiamo naturale: rimettersi a cantare, incidere un disco, promuoverlo sui giornali e fare tutte le cose banali che i cantanti fanno, come firmare gli autografi, perché dal passato arrivasse questa scheggia impazzita che si portava tutte le frustrazioni accumulate in quindici anni, con una pistola in mano.

San Carlo non era un cretino (e noi?)
07-11-2020, 02:25autocritiche, Chiesa, epidemia 2020, Il Post, santiPermalinkTra i pezzi sui santi che non ho ancora rimesso a posto c'è quello su Carlo Borromeo, che dovrei proprio riscrivere da capo. Per quanto il tizio mi sia antipatico (quanto può esserlo un amministratore milanese assai bigotto) (cioè tantissimo) devo ammettere che sono stato molto più ingiusto con lui che con altri. Nel Borromeo mi sono sforzato di vedere l'anticipatore di quella che
"i teocrati milanesi di oggi chiamano “sussidiarietà”: dove lo Stato non arriva ci pensa la Compagnia, per cui è una fortuna che lo Stato non arrivi quasi mai a combinare nulla di concreto. Nel caso della peste lo Stato si adopra così poco, e Carlo così tanto, che l’epidemia viene onorata del suo nome, e ancora oggi la si chiama “peste di San Carlo”.
Fin qui se ne poteva ancora discutere: in fondo non era colpa di Carlo se gli amministratori spagnoli abbandonarono Milano a sé stessa; il problema è quel che soggiungevo:
Per i suoi detrattori, la peste merita ugualmente di essere chiamata di San Carlo perché senza di lui probabilmente sarebbe durata molto meno: senza la sua mania di convocare oceaniche processioni, formidabili occasioni per la diffusione del morbo, ci sarebbero state assai meno vittime, assai meno occasioni per dimostrare l’abnegazione del cardinale. Va bene, per l’epidemiologia era ancora molto presto, ma l’osservazione che le adunate di popolo facilitavano il contagio era già condivisa da dotti e sapienti, e Borromeo se ne fregava: aveva il suo Sacro Chiodo da far sfilare, tra i mucchietti di vittime del giorno; e se non avesse funzionato, si poteva pure bruciare qualche untorella.
E qui, davvero, stavo giocando sporco. Non risultano untorelle bruciate sul rogo a Milano durante la peste di San Carlo, anche se almeno un poveraccio lo impiccarono con un'accusa del genere. D'altro canto quando c'era una donna da condannare al rogo con l'accusa di stregoneria il cardinale non si tirava certo indietro, anzi: in almeno un'occasione dovettero intervenire il Papa e l'inquisizione per... fermarlo, perché secondo Carlo accuse del genere erano troppo gravi per garantire un giusto processo. Ma nel caso della peste del 1576, il mio vecchio pezzo travisa completamente l'atteggiamento assunto dal Borromeo. È vero, che le adunate di popolo facilitassero il contagio era già un'osservazione condivisa; è vero, Borromeo ritenne giusto organizzare comunque delle processioni, ma nell'occasione prese precauzioni che a distanza di quattro secoli facciamo fatica a prendere noi. La processione che portò il Sacro Chiodo in giro per la città il 5 ottobre era composta di soli uomini: donne e minori di 15 anni, che risultavano maggiormente soggetti al contagio, erano in lockdown domiciliare dal primo ottobre. Tra un partecipante e l'altro, un distanziamento di tre metri, che considerati i modi spicci dei birri del tempo era probabilmente rispettato (noi oggi a più di un metro di distanza non riusciamo a stare, neanche in coda in farmacia).
 |
| Il pittore (Fiamminghino) ha l'aria di non aver mai assistito a un lockdown in vita sua. |
Altre direttive del Borromeo ai suoi sottoposti fanno intuire che una rudimentale scienza epidemiologica esistesse già, anche in mancanza di microscopi e del concetto di virus. Dando un'occhiata un po' più da vicino al suo caso, mi sono accorto di quanto somigliasse al terremoto estense di qualche anno prima: anche in quel caso accanto a risposte completamente irrazionali, c'era già chi basandosi sui fatti formulava proposte operative che funzionano ancora oggi. Non erano tutti cretini nel Cinquecento, così come non lo siamo noi del Duemila che in teoria abbiamo ancora meno scuse. Carlo visitava i malati come il suo ruolo imponeva, ma si portava una lunga bacchetta per tenerli a distanza: tra una visita e l'altra faceva bollire i vestiti (quindi l'idea che qualcosa di minuscolo non resistesse alle forti temperature c'era già: al limite le pulci). Altri strumenti, in un mondo senza alcool distillato, erano la spugna d'aceto e le candele su cui passare le mani dopo aver distribuito l'eucarestia. Certo, era pur sempre un uomo di fede e di una fede rigida, arcigna: eppure non si oppose alla decisione del Tribunale di Sanità di prolungare il lockdown oltre il giorno di Natale, malgrado già a metà dicembre la curva dei contagi fosse scesa. Diede anche disposizione perché i sacerdoti benedicessero le abitazioni dalla strada, senza entrarvi. Insomma l'immagine fortissima della basilica di San Pietro vuota durante la pasqua del 2020 non è, come credevo, una completa novità storica. Persino nel periodo più cupo della Controriforma, un cardinale intransigente sapeva quand'era ora di chiudere le chiese, e che oltre a sperare in Dio bisognava anche stare in casa il più possibile. Il lockdown sarebbe durato fino a febbraio. Tutto sommato, un successo, se si confronta per esempio il numero pur ingente di vittime (17000) con quanti ne morirono per lo stesso morbo a Venezia (70000).
Tutto questo quando mi misi a scrivere il pezzo su San Carlo non lo sapevo, il che non mi scusa: avrei potuto almeno arrivarci via Manzoni. La peste che lui descrive arriva cinquant'anni dopo – il mezzo secolo che noi italiani siamo abituati a considerare come il trionfo dell'oscurantismo, quello in cui si processano Bruno e Galilei. Tutto giusto, eppure in capo a questo mezzo secolo, quando i milanesi chiedono al nuovo cardinale Borromeo di portare in processione le spoglie del vecchio, Federigo si mostra tutt'altro che entusiasta. "Gli dispiaceva quella fiducia in un mezzo arbitrario, e temeva che, se l'effetto non avesse corrisposto, come pure temeva, la fiducia si cambiasse in iscandolo. Temeva di più, che, se pur c'era di questi untori, la processione fosse un'occasion troppo comoda al delitto: se non ce n'era, il radunarsi tanta gente non poteva che spander sempre più il contagio: pericolo ben più reale".
Le autorità però insistono e alla fine Federigo cede. Dopo tre giorni di preparativi, una parata in grande stile percorre Milano. Il "venerato cadavere, vestito di splendidi abiti pontificali, e mitrato il teschio" viene scorrazzato per la città con molte meno precauzioni di quante aveva voluto prendere da vivo: la processione si ferma a tutti i crocicchi in cui il vecchio cardinale aveva fatto erigere delle croci per le celebrazioni religiose all'aperto. Questa cosa per me rappresenta un'ironia micidiale: Carlo che da vivo aveva lottato contro il contagio, da morto diventa un feticcio che guida i milanesi nell'opposta direzione: i simboli del distanziamento sociale che da vivo aveva disseminato per la città diventano dopo cinquant'anni i luoghi di assembramento intorno al suo cadavere. "Ed ecco che, il giorno seguente, mentre appunto, regnava quella presontuosa fiducia, anzi in molti una fanatica sicurezza che la processione dovesse aver troncata la peste, le morti crebbero, in ogni classe, in ogni parte della città, a un tal eccesso, con un salto così subitaneo, che non ci fu chi non ne vedesse la causa, o l'occasione, nella processione medesima. Ma, oh forze mirabili e dolorose d'un pregiudizio generale! non già al trovarsi insieme tante persone, e per tanto tempo, non all'infinita moltiplicazione de' contatti fortuiti, attribuivano i più quell'effetto; l'attribuivano alla facilità che gli untori ci avessero trovata d'eseguire in grande il loro empio disegno".
Insomma San Carlo poteva essere un oscurantista misogino: ma non un cretino. Nemmeno suo nipote Federigo. Il che non significa che cretini non ce ne fossero anche a quei tempi; e ancor più dei cretini tanta gente in buona fede ma un po' troppo disposta a credere a quel che vuole, e quel che vuole è sempre una versione dei fatti semplificata, rassicurante, e qualche volta foriera di disastri. A Milano, nel 1576, per partecipare a un corteo serviva un distanziamento di tre metri; cinquecento anni dopo, ci capita ancora di doverne spiegare il perché, a gente che non se ne convince. San Carlo non era un cretino: noi ci arrangiamo.
Le canzoni dei Beatles (#30-21)
30-07-2020, 02:21beatles, Il Post, musicaPermalinkRicordo a tutti che la classifica non la faccio io, anzi io mi dissocio formalmente, è la media di tutte le classifiche redatte dai giornalisti musicali, credo che li assumano soltanto se dimostrano di non percepire la differenza tra Il flauto magico e una mietitrebbia.
Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66), (#65-56), (#55-46), (#45-36)
30. Nowhere Man (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965).
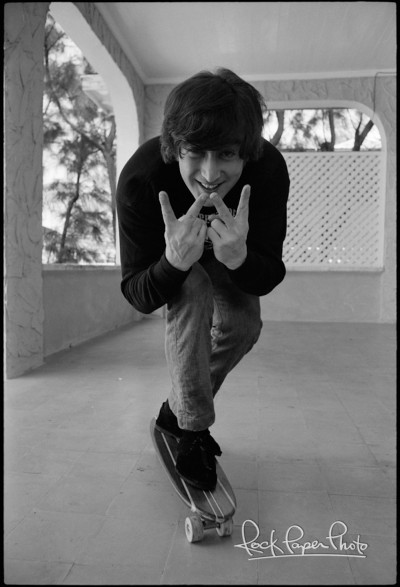 Uomo di Nessun Dove, il mondo aspetta i tuoi ordini. Quando lo andò a trovare qualche mese dopo, nella sua villa di Weybridge, la giornalista Maureen Cleave trovò un John Lennon sospeso tra inquietudine e apatia, isolato dal mondo in un villino ingombro di elettrodomestici e gadget di cui si era stancato a volte prima di scartarli. Lennon non poteva rinunciare a dire spiritosaggini – era il suo personaggio – e a un certo punto gli scappò detto che non vedeva molto futuro per il cristianesimo, forse non sarebbe sopravvissuto neanche ai Beatles. Una battuta a cui in Inghilterra nessuno fece caso, ma che ripresa dalla stampa americana alla vigilia di un tour scatenò una delle prime shitstorm di cui la storia del costume sia a conoscenza: minacce di morte, roghi di dischi, eccetera. L'intervista della Cleave è passata alla storia per quella battuta, ma rimane anche un bell'esercizio su quello che stava per diventare un topos giornalistico: il ritratto della giovane rockstar alienata. La stanza dei giocattoli, le auto di lusso che Lennon compra e rivende perché ha paura di spendere tutti i soldi che guadagna, salvo ricomprarle subito dopo... è tutto già così perfetto e familiare da seminare un dubbio: non è che Lennon stesse recitando, come aveva sempre fatto davanti ai microfoni dei giornalisti? Era davvero così compreso nel suo ruolo di divo con piscina e Rolls Royce, o non stava semplicemente dando al pubblico quello che il pubblico si aspettava da lui, quello che il pubblico si aspetta ancora oggi, un'ostentazione spudorata di status symbol, tratti eccentrici e sintomi di alienazione? Essendo inglese non poteva candidarsi alla Casa Bianca come Kanye West; si limitò a un po' di dissing su Gesù Cristo. Non stava semplicemente fornendo ai fan una specie di tableau vivente del brano che era appena uscito come singolo negli USA, Nowhere Man?
Uomo di Nessun Dove, il mondo aspetta i tuoi ordini. Quando lo andò a trovare qualche mese dopo, nella sua villa di Weybridge, la giornalista Maureen Cleave trovò un John Lennon sospeso tra inquietudine e apatia, isolato dal mondo in un villino ingombro di elettrodomestici e gadget di cui si era stancato a volte prima di scartarli. Lennon non poteva rinunciare a dire spiritosaggini – era il suo personaggio – e a un certo punto gli scappò detto che non vedeva molto futuro per il cristianesimo, forse non sarebbe sopravvissuto neanche ai Beatles. Una battuta a cui in Inghilterra nessuno fece caso, ma che ripresa dalla stampa americana alla vigilia di un tour scatenò una delle prime shitstorm di cui la storia del costume sia a conoscenza: minacce di morte, roghi di dischi, eccetera. L'intervista della Cleave è passata alla storia per quella battuta, ma rimane anche un bell'esercizio su quello che stava per diventare un topos giornalistico: il ritratto della giovane rockstar alienata. La stanza dei giocattoli, le auto di lusso che Lennon compra e rivende perché ha paura di spendere tutti i soldi che guadagna, salvo ricomprarle subito dopo... è tutto già così perfetto e familiare da seminare un dubbio: non è che Lennon stesse recitando, come aveva sempre fatto davanti ai microfoni dei giornalisti? Era davvero così compreso nel suo ruolo di divo con piscina e Rolls Royce, o non stava semplicemente dando al pubblico quello che il pubblico si aspettava da lui, quello che il pubblico si aspetta ancora oggi, un'ostentazione spudorata di status symbol, tratti eccentrici e sintomi di alienazione? Essendo inglese non poteva candidarsi alla Casa Bianca come Kanye West; si limitò a un po' di dissing su Gesù Cristo. Non stava semplicemente fornendo ai fan una specie di tableau vivente del brano che era appena uscito come singolo negli USA, Nowhere Man?Quando non faceva il matto davanti ai giornalisti e non era in tour da qualche parte, John aveva pur sempre un gruppo da portare avanti. La tabella era sempre quella concordata con Brian Epstein tre anni prima: due album e quattro singoli all'anno. Ormai ci si aspettava che gli album fossero composti tutti di materiale originale, che non si scriveva da solo, per cui no: Lennon non è che non stesse facendo nulla tutto il giorno. Il problema dell'artista (e soprattutto di chi gli vive intorno) è che è quasi impossibile distinguere i momenti in cui sta creando da quelli in cui sta cazzeggiando. Si capisce che gironzolare mezzo fatto per la casa non restituisce una buona impressione di te, ma se sei il tizio che scrive le canzoni di Lennon-McCartney può darsi che sia il modo più proficuo di passare il tempo.Un buon esempio è proprio la leggenda di Nowhere Man: dopo cinque ore passate a cercare una canzone che non gli veniva, Lennon si butta sul letto, comincia a osservare dall'esterno quel sé stesso che si dibatte tra noia e velleità, ed eureka: ecco Nowhere Man. Quando non riesci a trovare niente da dire, puoi sempre mettere in scena te stesso che non riesce a trovare niente. Due anni prima Federico Fellini ci aveva fatto un film: Nowhere Man è l'8 e 1/2 di Lennon.
 Né dobbiamo credere per forza che le ore passate prima di buttarsi a letto fossero state infruttuose: magari le aveva passate ad ascoltare qualche disco d'importazione. In febbraio negli USA era uscito Bringing It All Back Home, il disco in cui Dylan suonava per la prima volta con una band. Ma il brano che probabilmente doveva averlo colpito di più era ancora acustico: si chiamava Mr Tambourine Man. In marzo poi un gruppo californiano aveva pubblicato la sua versione 'elettrica' di Mr Tambourine Man: si facevano chiamare Byrds e le loro chitarre ricordavano smaccatamente la 12 corde usata da George Harrison in Ticket to Ride: insomma se Lennon avesse voluto copiarli, non avrebbe che "riportato tutto a casa".
Né dobbiamo credere per forza che le ore passate prima di buttarsi a letto fossero state infruttuose: magari le aveva passate ad ascoltare qualche disco d'importazione. In febbraio negli USA era uscito Bringing It All Back Home, il disco in cui Dylan suonava per la prima volta con una band. Ma il brano che probabilmente doveva averlo colpito di più era ancora acustico: si chiamava Mr Tambourine Man. In marzo poi un gruppo californiano aveva pubblicato la sua versione 'elettrica' di Mr Tambourine Man: si facevano chiamare Byrds e le loro chitarre ricordavano smaccatamente la 12 corde usata da George Harrison in Ticket to Ride: insomma se Lennon avesse voluto copiarli, non avrebbe che "riportato tutto a casa".Alcune caratteristiche formali di Nowhere Man si spiegano proprio se si confrontano con quello che stava succedendo negli USA: per la prima volta un bridge compare tre volte (ciononostante la canzone è ancora breve rispetto ai modelli dylaniani). Le chitarre danno la loro versione del jingle-jangle byrdiano: Paul ricorda con soddisfazione di avere costretto i tecnici del suono a oltrepassare i limiti della strumentazione disponibile, facendo passare le chitarre da un amplificatore intermedio per aumentare le frequenze alte oltre il consentito. Persino la scelta di non correggere la lieve dissonanza tra il coro iniziale e gli strumenti in entrata potrebbe essere un tentativo di aggiornarsi al suono 'sporco' che negli USA era l'ultimissima novità – Dylan in studio a volte non si preoccupava nemmeno di accordare la chitarra, e Dylan era la cosa più hip che ci fosse. Si dice che Nowhere Man sia il primo brano dei Beatles che non parli d'amore: in superficie è proprio così, ma dopotutto è una canzone di John su sé stesso: c'è più amore qui che in Day Tripper. Qualche anno più tardi Dylan avrebbe spiegato in un'altra celebre intervista che molte canzoni che credeva di dedicare agli altri, in realtà erano rivolte a sé stesso. Lennon, mentre fissava il soffitto della sua camera da letto di Weybridge, lo aveva già capito.
29. Rain (Lennon-McCartney, lato B di Paperback Writer).
Sempre a Weybridge una sera, dopo essersi rollato un joint, Lennon spinge un bottone perché vuole riascoltare il brano a cui sta lavorando. Viene investito da una canzone mai sentita: eppure è lui che canta, anche se è come se chiamasse da un mondo al di là dello specchio. Rimane perplesso per qualche istante (il joint in mano), prima di capire: ha montato la bobina a rovescio, sta ascoltando l'esatto contrario di quello che ha inciso ad Abbey Road. Niente di così strano, tranne che la canzone gli piaceva di più così.
Il giorno dopo cerca di spiegare ai colleghi e a George Martin che Rain suona meglio alla rovescio. Alla fine Martin acconsentirà ad inserire almeno un frammento invertito della traccia vocale di John nel finale (nei video musicali che vengono girati, John dovrà mimare anche questa traccia invertita). È un episodio famoso forse più di quanto meriti – di tante innovazioni tentate con Rain, la voce alla rovescio è la più appariscente ma la meno incisiva. L'episodio fotografa comunque un John Lennon che dopo tre anni di esperienza vive ancora la sala prove come una stanza di giocattoli da smontare alla ricerca di qualche effetto inatteso e divertente. È anche il sintomo di una resa: su Rain si poteva osare di più perché in fondo era chiaro dall'inizio che sarebbe stato solo un Lato B. È come se dopo il passo falso di Day Tripper, Lennon cominci a ritirarsi in un ghetto creativo: se Paul davvero vende di più, John diventerà l'anima sperimentale della band (il ruolo che in precedenza Harrison aveva iniziato a ritagliarsi).
Rain è un brano che dà sempre l'impressione di restare un po' nascosto – per quanto possa restare nascosto un brano dei Beatles. C'è un motivo semplice: era un lato B, appunto, e Allen Klein non volle inserire lati B nell'antologia ufficiale del periodo 1962-66, il cosiddetto Disco Rosso. Lo spazio c'era, ma in effetti Rain, che pure è il brano in cui Ringo Starr ritiene di avere dato il meglio di sé, non è quel tipo di canzone che metteresti in vetrina. Gli è perfettamente congeniale la sua dimensione di lato B, che oggi non possiamo più percepire: se nei primi anni della Beatlemania il lato B era quello dedicato al lento, verso la metà degli anni Sessanta ormai dedicare tempo all'ascolto dei lati B era la forma di snobismo più a buon mercato cui i giovani consumatori di musica potessero accedere. Il lato B era diventato lo spazio per gli intenditori: se il lato A era la vetrina, il B era il retrobottega dove gli esercenti tenevano da parte per la clientela più affezionata le cose veramente buone o comunque un insolite, non per tutti. E cosa c'era di 'buono ma non per tutti', all'inizio dell'anno di grazia 1966, nel menu dei Beatles? Un brano volutamente sfuocato, compresso, saturato che dà l'impressione di rallentare in corsa finché a un certo punto non è più un'impressione: rallenta davvero. Il ritornello, anche se non ha nulla di specificatamente indiano, comincia a suonare come un mantra.
 Anche l'idea di accelerare o rallentare le tracce vocali e strumentali non l'hanno inventata i Beatles – è sempre stata un'opzione, sin dall'invenzione del fonografo. Alcuni musicologi sono convinti che le registrazioni degli anni '20 di Robert Johnson siano accelerate del 20%: per un secolo tutti gli apprendisti blues e poi rock avrebbero tentato di imitare uno stile molto più svelto del suo. Ma prima dei Beatles era un trucco tenere i dischi più brevi e farli suonare meglio; ai limiti un gioco per divertire i bambini (i Chipmunks prima ancora di diventare personaggi televisivi erano un gruppo vocale che registrava cover accelerate). Con i Beatles il trucco diventa una tecnica, esplorata in tutte le sue potenzialità e a volte persino esibita. In Rain Lennon chiede a Martin di rallentare gli strumenti e accelerargli la voce; del resto è la canzone che parla di un uomo che non vive alla velocità degli altri, e non capisce più l'affanno di chi ancora subisce il tempo atmosferico ("posso mostrarti che è solo uno stato della mente", ok John, io l'ombrello comunque me lo porterei). È l'equivalente musicale di quei video girati in time-lapse in cui una persona quasi ferma si staglia su uno sfondo di persone o automobili che sciama a velocità rapidissima. Sui forum di fotografia qualcuno lo chiama "effetto Koyaanisqatsi", dal nome del celebre film sperimentale che negli anni '80 rese popolare il time-lapse. La progressione armonica è più semplice del solito – come del resto nel brano in vetrina, Paperback Writer: la sperimentazione della coppia Lennon-McCartney si è spostata dagli accordi ai suoni e ai nastri; ormai i loro veri strumenti sono gli amplificatori, gli equalizzatori, i magnetofoni a bobina. Non c'è più nulla che non si possa fare: la pioggia può suonare come il sole, è tutto uno stato della mente.
Anche l'idea di accelerare o rallentare le tracce vocali e strumentali non l'hanno inventata i Beatles – è sempre stata un'opzione, sin dall'invenzione del fonografo. Alcuni musicologi sono convinti che le registrazioni degli anni '20 di Robert Johnson siano accelerate del 20%: per un secolo tutti gli apprendisti blues e poi rock avrebbero tentato di imitare uno stile molto più svelto del suo. Ma prima dei Beatles era un trucco tenere i dischi più brevi e farli suonare meglio; ai limiti un gioco per divertire i bambini (i Chipmunks prima ancora di diventare personaggi televisivi erano un gruppo vocale che registrava cover accelerate). Con i Beatles il trucco diventa una tecnica, esplorata in tutte le sue potenzialità e a volte persino esibita. In Rain Lennon chiede a Martin di rallentare gli strumenti e accelerargli la voce; del resto è la canzone che parla di un uomo che non vive alla velocità degli altri, e non capisce più l'affanno di chi ancora subisce il tempo atmosferico ("posso mostrarti che è solo uno stato della mente", ok John, io l'ombrello comunque me lo porterei). È l'equivalente musicale di quei video girati in time-lapse in cui una persona quasi ferma si staglia su uno sfondo di persone o automobili che sciama a velocità rapidissima. Sui forum di fotografia qualcuno lo chiama "effetto Koyaanisqatsi", dal nome del celebre film sperimentale che negli anni '80 rese popolare il time-lapse. La progressione armonica è più semplice del solito – come del resto nel brano in vetrina, Paperback Writer: la sperimentazione della coppia Lennon-McCartney si è spostata dagli accordi ai suoni e ai nastri; ormai i loro veri strumenti sono gli amplificatori, gli equalizzatori, i magnetofoni a bobina. Non c'è più nulla che non si possa fare: la pioggia può suonare come il sole, è tutto uno stato della mente.28. Here, There and Everywhere (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).
"Per vivere una vita migliore ho bisogno che il mio amore sia qui..." è abbastanza significativo che la canzone che parla della necessità di non separarsi mai dall'amata ("ogni giorno dell'anno") provenga dall'unico Beatle che nel 1966 viveva felicemente scapolo. Mentre John deve "nascondere il suo amore" e ricorrere a giri di parole sempre più immaginifici per cantare le sue avventure senza insospettire Cynthia, Paul è libero di uscire e tornare a casa all'ora che vuole, e se non ha sonno mettersi a fantasticare di come sarebbe bello avere lei in ogni giorno dell'anno. Ci può anche scrivere una canzone senza che nessuno venga a disturbarlo. Ma cosa significa scrivere una canzone? Per Paul è spesso una questione strutturale: si tratta di costruire un piccolo mondo, anche solo un appartamento.
Tra le caratteristiche inconfondibili dei giovane compositore McCartney c'è l'abitudine a variare la progressione armonica nel bel mezzo della strofa creando nell'ascoltatore un effetto sorpresa (i compositori suoi coetanei, se riescono ad azzeccare quattro accordi se li tengono, a volte per sicurezza non li cambiano nemmeno per il ritornello). Here There è l'esempio classico: si annuncia come canzoncina dolce dolce in quattro accordi, una scala ascendente lungo un intervallo di quarta (Sol, La-, Si-, Do) che ci fa desiderare di sbucare sul Re che completerebbe la quinta – e proprio quando ce l'aspettiamo Paul cambia tutto con Fa#-. Bisogna fare caso anche al testo: Paul ha appena detto "changing my life" e il Fa#- imprevisto avviene proprio "with a wave of her hand": scrivere canzoni non significa proprio costruire mondi che possono cambiare con un gesto della mano? È come se a un certo punto mentre ci mostrava il suo ménage immaginario, abbia aperto una porta e ci abbia condotto in una stanza diversa, da cui finalmente si accede al Re sospirato ma ormai inatteso.
E il bridge? È un'altra stanza ancora: per arrivarci si passa da uno strano scalino (Re-Fa-Sib) e quando per un attimo siamo convinti di esserci finalmente accomodati in una confortante 50s progression (Sib, Sol-, Do-), il quarto accordo è un Re7 e non sai più bene se sei nel vestibolo o nel salotto buono. Invece di accendere la luce Paul si è messo a intonare una melodia rétro ("and if she's beside me I know I need never care"); non fai in tempo ad ambientarti ("but to love her is to meet her...") che Paul accende la luce davvero e scopri che sei al punto di partenza! ("everywhere"). E non può non lasciarti ammirato il modo in cui il bridge si appoggia naturalmente sulla strofa successiva, persino dal punto di vista sintattico ("knowing that love is to share": non sono molte le canzoni in cui una frase comincia nel bridge e prosegue nel ritornello). Sei tornato da dove avevi cominciato, ma ora vedi tutto con un occhio diverso. Ci sono canzoni di McCartney che suscitano entusiasmo, affetto, malinconia, diffidenza (persino ripugnanza...): Here, There è la canzone che suscita ammirazione. Lennon la considerava una delle sue preferite non solo di McCartney, ma dei Beatles, e in effetti nel modo in cui il bridge trapassa immediatamente nella strofa riconosciamo un suo vecchio trucco di scena; a sua volta Lennon avrebbe fatto tesoro della principale suggestione di Here There, l'idea di una canzone che si rovescia in sé stessa come una scala di Escher. Il tratto distintivo più appariscente della canzone rimangono comunque i languidi coretti, un richiamo senza vergogna ai numeri dei crooner anni Quaranta. È uno dei rari casi in cui abbia ammesso un ripensamento, quando nel 1984 ripubblicò il brano nella colonna sonora di Give My Regards to Broad Street.
27. You've Got to Hide Your Love Away (Lennon-McCartney, Help!, 1965).
Eccomi qui, con la testa tra le mani. You've Got to Hide, lo dicono tutti, è la canzone in cui Lennon si rifà a Dylan. Diciamo pure che rifà Dylan: il timbro della voce rasenta la caricatura. È l'elemento più dylaniano di una canzone che non somiglia in particolare a nessun brano del Dylan folk – la parentela più probabile è con I Don't Believe You, in Another Side, che comincia con una rima molto simile, "I can't understand / she let go of my hand". In quegli anni la voce di Dylan era una sfida a tutto ciò che si poteva considerare radiofonicamente accettabile (un po' è ancora così: avete sentito per caso qualche brano del suo ultimo disco per radio?) Che i Beatles tentassero di imitarlo non era affatto scontato.
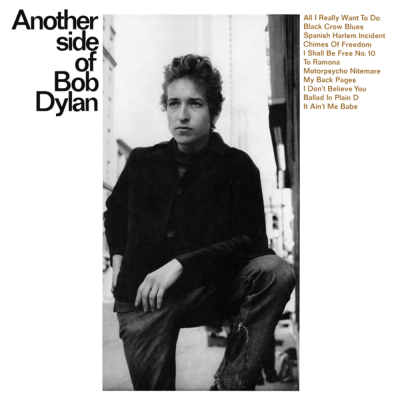 Dylan era un fenomeno di nicchia, anche in Inghilterra (dove la sua svolta rock avrebbe destato le reazioni peggiori nei fan): cominciava a essere un nome importante tra i frequentatori abituali dei negozi di dischi; era già il volto più celebre di quella cosa che di lì a poco si sarebbe cominciata a chiamare Controcultura; esibire i suoi dischi su mensole e tavolini conferiva già a studenti e professionisti un certa credibilità intellettuale. I Beatles, ormai onnipresenti sui media, giocavano in un altro campionato. Dylan avrebbe avuto tutti i motivi per disprezzare quei figurini venuti dal vecchio mondo a profanare la vera essenza dello spirito americano, la sua musica; invece li trovava fantastici sin dal primo momento impazziva proprio per le cose più smaccatamente pop, come I Want to Hold Your Hand, e non vedeva l'ora di incontrarli e fumarci assieme. Lennon dal canto suo avrebbe avuto più di un motivo per riservare a Dylan la stessa diffidenza che riservava ai coetanei che fino a quel momento potevano aspirare soltanto a porzioni della sua fama. Dylan in effetti è il più giovane tra gli autori che hanno avuto un peso rilevante nella sua formazione artistica: l'unico coetaneo che abbia preso a modello.
Dylan era un fenomeno di nicchia, anche in Inghilterra (dove la sua svolta rock avrebbe destato le reazioni peggiori nei fan): cominciava a essere un nome importante tra i frequentatori abituali dei negozi di dischi; era già il volto più celebre di quella cosa che di lì a poco si sarebbe cominciata a chiamare Controcultura; esibire i suoi dischi su mensole e tavolini conferiva già a studenti e professionisti un certa credibilità intellettuale. I Beatles, ormai onnipresenti sui media, giocavano in un altro campionato. Dylan avrebbe avuto tutti i motivi per disprezzare quei figurini venuti dal vecchio mondo a profanare la vera essenza dello spirito americano, la sua musica; invece li trovava fantastici sin dal primo momento impazziva proprio per le cose più smaccatamente pop, come I Want to Hold Your Hand, e non vedeva l'ora di incontrarli e fumarci assieme. Lennon dal canto suo avrebbe avuto più di un motivo per riservare a Dylan la stessa diffidenza che riservava ai coetanei che fino a quel momento potevano aspirare soltanto a porzioni della sua fama. Dylan in effetti è il più giovane tra gli autori che hanno avuto un peso rilevante nella sua formazione artistica: l'unico coetaneo che abbia preso a modello.A Lennon non interessa copiare una progressione di accordi o altri trucchi del mestiere. La maggior parte continua a portarseli da casa (persino nel ritornello di questo 'pezzo folk' si annida la cara vecchia cadenza I-IV-V di Twist and Shout): gli interessava l'atteggiamento, un modo completamente diverso di porsi nei confronti del pubblico, e che rendeva credibili tutta una nuova gamma di sentimenti che fino a quel momento John non aveva mai tentato di mettere tra i solchi. You've Got to Hide ritrae un innamorato frustrato e senza speranza che in effetti somiglia all'eroe di molte ballate acustiche di Dylan. Ma è proprio a questo livello che possiamo misurare la distanza: per Dylan la frustrazione sentimentale è sempre una questione intima, che al limite può essere condivisa con l'oggetto del proprio amore sfortunato (e delle proprie recriminazioni, che Dylan protrae per strofe e strofe).
Per Lennon questa intimità non esiste: ogni sentimento è un fatto sociale che assume un senso solo se c'è un coro che ascolta, osserva, commenta, e in questo caso gli ride in faccia: ehi, bisogna che quell'amore te lo metti via. Esiste un amore se nessuno lo guarda? You've Got to Hide è il lato oscuro di I Feel Fine: se per essere felici del proprio amore è necessario vantarsi con qualcuno, è proprio l'esistenza di tutti questi qualcuno a rendere insostenibile la situazione in cui l'amore non va in porto. Lennon è circondato da un coro di osservatori in maschera da clown che lo spìano, lo giudicano, lo irridono, lo costringono a coprirsi la faccia e voltarsi verso il muro. La ragazza quasi non c'entra, anzi sembra compassionevole. Una volte gli aveva persino detto "l'amore troverà una strada". (Due anni dopo, alla festa per il lancio di Magical Mystery Tour, Lennon imbarazzerà gli ospiti danzando tutta la sera con Patti Boyd Harrison).
26. Paperback Writer (Lennon-McCartney, singolo del 1966).
 "Gentile signore / gentile signora, leggereste il mio libro?" Nell'anno precedente la Arnoldo Mondadori Editore aveva tentato un esperimento: una collana di libri da vendere non nelle librerie, ma in edicola, in un formato tascabile (o come si dice in inglese, "paperback"). Il romanzo scelto per la prima uscita fu Addio alle armi di Ernest Hemingway, un titolo che le librerie italiane sfoggiavano ormai da vent'anni, ma chissà, forse in questo nuovo formato avrebbe intercettato un pubblico diverso. Sulla fragile copertina in cartoncino campeggiava ben evidente il nome piuttosto pacchiano della nuova collana, "Gli Oscar", nonché l'aspetto più allettante dell'edizione, il prezzo: sole 350 lire! Ne stamparono sessantamila copie, una follia. Finirono in giornata. Scoppiava anche in Italia il boom dei tascabili, "i libri-transistor che fanno biblioteca", si leggeva nel risvolto di copertina. "A casa, in tram, in autobus, in filobus, in metropolitana, in automobile, in taxi... Gli Oscar sono gli Oscar dei libri: si rinnovano ogni settimana, durano tutta la vita". Si sarebbero scollati molto prima, come ognuno di noi ben sa.
"Gentile signore / gentile signora, leggereste il mio libro?" Nell'anno precedente la Arnoldo Mondadori Editore aveva tentato un esperimento: una collana di libri da vendere non nelle librerie, ma in edicola, in un formato tascabile (o come si dice in inglese, "paperback"). Il romanzo scelto per la prima uscita fu Addio alle armi di Ernest Hemingway, un titolo che le librerie italiane sfoggiavano ormai da vent'anni, ma chissà, forse in questo nuovo formato avrebbe intercettato un pubblico diverso. Sulla fragile copertina in cartoncino campeggiava ben evidente il nome piuttosto pacchiano della nuova collana, "Gli Oscar", nonché l'aspetto più allettante dell'edizione, il prezzo: sole 350 lire! Ne stamparono sessantamila copie, una follia. Finirono in giornata. Scoppiava anche in Italia il boom dei tascabili, "i libri-transistor che fanno biblioteca", si leggeva nel risvolto di copertina. "A casa, in tram, in autobus, in filobus, in metropolitana, in automobile, in taxi... Gli Oscar sono gli Oscar dei libri: si rinnovano ogni settimana, durano tutta la vita". Si sarebbero scollati molto prima, come ognuno di noi ben sa.Nel Regno Unito la situazione era diversa, per il solito motivo che i britannici leggono di più. I paperback esistevano da inizio secolo e un boom delle vendite, se c'era stato, era avvenuto durante la Seconda Guerra, in un momento in cui i lettori si erano trovati più spesso in viaggio, sfollati o al fronte. I paperback erano il regno della letteratura di genere, e avevano spodestato le riviste pulp: gialli, intrighi di spionaggio, "sword and sorcery" (il termine fantasy doveva ancora prendere piede). Il protagonista di Paperback Writer non aspira alla fama di un Hemingway, non cerca l'Oscar: vuole scrivere robaccia che entri nelle case di tutti. Non lo spinge la sete di gloria, né la prospettiva di un guadagno. Non vuole finire come il padre, non vuole lavorare per sempre al Daily Mail. Quello che vuole fare nella vita è scrivere migliaia di pagine alla settimana – it took me years to write, will you take a look? Se riuscisse a farne un mestiere, sarebbe l'uomo più felice sulla terra, (dopo McCartney, ovviamente).
Pungolato dalla zia Lil, che voleva sentire almeno una canzone che non fosse d'amore, Paul ritorna sul sentimento che tutti nel 1966 hanno il diritto di provare, tranne lui: l'ambizione. Ma l'aspirante scrittore-di-tascabili non è animato come la ragazza di Drive My Car dalla fede nel successo finale, bensì da un desiderio irrefrenabile di creare mondi immaginari in cui forse rinchiudersi – anche se alla fine, non importa in quale galassia ambienti la tua saga, per qualche bizzarro motivo ci trovi dentro tuo padre. Proprio come Paul, che da lì a poco comincerà a intravedere l'ombra di "Father McCartney" sui set delle sue canzoni, l'aspirante scrittore di paperback comincia a inventarsi un personaggio ("è la lurida storia di un lurido uomo, e la sua affezionata moglie non lo capisce") e solo dopo un verso si rende conto che è di lui che la favola sta narrando. "Suo figlio lavora per il Daily Mail, è un bel posto fisso, ma lui vuole fare lo scrittore di paperback".
Sul piano musicale, Paul dichiara di voler proseguire l'esperimento già tentato da John con The Word, la canzone su un accordo solo: alla fine ne adopera due ma scarta l'intervallo più tipico, quello di quinta, come se una canzone senza amore non avesse diritto a sbocciarvi. La canzone rimane costretta in un più angusto intervallo di quarta che non si risolve mai – proprio come le richieste del protagonista non trovano mai un riscontro. È come se Paul stesse tentando di operare una sintesi tra le due anime che si erano espresse nel singolo di quattro mesi prima: Paperback è una canzone veloce (forse la più veloce di tutte) basata su un riff, come Day Tripper: come We Can Work It Out s'interrompe all'improvviso per lasciare spazio a un elemento vistosamente non-rock, un mini-coro a cappella che è rimasto a tutt'oggi uno degli stilemi più noti dei Beatles, e che però fino al 1966 non si era ancora sentito – e che anche in seguito i Beatles avrebbero adoperato con parsimonia. Il fatto che abbia lasciato un solco tanto profondo è la prova di quanto suonasse già allora caratteristico. Benché non compaia nessuno strumento classico, contiene già un rimando irresistibile alla 'musica seria': sta a Bach come i paperback stanno ai classici della letteratura. Il coro appare come una parrucca incipriata o una corona d'alloro che si cala all'improvviso sull'aspirante scrittore: il testo non lo dice, ma il coro ce lo fa capire, il ragazzo ha la stoffa. Forse non diventerà mai famoso, ma nella sua stanza, mentre batte a macchina centinaia di lettere al minuto, Paperback Writer è felice.
25. Can't Buy Me Love (Lennon-McCartney, singolo, del 1964, poi in A Hard Day's Night)
“Poi siamo andati in America, abbiamo fatto un giorno di vacanza a Miami ed è stato incredibile. C'era un mucchio di ragazze belle, sexy e abbronzate. Abbiamo fatto un servizio fotografico sulla spiaggia con loro e naturalmente abbiamo proposto loro di uscire con noi. La MG stava per mettere in vendita una sua nuova automobile, una decappottabile, e ce ne prestò una a testa proprio per farsi pubblicità. Ricordo di aver portato a cena una di quelle ragazze con questa automobile, ricordo quella notte in Florida, con le palme che ondeggiavano alla brezza. Un ragazzotto di Liverpool con una bella ragazza così in una decappottabile MG... avrei dovuto scrivere Money Can Buy Me Love, altro che can't!”
D'altro canto, cosa c'è di più swag di cominciare una canzone con "ti comprerò un anello di diamanti, amica mia, se questo ti fa stare bene"? Paul si fa venire in mente una frase del genere a Parigi in una camera di hotel che gli costa più o meno tutto quello che gli rende suonare all'Opéra dopo Sylvie Vartan. Non ha idea di quanto sta guadagnando, non ha idea di quanto sta spendendo, l'unica cosa che ha capito del denaro è che non ci può comprare l'amore ma non ne è nemmeno così sicuro. Però "tutti gli dicono così" (Everybody tells me so), e lui si fida. Can't Buy Me Love è l'apogeo della Beatlemania: lo incidono nell'esatto momento in cui I Wanna Hold Your Hand arriva in cima alla top100 americana. Andrà dritto al primo posto subito dopo I Wanna Hold e She Loves You, nel momento in cui nella stessa top100 ci sono 14 singoli dei Beatles. Nel 1963 tutto questo equivale a un sacco di soldi che Paul non è in grado di contare. Quello che può fare è cavalcare l'onda, comprando mobili e immobili prima che i soldi vengano assorbiti da qualche professionista di management o dagli uomini del fisco. Nel momento in cui in America nascono gruppi fotocopia come i "Beetles", nessuno ha bisogno che il prossimo singolo sia un capolavoro, davvero: e in effetti non lo è.
È anzi un brano atipico, in un momento in cui l'immagine dei Beatles dipendeva da una serie di stilemi molto riconoscibili: erano quelli che cantavano "Yeah Yeah", e Paul qui canta "No no no, no". Erano famosi per i coretti armonizzati in modo molto peculiare, e qui i Quattro, dopo averli incisi, decidono di farne a meno: scelta coraggiosa. Erano riconoscibili per le progressioni imprevedibili, e qui Paul opta nella strofa per uno schietta e prevedibile progressione blues. Suonano una miscela di rock e pop, ma qui Paul sembra avere in mente qualcosa di più classico e swingante, e più tardi si sentirà onorato della versione di Ella Fitzgerald. Come se i Beatles fossero già stanchi della formula che li sta coprendo d'oro – o semplicemente non hanno nient'altro per le mani e bisogna battere il ferro finché è caldo. In fondo poteva finire tutto tanto rapidamente quanto era iniziato, e cosa sarebbe rimasto? La consolante idea che con tutti quei soldi piovuti ed evaporati non avrebbero potuto comprarci un grammo d'amore. O no?
Can't Buy esce su singolo insieme a You Can't Do That: su un lato John si atteggia a maschio possessivo, sull'altro lato Paul spergiura che i soldi non danno la felicità. Suonano credibili entrambi, ma è solo l'inizio del 1964.
24. Blackbird (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
Take these broken wings and learn to fly. A Rikikesh come è noto Lennon e McCartney fecero progressi con la meditazione, ma soprattutto col fingerpicking. È emozionante notare come malgrado il maestro fosse lo stesso, i discepoli abbiano sviluppato immediatamente due stili completamente diversi – del resto il fingerpicking è una delle tecniche più idiosincratiche, ognuno ha una mano diversa e la chitarra se ne accorge più di altri strumenti. Se Lennon è più ossessivo, quasi alla ricerca dell'equivalente chitarristico di un mantra, Paul approfitta subito della possibilità di trattare la chitarra come una piccola orchestra, con una chiara ripartizione dei ruoli tra corde basse e acute. Una cosa di cui probabilmente nessuno si sarebbe accorto se Paul non ce l'avesse raccontato è che Blackbird trae ispirazione nientemeno che da da una breve frase della Bourrée in Mi- di Johann Sebastian Bach che John e Paul suonavano alle feste per dimostrare "che non eravamo stupidi come sembravamo". Ma siccome non erano nemmeno così brillanti, la loro Bourrée abortiva spontaneamente dopo otto battute (qualche anno più tardi una versione più completa sarebbe diventata un cavallo da battaglia dei Jethro Tull in concerto).
Quando a Rikikesh Paul scopre le potenzialità polifoniche della chitarra, l'indice della mano sinistra corre istintivamente sui tasti di quella bourée. Ricordiamo che il fingerpicking, che nel giro di pochi anni diventerà un luogo comune della cultura giovanile, nel 1968 era qualcosa di pionieristico che Donovan raccontava di aver appreso in Europa mentre viaggiava in una carovana di gitani. Comporre un brano in questo stile significa letteralmente brevettare diteggiature e accordi che nessuno ha ancora sentito: per qualche anno il segreto di come si suona Blackbird sarà gelosamente custodito e passerà solo da bocca di hippy a orecchio di hippy. Blackbird può approfittare di quell'estetica del non finito che trionfa nel Disco Bianco: qualche anno prima lo stesso Paul avrebbe sentito l'esigenza di annegarla nei violini, com'era successo a Yesterday. Nel 1968 i tempi sono maturi perché sul disco della band più famosa del mondo compaia un breve brano acustico col rumore del battito del piede in sottofondo. Quasi un invito ai chitarristi di tutto il mondo a cimentarcisi: prendete quelle ali spezzate, anzi quelle dita, e spiccate il volo. A parte il merlo ridondante in sottofondo, la stiamo ascoltando come l'ascoltarono le Apple Scruffs, le ragazze che si appostavano tutta la notte davanti all'appartamento di Paul, a cui una sera la suonò dal balcone, come una serenata al contrario (forse anche un invito a farsi una vita).
(Anche stavolta Paul non si risparmia un paio di incongruenze: come si fa a imparare a volare con "ali spezzate"? Come si fa a volare "nella luce di una notte buia e oscura"?).
 |
| Diana Ross e Brian Jones nel 1968. |
Non sembra una coincidenza il fatto che Blackbird appartenga a quel gruppetto di canzoni che cronologicamente Paul non poteva aver dichiarato a Jane Asher, ma che nemmeno poteva attribuire alla sua storia d'amore con Linda Eastmann. In quel periodo aveva una relazione un po' meno impegnativa con l'aspirante scrittrice Francie Schwartz. Francie era presente in Abbey Road durante le sessioni di alcuni brani del Disco Bianco, tra cui Blackbird, ma non sarebbe rimasta a lungo sullo stesso ramo di Paul. Ufficialmente non ci sono canzoni che parlano di lei. Blackbird dopotutto non deve parlare di nessuno in particolare: è una canzone che cattura semplicemente l'emozione di chi sta facendo qualcosa di fantastico per la prima volta. Cioè parla di sé stessa, e di quanto è fantastico riuscire a suonare per la prima volta Blackbird. Vola uccello nero, vola.
23. Come Together (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
 |
| Timothy Leary ma nel 1983, con la moglie e Susan Sarandon |
One and one and one is three. Uno dei tipici problemi della band che si stanno sciogliendo, è che i membri che scrivono le canzoni cominciano a mettere da parte le migliori. Dando un'occhiata ad Abbey Road e ai dischi solisti che uscirono pochissimi mesi dopo, appare abbastanza chiaro chi dei due soci stava già pensando a organizzarsi una carriera da solista e chi invece non si rassegnava. Lennon di lì a poco avrebbe buttato fuori Instant Kharma, Mother, Imagine, Working Class Hero, ma quando in estate i Quattro si ritrovarono in Abbey Road per assolvere i doveri contrattuali, sembrava aver meno musica da offrire di George Harrison. Giusto quel blues composto nei giorni di Twickenham, a cui avrebbe imposto una coda sinfonica che nelle sue intenzioni sarebbe diventata la marcia funebre del gruppo; un altro strano ghiribizzo beethoveniano, e qualche scarto del Disco Bianco. Tra gli altri c'era anche un brano alla Chuck Berry che aveva iniziato a comporre per Timothy Leary quando si era candidato alla carica di governatore della California contro un ex attore di serie B, Ronald Reagan; Leary si era fatto arrestare per possesso di marijuana prima che Lennon finisse il pezzo e così lo propose a Paul, con la preghiera di farlo suonare meno chuckberriano possibile: il tizio aveva la denuncia facile. Il brano prendeva il nome dallo slogan elettorale di Leary, “Come Together”: forse per un attimo l'idea di usarlo come tappabuchi nell'album del divorzio gli sembrò ironica: per completare il testo gli sarebbe stato sufficiente rispolverare un po' di quel surrealismo un tanto al chilo che non lo appassionava più come ai tempi di Lucy, ma di cui restava il maestro: et voilà, una canzone in un qualche modo ci sarebbe saltata fuori ed era tutto quello che serviva a Klein, un'altra manciata di canzoni per tranquillizzare azionisti e avvocati.
Invece saltò fuori un capolavoro.
I Beatles nel 1969 erano diventati Cinque. Già durante la lavorazione del Disco Bianco Harrison aveva capito che le sessioni diventavano più proficue se si invitava un quinto musicista. In certi casi era l'unico modo per smettere di trattarsi da vecchi amici scazzati e cominciare a trattarsi da professionisti. Purché fosse un musicista valido – qualcuno davanti al quale avrebbero avuto pudore di sbagliare – e anche una vecchia conoscenza, come Eric Clapton, o Billy Preston. Get Back, il primo singolo del 1969 era attribuito a "The Beatles With Billy Preston": un modo di valorizzare un musicista della scuderia Apple, ma anche l'ammissione che Preston non era il solito turnista di lusso invitato a dare un sapore particolare a una sola canzone: al di là di alcuni assoli effettivamente strepitosi, il suo organo Vox cambia davvero il suono dei Beatles. Ha un timbro inconfondibile che ci rimanda immediatamente a quegli anni a cavallo tra '60 e '70; uno tocco che trasuda professionalità americana e quindi crea uno scarto percepibile con lo stile più emotivo degli altri Quattro. Ciononostante, a un certo punto Lennon buttò lì l'ipotesi di far entrare Preston nel gruppo. Chi lo diceva, in fondo, che i Beatles dovessero restare sempre gli stessi quattro inglesi fino alla fine? Magari avrebbero potuto diventare qualcosa di diverso, un collettivo organico che si modifica, adattandosi ai tempi, alle sfide. Lennon diceva tutto quello che pensava e a volte anche cose che non pensava davvero (una volta che Harrison aveva sbattuto la porta aveva buttato lì di sostituirlo con Clapton). Ma se per un un attimo l'idea di un gruppo da Cinque lo poté solleticare, probabilmente fu davanti al risultato di Come Together. Una canzone che aveva scritto quasi per sbaglio, chiedendo esplicitamente ai colleghi di stravolgerla: un blues virato in minore, che all'improvviso prende vita. Secondo George Martin la molla che fece scattare il meccanismo fu il riverbero di un battito di mani di John vicino al microfono, che combinato con una nota insistita del basso di Paul creava un senso di mistero, accresciuto da quella sibilata palatale un po' inquietante, "shoot me!"
Dopodiché entra Ringo, con una delle sue più folli idee batteristiche: quattro tocchi al charleston e dieci ai tom. In qualsiasi altro gruppo, un qualsiasi altro batterista non avrebbe avuto nemmeno il coraggio di proporre qualcosa che anche a cinquant'anni di distanza suona così grottesco: ma erano i Beatles, potevano fare tutto. Durante le sessioni di Abbey Road, Come Together diventa quel blues drammatico e sospeso che avrebbe potuto essere Helter Skelter, prima che Paul decidesse di trasformarlo in un monumento al frastuono. Quel titolo che era rimasto attaccato per caso fu di ottimo auspicio: Come Together è il risultato più alto dei Beatles nella formazione a Cinque. Fanno tutti qualcosa di indispensabile: Lennon canta i suoi nonsense come fossero profezie della fine, Paul lo appoggia alla voce ma il suo basso è il collante di tutto il brano; Ringo ci mette la fantasia; George capisce al volo che il brano ha bisogno di un assolo lento, ipnotico; l'organo di Preston aggiunge un'arcana profondità. Come Together era la risposta del Dio della musica alla domanda di Lennon: che senso ha restare assieme? ecco che senso ha, imbecille. In questo studio persino la tua spazzatura diventa oro: potrebbe essere l'unico luogo dell'universo dove 1+1+1+1+1= infinito, e tu vuoi rinunciare a tutto questo? Questi stivali da tricheco, sai dove dovrei piazzarteli?
Sparami.
22. All You Need Is Love (singolo del 1967 per la trasmissione in mondovisione Our World; poi nell'edizione Capitol di Magical Mystery Tour).
Non c'è nulla che puoi fare che non possa essere fatto. Non si vive di soli Beatles, per esempio gli inglesi nel 1967 andavano anche pazzi per un personaggio tv, una spia impersonata dall'attore Patrick McGoohan. Dopo un inizio abbastanza convenzionale, verso il 1967 il personaggio sembrava andato fuori di testa (un po' come i Beatles) e la sua serie era diventata l'esperienza più psichedelica che i telespettatori potessero fare da sobri (oltre ad ascoltare i Beatles). Ora la serie si chiamava The Prisoner e mescolava in libertà Orwell, Huxley, James Bond e la Nouvelle Vague, in un calderone paranoico non sempre comprensibile ma che lasciava il segno. L'ultima puntata era attesa nel febbraio 1968. È la puntata in cui McGoohan, detto Numero 6, dopo avere sconfitto tutti i Numero 2 che lo tenevano recluso in una strana isola-campo-di-rieducazione, chiede e ottiene di incontrare il Numero 1, il personaggio misterioso che manovra tutti i fili della trama e che nessuno ha mai visto in volto. Tutto questo lo sto raccontando perché The Prisoner continuò a essere programmato a lungo in Italia, persino sui canali locali, e l'ultimo episodio è il primo ricordo che ho di All You Need Is Love. Per me, prima di essere un inno alla pace e all'amore, era il brano sparato all'unisono da cinque jukebox nella galleria che conduceva Numero 6 al rifugio di Numero 1. Probabilmente non capivo le parole, e comunque le avrei trovate molto ironiche, perché l'unico vero tema di tutte le 17 puntate di The Prisoner è il Lavaggio del Cervello, e All You Need Is Love è in effetti la classica cosa che un pool di psico-spie potrebbe cantarti mentre ti lobotomizzano. Più tardi si risente durante una sparatoria.
Una canzone originale dei Beatles in una fiction è un caso molto raro: anche nei pochi casi in cui succedeva, le canzoni venivano poi eliminate dalla versione home video. L'ultima puntata di The Prisoner è l'eccezione, probabilmente perché (secondo la testimonianza del figlio di George Harrison) il programma piaceva tantissimo a uno o più Beatles: al punto che tra i progetti cinematografici ipotizzati dopo Help! era stata sul tavolo anche l'ipotesi di fare una cosa in stile Prisoner. Difficilmente sarebbe venuta peggio di quel che poi fu realizzato davvero, ovvero The Magical Mystery Tour. Ma diciamo la verità: difficilmente sarebbe venuta peggio dell'ultima puntata di The Prisoner, una pagliacciata così avvilente, un tentativo così fallito di nascondere la mancanza di idee sotto un tappeto di ambiguità metafisiche, che al confronto l'ultima puntata di Lost è un capolavoro. Perché vi sto parlando di questo?
Perché l'imprinting è importante e nella canzone che per tutti più rappresenta la filosofia dell'amore universale, io ho sempre voluto cercare un fondo di ironia e paranoia. E retrospettivamente, devo ammettere, ho maturato su All You Need Is Love gli stessi dubbi che mi sono venuti rivedendo l'ultima puntata del Prigioniero: punto supremo di una coraggiosa visione artistica e filosofica, o canzone realizzata in fretta e furia nascondendo sotto un tappeto di aforismi enigmatici una certa mancanza di idee? Bisogna dire che All You Need Is Love è invecchiata molto meglio di The Prisoner, ma questo è il minimo: tutta la musica del 1967 è ancora ascoltabile, quasi tutta la tv di allora non è più guardabile. Sia McGoohan che i Beatles avevano oggettivamente poco tempo a disposizione: McGoohan per risolvere i misteri che avevano incollato milioni di spettatori al tubo catodico, Lennon e McCartney per produrre qualcosa all'altezza del loro nome per il primo programma in mondovisione, che sarebbe andato in onda in diretta il 25 giugno 1967. Ogni nazione portava in vetrina qualcosa di nuovo, e di potenzialmente interessante anche per gli stranieri: l'Italia portò le telecamere sul set di Romeo e Giulietta di Zeffirelli; il Regno Unito propose i Beatles.
Costoro potevano contare (a differenza di McGoohan) di un collaboratore che non li tradiva mai e che dimostrò nell'occasione una versatilità straordinaria. Lennon aveva per l'occasione una canzone dal testo più che appropriato: semplice, universale, un po' enigmatico ma è meglio un buon enigma di una pessima spiegazione. Il guaio è che lo aveva scritto su un tempo sghembo impossibile, una specie di sette quarti, una battuta rock e una valzer: e pretendeva che un'orchestra lo seguisse, su un tempo zoppo del genere, in Mondovisione. Qualcun altro lo avrebbe mandato a quel paese; George Martin ci rifletté sopra: il tema iniziale gli ricordava la Marsigliese. Perché non mettere proprio la Marsigliese? Non bisognava pagare i diritti a nessuno, dopotutto, e ai telespettatori francesi magari avrebbe fatto piacere. E già che ci siamo, perché non infilarci un concerto brandeburghese? E In The Mood?
Nel 1967 George Martin coglie subito il punto: i Beatles stavano diventando un feticcio culturale. La mondovisione sarebbe stata la consacrazione: i Beatles come Zeffirelli, come l'opera, la selezione del Reader's Digest. All You Need Is Love si candidava a diventare un inno generazionale ma la tv l'avrebbe portata ancora più in là nell'empireo della cultura middlebrow. Una simile occasione meritava pompa e circostanza. Le citazioni di All You Need non sono ironiche, sono necessarie come i volumi in pelle che si sfoggiano sulla libreria di un salotto rispettabile, altro che paperback da mezza sterlina. Una rivendicazione in diretta tv: siamo i Beatles, la Marsigliese del Novecento la stiamo componendo noi, qui, in diretta, con i nostri amici. Al centro di tutto questo monumento che si stanno scolpendo addosso, i Quattro cercano se possibile di restare seri. Non ce la fanno del tutto. Paul si mette a incitare il pubblico come l'artista circense che forse preferirebbe essere. Alla fine qualcuno (non si è mai capito chi) si mette a cantare “Yeah Yeah Yeah She Loves You” sulle auguste rovine di In the Mood: ha perfettamente senso (e anche In the Mood era diventato un feticcio da pochissimo: la generazione precedente lo considerava un semplice brano ballabile). Eppure, quello “Yeah Yeah Yeah” sembra la scritta lasciata da un teppistello su un monumento.
21. I Am the Walrus (Lennon-McCartney, lato B di Hello Goodbye e Magical Mystery Tour, 1967).
 LENNON: Io sono l'uomo uovo.
LENNON: Io sono l'uomo uovo.GLOUCESTER: Dite, mio buon signore, chi siete?
LENNON: Essi sono l'uomo uovo
EDGAR: Un pover’uomo domato dai colpi della Fortuna,
LENNON: Io sono il Tricheco...
Vale ancor più per I Am the Walrus lo stesso dubbio confessato per All You Need Is Love: geniale capolavoro o sublime presa in giro? E come nel caso di All You Need, non è che si debba per forza scegliere. I Am the Walrus potrebbe anche essere entrambe le cose. Ogni brano ha la sua leggenda, ma all'altezza di Walrus Lennon ne era consapevole e si divertiva manifestamente a confondere le acque. Ogni glossatore di Walrus si sente il dovere di elencare tutti i riferimenti già acquisiti: il tricheco è un famoso personaggio della solita Alice, un libro da John più citato che letto visto che si sarebbe accorto solo in seguito che si trattava di un bieco sfruttatore; "crema di materia gialla che cola dal cane morto" è il residuo di una filastrocca da cortile rammentata a John dall'ex compagno di giochi Pete Shotton; "Semolina Pilchard" sarebbe un riferimento al sergente di Scotland Yard Norman Pilcher, che lottava contro la droga indagando i VIP e aveva appena tentato di incastrare i Rolling Stones; i pinguini elementari che cantano Hare Krishna sarebbero un riferimento ad Allen Ginsberg o a i poser che credono che basti inneggiare a Krisha per salvare il mondo: nessuno però ha mai fornito un movente per il loro prendere a calci Edgar A. Poe. Tutto chiaro adesso? Rimane il dubbio: ha senso davvero occuparsi di tutto questo, ha senso discutere delle esperienze sessuali di Eric "egg-man" Burton con una ragazza caraibica e un uovo crudo, o chiarire l'identità della pornosacerdotessa che fa cascare le mutande a un ragazzo che sta facendo la birichina ("naughty girl")? Non stiamo semplicemente cascando a piedi pari nella trappola che Lennon ha allestito nel 1967, dopo avere scoperto che nelle scuole di Liverpool agli studenti venivano richieste interpretazioni dei suoi brani? Non è sufficiente derubricare il tutto a sberleffo nei confronti di chi insiste a farne un feticcio? Quattro anni prima era stato un critico musicale che si era ingegnato a trovare una "cadenza eolia" in una sua canzoncina per teenager; ora c'è già qualcuno che vuole mettere Strawberry Fields e Lucy in the Sky nelle antologie scolastiche, Lennon non ci sta.
Alla fine del 1967 I Am the Walrus richiama sin dalle prime note di mellotron il singolo uscito appena in febbraio, Strawberry Fields. In mezzo c'è stato uno degli anni più importanti della storia del costume e del rock; i Beatles hanno partecipato con un disco "en travesti" sospeso tra avanguardia e nostalgia che è andato bene ogni oltre più rosea aspettativa. È un anno che Lennon ha trascorso consumando LSD con una certa continuità, ma il brano che sembra voler riprendere Strawberry da dove si era fermata ci fa anche apprezzare la differenza. La sintassi franta e caotica di Strawberry, che sembrava davvero scritta in trance, lascia il passo a un nonsense compiaciuto che si ricollega al surrealismo giocoso degli scritti giovanili. È un Lennon che sta già cominciando a farsi il verso, e lo sa, e se ne diverte; i due brani di quel singolo di Natale sono forse l'espressione più pura di quella concezione di musica come gioco. L'orchestra di Martin, la radio che trasmette Shakespeare, il surrealismo, Alice: è tutto un giocattolo. Lennon si fa un punto di onore di usare tutti gli accordi della scala, che in inglese hanno le sette lettere dell'alfabeto: ABCDEFG, come un bambino che voglia usare tutti i tasti del suo strumento in miniatura. In particolare la cadenza del ritornello è bizzarra ma puerile: I-II-III.
Credo che chi ama I Am the Walrus ne colga soprattutto questa dimensione giocosa. Malgrado John continui a insistere che "sta piangendo": ma per una volta ci riesce più facile fidarci del video (una sequenza del Magical Mystery Tour) in cui ghigna per tutto il tempo. È anche merito di due compari che reggono il gioco in modo impareggiabile. Uno è Ringo Starr, che si prende cura della canzone offrendole un groove imprevedibile; di tutti i capolavori psichedelici Walrus è l'unico che si potrebbe ballare. Ringo ci crede particolarmente e allo stesso tempo non ruba mai la scena, anche perché questo spetta all'altro compare, George Martin.
I Am the Walrus è una di quelle canzoni che nascono più da uno stimolo cerebrale che da un'intuizione emotiva: Lennon vuole mettere alla prova le nostre derive interpretative e nel farlo non si preoccupa più di tanto di annoiarci. Il fatto che non succeda lo abbiamo sempre preso come una dimostrazione delle sue trascendentali capacità compositive... ma provate ad ascoltare su Anthology la stessa canzone senza l'orchestra diretta da Martin. Non diventa subito molto meno interessante? Martin considerava I Am the Walrus il suo score migliore, e parliamo del signore che aveva composto gli spartiti per Yesterday e Eleanor Rigby. Martin è solitamente considerato soprattutto l'anima sinfonica dei Quattro, sempre tentato dall'aggiungere violini e clavicembali là dove a volte non ce ne sarebbe bisogno. Lui stesso dopo l'avventura coi Beatles ha preferito presentarsi al pubblico come un rispettabile maestro d'orchestra: ma prima di incontrare gli stessi Beatles il suo mestiere era anche reperire suoni buffi per gli album di varietà che erano il core business della Parlophone,o per i programmi radiofonici di Peter Sellers. C'è in Martin una dimensione farsesca e giocosa che gli permise di individuare la stessa componente nei Beatles, e farla risplendere al momento giusto: più spesso quando lavorava con John. Dopo l'happening di A Day in the Life, con gli orchestrali invitati a mettersi in maschera e a suonare la fine del mondo; dopo il pandemonio postmoderno di All You Need Is Love; stavolta Martin convoca un coro di professionisti e li costringe a fare le boccacce ("hoo hoo haa haa"); obbliga nel finale gli archi a scendere mentre i bassi salgono: sta giocando, anche lui.
L'orchestrazione di I Am the Walrus la solleva letteralmente da terra, lasciandola sospesa in una nuvola surreale in cui tutto diventa possibile – al punto che Lennon può accendere una radio nel bel mezzo del brano e captare una scena di Re Lear che miracolosamente si introduce tra i versi del ritornello creando un senso sinistro là dove un senso non c'era. La vostra poesia che comporrete pescando frasi ritagliate a caso da un cappello vi assomiglierà, scriveva Tszara. Ripensandoci, è quasi una maledizione.
Walrus è l'ultimo trionfo della collaborazione tra Lennon e Martin. La lavorazione del brano comincia appena nove giorni dopo la morte di Epstein; uscirà nel momento forse più alto della traiettoria artistica dei Beatles, il momento in cui dopo Sgt Pepper hanno convinto quasi tutti e sanno di potersi permettere quasi tutto: che è proprio quello che fanno in Hello Goodbye e Walrus. A scegliere la prima come lato A del singolo sarebbero stati McCartney e Martin, gettando in Lennon i semi di una frustrazione che l'avrebbe portato, più di un anno dopo, a chiedere il divorzio. È una ricostruzione che lascia perplessi: se Lennon avesse davvero voluto quel lato A, non avrebbe evocato quella "pornographic priestress" più che sufficiente a bandire il brano dalla programmazione radiofonica sia nel Regno Unito che negli USA. Certo col senno del poi Walrus è rimasta molto più che Hello Goodbye, ma nemmeno Lennon credo che potesse immaginarlo a fine '67. In quel momento aveva soprattutto voglia di giocare – il che comunque era un buon segno – e forse non pensava nemmeno che il gioco gli sarebbe riuscito così bene.
Le canzoni dei Beatles (#50-41)
15-07-2020, 11:29beatles, Il Post, musicaPermalinkPS: vi amo. No, in realtà volevo ricordare che la classifica non la faccio io: è una media di tutte le classifiche messe on line da critici specializzati. Sono loro che tifano John, io non c'entro...
50. If I Fell (Lennon-McCartney, A Hard Day's Night, 1964)
"Se mi innamorassi di te, mi prometteresti di essere fedele?" Certe canzoni parlano di sé stesse, al punto che potremmo chiamarle metacanzoni (ma forse è meglio di no). Per esempio If I Fell parla della necessità di fare le cose sul serio, ed è effettivamente la canzone più sofisticata che i Beatles avessero scritto fino a quel momento. Dunque, se da una parte c'è un'aspirante innamorata che deve capire che "l'amore è più che stringersi le mani", dall'altra ci siamo noi, che dobbiamo capire che John Lennon non è solo l'idolo delle teenager che ha appena sbancato le top10 di mezzo mondo con una canzoncina sullo stringersi le mani. John Lennon è un compositore coi controcazzi, altroché, senti che progressioni, senti che armonie. E sia noi sia la ragazzina in effetti restiamo impressionati da tanto sfoggio di argomenti, ma... non riusciamo a fidarci.
C'è qualcosa di troppo artefatto, costruito – sofisticato, appunto. Persino sul piano sintattico: già il verso introduttivo è un periodo ipotetico del secondo tipo, detto anche periodo della possibilità (ovvero sì, ci sono ancora effettive chance che io mi innamori di te). Da un punto di vista musicale, stiamo ascoltando una lunga introduzione lenta, uno stilema tipico degli standard confidenziali (ad esempio Night and Day). Così, sin dai primi istanti ("from the very start") sia la musica che la sintassi del testo ci hanno avvisato: questa non sarà la solita facile canzone d'amore in balera, qui le cose cominciano a farsi intricate. Se non proprio contorte. Eppure lo scambio proposto è lo stesso descritto basilarmente in Love Me Do: amore in cambio di fedeltà ("I'll always be true, so please love me do"). Ma ora è tutto ipotetico, come durante una contrattazione.
In inglese l'innamoramento si esprime con un verbo che implica una caduta: to fall in love (in italiano invece l'amore è qualcosa in cui si entra). Dunque innamorarsi in inglese è un lasciarsi cadere compromissorio. Lennon non può farlo senza precise garanzie. Non è proprio il modo più romantico di descrivere l'inizio di una relazione, ma Lennon aggiunge un ulteriore livello di sofisticazione: il motivo per cui non è così sicuro di lasciarsi cadere è che comunque ha già (avuto?) una partner, quindi si tratta di capire se un'eventuale seconda caduta possa comportare un'esperienza più appagante.
Ma più appagante in cosa? Non lo sapremo mai – anche e soprattutto in questo consiste l'ambiguità della canzone. Cosa significa "l'amore è più che stringersi le mani", cosa vogliono esattamente John e Paul quando chiedono di essere amati "di più": una più alta comunione delle anime? O una più lieta disposizione al sesso prematrimoniale? Non lo sapremo mai, ma su wikipedia qualcuno ha annotato che cantandola dal vivo avevano spesso difficoltà a trattenere le risate (anche la sequenza di A Hard Day's Night propone una lettura goliardica, con Ringo che diventa oggetto delle affettuose attenzioni di John). In cambio di questa non meglio precisata prova d'amore, la partner otterrà non solo le gioie dell'amore corrisposto, ma quelle più sofisticate che si ottengono soltanto quando si diventa oggetto d'invidia: "Spero che tu veda che mi piacerebbe amarti e che lei piangerà scoprendo che noi siamo in due, se m'innamorassi di te". Questa strofa finale merita uno schema, perché concentra in quattro versi una complessità sintattica che non credo di aver trovato in nessun'altra canzone pop: addirittura la frase "If I fell in love with you", quando torna alla fine (suggerendo l'idea della chiusura di un cerchio), è diventata una subordinata di quinto grado!
E va bene mr Lennon, abbiamo scoperto che lei non è solo uno scimunito che agita la frangetta sul palco in costume di scena. Lei è un musicista capace di comporre progressioni armoniche originalissime e un cantante in grado di seguire melodie complesse; inoltre è un seduttore/manipolatore, ben disposto a innamorarsi ma solo dietro precise garanzie, espresse con una retorica fin troppo forbita e intricata, che forse esprime anche un certo disagio, l'imbarazzo dei negoziatori. Beh, se le cose stanno così, forse è meglio che ti rimetti il costume, John, e che ricominci a raccontarci qualche amorazzo da balera...
49. All My Loving (Lennon-McCartney, With the Beatles, 1963).
Chiudi gli occhi e ti darò un bacio. A chi vi dice che John Lennon era un chitarrista scarso, chiedete di suonare la chitarra ritmica di All My Loving. Quattro terzine a battuta, si era mai sentita una cosa del genere? Si è mai sentita in seguito? Forse aveva in mente il banjo di sua madre, anche se alle nostre orecchie mediterranee può ricordare più facilmente un mandolino. Rimane il tratto distintivo di All My Loving, ulteriormente impreziosita dalla linea di walking bass di Paul e dai gorgheggi di quest'ultimo, armonizzati con parsimonia. All My Loving potrebbe essere il primo vero caso in cui i Quattro hanno cercato di dimostrare che sotto i caschetti c'erano dei musicisti, anche se la loro idea di virtuosismo era sensibilmente diversa dalla nostra (e non fu ripresa dai gruppi coevi): vedi l'assolo countryeggiante di George, che invece di essere il vertice tecnico del brano è quasi un momento di riposo tra due strofe che sono una tempesta di accordi e una mitraglia di note di basso.
Non era affatto semplice da suonare All My Loving, e ce ne possiamo accorgere ascoltandola nella versione live all'Hollywood Bowl, con Ringo che parte un po' troppo veloce e John e Paul che con tutta la più buona volontà non riescono a stargli dietro. E possiamo notare due cose: la prima è che non erano effettivamente i bravi musicisti che avrebbero voluto essere. Il che avrebbe potuto consigliare loro più prudenza in sede di studio, e invece no, tutto il contrario: continueranno a suonare cose più difficili di loro e al limite smetteranno di suonarle dal vivo. La loro musica non smetterà mai di essere una sfida alle loro capacità di strumentisti, un modo per sorpassare i propri limiti. La seconda cosa è che all'Hollywood Bowl malgrado gli errori a catena la canzone funziona lo stesso, come se tutta l'intelaiatura meticolosamente costruita in sala prove alla fine non fosse che un dettaglio: la vera energia della canzone pulsa più in profondità. Per quante volte abbiamo biasimato le ragazzine che ebbero il privilegio di ascoltare i Quattro dal vivo e l'hanno sprecato a urlare tutto il tempo sovrastando gli amplificatori, vale la pena di farsi venire il dubbio: forse era l'unico modo di vivere davvero l'evento, spogliando le canzoni dalla prestazione occasionale dei Quattro, coprendo i suoni imperfetti con un rumore bianco oltre il quale resiste poco più del ricordo della canzone che ci siamo già ascoltati centinaia di volte su giradischi di casa. Proprio come chiudere gli occhi e fingere di baciare quelle labbra (invece di quelle di chiunque altro).
48. Don't Let Me Down (Lennon-McCartney, lato B di Get Back!, 1969; inserita in Let It Be Naked).
Un giorno finalmente qualcuno chiese ad Arthur Janov, lo psicoterapeuta che ideò la terapia primaria: quanto c'è di vero nella scenetta tipica delle biografie di John Lennon? Cioè davvero lui si metteva in un angolo a urlare e lei lo stuzzicava a rovistare nel profondo dei suoi traumi infantili? Lui rispose: "Nonsense. Non facevamo nulla del genere". È che ai biografi piace romanzare, senz'altro, e il fatto che il bestseller di Janov si chiamasse L'urlo primordiale è una circostanza troppo ghiotta. Ma Lennon aveva già iniziato a emettere urla primordiali molto prima di conoscere Janov. Anzi è probabile che tra tanti terapeuti scelse Janov, malgrado non fosse proprio il più comodo (esercitava in un altro continente) proprio perché questa idea dell'urlo risuonava con quello che aveva già sperimentato cantando "yes I'm lonely, wanna die", o "I want you so bad it's driving me mad", e soprattutto "don't let me down", questo piccolo enorme verso intraducibile in italiano.
Non è che John stia semplicemente supplicando di non essere deluso: John vuole essere sorretto. Ne va della sua vita. Il primo "don't let me down" è una supplica, che lo sospende sull'orlo di un Fa#minore; il secondo è già una risposta, che lo riaccoglie nell'abbraccio di un confortevole Mi. Lennon era già in una fase di autoterapia: tutti e Quattro in un certo senso lo erano. Negli studi di Twickenham nel gennaio del 1969 stavano cercando di ritrovare un senso al loro stare insieme. Forse avevano aspettative troppo alte: suonare dal vivo, ma senza tradire gli standard che avevano raggiunto ad Abbey Road con le sovraincisioni. L'unico sistema era provare, provare e ancora provare. Si sarebbe rivelato ben presto un metodo troppo sfibrante per i Quattro, eppure i due brani che furono stampati in aprile su un 45 giri (Get Back! e Don't Let Me Down), sono di ottima fattura. Registrati a fine gennaio dopo che il gruppo era tornato agli studi della Apple, con l'apporto non secondario di Billy Preston, non assomigliano già più ai brani del Disco Bianco che era uscito da pochi mesi (a uccidere i Beatles fu anche questa terribile fretta). Sono brani apparentemente semplici, ma realizzati in un modo unico, da cinque musicisti che li hanno suonati e risuonati fino a dare uno stile personale a ogni nota. L'amore per gli arrangiamenti sovraincisi è stato sostituito da un gusto per la prestazione: anche se non c'è il pubblico ti sorprendi a pensare "speriamo che ce la facciano stavolta". In effetti qualche errorino verso la fine c'è, ma sono pur sempre i Beatles, e non era così facile suonare i Beatles, per i Beatles. Ho sempre trovato straordinario quel contrappunto scandito nel bridge centrale all'unicono dal basso di George e dalla chitarra di Paul, mentre John canta che è innamorato per la prima volta ("non capisci? Durerà! È un amore senza fine, un amore senza età"). Sembra di sentire una sezione di fiati. Non c'è, ma se ci fosse suonerebbe esattamente le note di George e Paul. Sembra una scelta talmente ovvia: un po' di Esercito della Salvezza a fare il verso a John che ha quasi trent'anni e insiste nel ruolo di orfano.
A Don't Let Me Down capita quello che succedeva ad altre canzoni dei primi Beatles dopo un po' che le suonavano: una specie di progressivo insorgere della parodia. Dovrebbe essere un grido d'amore assoluto, ma qua e là è lo stesso John a fomentare il sospetto che si stia facendo il verso da solo. Il vezzo melodrammatico di allungare di un quarto gratuito la prima battuta della strofa ("Nobody ever love me like she does", quell'"ever" è del tutto ridondante, come ogni avverbio) quando arriva alla strofa finale sembra autoparodico ("I guess nobody ever really done me"), addirittura due avverbi! Nel film sorridono tutti parecchio, tranne Ringo che è preoccupato di sbagliare le entrate. Paul accenna anche qualche posa in favore del cameraman; per lui più che un urlo primordiale è un ballabile lento.
Nessuno ha mai capito davvero perché Don't Let Me Down fu esclusa da Let It Be, il disco postumo che documentava quelle sessioni: tanto più che nel film omonimo la canzone viene eseguita sul tetto della Apple (in Let It Be Naked c'è una versione del concerto, ottenuta montando due take diverse). Non va presa necessariamente come una sconfessione del brano; magari aveva un senso commerciale. I Beatles avevano sempre evitato di far confluire tutto il materiale dei singoli negli album. E allo stesso tempo non si può ignorare come Don't Let Me Down sia una delle testimonianze più importanti e riuscite di quel particolare periodo della storia dei Beatles – uno dei pochi episodi che danno un senso a un'esperienza altrimenti fallimentare. Di lì a poco sarebbero tornati in uno studio coperto e si sarebbero rimessi a sovraincidere come se non ci fosse un domani (che in effetti non ci fu).
47. I Want You (She's So Heavy) (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
 |
| Was mache ich hier |
Se ammettiamo che I Want You (il blues) e She's So Heavy (Beethoven) siano due canzoni separate ma montate assieme, su Abbey Road di medley ce ne sarebbero due: quello lungo sul secondo lato che termina con La Fine, e quello breve lennoniano sul primo lato, che finisce con una lunga coda strumentale e un silenzio improvviso. Sappiamo che Lennon pensava ormai di divorziare dai tre colleghi. Sappiamo anche che avrebbe voluto invertire i lati del disco, ovvero farlo cominciare con Here Comes the Sun e chiuderlo nell'abrupto modo in cui finisce She's So Heavy, quello stacco netto che probabilmente portò qualche acquirente a riportare il disco in negozio come copia fallata. Alla fine vinse Paul, che aveva più voglia di preoccuparsi di dettagli come la scaletta del disco e il mix finale; ma soprattutto un'idea di finale molto più conciliante col pubblico: un bel carosello di chitarre, una bella frase proverbiale e cerimoniosa al punto giusto, magari ancora un ultimo scherzo per gli amici, e poi a casa: che non è mica finito il mondo, eh? Al limite saranno finiti i Beatles.
Invece per Lennon stava finendo proprio il mondo. Il confronto tra i finali dei due medley tradisce proprio questo enorme scarto esistenziale: è come se dai due lati del disco John dicesse a Paul: ma ancora ti preoccupi per i Beatles? Non capisci che sto morendo? Potrebbe essere domani come tra vent'anni, non lo sai che il tempo è un dettaglio, un'illusione? che tutto è già stato scritto, come un serpente di note che si mangia la coda, e inoltre sono passato all'eroina? E anche ammesso che sopravviva all'oppiaceo più forte sul mercato, cosa può esserci dopo di più potente, di più definitivo, di più pesante?
Il brano comincia, ironicamente, con un assaggio della coda finale, interrotto dopo dieci secondi dal riff di I Want You. Che sia un blues lo capiamo al primo ascolto, anche solo dal fatto che Lennon canti all'unisono con la chitarra, come aveva cominciato a fare durante le sessioni di Twickenham, e sembra non potersene stancare. Diventa ancora più chiaro dopo dieci battute, quando il riff viene ripetuto una quinta più in alto: è un blues lentissimo dunque, quasi fermo, ed è in minore: ma è un blues. Lennon desidera qualcosa, la desidera così forte che ne sta impazzendo, e questo è tutto. Non c'è neanche più spazio per il bestiario allegorico di Yer Blues, qui non ci sono più né immagini né metafore, la coscienza è ridotta a una voce che grida il suo desiderio nel deserto. Può essere il desiderio di una persona o di una sostanza, ma è un desiderio nudo, che non lascia scampo, al punto che non sembra più avere molta importanza se sarà alla fine soddisfatto o no: follia e morte seguiranno in ogni caso. Nei momenti in cui gli viene lasciato spazio il basso di Paul non sta fermo un attimo, un canarino in una gabbia pentatonica; alla fine di ogni strofa Billy Preston pesta l'organo come uno strumento a percussione: finché sulla soglia dei due minuti tutto tace all'improvviso per un istante brevissimo – neanche il tempo di inalare, e John sta già intonando "She's So..." Ed entra il Destino.
 |
| Lei è così pesa. |
È abbastanza ironico che la parte beethoveniana della canzone sia più semplice della parte blues: e allo stesso tempo è giusto così, Lennon non ricorre a Beethoven per mitigare un complesso di inferiorità musicale: Lennon cerca nel romanticismo qualcosa di molto più semplice e mortale. Il serpente di note che si mangia la coda è formato da una breve scala ascendente di quattro semiminime che appena sembrano essersi assestate su un plateau, cascano subito in basso con una terzina (dal sapore vagamente blues); cominciano ad annaspare con un'altra terzina e finalmente ritrovano la via per risalire verso l'alto: ma a questo punto siamo di nuovo sullo stesso plateau, stiamo di nuovo per ricadere con la stessa terzina, stiamo di nuovo annaspando: è un loop, non se ne esce, non se ne può più uscire. Dopo qualche ciclo non ricordiamo neanche più qual era l'inizio e quale la fine: è tutto perfettamente circolare e autoconseguente e noi ne siamo prigionieri. Ci alziamo, prendiamo fiato, ricadiamo, annaspiamo, ci rialziamo. Sarà sempre così: desiderio, parziale appagamento, delusione, angoscia, desiderio. Possiamo cambiare donna e cambiare sostanza, ma non possiamo cambiare il nostro destino: siamo nati desiderando e il Desiderio ci farà girare finché non sarà stanco di noi: finché senza preavviso non ci saremo più e non avremo nemmeno il tempo per accorgercene, sarà uno stacco netto, ecco, John Lennon la sua morte la immaginava così. Sì, lo so, voi volevate soltanto riascoltare una vecchia canzone, mi dispiace. Non succederà più, prometto. Non si poteva più fare niente dopo I Want You. John lo aveva fatto presente, ma Paul non capiva e poi vabbe', chissenefrega, divertitevi pure coi vostri dischi di canzoncine, mentre io muoio.
46. Drive My Car (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)
Ho detto a questa ragazza che avevo buone prospettive, lei mi ha risposto, seh vabbe' lo sappiamo. È tutto ok quando lavori per due noccioline, ma io ti farò vedere cos'è il successo. Baby, puoi guidarmi la macchina, lo sai che io sarò una star. Se vi chiedessero di spiegare l'ottimismo della Swinging London con una canzone sola, avreste qualche dubbio? Beep Beep, Beep Beep, Yeah! Philip Norman racconta come Paul in quel periodo andasse in giro travestito, baffi finti e cose del genere, giusto per il gusto di stare in mezzo alla gente. Dopo averlo letto diventa impossibile non immaginare che Drive My Car parli proprio di questo: Paul che si diverte ad attaccar bottone con una ragazza che ha Grandi Aspettative: lei sarà una star del grande schermo, tu nel frattempo puoi farle da chaffeur. Non c'è neanche bisogno di decifrare il doppio senso – che comunque c'è, autorizzato dallo stesso Paul ("Drive my car era un vecchio eufemismo blues per il sesso"). La ragazza ce la può fare, in fondo è sfrontata il giusto, probabilmente ha anche già riconosciuto chi è quel tizio con i baffi finti che può davvero guidarla al successo.
 |
| Da I Beatles in infografiche |
Con Drive My Car Paul sta giocando a nascondino col suo personaggio pubblico. La protagonista sta confessando i suoi sogni di gloria all'unico ventenne a Londra che non ne ha più, li ha realizzati tutti – cos'altro poteva chiedere alla fortuna Paul McCartney, nel 1965? Magari giusto una ragazza ingenua e intraprendente da rimorchiare al parco, un pomeriggio da persona normale a fare sogni a occhi aperti. Anche da un punto di vista musicale, Drive My Car rappresenta i Beatles formato rock al massimo della forma: sembra tutto semplice ma non c'è niente di banale. Paul, che per una volta ha una storia coerente da raccontare (con tanto di battuta finale!), opta per la più classica alternanza di strofa e ritornello. Per la strofa rispolvera il suo timbro littlerichardiano: una scelta singolare visto che sta dando la parola a una ragazza: ma serve a ribadirne la sfrontatezza: e soprattutto a marcare il contrasto col momento in cui da sfrontata si fa ammiccante, e le seconde voci si dispongono un accordo di settima minore ("but you can do something in between"). Il riff di chitarra raddoppiato dal basso è un'idea di George, un prestito riconosciuto da Respect di Otis Redding.
Drive My Car è in effetti uno dei rari casi in tutto il catalogo Beatles in cui una donna parla. Il caso è ancora più eccezionale dal momento che parla per tutto il ritornello, ed è suo lo stesso titolo della canzone: non succederà più, mi pare, fino a Let It Be. Molti titoli dei primi Beatles erano richieste d'amore da declinare in modo più o meno fisico: Love Me Do, Please Please Me, Hold Me Tight, I Want to Hold Your Hand, eccetera. Ma il più provocatorio di tutti Paul lo mette in bocca a questa ragazza che forse è meno ingenua di quanto appare: puoi guidarmi la macchina, baby. E forse ti amerò. Chi sta guidando davvero, dei due?
45. I Feel Fine (Lennon-McCartney, singolo, 1964)
I'm so glad that she's my little girl. Non solo i Beatles dei primi due anni cantavano esclusivamente canzoni d'amore, ma con qualche eccezione (cover, per lo più) si tratta di amore corrisposto. Io la amo, lei ti ama, tu mi fai piacere, io ti faccio piacere, stringiamoci le mani, abbracciamoci forte, adesso seriamente non è fantastico? Mettiamo che possiate scegliere di assumere una droga in questo istante: preferireste un oppiaceo, un vasodilatatore, un allucinogeno, o una sorsata della dopamina di quando eravate adolescenti e lei vi amava e voi l'amavate e quel giorno tutti hanno scoperto che stavate assieme? Purtroppo non è in commercio, mi dispiace (ma potete sempre ascoltare i Beatles).
L'effetto dopante è amplificato da una condizione che Lennon e McCartney avevano scoperto verso la fine del 1962, e che ne ha decretato il successo: gli osservatori esterni. Essi ci guardano (If I Fell), a volte ci aiutano (She Loves You), sempre ci invidiano. Non ci fossero loro che ci spìano non ci sarebbe neanche tutto questo gusto ad appartarsi. Questo può spiegare come mai il ritornello di I Feel Fine reciti: "I'm in love with her", che sintatticamente non ha molto senso, perché viene dopo una strofa ("Baby says she's fine, you know, she tells me all the time, you know") che termina con un "she said so", "lei ha detto così". A questo punto ci aspettiamo che il cantante riporti ancora un discorso diretto della partner, e invece dopo quel "she said so" Lennon parla in prima persona: "I'm in love with her and I feel fine". Ok, da un punto di vista sintattico "I'm in love with him" avrebbe avuto più senso, ma si può comprendere la ritrosia di Lennon a cantare un ritornello del genere in un singolo del 1964 (solo Ringo aveva la flemma per gridare "I'm talking 'bout boys now"!)
Un'altra possibilità era passare al discorso indiretto e cantare "She's in love with me and I feel fine": che è poi quello che fa Lennon a fine canzone. Ma all'inizio no, perché? Perché ha bisogno di un interlocutore. "I'm in love with her" aggiunge questo alla canzone: la presenza di un confidente, muto, che non deve far altro che ascoltare l'estasiata testimonianza di John: oh, sono così felice, lei dice a tutto il mondo che le compro un sacco di cose, sai, le compro gli anelli di diamanti, lei dice proprio così. Che senso ha avere una ragazza felice di stare con te se non lo stai raccontando a qualcuno?
I Feel Fine viene in soccorso del musicologo che ci tiene a dimostrare come l'evoluzione di Lennon/McCartney proceda in modo progressivo, senza salti bruschi o crisi significative: se la strofa è molto innovativa e anticipa gli sviluppi più rock del biennio '65-'66, il bridge è ancora saldamente ancorato in quella poetica yeh-yeh che aveva regalato ai Beatles quattro singoli al primo posto: I Feel Fine fu il quinto, il che sorprese positivamente lo stesso Lennon, che pensava di aver rischiato più del solito. Sua fu l'idea di cominciare il brano con un feedback, il 'fischio' di un amplificatore troppo vicino a un microfono, che oggi passa quasi inosservato ma ai tempi era una maleducazione inconcepibile in un prodotto inciso, al punto che George Martin dovette farlo passare per un errore. "Prima di Hendrix, prima degli Who, prima di chiunque. Il primo feedback su qualsiasi disco". È la prima incursione dei Beatles di studio nel mondo dei rumori, un'anticipazione delle follie di là da venire: ma è anche un ritorno alle radici grezze, al sound cacofonico del Cavern Club o di Amburgo; "Tutti giocavano col feedback nei concerti, e la roba alla Jimi Hendrix succedeva già da un pezzo. In effetti tutta quella roba punk di adesso è solamente quello che [ai nostri tempi] la gente faceva nei club". La novità più macroscopica resta il riff della strofa, suonato all'unisono dalle chitarre di George e di John (che non riusciva però a cantarci sopra). È un esercizio pentatonico ripetuto su tre accordi diversi: con ogni probabilità il riff più complesso che si poteva sentire in un pezzo rock alla radio nel 1964 – anche perché i rivali stavano piuttosto cercando di semplificare, il riff di You Really Got Me dei Kinks giocava su due note, quello di Satisfaction su tre o quattro, si era insomma aperta la caccia al riff più basilare e maestoso, da suonare magari roteando teatralmente il braccio destro come Pete Townshend. Invece a fine 1964 Lennon sembrava avere una fobia del vuoto: riempiva le battute di note proprio come la voce narrante riempiva la frase di intercalari (tutti quegli "you know", apparentemente inutili, ma che servono a ribadire la presenza di un testimone). In tutta quest'ansia di non lasciare spazio al silenzio, col senno del poi, possiamo leggere già quell'irrequietezza esistenziale che comincia ad affiorare nei solchi più interessanti di Beatles for Sale: ma dobbiamo proprio? Non possiamo semplicemente esser felici perché quei due stanno assieme e sono felici? Ne avremo, di tempo, per le canzoni tristi. I Feel Fine è la canzone più felice di John Lennon, ed è anche l'ultima sua che ascolteremo su un lato A di un 45 giri per più di due anni (se si eccettuano i 45 giri estratti dagli album). Non è una coincidenza.
44. Get Back (Lennon-McCartney, singolo, 1969; poi in Let It Be, 1970).
Retrospettivamente, Get Back non fu una grande idea. Non il brano in sé (che schizzò immediatamente al primo posto della top10 britannica e ci restò per sei settimane), ma proprio il titolo. I Beatles avevano sempre creduto nell'importanza di un buon titolo, Paul soprattutto ("se qualcuno ti chiede "Qual è la tua nuova canzone" e tu hai un titolo interessante, sei già a metà strada"). A Hard Day's Night era un titolo buffo e intrigante. Beatles For Sale era autoparodico. Help!, Rubber Soul, Revolver, Sgt Pepper's..., Magical Mystery Tour: tutti titoli che attirano l'attenzione, destano curiosità. Get Back spiegava quello che volevano fare i Quattro all'inizio del 1969, in modo semplice. Forse troppo semplice. Anche un po' brutale. "Torna indietro" non è mai un buon messaggio. Ti si ritorce contro.
Proprio nell'anno della contestazione, nell'ambiente rock tirava un'aria di ritorno all'ordine. Già nel 1968 i Rolling Stones dopo la sbornia psicadelica erano tornati al solido blues di Beggars Banquet. Bob Dylan già a fine 1967 aveva già sorpreso tutti con un breve disco enigmatico e spogliato all'osso, John Wesley Harding. Poi in estate era uscito il disco del gruppo che accompagnava Dylan, e che ora si faceva chiamare semplicemente Band, Music From the Big Pink, e aveva sorpreso pubblico e addetti ai lavori per quell'atmosfera di semplicità, di musica fatta in casa con amore e senza troppi fronzoli. Eric Clapton ascoltandolo aveva deciso di chiudere coi Cream. La "Big Pink" era la casa di Woodstock nella cui cantina Dylan e la Band si erano ritirati a suonare musica per il gusto di farlo. George Harrison era andato a trovarli a Woodstock e si era lasciato conquistare dall'atmosfera informale, dalla serenità che il gruppo sprigionava suonando per il gusto di suonare. Potevano i Beatles fare lo stesso? Ma senza smettere di essere i Beatles, cioè il gruppo da cui ci si aspettava un singolo di successo ogni quattro mesi, un album capolavoro entro l'estate? Ci potevano almeno provare.
 Quando in estate uscì il primo disco (abusivo) con le canzoni registrate da Dylan e dalla Band in cantina, tutti poterono misurare la somiglianza con Get Back, registrata in gennaio ma pubblicata in aprile: canzoni semplici, divertenti da suonare (in particolare si diverte Lennon con la chitarra solista), testi enigmatici ma spesso probabilmente inventati davanti al microfono. Get Back è un classico esempio di metacanzone: non dice soltanto "torna indietro" – anzi lo dice in modo abbastanza confuso – ma rappresenta un ritorno indietro, a un passato ormai mitico in cui i Quattro improvvisavano rock'n'roll su due accordi. Il brano piacque subito, anche perché paradossalmente proponeva un'idea di suono beatle già molto diversa da quella del Disco Bianco che era uscito pochi mesi prima: ancor più che la direzione, al pubblico interessava il movimento. Si sarebbe in seguito scoperto che "tornare indietro" per i Beatles era un'opzione ancora più faticosa di andare avanti. Per ottenere quel suono fatto in casa che suonasse naturale i Quattro dovettero riprovarla fino allo sfinimento di volte (oltre a farsi dare una mano da Billy Preston all'organo).
Quando in estate uscì il primo disco (abusivo) con le canzoni registrate da Dylan e dalla Band in cantina, tutti poterono misurare la somiglianza con Get Back, registrata in gennaio ma pubblicata in aprile: canzoni semplici, divertenti da suonare (in particolare si diverte Lennon con la chitarra solista), testi enigmatici ma spesso probabilmente inventati davanti al microfono. Get Back è un classico esempio di metacanzone: non dice soltanto "torna indietro" – anzi lo dice in modo abbastanza confuso – ma rappresenta un ritorno indietro, a un passato ormai mitico in cui i Quattro improvvisavano rock'n'roll su due accordi. Il brano piacque subito, anche perché paradossalmente proponeva un'idea di suono beatle già molto diversa da quella del Disco Bianco che era uscito pochi mesi prima: ancor più che la direzione, al pubblico interessava il movimento. Si sarebbe in seguito scoperto che "tornare indietro" per i Beatles era un'opzione ancora più faticosa di andare avanti. Per ottenere quel suono fatto in casa che suonasse naturale i Quattro dovettero riprovarla fino allo sfinimento di volte (oltre a farsi dare una mano da Billy Preston all'organo).Persino improvvisare quattro versi al microfono era meno semplice del previsto. Ogni parola era un'insidia. In una delle prime versioni c'era un'intera strofa dedicata agli immigrati, in particolare ai "pakistani" perché Paul aveva letto della loro drammatica condizione negli slums britannici e soprattutto gli piaceva il suono della parola. A quel punto il ritornello sarebbe diventato una satira del nazionalismo britannico ("Tornatevene da dove siete venuti"). Molto progressista per un gruppo che aveva sempre dribblato il coinvolgimento politico – e anche molto rischioso: l'ironia è un procedimento retorico che richiede la complicità del pubblico. Per ottenere questa complicità serve almeno un segnale (un occhiolino, un emoticon) che le radio di tutto il mondo non avrebbero potuto trasmettere. Quel Get back rischiava di suonare indistinguibile dagli slogan di cui si prendeva gioco e così i Quattro decisero, saggiamente, di toglierlo e rifugiarsi nel nonsense, nelle libere associazioni dell'inconscio. Ma l'inconscio è una brutta bestia, ne abbiamo già parlato.
"Credo che ci fosse qualche allusione a Yoko, sai Tornatene al luogo a cui appartenevi. Ogni volta che cantava quel verso in studio, dava un'occhiata a Yoko. Probabilmente dirà che sono un paranoico". Beh in effetti, sì, signor Lennon, la paranoia va messa in conto, specie quando si fa uso di stupefacenti. E allo stesso tempo, davvero, come si fa a escludere che Paul abbia guardato anche una volta sola Yoko Ono, mentre intonava Get Back? Giusto il tempo di uno sguardo importuno: vi è mai capitato di fissare la persona che non avreste dovuto fissare, nel momento meno indicato in assoluto? Potrebbe essere successo anche a Paul. Yoko veniva da New York, e prima ancora veniva dal Giappone; la canzone è proprio un invito a tornarsene a casa; un messaggio pericoloso. Mentre canto il ritornello forse è meglio evitare di guardare la straniera in faccia, a proposito, dov'è? Ops, troppo tardi, l'ho guardata. Vabbe', facciamo finta di niente.
Il solito problema delle parole delle canzoni. Meno senso hanno, più senso possono trattenere.
Paul s'inventa un personaggio, "Jojo", doppio già nel nome (Jojo non suona come Yoyo, ma neanche troppo diverso), che pensa di essere solitario ma sa che non può durare (chi era fino a pochi mesi prima lo scapolo d'oro dei Beatles?) Jojo decide di lasciare la sua casa che, di tutti i posti al mondo, è proprio a Tucson, in Arizona: un luogo proverbiale per tutti gli spettatori di film western, ma anche la città in cui aveva vissuto la famiglia di Linda Eastman. Jojo è "metà uomo, metà donna, molto ambiguo" spiega Paul nella sua autobiografia, e forse è un lapsus interessante, perché fino a quel momento era lecito pensare che fosse l'altro personaggio, "sweet Loretta Martin", a "credere di essere una donna mentre era un altro uomo". Loretta Martin ha le stesse iniziali di Linda McCartney. L'accusa di essere una donna-uomo veniva mossa talvolta alle spalle di Yoko Ono, non solo perché la sua femminilità non si inquadrava negli schemi di allora, ma per spiegare il fatto che dopo averla incontrata Lennon si fosse parzialmente femminilizzato. Insomma, Get Back nella sua versione finale non parla di nulla: ma se parlasse, forse avrebbe qualcosa da dire sulle rispettive partner degli autori. Vengono da lontano e stanno per lacerare definitivamente il gruppo. Non potrebbero tornarsene indietro, al luogo in cui appartengono? Non è che Paul volesse dire questo, anzi: Paul voleva dire tutto tranne questo. Ma sono proprio quelli i momenti in cui ti tradisci.
Col senno del poi, quel titolo era tremendo. Se è vero che azzeccando un buon titolo sei a metà strada, se lo sbagli non recuperi più. È facilissimo offendere qualcuno cantando Get Back. Ci sarà sempre qualcuno che si sente fuori posto e che si sentirà offeso. E siccome ci sentiamo tutti un po' fuori posto, e stiamo aspettando tutti un'occasione per offenderci...
43. We Can Work It Out (Lennon-McCartney, singolo, 1965).
Try to see it in my way... Potrebbe essere la canzone centrale di tutta la storia dei Beatles: il perno, il fulcro, il momento in cui Paul sorpassa John, l'inizio della fine, la fine dell'inizio. A decidere fu il pubblico, comunque. Lennon non credeva in We Can Work It Out; pensava che la sua Day Tripper avrebbe funzionato meglio come singolo, e riuscì a ottenere un compromesso: il 45 giri uscì senza stabilire una gerarchia tra "lato A" e "lato B", le due canzoni avevano pari importanza. Insomma tra il rock-blues di Day Tripper e l'esperimento pop-valzer di We Can Work It Out avrebbe scelto il pubblico, in particolare quello radiofonico. Il pubblico scelse We Can Work It Out.
Non era così scontato. Paradossalmente quello che faceva la differenza nel brano di Paul era il pezzo scritto da John: l'inserto vagamente melodrammatico, "Life is very short", che culminava con un inedito passaggio in tre quarti (soluzione suggerita da George Harrison): qualcosa che in radio non si era mai sentito e che, chi l'avrebbe detto mai, gli ascoltatori inglesi avevano voglia di sentire.
In sostanza John si era sconfitto da solo: il John più rock'n'rolleggiante era stato eclissato dal John sperimentale, quello più interessato ad assecondare l'eclettismo di Paul (anche solo per sabotarlo dall'interno). Se Day Tripper avesse vinto lo scontro, la storia dei Beatles sarebbe stata sensibilmente diversa. Se il grande pubblico avesse mostrato nel '65 di preferire un sano rock'n'roll, i Beatles non avrebbero perso troppo tempo a procurarglielo, concedendo meno spazio alle sperimentazioni e alle esplorazioni che alla lunga alienarono soprattutto Paul dal resto del gruppo. Può anche darsi che i Beatles sarebbero durati di più (e i Rolling Stones avrebbero avuto meno spazio). Ma nel '65 la gente preferiva ascoltare We Can Work It Out, un brano sghembo, non molto ballabile, neanche così cantabile, ma che doveva suonare come la promessa di cose favolose di là da venire. Una canzone che senza farlo apposta contiene la formula dei Beatles dal 1966 alla fine: il 60% è di Paul, che canta tutta la strofa e cerca di salvare un rapporto complicato con un atteggiamento paternalistico che può indisporre; il 35% è di John che canta tutto il bridge e la butta sull'esistenziale; il 5% è di George che suggerisce il breve passo di valzer. Possiamo tenere i piedi in tutte le staffe, canta Paul (ma la vita è troppo corta, obietta John). Possiamo spiegarci tra di noi, possiamo andare avanti, possiamo farcela. Ma il valzer non è d'accordo, e ha l'ultima parola.
42. With a Little Help From My Friends (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band).
Hai bisogno di qualcuno? Potrebbe essere chiunque? Sgt Pepper è uno spettacolo così variopinto che ci metti un po' a notare gli elementi che mancano. Anche quelli un tempo fondamentali. Uno è il rock'n'roll, annunciato con grandi fanfare nel primo minuto del disco, ma poi eclissato proprio dalle fanfare. Un altro è l'amore. Ce n'è proprio poco, anche volendo considerare l'attrazione nei confronti di Lovely Rita qualcosa di più di un'infatuazione. Considerato che fino a due anni prima Lennon e McCartney scrivevano esclusivamente d'amore, è un dato impressionante che l'unica vera canzone di amore corrisposto sia Getting Better, non a caso quella che suona più "vecchi Beatles". Anche With a Little Help indugia in un suono che rappresenta un passo indietro persino rispetto a Revolver, ed è a suo modo una canzone in cui dell'amore si sente la necessità, anche se non c'è più e va ritrovato (con un piccolo aiuto degli amici). E forse arriva nell'ultimo verso, molto ambiguo. ("Cosa hai visto quando si è spenta la luce? Non posso dirtelo, ma so che è mio": una di quelle strizzatine d'occhio di Paul che lasciano perplessi).
Che With a Little Help avesse le qualità per diventare un classico, l'avrebbe dimostrato di lì a poco Joe Cocker. In Sgt Pepper invece è quasi mortificata da un arrangiamento non semplice, ma semplicista, che si sforza di far passare un solido brano r'n'b per una canzoncina che un artista amatoriale potrebbe cantare su un gazebo, in un umido parco di una non meglio precisata località dell'Inghilterra settentrionale. Si chiama Billy Shears, veste un buffo costume fucsia, ma ovviamente è Ringo – alla fine forse l'idea di fare un disco come Sgt Pepper, un alternarsi di numeri di varietà, non è che l'estensione di quella pratica per cui, dal 1964 in poi, i brani cantati da Ringo erano concepiti sempre più come dei siparietti. Di tutti e Quattro, Ringo era la presenza più teatrale, non solo nei film: più personaggio che musicista (il musicista fa in tempo a regalare un breve intermezzo di tom-tom che cinquant'anni dopo strappa ancora l'applauso). La necessità di imbastire un pezzo 'facile' per le sue limitate capacità vocali viene qui portata al grottesco, e i Beatles forse per la prima volta intonano una parodia di loro stessi. With a Little Help è l'idea dei Beatles che hanno molti che credono di detestarli: una canzoncina semplice tutta coretti e sentimenti stereotipati, con un ritmo martellante che ne ingessa le potenzialità soul. Di fianco a loro, sulla copertina di Sgt Pepper, i Quattro avevano voluto i quattro manichini di cera che li ritraevano nel museo di Madame Tussaud; With a Little Help è l'equivalente musicale di quel contrasto fotografico: dopo la variopinta fanfara che dà il titolo al disco, ecco un brano che ci riporta al passato recente, quando eravamo quattro manichini produttori di canzoni d'amore in serie.
41. Taxman (Harrison, Revolver, 1966).
And you're working for no one but me. Taxman è la prima canzone dei Beatles a giocare con un riferimento pop (se davvero, come sembra difficile negare, George avesse in mente la sigla del telefilm di Batman che però nel Regno Unito non era ancora arrivato). È la prima canzone a nominare due uomini politici – primo ministro e capo dell'opposizione, mica fessi questi Beatles – e a contenere una rivendicazione politica, più rancorosa che documentata, ma comunque anni luce più concreta di qualsiasi cosa avessero cantato fino a quel momento: ehi, l'uomo delle tasse ci prende il 95% degli utili, non è un iperbole, è proprio così.
È la prima canzone in cui i soldi non sono un elemento retorico, una cosa che serve a comprare tutto ma-non-l'amore, ma una realtà fisica, misurabile e volatile: troppo volatile, povero George. È la prima canzone di Revolver, il disco che cambia davvero tutto proprio quando tutto sembrava già molto cambiato. È la prima canzone in cui George Harrison fa davvero la differenza, mostrando uno stile suo a cui i colleghi per la prima volta scelgono di adattarsi, al punto che la chitarra solista di Paul se ne va di sua spontanea iniziativa alla ricerca di una specie di raga indiano.
Taxman insomma è la prima canzone in tanti elenchi... tutti piuttosto brevi. I Beatles non abbonderanno mai coi riferimenti pop; non nomineranno più uomini politici, non aderiranno a nessuna piattaforma politica e non avanzeranno più nessuna rivendicazione fiscale. Lo stesso George, dopo l'exploit di Revolver (tre brani su quattordici, record assoluto), continuerà a faticare molto per imporre le sue canzoni. Taxman insomma contiene molte più possibilità di quelle che i Beatles decisero di praticare davvero.
In effetti è un brano che corre il rischio di risultare antipatico – non ci sono molti altri episodi della storia del rock in cui un milionario scelga di denunciare non i problemi del mondo, ma i propri problemi col fisco. A sua discolpa, George era molto più giovane e ingenuo di quanto credeva di essere, e la fiscalità britannica molto iniqua con questi quattro ex proletari rei di avere scavalcato un'intera rampa della scala sociale. Il modo migliore di apprezzare Taxman credo sia quello di fingersi un ascoltatore del 1966, privo di pregiudizio, e rimanere completamente allibito: cosa sta succedendo? Sembrano colpi di tosse, il disco è difettoso? Perché insistono a suonare un solo accordo solo? Ma è George che canta, sul serio? E la chitarra, mio dio, ma che sta succedendo? Sono davvero i Beatles questi? Roba da matti, non c'è più religione.
Le canzoni dei Beatles (#60-51)
07-07-2020, 09:54beatles, Il Post, musicaPermalinkLa playlist su Spotify.
50 anni fa... lo sapete benissimo cos'è successo. Invece 80 anni fa nasceva in un sobborgo difficile di Liverpool Richard Starkey, uno dei batteristi più importanti di sempre e un membro dei Beatles per otto anni. Insomma, Ringo è stato un Beatle per un decimo della sua vita; dopodiché ha avuto un altro mezzo secolo per gestire la cosa e non è sempre stato semplice. Comunque ce l'ha fatta, viva Ringo, viva i Beatles. Noi a che punto siamo? Ormai dovrebbero uscire solo canzoni famosissime, tranne...
60. She's Leaving Home (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967).
Paul McCartney non poteva ricordarselo, ma aveva già stretto la mano a Melanie Coe qualche anno prima di ispirarsi a lei per She's Leaving Home. A 14 anni Melanie aveva partecipato a una gara di imitazioni sul set televisivo di Ready Steady Go: Paul era il giudice e aveva indicato Melanie senza esitazione. Appena tre anni più tardi, la ragazza col massimo dei voti e una pelliccia nell'armadio della cameretta era scappata di casa senza neanche prendere la macchina che i genitori le avevano regalato. Del resto era il 1966, queste cose succedevano dappertutto. In California ormai gli scappati di casa erano legione, di lì a poco qualcuno avrebbe provato a organizzarli in qualcosa di più rivoluzionario, ad es. Charles Manson. She's Leaving Home arrivava insomma esattamente nel momento giusto: quello in cui le preadolescenti della Beatlemania cominciavano a lasciare i genitori. E allo stesso tempo She's Leaving è una mossa disorientante, perché invece di venire incontro a queste quasi-maggiorenni con un prodotto nuovo che assecondi la loro voglia di libertà, pretende di intrattenerli con musica da camera e un approccio deliberatamente crepuscolare. Se il personaggio sembra una Eleanor Rigby che può ancora salvarsi dal suo destino di solitudine e follia, la musica lascia meno spiragli. A tratti sembra che la canzone prenda le parti dei genitori, più che della figlia: ed è proprio in vece dei genitori che parla John Lennon, quel caporal Lennon spiazzante in occhialini e baffi e accenti paterni (o materni): "Le abbiamo dato tutto quello che i soldi potevano comprare!"
Se Sgt Pepper fosse davvero quel che all'inizio prometteva di essere – una riflessione sulla vita di provincia, She's Leaving Home ne rappresenterebbe il momento più inquietante: quello in cui il piccolo mondo della nostalgia comincia a chiudersi intorno alle sue vittime come una sfera di vetro. Povera Melanie, dove credi di andare? Ovunque andrai, arpe e violoncelli saranno lì ad aspettarti, non c'è scampo.I Beatles hanno sempre cercato di proporre cose nuove, e a tratti Sgt. Pepper sembra il momento in cui questa incessante sperimentazione prende loro la mano. Negli ultimi anni hanno sorvolato per gioco continenti nuovi, e adesso vorrebbero esplorarli con più attenzione di quanta l'ascoltatore possa concedere a un gruppo pop in un disco di mezz'ora. L'espediente di trasformare il disco in un carosello di numeri in costume è una mossa geniale ma quasi obbligata, visto l'eterogeneità del materiale. In due o tre casi si ha veramente la sensazione che alcuni universi musicali stiano risucchiando i loro fortuiti scopritori: è il caso di George Harrison, ormai travolto dalla musica indiana in Within You Without You – ma ancora più eclatante è la situazione di Paul con la musica da camera.
Neanche due anni prima George Martin aveva faticato non poco a convincerlo che fosse la soluzione migliore per Yesterday; poi nel giro di pochi mesi Paul aveva composto Eleanor Rigby e ora ormai considerava Martin il suo arrangiatore personale, l'intermediario tra la melodie che aveva in testa e lo spartito. Invece George Martin restava il produttore della Parlophone, con la sua agenda di impegni professionali, e il giorno in cui Paul telefonò perché aveva in testa la musica di She's Leaving Home, Martin aveva un disco più urgente da chiudere (una cosa di Cilla Black a quanto pare). Paul quindi si rivolse a un altro arrangiatore, Mike Leander, cosa di cui poi è stato da tutti rimproverato e in effetti nessuno osa preferire pubblicamente She's Leaving a Eleanor Rigby. A sua difesa, stiamo parlando di un compositore capace di macinare milioni di sterline con le idee che ha in testa, purché qualcuno si sbrigasse a fissarle su carta, visto che lui non ne era capace: She's Leaving poteva essere la nuova Yesterday, ma poteva anche dissolversi da un momento all'altro, la nostra testa ci fa questi scherzi. Anche quella di Paul.

I grandi poeti e i cattivi poeti hanno una caratteristica in comune, che rende difficile distinguerli al primo colpo: l'amore per l'ambiguità. I grandi poeti hanno troppo a cuore la loro poesia per sopportare che si prenda carico di un solo messaggio: deve rimanere aperta, ambigua, ispirare più interpretazioni. Anche i cattivi poeti sono ambigui, semplicemente perché non hanno nessun vero messaggio o comunque non capiscono bene come funziona questa cosa di veicolarlo. Tra i grandi poeti e i cattivi poeti ci sono poi quelli decenti, o se preferite mediocri: quelli che hanno un messaggio e ci tengono a farlo passare. Che tipo di poeta è Paul McCartney? Non saprei, ma sicuramente non è tra i mediocri. Prendi She's Leaving Home: da che parte sta Paul? È giusto scappare di casa, abbandonare chi ha sacrificato tutta la sua vita per te, dedicarsi alla ricerca della felicità, anzi del Divertimento? In teoria sì, basta svegliarsi alle cinque del mattino di un mercoledì e fare quel passo oltre in cancello di casa: la swinging London è là fuori. In teoria. In pratica tre giorni dopo Lei si sta già mettendo nei guai con un venditore di automobili ("man from the Motor Trade). Il riferimento, abbastanza ambiguo da far sospettare che Paul alludesse a un medico abortista, è semplicemente uno di quegli inserti realistici che Paul monta nei suoi versi senza darsi troppo la pena di spiegarli – come ritagli di giornali – e che col tempo si sovraccaricano di senso, perché davvero, tutto riusciamo a immaginarci tranne che le cose finiranno bene con quel "man from the Motor Trade". In seguito nella sua autobiografia Paul avrebbe confermato di aver voluto spargere dello squallore ("sleaziness") sulla coda della canzone: "era solo il tipico personaggio squallido, che avrebbe potuto rimorchiare una ragazzina dicendo: "vuoi un passaggio nella mia macchina, tesoro? Un bell'abitacolo vellutato, ecco come acchiappi le ragazze. Così, era solo un bel tocco di squallore" ("it was just a nice little bit of sleaze").
Questo spiega anche l'altro mistero che tormenta i commentatori di The Beatles Bible: perché Paul canta che l'unica cosa che il denaro non può comprare è il "Divertimento"? È così ineffabile il divertimento? Non era l'Amore la sostanza non misurabile in sterline? Sì, ma Paul l'amore non vuole proprio metterlo stavolta: lo ha sparso in centinaia di canzoni, su Desmond e su Molly, ma alla protagonista di She's Leaving Home il massimo che capita è di "divertirsi". È quasi un avvertimento a tutti i provinciali: potete abbandonare una casa, ma non la provincia. La provincia è dentro di voi: vi seguirà ovunque sarete. Nel mondo vero, Melanie Coe tornò a casa dopo una decina di giorni. Era scappata con il croupier di un casinò locale.
59. Hello Goodbye (Lennon-McCartney, singolo del 1967, poi nella versione USA di Magical Mystery Tour).
 Tu dici di sì, io dico di no. Ogni canzone ha la sua leggenda, questo ormai è chiaro ed è anche il motivo per cui ne stiamo discutendo qui. Ma quand'è che comincia a essere chiaro anche ai Beatles? Un termine importante è l'uscita di Sgt. Pepper, e la ridda di interpretazioni che scatenò. Nel frattempo i Quattro avevano ammesso l'uso di sostanze stupefacenti, e questo aveva scatenato un'ulteriore ondata di esegeti alla ricerca di riferimenti alle droghe. Dopo l'estate del 1967, Lennon e McCartney non potevano più non ignorare che ogni parola delle loro canzoni sarebbe stata sviscerata e interpretata in ogni modo possibile. Qualcun altro si sarebbe bloccato: loro pubblicarono il singolo Hello Goodbye / I Am the Walrus, in cui li osserviamo reagire al medesimo stimolo nei modi più diversi possibile. Per Lennon la deriva intepretativa si risolve con la parodia: Walrus è uno sberleffo a chiunque tenti di interpretarlo. La risposta di McCartney apparentemente è meno ardita: se qualsiasi parola può essere usata contro di me, allora userò le parole più semplici possibile: Hello, Goodbye, se riuscite a trovare droga satanismo e comunismo in Hello Goodbye il problema evidentemente è vostro. Ma questo è solo il livello più superficiale. Ce n'è un altro: in una situazione in cui ogni canzone ormai diventava uno o più racconti (pensate a Lucy in the Sky with Diamonds, che a seconda degli interpreti poteva essere sia l'acrostico di LSD sia il titolo di un disegno infantile), Hello Goodbye è la prima canzone intorno alla quale Paul cerca di costruire un mito d'autore: l'arcinoto episodio secondo il quale Hello Goodbye sarebbe nata all'armonium di casa, da una breve lezione di improvvisazione creativa impartita da McCartney ad Alistair Taylor – già assistente di Brian Epstein e più tardi general manager della Apple.
Tu dici di sì, io dico di no. Ogni canzone ha la sua leggenda, questo ormai è chiaro ed è anche il motivo per cui ne stiamo discutendo qui. Ma quand'è che comincia a essere chiaro anche ai Beatles? Un termine importante è l'uscita di Sgt. Pepper, e la ridda di interpretazioni che scatenò. Nel frattempo i Quattro avevano ammesso l'uso di sostanze stupefacenti, e questo aveva scatenato un'ulteriore ondata di esegeti alla ricerca di riferimenti alle droghe. Dopo l'estate del 1967, Lennon e McCartney non potevano più non ignorare che ogni parola delle loro canzoni sarebbe stata sviscerata e interpretata in ogni modo possibile. Qualcun altro si sarebbe bloccato: loro pubblicarono il singolo Hello Goodbye / I Am the Walrus, in cui li osserviamo reagire al medesimo stimolo nei modi più diversi possibile. Per Lennon la deriva intepretativa si risolve con la parodia: Walrus è uno sberleffo a chiunque tenti di interpretarlo. La risposta di McCartney apparentemente è meno ardita: se qualsiasi parola può essere usata contro di me, allora userò le parole più semplici possibile: Hello, Goodbye, se riuscite a trovare droga satanismo e comunismo in Hello Goodbye il problema evidentemente è vostro. Ma questo è solo il livello più superficiale. Ce n'è un altro: in una situazione in cui ogni canzone ormai diventava uno o più racconti (pensate a Lucy in the Sky with Diamonds, che a seconda degli interpreti poteva essere sia l'acrostico di LSD sia il titolo di un disegno infantile), Hello Goodbye è la prima canzone intorno alla quale Paul cerca di costruire un mito d'autore: l'arcinoto episodio secondo il quale Hello Goodbye sarebbe nata all'armonium di casa, da una breve lezione di improvvisazione creativa impartita da McCartney ad Alistair Taylor – già assistente di Brian Epstein e più tardi general manager della Apple.Paul lo avrebbe invitato a sedersi di fianco a lui davanti all'organo che teneva nel suo salotto in Cavendish Avenue – confessando inconsciamente la sua necessità di un partner, se non proprio di una specie di gemello cattivo: "Suona una nota e io ne suonerò un altra. E quando io canterò una parola, tu canterai il contrario e ci farò una melodia". Lo stesso Taylor non è mai riuscito del tutto a credere che Paul non avesse già pronta la canzone in testa. McCartney in effetti potrebbe anche aver scoperto la melodia e gli accordi di Hello in quel preciso momento, ma non è questo il punto. Il punto è che sentiva ormai la necessità di raccontarlo: se ogni canzone ha una sua leggenda, significa che prima di incontrare la sua leggenda la canzone è incompiuta: e a Paul non piaceva lasciare le canzoni incompiute. A partire da Hello Goodbye gli capiterà molto spesso di fornire a giornalisti e addetti stampa la corretta interpretazione delle sue canzoni, aggiungendo dettagli che in effetti senza di lui non avremmo mai scoperto: Helter Skelter era una sfida agli Who, Blackbird un omaggio alla lotta della comunità afroamericana per i diritti civili (ma sarà vero?), Let It Be un sogno della madre, eccetera eccetera.
Il fatto che Paul racconti storie non significa che dobbiamo credergli, o non battere altre piste. Per esempio: quattro mesi prima finalmente Lennon era riuscito a imporre una sua canzone sul lato A di un singolo, dopo tre anni di dominio quasi incontrastato di Paul. Si trattava però di un pezzo sui generis, scritto in fretta per la prima trasmissione in mondovisione, All You Need Is Love. Il brano proposto da Paul per la serata era Your Mother Should Know ed effettivamente non avrebbe funzionato altrettanto bene. Il brano di John era perfetto per la circostanza: ecumenico, universale, anche abbastanza facile da capire per i non anglofoni. Magari è solo una circostanza, ma il singolo successivo di Paul è un brano dal testo ancora più semplice, dal contenuto ancora più evanescente ma, a suo modo, altrettanto universale di All You Need.
Anche dal punto di vista musicale, Hello Goodbye mantiene un rapporto speculare con il suo lato B (più apprezzato dai critici, ma senz'altro meno radiofonico). Lennon con Walrus gioca con gli accordi: si ingegna a infilare tutte e sette le note; Paul con Hello mantiene una gabbia di accordi molto più semplice, ma poi si diverte a infiorettarla di soluzioni impreviste. Non tanto sullo spartito (dove comunque proprio dove ti aspetti un banalissimo I (I don't know why) – IV (You say goodbye) – V (I say hello) Paul ti coglie alle spalle sostituendo al IV una... III bemolle, un modo curioso di dirsi addio. Il vero campo di gioco di Hello Goodbye è la sala di registrazione, dove Paul si diverte a pasticciare con qualsiasi trucco, compreso l'eco sulla voce. "L'abbiamo PhilSpectorata!", avrebbe dichiarato in seguito. In seguito avremo tempo per stigmatizzare questa mania di trasformare le canzoni in un patchwork di effetti musicali: ma ascoltare Hello Goodbye è come vedere un bambino felice di aver capito come si usa un giocattolo, che gli vuoi dire a Paul? Che la vita è molto più complessa e drammatica? Se ne accorgerà da solo. Hello è forse l'ultimo momento veramente spensierato della storia dei Beatles, prima che qualcosa cominci a steccare: a partire dal flop televisivo del Magical Mystery Tour.
58. Eight Days a Week (Lennon-McCartney, Beatles For Sale, 1964).
 Uh, ho bisogno del tuo amore, baby... immagino che tu sappia che è vero. La sentite la stanchezza? È nei dettagli, quei pezzi di frase che si inseriscono meccanicamente per completare una canzone, ma non vogliono veramente dire nulla: lunghe zeppe come "guess you know it's true". Spero che tu abbia bisogno del mio amore, baby, proprio come io ho bisogno di te. Non ce la fanno più. Sempre le solite quattro sciocchezze da incidere su due album e quattro singoli all'anno, una trentina di pezzi possibilmente originali e devono tutti dire le stesse cose: Stringimi, amami, non ho altro che amore, baby... "otto giorni alla settimana".
Uh, ho bisogno del tuo amore, baby... immagino che tu sappia che è vero. La sentite la stanchezza? È nei dettagli, quei pezzi di frase che si inseriscono meccanicamente per completare una canzone, ma non vogliono veramente dire nulla: lunghe zeppe come "guess you know it's true". Spero che tu abbia bisogno del mio amore, baby, proprio come io ho bisogno di te. Non ce la fanno più. Sempre le solite quattro sciocchezze da incidere su due album e quattro singoli all'anno, una trentina di pezzi possibilmente originali e devono tutti dire le stesse cose: Stringimi, amami, non ho altro che amore, baby... "otto giorni alla settimana".Non avesse fatto la rockstar avrebbe avuto qualche potenzialità come pubblicitario, Paul McCartney: per sua ammissione, il titolo era già meta della canzone. "Eight Days a Week" la sentì dire da un tassista. Era perfetto: meno originale di "It's been a hard day's night", ma più diretta. L'idea era la stessa: catturare l'entusiasmo della beatlemania, la frenesia di chi sta cominciando ad arricchirsi e non ha più tempo per riposarsi. Ma ogni entusiasmo deve finire prima o poi, e verso la fine del 1964 i Quattro non ne potevano più. Non provavano nemmeno a fingere il contrario: persino la foto sull'album li mostra un po' provati, persino quel titolo (Beatles For Sale) lascia intendere che stiano speculando su sé stessi e ormai siano agli sgoccioli. Eight Days a Week è una canzone che non hanno mai amato. L'hanno scritta perché avevano bisogno di un pezzo radiofonico per lanciare il disco di Natale in Inghilterra (il quarto album in venti mesi), e un singolo per il mercato americano: ci hanno messo quasi tutte le cose che i fan si aspettavano da loro, i battimani e gli "hold me, love me" e tutto il frasario scemo basato sul concetto "uh ti amo e anche tu mi ami evviva". Ci hanno lavorato con coscienza, perché erano professionisti, e non hanno dimenticato di aggiungere almeno una novità: l'introduzione in fade in, la versione speculare del finale in dissolvenza: la canzone cresce dal silenzio. Insomma hanno fatto tutto quello che dovevano per rendere Eight Days a Week il successo che immancabilmente fu. Ma con la testa erano già altrove. Lo si sente già nel bridge, in quel gorgheggio inatteso (I lo-o-o-o-ove you), ancora abbastanza semplice ma che anticipa le soluzioni barocche che affioreranno nei mesi successivi.
(Ce l'abbiamo fatta, con Eight Days a Week abbiamo completamente coperto Beatles For Sale. È il primo disco che esce dalla gara: un album così sotto lo standard che non contiene nessuna canzone tra le prime cinquanta. Eppure in media è lievemente superiore a With the Beatles, che del resto ha in ballo ancora una sola canzone).
57 Hey Bulldog (Lennon-McCartney, Yellow Submarine, 1968).
C'è un certo tipo di solitudine la cui unità di misura sei tu. Questo, che è uno dei versi più folli e brillanti di tutto il sodalizio Lennon-McCartney, è il risultato di un equivoco: John aveva scritto "in news", non "in you", ma Paul non riusciva a leggere la calligrafia. È questo il vantaggio segreto del lavoro di squadra, quando c'è: la possibilità che abbiamo tutti di fraintenderci e così facendo scoprire qualcosa a cui nessuno dei singoli individui aveva pensato. Hey Bulldog la conoscono soltanto i veri beatlemani, molti dei quali a questo punto sono già sdegnati perché la vorrebbero almeno nella top20. In effetti è una canzone che conserva una freschezza impressionante, ed è lecito domandarsi quanto dipenda dal fatto che per molto tempo è rimasta nel limbo delle rarità – si fa per dire, Yellow Submarine non era certo un disco raro, ma è quel tipo di episodio su cui ti soffermi soltanto se ne hai veramente voglia. Hey Bulldog è invecchiata molto bene, come certi vini ben nascosti in cantina: oppure è stata l'idea di rimettere su Youtube il video in cui i Quattro la incidono. Per molti è stato come ascoltare, finalmente, un nuovo pezzo dei vecchi Beatles.
A differenza di tutti i video farlocchi che potete trovare su Youtube, fabbricati mettendo assieme immagini prese qua e là senza troppo senso, quello di Hey Bulldog è un atto doveroso di filologia audiovisiva, perché è ottenuto rimontando spezzoni del video di Lady Madonna. Quel giorno però John Lennon in particolare non aveva nessuna voglia di fingere di suonare Lady Madonna, che era già stata incisa qualche giorno prima, e quindi propose ai colleghi di lavorare a un'altra canzone, di cui aveva giusto il riff e qualche frase da bofonchiare al microfono. Può anche darsi che non immaginasse una canzone così allegra, ma l'allegria era necessaria, dal momento che mentre provavano Hey Bulldog, i Beatles stavano recitando di suonare Lady Madonna. Doveva chiamarsi Hey Bullfrog: poi Paul si mise ad abbaiare come ai vecchi tempi del Cavern e John non ebbe difficoltà a cambiare al volo in "bulldog". John nel video ha una conformazione pilifera unica, con due basette sul punto di diventare favoriti, e si diverte così tanto a suonare da metterci in confusione: di che anno è questo video? Sembra preso da una linea temporale alternativa dove i Beatles si pettinavano in un modo un po' diverso ma soprattutto hanno continuato a divertirsi a suonare assieme; senza sentire la pressione a cui era sottoposta la più grande band del mondo, senza prendersi per compositori; hanno continuato a pigliare riff semplici e frasi a caso e a confezionarci il pop-rock più divertente mai sentito al mondo, una lezione di leggerezza per tutto il multiverso.
Nel nostro mondo invece i Beatles stavano per partire per l'India, e fa abbastanza impressione pensare che quando sarebbero tornati ognuno si sarebbe messo a lavorare in uno studio separato: qui invece sembra che si divertano a suonare il riff all'unisono, col pianoforte e il basso e due chitarre (se Ringo potesse, suonerebbe lo stesso riff anche lui). Verso la fine si divertono a... divertirsi: al posto di un assolo strumentale, non c'è semplicemente Paul che abbaia e John che lo incita, ma tutta la scenetta di Paul e John che cercano un modo originale di chiudere la canzone e alla fine sono convinti di averlo trovato e sghignazzano dalla soddisfazione. Come quando alla fine di un film ti mostrano il backstage. Il ritornello inverte uno di quelli che stava ormai diventando un loro stilema riconoscibile (la scala cromatica discendente), e riprende da un altro loro esperimento semisconosciuto (You Know My Name) l'idea di ripetere la stessa frase-slogan accelerandola e rallentandola: un espediente che tradisce la strana concezione del tempo di Lennon e riecheggia la buffa metrica della strofa, dove a una frase di due sillabe lunghe ("Sheep/dog") ne segue una di cinque brevi che occupano lo stesso tempo ("stand/ing/ in/ the/ rain"). Un trucco abbastanza originale perfino per i Beatles, che contribuisce a questa sensazione di universo parallelo. Un posto dove, sembra di intuire, è andato tutto un po' meglio che nel nostro. You think you know me, but you haven't got a clue.

56. Back in the U.S.S.R. (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
Fammi sentire come fai squillare quella balalaika! Back in the USSR è un allegro pandemonio, anche se le premesse non erano poi così incoraggianti: Ringo a un certo punto non aveva più retto i 'consigli' di Paul su come suonarla e se n'era andato al mare; Paul era passato alla batteria e John al basso ma per ottenere un risultato accettabile si sovraincisero a vicenda così tante volte che nel risultato finale si dovrebbe sentire il contributo di tutti e tre sia al basso, sia alle percussioni, sia alla chitarra. Nel frattempo i carri armati sovietici raggiungevano Praga, ma i Tre erano probabilmente troppo occupati per accorgersene.
Scrivere sui Beatles è complicato: bisogna dribblare tutto quello che è già stato scritto: raccogliere uno spunto qua, interpretarne un altro là e sperare che non salti fuori qualcosa che qualcun altro ha già detto meglio. Scrivere sui Beatles è emozionante: hai la sensazione di partecipare a un grande dibattito che durerà ancora tantissimo tempo, perché se dopo cinquant'anni siamo ancora tutti abbastanza convinti che siano stati la band più importante del secolo, a questo punto ci sono buone speranze che tra un secolo i posteri ne stiano ancora parlando (come noi parliamo di Beethoven, di Dante), e insomma fa un certo effetto pensare che siamo in linea con loro: magari non leggeranno quello che scrivo io, ma continueranno a farsi le stesse domande, come ad esempio: che cos'è l'Unione Sovietica per i Beatles? Un mistero? Una parodia degli USA? Ma è possibile che i Beatles abbiano davvero vissuto al tempo della Guerra Fredda, possibile che lo spettro della mutua distruzione assicurata non abbia lasciato nei loro testi niente più che qualche vago richiamo all'Amore universale?
In effetti, considerato che la Beatlemania scoppia nell'anno del Dottor Stranamore, è impossibile non sospettare una rimozione. Senza scomodare Dylan, che cominciò a scrivere canzoni sui rifugi antiatomici – perfino Mick Jagger ha un catalogo più facile da associare a eventi storici (perlomeno se ascolti Sympathy for the Devil sai che sono morti già due Kennedy). I Beatles queste cose non le facevano: in un primo momento erano soltanto artigiani di canzoni d'amore; in un secondo momento forse perché era bastato concedersi una battuta su Gesù perché in America qualcuno decidesse di mettere al rogo i loro dischi, quindi meglio darsi al surrealismo o a un vago Amore che si potesse intendere nel modo più ecumenico possibile. L'unica canzone di tutto il catalogo in cui si menziona la seconda superpotenza mondiale è un esempio quasi plateale di rimozione: l'Unione Sovietica è solo uno specchio degli States, se solo potessimo andarci ci troveremmo come Alice dall'altra parte dello specchio. Anche loro avranno il rock and roll, da qualche parte ci sarà un posto dove Beach Boys surfano sulle rive del Baltico, le ragazze di Mosca saranno uno sballo come quelle di Amburgo, e c'è sempre una Georgia che mi resta in mente. Nulla di politico, insomma: solo un modo per cominciare il Disco Bianco nel modo più fracassone possibile: che si capisca sin dall'inizio che è una festa (e cosa c'è di più festaiolo dei cori alla fratelli Wilson) e che si indulgerà ancor più del solito nella figura della parodia.
I Beatles non lo sapevano, ma Back in the USSR alla fine sarebbe diventata la più politica delle loro canzoni, proprio in virtù di quel messaggio semplice e inoppugnabile: siamo tutti uguali. Non importano le ideologie e le lingue: siamo uguali nella voglia di tornare a casa che ci assale sull'aeroplano, nella nostalgia delle ragazze di casa e nella voglia di far casino fino all'alba. Forse è vera l'ipotesi di She's Leaving Home: i Beatles sono stati i profeti non già dell'amore, ma del "fun": la contagiosa allegria dei babyboomers occidentali spacciata come un dato naturale, un diritto fondamentale dell'uomo. Mentre la cultura pop continuava a descrivere i compagni come automi indottrinati, Paul semplicemente non riusciva a credere che non fossero dei simpatici compagnoni di bevute. Forse John esagerava a pensare che sarebbe rimasto famoso per più tempo di Cristo, ma in compenso Back in the USSR è durata più dell'Unione Sovietica vera; ci ha messo un po', ma alla fine è riuscito a suonarla nella Piazza Rossa (non è neanche stato il primo).
55. Girl (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)
Tetta, tetta, tetta. Dicevamo che con Michelle i Beatles stavano cercando consapevolmente di conquistare il mercato continentale europeo. In effetti la canzone uscì in singolo soltanto in alcuni Paesi europei (tra cui l'Italia): il lato B era Girl, con cui spesso viene paragonata, nel classico derby McCartney/Lennon. E anche in questo caso, se il favore del pubblico va al Lato A di Paul, i critici preferiscono nettamente il numero di John. Sembra più sofferto, sincero, meno stereotipato, ecc. ecc. Senonché, proprio nel momento più drammatico del brano, mentre il bridge sta per convergere sul ritornello, ti accorgi che in sottofondo qualcuno sta cantando in falsetto: "tetta, tetta, tetta". Così, per scherzo. "Era un modo per rilassarci un po' nel bel mezzo di questa grande carriera che stavamo forgiando" (è Paul, nella sua autobiografia). "Quando potevamo metterci qualcosa che fosse un po' sovversivo, lo facevamo. George Martin avrebbe potuto dire; "ma stavate cantando dit dit o tit tit?" "Oh, senz'altro dit dit, George, ma suona un po' come "tetta tetta", vero?" E poi entravamo in macchina e scoppiavamo a ridere". C'è questa componente autoironica, in tutta la storia dei Beatles, che può essere disorientante.
Eppure Lennon con Girl sembrava voler fare sul serio. Il desiderio di comporre un brano "all'europea" è tradito dalla progressione degli accordi nella strofa, più semplice del solito ma ricalcata su un'idea quasi archetipica di ballata cantautorale: la minore, re minore, mi maggiore. È l'unica strofa dei Beatles che avrebbe potuto aver scritto anche un Brassens, anche un De Andrè: quest'ultimo in particolare avrebbe potuto scriverla anche dieci anni dopo. Nel ritornello (un giro di Do neanche troppo camuffato) Lennon ha l'idea di introdurre un nuovo strumento musicale: il sospiro affannoso, anzi, l'aspirazione affannosa (c'è chi ci legge un chiaro riferimento al consumo di cannabis) (c'è chi vede la cannabis dappertutto, e in molti casi è soprattutto negli occhi rossi di chi guarda) (però nel caso dei Beatles del 1965 non è un'ipotesi così azzardata).
L'ultimo tocco europeo, a dire il vero un po' incongruo ma suggestivo, è lo strano effetto 'sirtaki' ottenuto dal raddoppiamento delle chitarre acustiche verso la fine. Anche questa un'idea di Paul, ispirata da una recente vacanza in Grecia. Alla fine anche il John di Girl è un turista dell'esistenzialismo: senz'altro meno sfacciato di Paul, non usa un frasario da turista per provarci con le ragazze locali, ma si apparta in un angolo a contrariarsi per un amore difficile per una donna impossibile che dovrebbe averlo ridotto a uno straccio – un amore che ai biografi non risulta ma vabbe', dettagli. In seguito avrebbe raccontato nelle interviste che "la ragazza che più la vuoi più te ne fa pentire, eppure non rimpiangi un solo giorno" era una prefigurazione di Yoko. E se da una parte fa un po' sorridere questa tendenza a dedicare a tua moglie anche le canzoni che hai scritto prima di conoscerla, l'idea che la Ragazza sia davvero Yoko rende la terza enigmatica strofa un ascolto da brividi. Le fu mai detto, quando era giovane, che il dolore l'avrebbe condotta al piacere? Ha capito cosa intendeva colui che disse che l'uomo deve spezzarsi la schiena per meritarsi un giorno di riposo? Ci crederà ancora, quando lui sarà morto?
54. The End (Lennon-McCartney, ma si sarebbe dovuta attribuire a tutti e Quattro; Abbey Road, 1969).
Oh Yeah! All right! Prima di diventare la Fine dei Beatles, The End era semplicemente il finale del Medley di Abbey Road, e a quanto pare ne è anche il brano più apprezzato dai critici. Curioso, perché è il momento del Medley che assomiglia meno a una canzone e più a un movimento di un brano musicale più complesso. Si tratta di un pezzetto di musica notevole soprattutto per quello che non è: non è un lungo addio, non è una melanconica suite strumentale, non è un pezzo di bravura. The End è molto meno, e questo ce la fa amare molto di più. Questa idea di andarsene alla svelta senza troppe smancerie.
Oh you gonna be my dream tonight. Se davvero The End fosse una jam session – ne ha tutta l'aria, ma diffidiamo – sarebbe probabilmente la jam più breve mai incisa : due minuti (un minuto e mezzo se togliamo la coda). Per fare un confronto con quel che andava per la maggiore in quel periodo si può accostarla ad Apple Jam, il terribile disco che Harrison allegò in omaggio con All Things Must Pass: più di mezz'ora di improvvisazioni strumentali senza capo né coda. Oppure con i brani live sempre più interminabili dei Cream. Già, i Cream.
The End all'inizio si chiamava Ending. Non era necessariamente la Fine dei Beatles, ma avrebbe potuto esserlo. Un momento però: cosa voleva dire "la Fine dei Beatles"?
Oggi abbiamo tutti una certa familiarità col concetto di 'fine di un gruppo'. Può trattarsi di un litigio, meno spesso di una separazione consensuale – sappiamo anche di non doverci fidare troppo, ci sono gruppi che si sono già sciolti tre o quattro volte. Ma nel 1969 tutta questa liturgia non esisteva. Le band erano una relativa novità: nascevano continuamente, spesso cambiavano elementi da un disco all'altro, e altrettanto spesso sparivano dalla circolazione: un disco sbagliato, un contratto finito, e dopo un po' nessuno si chiedeva più se i Them esistessero ancora o no. Al tempo insomma era più un fallimento che un divorzio. Le cose però stavano cambiando, e anche in questo i Beatles avrebbero potuto essere all'avanguardia: la prima band a sciogliersi ufficialmente. Se non che prima di loro c'era già stata una band molto famosa che non solo aveva già concepito il suo scioglimento come un divorzio, ma lo aveva anche messo letteralmente in scena, con tanto di disco e concerto d'addio: i Cream.
Un vero fulmine per la scena rock: persino i Beatles, durati appena otto anni, fecero in tempo a vederli nascere, esplodere come fenomeno commerciale e artistico, e uscire di scena col botto. Come dice il demiurgo in quel film: la luce che arde col doppio di splendore brucia per metà tempo. I Cream si erano dissolti per aver preso una strada che prima dei Beatles non era nemmeno tracciata: il titanismo strumentale. Si erano letteralmente liquefatti in un brodo di jam, risucchiati dai rispettivi ego che portavano Jack Bruce ad alzare sempre più il volume del basso e Ginger Baker a pestare sempre più forte per farsi sentire: una sera Clapton smise semplicemente di suonare, e i due colleghi nemmeno se ne accorsero. Tutto questo in quella manciata di anni in cui questo genere musicale – il blues inglese suonato nell'accezione più virtuosistica – era considerato dai critici un genere commerciale, un cedimento al gusto del pubblico, che evidentemente è molto cambiato: oggi vuole sentire dei finti gangster chiacchierare al microfono, ieri si deliziava di lunghissimi assoli di chitarra, basso e batteria. I Beatles avevano potuto assistere a tutto il fenomeno da una posizione privilegiata, e ora toccava a loro lasciare la scena. I Cream sul lato A di Goodbye avevano salutato il loro pubblico con quindici minuti di improvvisazioni: i Beatles si concessero novanta secondi. The End non è una caricatura degli eccessi del blues rock inglese (come si poteva intendere Yer Blues): anzi tutto il contrario. Se le caricature accentuano proprio gli aspetti eccessivi, The End fa l'esatto opposto, obbligando i quattro strumentisti a dare il meglio di sé in una brevissima unità di tempo, che forse è il più importante stilema dei Beatles: la concisione.
Dopo il rapido assolo di Ringo (il titubante Ringo che sin dall'inizio dell'avventura aveva messo ben chiaro che gli assoli non lo interessavano), i tre chitarristi non solo hanno pochi secondi a disposizione, ma devono cedersi il posto ogni due battute: più che una jam è una coreografia. Alla fine è probabilmente l'unica jam che qualche ascoltatore conosce a memoria, dai primi tom tom di Ringo all'accordo di pianoforte che emerge sul finale. Prima suona Paul, poi George, poi John; di nuovo Paul, di nuovo George, di nuovo John. E per una terza e ultima volta: Paul, George, John. Ognuno cerca per quel che può di descrivere sé stesso con la chitarra. Nessuno ha tempo o spazio per fare cose incredibili: John compensa al suo deficit tecnico con la creatività che contraddistingue i suoi migliori momenti di chitarrista tecnico. "Nessuno di noi", sembrano intendere, "avrebbe molto da dire da solo". Eppure si stanno salutando.
E alla fine l'amore che prendi è uguale all'amore che fai. Il che è molto poetico, apparentemente, ma se ci rifletti non è che significhi granché, è un mccartneysmo da incarto di cioccolatino. A meno che non voglia dire una cosa molto triste: l'amore è un gioco a somma zero, tu porti il tuo, l'Altro porta il suo, e alla fine ve ne tornate con la stessa quantità d'amore con cui eravate partiti. Al che rispettosamente dissento, sir Paul McCartney: l'amore che vi siete fatti è sempre stato di molto superiore alla somma delle parti, e vi ha lasciato senz'altro più ricchi, anche se forse non era facile accorgersene nel 1969. Ma si sa, avevate tutti avuto un anno difficile.
53. Got to Get You Into My Life (Lennon-McCartney, Revolver, 1966)
Ma te l'ho detto che ho bisogno di te ogni singolo giorno della mia vita? A un certo punto sembrava che tutte le canzoni d'amore in realtà parlassero di droga – no, non è stato un certo punto, sono stati tipo trent'anni, da Lucy in the Sky a La mia signorina di Neffa, tutto un estenuante darsi di gomito, uno strizzare l'occhiolino. (In seguito non è che le canzoni abbiano smesso di parlarne, ma almeno sono usciti dalla gabbie dei doppi sensi). È una cosa che ho sempre trovato poco sopportabile, forse perché non mi drogo. In realtà assumo sostanze anche più nocive, ma consentite dalla legge, per cui non c'è gusto a farci i doppi sensi.
Parlare di sostanze stupefacenti in una canzone era coraggioso, diciamo fino al 1968: poi è diventata una soluzione perfino banale, una specie di gioco a protrarre l'adolescenza come se là fuori ci fossero ancora i vostri genitori che si preoccupano se a vent'anni vi fate le canne (nel frattempo i genitori sono scappati a Cuba con la badante sexy e i soldi della vostra università). Per una o due canzoni in cui la dipendenza è descritta in modo mirabile, ce ne sono centinaia che si limitano a vendere un po' di trasgressione ai ragazzini. E più che gli artisti a volte sono proprio i fan che si intestardiscono a cercare riferimenti al fumo e all'acido e all'oppiaceo in qualsiasi brano, come se parlare di stupefacenti fosse intrinsecamente più cool che parlare d'amore o di pace universale o di tasse – quando invece è la cosa più banale e più semplice, si può fare da soli: persino per l'amore bisogna essere almeno in due. E però proprio quando cominciavamo ad abbracciare un sano processo di revisione, proprio quando iniziavamo ad accettare che Lucy in the Sky fosse stata ispirata a un disegno infantile e Cold Turkey raccontasse il decorso di un'intossicazione alimentare, se ne esce bel bello Paul McCartney e avverte il mondo che Got to Get You Into My Life, una delle sue canzoni d'amore più entusiastiche e trascinanti... era dedicata alla cannabis. Alla cannabis. Una droga che forse è stata cool in un semestre del 1965.
Ora. In effetti, se sposti l'attenzione dalla musica al testo, non c'è dubbio che Paul stia parlando di un rapporto ossessivo ("What can I do, what can I say, when I'm with you I want to stay there...") Sulla sincerità di Paul al riguardo non c'è modo di dubitare, visti anche solo i precedenti penali: Paul McCartney è riuscito a farsi sequestrare la marijuana in valigia quasi ovunque, dalla Svezia alle Barbados: una volta l'hanno beccato pure nella sua fattoria scozzese, coi semi sbagliati. L'episodio più famoso è la carcerazione in Giappone nel 1980: dieci giorni e tutte le date saltate. Però è un po' come immaginare che Strangers in the Night parli di un tizio che finalmente scopre le sigarette. Davvero, tutto qui? Paul ha bisogno di cannabinoidi tutti i giorni della sua vita? Se glieli date sarà felice e canterà meravigliose canzoni? C'è qualcuno che considera la canzone migliore, ora che l'abbiamo calata nel contesto indicato dall'autore?
Io no. Anzi ho bisogno di non crederci. Secondo me Got to Get You Into My Life si merita una storia migliore. Ho deciso di credere che parli (come Here, There and Everywhere) di una persona fantastica che Paul incontra proprio perché ha bisogno di cambiare prospettiva: e che decide di amare ogni giorno della sua vita. In effetti sembra proprio Linda Eastman, salvo che... Paul non l'aveva ancora conosciuta. Da cui forse la necessità di una rimozione: dopo aver incontrato Linda, Paul potrebbe avere avuto pudore di una canzone come Got to Get You. Obietterete che è Paul McCartney, e di canzoni in cui giurava eterno amore ne aveva già scritte a quintalate, a partire da Love Me Do (sì, c'è una promessa di eterno amore persino in Love Me Do). Giustissimo, ma Got to Get You è più intima. Forse proprio perché stavolta Paul non promette più niente, stavolta Paul implora. È finito il tempo in cui componeva brevi frasi retoriche per gli innamorati timidi, ora per Paul l'amore non è più un contratto: è un'impellenza fisica, una necessità quotidiana. Una droga? Sì, forse una droga. Ma non necessariamente.
A parte questo, Got to Get You è una straordinaria canzone soul. Come fai a capire quando hai scritto una straordinaria canzone soul? Se te la riprende quasi pari Ella Fitzgerald, ci sono buone possibilità. Se poi te la rileggono gli Earth, Wind and Fire, direi che ci siamo. Una cosa interessante è che Got to Get You non nasce così immediatamente soul: ha un periodo di incubazione in cui mostrava più tracce evidenti di quel gusto vagamente ipnotico-orientale che Paul aveva seminato qua e là in Revolver (l'assolo di Taxman, il melisma di I Want to Tell You). Soprattutto i cori di John, che si sentono in una outtake di Anthology e avrebbero portato la canzone in una direzione sensibilmente diversa (e più vicina ad altri brani revolveriani di John e George). Paul però, lo abbiamo visto, è in grado non solo di inventarsi notevoli soluzioni di arrangiamento, ma anche e soprattutto di scartare quelli che non funzionano abbastanza. Chiunque altro si sarebbe tenuto quei cori, ma Paul voleva qualcosa di più, e così li toglie (proprio come in Can't Buy Me Love, altro brano ripreso dalla Fitzgerald) e sceglie di inserire una trionfale sezione di fiati che diventano il tratto distintivo della canzone.
52. Julia (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
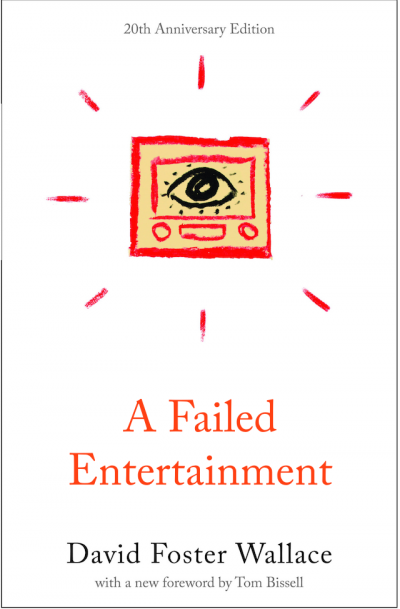 Metà di quel che ho detto non ha senso, ma l'ho detto solo per raggiungerti – questa che sulle pagine di Kahlil Gibran sembra in effetti una mezza scemenza, cantata da Lennon diventa una verità profonda. La trama di Infinite Jest, il mastodontico romanzo di David Foster Wallace, ruota intorno all'Intrattenimento, un breve film che rende chi lo guarda incapace di altro desiderio che non sia continuare a guardarlo. Un simbolo potente della dipendenza, ma cosa c'è davvero in quell'Intrattenimento? Cosa lo rende così irresistibile? Per almeno un migliaio di pagine il lettore non lo sa e non ha neanche molte speranze di impararlo, perché si sa come funziona con questi capolavori postmoderni. Poi quando meno te l'aspetti un personaggio secondario che ha assistito alle riprese lo racconta: [SPOILER] dunque in questo breve film una ragazza bellissima, ma dal volto coperto, spiega allo spettatore che la donna che lo uccide in questa vita è la stessa donna che gli darà vita nella seguente. Le ottiche del film sono realizzate in modo da dare allo spettatore il punto di vista di un bambino: forse di un bambino che sta nascendo. Ecco l'intrattenimento irresistibile: poter nascere/morire senza paura, passando dalla stessa porta, dalla stessa madre [/SPOILER].
Metà di quel che ho detto non ha senso, ma l'ho detto solo per raggiungerti – questa che sulle pagine di Kahlil Gibran sembra in effetti una mezza scemenza, cantata da Lennon diventa una verità profonda. La trama di Infinite Jest, il mastodontico romanzo di David Foster Wallace, ruota intorno all'Intrattenimento, un breve film che rende chi lo guarda incapace di altro desiderio che non sia continuare a guardarlo. Un simbolo potente della dipendenza, ma cosa c'è davvero in quell'Intrattenimento? Cosa lo rende così irresistibile? Per almeno un migliaio di pagine il lettore non lo sa e non ha neanche molte speranze di impararlo, perché si sa come funziona con questi capolavori postmoderni. Poi quando meno te l'aspetti un personaggio secondario che ha assistito alle riprese lo racconta: [SPOILER] dunque in questo breve film una ragazza bellissima, ma dal volto coperto, spiega allo spettatore che la donna che lo uccide in questa vita è la stessa donna che gli darà vita nella seguente. Le ottiche del film sono realizzate in modo da dare allo spettatore il punto di vista di un bambino: forse di un bambino che sta nascendo. Ecco l'intrattenimento irresistibile: poter nascere/morire senza paura, passando dalla stessa porta, dalla stessa madre [/SPOILER].Julia funziona in un modo simile. Mi piace pensare che Lennon abbia iniziato a scriverla addirittura pensando al figlio Julian – per poi virare immediatamente verso il ricordo della madre – che sfuma immediatamente in quello dell'amante: "Ocean Child", Yoko Ono. Tre persone intorno al cuore, tre generazioni che sono la stessa persona che nasce, muore, rinasce. Il tutto salmodiato sopra quell'arpeggio ipnotico che è il vero tesoro che Lennon ottenne in India: non dal maestro di meditazione Maharishi, ma dal maestro di fingerpicking Donovan. È lo stesso arpeggio infinito che sentiamo in Dear Prudence; lo stesso sul quale un anno dopo Lennon sta ancora cantando Everybody Had a Hard Year. Julia è l'unico brano di tutto il canone beatle che Lennon suona da solo – scartando anche qualche potenzialità armonica scoperta durante le prove: la versione finale è ancora più scarna dei demo. È un brano che può mettere in imbarazzo – quale altro artista, prima o dopo il 1968, avrebbe confessato con altrettanto candore a un pubblico così vasto che per lui madre e amante erano una cosa sola? E doveva ancora cominciare l'analisi.
I posteri si domanderanno se John Lennon abbia veramente posato i piedi sulla nostra stessa terra. Dopotutto Edipo è un mito; Buddha e Gesù Cristo sono più miti che personaggi storici; ma un figlio di un marinaio nato sotto i bombardamenti, squartato emotivamente da un padre che lo vuole in Nuova Zelanda e una madre che lo affida alla sorella; cresciuto da donne, poi orfano; ragazzo terribile in pantaloni attillati; giovane padre, chitarrista cantante e compositore pop, idolo delle teenager e del suo manager omosessuale; tossicomane, poi artista concettuale, leader pacifista sotto inchiesta federale; poeta maledetto, avvistatore di UFO, rockstar in congedo permanente, morto per mano di un fan. Nessun mitografo o evangelista o romanziere postmoderno sarebbe riuscito a inventarsi un personaggio così. Eppure alla fine era solo un ragazzo che diceva quel che provava, come noi evitiamo di fare il più delle volte perché proviamo cose orribili o anche solo imbarazzanti. Julia, figlia dell'oceano, chiamami.
51. And Your Bird Can Sing (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).
Quando il tuo uccellino si sarà rotto, lo porterai indietro? Wikipedia ci informa che il twee pop è un sottogenere dell'indiepop caratterizzato da "semplicità e innocenza percepita", "armonie tra voci maschili e femminili", "melodie accattivanti e testi d'amore". Che tra tanti stili i Beatles abbiano anticipato anche il twee appare perfino scontato – in un certo senso il twee è un tentativo di rimanere vicini a quel nucleo di innocenza che durante l'esplosione del rock sembrava essersi nebulizzata nello spazio profondo. Lo stesso Lennon, quando compone il suo brano più apparentemente twee, si sta già guardando indietro: se è mai stato innocente, quel periodo è passato da un pezzo. Addirittura la finta ingenuità del testo riprende uno stilema dylaniano: c'è molto della Queen Jane ritratta sul secondo lato di Highway 61 in questa ragazza ricca di risorse e gadget che prima o poi tornerà da un innamorato che non si fa impressionare. And Your Bird Can Sing manca la top50 di striscio ed è un peccato, ma è in fondo il suo destino di brano-sottovalutato-di-Revolver: un pezzo in cui Lennon non sembrava credere troppo, caratterizzato da un riff sovrabbondante suonato da due chitarre armonizzate (a suonarle nella versione definitiva pare siano Paul e George), che tra tante possibili dimensioni del rock ne esplora una che nel 1966 non era forse ancora immaginabile. Quando la ripescheranno più quindici anni dopo, i Jam sembreranno aver trovato una gemma nascosta. Un altro piccolo tesoro è la "laughing track" di Anthology, in cui Paul e John vengono colti quasi subito da ridarola e non riescono a smettere: stupisce sempre la loro capacità di prendersi in giro da soli, facendo il verso alle proprie canzoni ancora prima di completarle. (Tutti i tentativi di trovare nel testo riferimenti a celebrità supponenti non superano il livello del gossip. La più demenziale evoca addirittura Frank Sinatra e la sua abitudine italianeggiante a riferirsi al sesso maschile col termine "bird". Ma no, nessuno ha mai sentito John o Paul davvero cantare "and your bird can swing").
Le canzoni dei Beatles (#70-61)
01-07-2020, 03:16beatles, Il Post, musicaPermalinkCinquant'anni fa i Beatles erano ormai ufficialmente sciolti. Cinquant'anni dopo, Paul McCartney ha partecipato a una raccolta fondi suonando When the Saints Go Marchin' In con la tromba, lo strumento con cui ha iniziato a fare musica da bambino (e che deve ancora perfezionare, diciamo). E in effetti c'è qualcosa di trombettista, a volerlo sentire, in certe sue linee di basso: quel modo un po' bandistico in cui cerca di tenere insieme ritmo e melodia. Nel frattempo noi andiamo avanti con la classifica, ormai siamo agli sgoccioli, mancano soltanto... 70 canzoni.
Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76).
70. Twist and Shout (Bert Berns – Phil Medley; incisa dai Beatles in Please Please Me, 1963).
Torciti e urla. E se dopo aver inciso il primo disco avessero preso anche loro l'aereo sbagliato, quel tipo di aereo che nel 1959 avevano preso Buddy Holly e Ritchie Valens? Ci ricorderemmo ancora di quel simpatico quartetto protagonista di un breve revival inglese del rock'n'roll, i Beatles? Forse no: per rimanere nel Libro devi diventare grande in America, il che sarebbe successo solo qualche settimana dopo. O forse sì, perché per passare alla Storia a volte basta un pezzo solo: pensa ai Trashmen! (chi?) Ma come chi, quelli di Surfin' Bird. O i Kingsmen, (chi?) quelli che registrarono Louie Louie così male che la gente ci sentiva dentro qualsiasi cosaccia le dettasse l'immaginazione e la FBI aprì un'inchiesta, storia vera. O a Chubby Checker di cui nessuno saprebbe citare tre pezzi in fila, ma almeno due twist li conoscono tutti. O Ritchie Valens, che quell'aereo lo prese davvero (aveva solo 17 anni!), ma aveva fatto in tempo a incidere La Bamba, e tanto ci basta. Anche perché Twist and Shout altro non è che la Bamba formato twist, scritta da due autori (Bert Berns e Phil Medley) che volevano proprio mettere insieme le due cose, ma poi passata a Phil Spector che immancabilmente insieme alle due cose voleva infilarcene tantissime altre, sicché la Twist and Shout dei Top Notes, la prima in assoluto (1961), sembra già un cross-over, una parodia. Ma Berns non si diede per vinto e alla fine riuscì a farla incidere come l'aveva in mente a un terzetto di reduci del twist, gli Isley Brothers.
Dopodiché forse Twist and Shout esiste già in natura, in fin dei conti cosa c'è di più naturale della progressione I-IV-V, cosa suona più spontaneo all'orecchio umano di un passaggio dal primo accordo al quinto, magari con una breve sosta al quarto per creare un po' di tensione? E però prima che Valens portasse La Bamba alla radio, l'idea non era venuta a nessuno e anche dopo ci mise un po' ad attecchire: gli Isley Brothers con la loro Twist and Shout rividero la Top40, e tutto sarebbe finito lì se un anno dopo un John Lennon rauco e febbricitante non avesse deciso di terminare le 15 ore di session del suo primo album riprendendo Twist and Shout con la stessa violenza autolesionista con cui la sparava contro le basse volute di mattoni del Cavern Club. Se avesse inciso anche soltanto quel pezzo, John Lennon sarebbe... uno sconosciuto, dal nome oscuro quanto quello dei cantanti che coverizzarono Bird is the World o Louie Louie. Ma quella voce, la sua voce avrebbe fatto il giro del mondo, e lui forse sarebbe impazzito dall'imbarazzo perché c'è qualcosa di osceno in quella voce, e lui non scherzava quando affermava di odiarla.
Twist and Shout avrebbe reso qualsiasi gruppo di sconosciuti una one-hit-wonder e forse avrebbe avuto più senso così, in fondo è quel che resta di un brano tradizionale messicano infilato da un autore professionista in uno stampino commerciale già esausto (il twist), poi ripreso nel quartiere a luci rosse di Amburgo da un oscuro gruppo di rocker inglesi dalla tonsille devastate dalla nicotina, trasformato in uno sguaiato inno alla dissoluzione che porta finalmente il rock'n'roll in un nuovo decennio. Il felpato professionismo dei vocalist americani viene riletto da un mancato mozzo di Liverpool che canta ogni verso come fosse l'ultimo senza sapere se riuscirà ad arrivare alla nota più alta – in effetti non è che ci arrivi realmente, la sua blue note non è un ammiccamento, è uno sforzo disperato di un chitarrista che torce le corde vocali come fossero corde della sua chitarra. Quel mancato mozzo e i suoi colleghi sciamannati diventeranno poi la band più famosa del mondo, scrivendo e cantando brani diversissimi ma tutti più complicati di Twist and Shout: però alla fine anche solo Twist and Shout ci sarebbe bastata. Non voglio dire che sia il più grande brano del rock, ma l'ultima volta che ho controllato il più grande brano del rock aveva come ritornello una versione un po' più lenta e rantolante di Twist and Shout. Tutto grazie a Lennon. E a Bert Burns. E a Valens (ma non a Phil Spector).
69. Two of Us, Lennon-McCartney, Let It Be, 1970).
We're on our way home. We're going home. Potenza del contesto. Registrata da qualsiasi altro artista in qualsiasi altro disco, Two of Us probabilmente non mi avrebbe detto un granché. Inserita da Lennon e McCartney all'inizio del loro disco postumo, Two of Us mi commuove. Non importa aver letto dappertutto che i "due di noi" erano Paul e Linda in gita in campagna. Nella mia testa i due vagabondi in impermeabile che scrivono cartoline accostandole ai muri non possono che essere Paul e John. Hanno ricordi più intricati della strada che hanno percorso, stanno tornando a casa da qualcosa che dalla distanza sembra una guerra. Comunque è finita, il nemico è battuto, non c'è più bisogno di litigare. Stanno tornando a casa e sarebbe bello se ci tornassero assieme. Sappiamo che non è così ma per un attimo vogliamo crederci. La storia dei Beatles è la storia di un'amicizia: è questo che la rende struggente e ci fa tornare sempre sul luogo del misfatto, anche se sappiamo come va a finire. Si può assistere a Romeo e Giulietta per cento volte e maledire ugualmente quel frate che si attarda con un messaggio importantissimo nella bisaccia: si può ascoltare Two of Us cento volte e continuare a domandarsi: perché non avete fatto la pace quando eravate ancora in tempo?
Paul nel periodo di Let It Be è sospeso tra tentazioni quasi jazzistiche e un impulso a semplificare gli arrangiamenti – anche per ridurre al minimo le discussioni coi colleghi coinvolti in un delicatissimo divorzio a quattro. Two of Us cattura questa tensione: una canzoncina apparentemente facile, suonata alla buona, con un bridge che all'improvviso si impenna – un improvviso sussulto di orgoglio, che rientra subito nei ranghi. Ma alla fine è la cosa migliore del brano, ed è anche quella a cui John dedicò più impegno, perché armonizzare sulla "strada che si allunga là fuori" gli costava effettivamente fatica ma almeno era una sfida. Potenza del contesto: Two of Us cattura la dolcezza dell'incontrare un vecchio amico con cui hai litigato ma gli vuoi comunque bene ma ci hai pur sempre litigato. Ma se l'avesse incisa qualcun altro, in qualsiasi altro disco, non ci avrei mai fatto caso.
(Nella versione di Let It Be Naked, mi pare che McCartney si limiti a tagliare la presentazione sardonica di John: "I Dig a Pygmy', di Charles Hawtrey e the Deaf Aids ... Prima parte, in cui Doris si procura la carota". Un'ottima idea: la frase in questione non era riferita alla canzone, ma era una delle sciocchezze che Lennon lanciava al microfono nelle pause sigaretta; Phil Spector probabilmente voleva suggerire l'idea di una registrazione estemporanea, ma introdurre la prima canzone che parla sicuramente di Linda con il greve doppiosenso di "Doris gets her oats" era un bel colpo sotto la cintura).
68. Lady Madonna (Lennon-McCartney, singolo del febbraio 1968).
See how they run, come corrono, 'sti ragazzi. Che cosa ci si aspettava dai Beatles all'inizio dell'anno di grazia 1968? Che continuassero a essere la più grande band del mondo, apprezzata da grandi e piccini; però anche innovativi, come erano sempre stati e certo non potevano smettere di esserlo proprio ora. D'altro canto dopo alcune sbandate situazioniste e psichedeliche sarebbe stato apprezzato anche un certo ritorno all'ordine, al rock'n'roll; però sempre garbato, per le urla sguaiate c'erano già Stones e Who. In vista della rivoluzione un po' di realismo sociale non avrebbe guastato, sempre condito da quell'ottimismo che era indelebilmente associato alla loro immagine pubblica. Ci si aspettava tutto questo dai Beatles, all'inizio del 1968: e Paul McCartney, infallibilmente, lo consegnò entro la scadenza: giusto in tempo per accompagnare in India chi andava alla ricerca di sé stesso.
Sul serio: non c'è nessuna promessa che i Beatles avessero fatto fin qui che Lady Madonna non mantenga, e te lo fa pure sembrare facile. È un pezzo allegro, ma il testo a pensarci bene è triste (ed è anche uno dei più riusciti testi di Paul, il migliore dei suoi bozzetti liverpooliani). È un ritorno al sano e vecchio rock'n'roll, o almeno così fu considerato dai critici che non sapevano bene cosa pensarne; c'era in effetti nell'aria una certa sensazione di stanchezza per le follie del '67. Il disco psichedelico degli Stones aveva lasciato tutti perplessi, Bob Dylan aveva appena pubblicato un disco spogliato all'osso ed enigmatico come John Wesley Harding. Ma a dire il vero Lady Madonna non rappresenta nessuna inversione di rotta, anzi chiarisce sempre di più la vocazione di Paul e soci per il pastiche, il numero in costume: quindi sì, c'è un bel rock pianistico alla Fats Domino nella strofa, ma il bridge si sposta sui territori swing che Paul ha iniziato a esplorare con When I'm 64, per impennare sul finale ("See how they run") con un ricordo di quei cori barocchi che erano un marchio di fabbrica della casa dai tempi di Paperback Writer. Anche l'arrangiamento sembra voler tenere i piedi in due scarpe, professionismo e giocoleria: Paul convocherà una sezione di ottoni ma non offrirà loro nessuno spartito da suonare: non solo, ma lui e gli altri ragazzacci si metteranno a scimmiottare gli ottoni in sordina con le voci in falsetto. A un certo punto un sassofonista esasperato produrrà un assolo free che si accompagna perfettamente all'allegra concitazione raccontata dal testo. Non solo Lady Madonna è in perfetta continuità con le trovate di scena e il bozzettismo di Sgt Pepper, ma dimostra che rispetto a Sgt Pepper le idee sono persino più chiare, gli arrangiamenti più nitidi, Paul più ispirato. Tutto quello che ci si aspettava dai Beatles, Lady Madonna lo forniva in due minuti e mezzo: di fronte a questa strabiliante dimostrazione di superiorità offerta da un Paul McCartney che aveva appena incassato il fiasco televisivo del Magical Mystery Tour, come reagì il pubblico?
Tiepidamente.
Oddio, il disco lo comprarono – però non arrivò mai al primo posto nella classifica americana, un caso abbastanza raro per i Beatles. Non aiutava il Lato B – The Inner Light, la composizione indiana meno compromissoria di George Harrison. Fu in assoluto il singolo meno lennoniano della storia dei Beatles – insoddisfatto dalla resa di Across the Universe, John aveva fatto un grande passo indietro. Ma insomma il relativo insuccesso di Lady Madonna dimostrava quello che i Beatles già prima di partire per l'India sapevano: non si poteva fare meglio di così. I Beatles avevano abituato il loro pubblico a un livello di qualità e innovazione impossibile da garantire ancora a lungo. Ormai ci si aspettava da loro con cadenza semestrale un capolavoro o un cambio di paradigma, o entrambe le cose insieme. Lady Madonna è uno dei brani dei Beatles che più si avvicina all'antico concetto di standard, quelle canzoni che conosci da sempre e puoi ascoltare tutti i giorni senza stancartene. Pur mantenendo un'impronta visibile del loro autore, gli standard possono essere rifatti da qualsiasi interprete e non tradiscono mai. Persino Fats Domino incise Lady Madonna, visto che tutti dicevano che sembrava un pezzo suo. Ne fece una buona versione in cui non cambiava praticamente nulla: il più grande complimento che Fats potesse fare a Paul McCartney. Ma sul serio, cosa puoi cambiare in Lady Madonna? Per Lennon era un pezzo "che non andava da nessuna parte". In un certo senso è vero: non c'era più nessuna parte dove andare, Lady Madonna si limita a mantenere la posizione. La gente si aspettava qualcosa di più, ma cosa?
67. Carry That Weight (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969)
Oh boy, questo peso te lo porterai addosso per un bel po' di tempo. Qualche settimana dopo, quando John Lennon manifestò l'intenzione di lasciare dal gruppo, disse, testuale: "voglio un divorzio". Se ci pensate, è terribile – qualsiasi divorzio lo è. Un matrimonio può finire, capita ai migliori. Ma un divorzio è per sempre. Ti segna la vita: non puoi smettere di essere divorziato: c'è un prima e c'è un dopo. E non capita a tutti – sposarsi, quello sì è alla portata di tutti. Sposarsi ti rende simile a chiunque altro, ma divorziare, quando capita, è come se capitasse solo a voi. Dovrete conviverci per tanto, tanto tempo. E dire che Paul ci aveva appena promesso di cantarci una ninna nanna. Invece, senza preavviso, parte un coro da stadio – la voce di Ringo è in evidenza, il ricordo di Yellow Submarine si inserisce subliminalmente, insieme a un presagio: questa cosa ce la porteremo addosso a lungo. E così siamo agli sgoccioli, e queste patetiche carte che ci stanno allontanando, queste ripicche da ragazzi, queste scemenze da avvocati sono il casus belli che ci dividerà per sempre, qualcosa per cui tutto il mondo ci rimprovererà finché campiamo, e alcuni di noi camperanno a lungo (per una macabra coincidenza, sono i due che cantano il coro).
Per tutte le volte che lo abbiamo accusato di inventarsi storie inutili, bisogna riconoscergli che nel momento in cui qualcuno doveva raccontare l'episodio più doloroso, è stato proprio Paul a non tirarsi indietro. E solo Paul del resto avrebbe potuto riuscirci – tutta l'esperienza maturata con le sue canzoni del disamore, alla fine gli ha permesso di realizzare con You Never Give Me Your Money e Carry That Weight un dittico di sincerità disarmante.
66. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Lennon-McCartney, nell'album omonimo, 1967)

È successo vent'anni fa oggi. Ci sono cose quasi impossibili da catturare con una macchina fotografica, o un registratore, o una videocamera. Per esempio, il momento in cui cresciamo – impossibile, lo facciamo troppo lentamente. La nostra prima nostalgia, il primo caso in cui ci voltiamo indietro: salvo che quando l'abbiamo vissuto non ce ne rendevamo conto, che era il primo. Oppure: il momento in cui nasce una moda. Il problema è che non nascono mai veramente, è tutto un perenne divenire. Londra, che a metà anni '60 era diventata il punto di riferimento della moda giovanile, tra 1966 e 1967 impose un brusco cambiamento di rotta, deciso non si sa bene da chi – probabilmente nessuno. In ogni caso, nel giro di qualche mese si passò da uno stile modernista, ispirato dalla corsa allo spazio e dalla op art, a un improvviso interesse per la chincaglieria del passato – all'improvviso Portobello invase Carnaby Street. Il perché non è chiaro e non è chiaro neanche il percome: la storia della moda procede un po' per narrazioni orali, poi ogni tanto qualcuno fa una mostra retrospettiva e una serie di collezioni, messe in fila, sembrano assumere un significato.
Non come la storia della musica, in cui almeno sai quali dischi hanno venduto e quali ti tiravano dietro: nella moda è tutto un successo fino a prova contraria e le prove nessuno le ha. Alla fine forse l'istantanea più affidabile di quel particolare momento è proprio quella scattata dai Beatles all'inizio del loro disco più ambizioso e colorato – pochi mesi prima, l'elegante Revolver si era concluso con il brano più avantgarde mai inciso dai Quattro, Tomorrow Never Knows. Il disco nuovo si presenta diversissimo già dalla copertina, eccessivamente variopinta: i Beatles non sono più gli unici protagonisti, anzi non sono mai stati così piccoli, vestiti da buffoni e circondati da un gruppo di celebrità intergenerazionale; come se il mondo degli adulti finalmente si fosse degnato di accoglierli. Quanto alla musica, beh – il primo brano sembra un rock piuttosto duro per il 1967, in linea con quanto suggeriva già Revolver nell'anno precedente. McCartney canta con la tipica foga little-richardiana su una nota sola: oggi non avremmo difficoltà a considerarlo un rap. È un suono brutalista e moderno: racchiude l'energia ribelle di una generazione e... dura sedici battute.
Poi partono gli ottoni.
Un pubblico finto reagisce con stupore; poi si mette a ridere. Ma è un disco o un musical? È come se i Beatles crescessero in quell'esatto momento: un istante impossibile da fermare sulla pellicola o sul nastro. Tutto quello che era importante un attimo prima... non lo è più. Molto altro bolle in pentola, avremo una sezione di ottoni e tanti numeri in costume. Sì, eravamo la rock band più importante del mondo, l'anno scorso. Adesso siamo qualcosa di nuovo, ma anche di vecchio. Qualcosa che comunque vi piacerà, sedetevi e godetevi lo show.
Succede tutto in pochi secondi. Il brano, a dire il vero, dopo l'inserto di ottoni continua a rockeggiare come se niente fosse. Invece è cambiato tutto, quello che nel 1966 era avanguardia ora è solo una posa fra tante. Nei negozi è arrivata roba nuova – che in realtà a guardare bene è roba vecchia, buffe giacche e vestiti di vent'anni fa. La guerra era appena finita, papà McCartney suonava vecchi standard jazz al pianoforte, mamma Lennon strimpellava il banjo, il Sergente Pepper insegnava alla sua banda a suonare. Possibile che nel 1967, mentre compitava parole a caso per il nuovo disco, Paul McCartney conoscesse già la Regola dei Vent'anni, quel teorema del consumo per cui nel momento in cui ogni generazione comincia a guardarsi indietro, il punto in cui si fissa è situato di solito vent'anni prima? Fino a poco prima forse guardarsi indietro non conveniva: c'era la guerra, razionamenti e bombardamenti. Nel 1967 all'improvviso è come se si aprissero gli archivi: tutto il passato diventa riciclabile, ricolorabile, interessante. La parola "postmoderno" è ancora un tecnicismo accademico: i Beatles non sono stati ancora informati ma sono già i più postmoderni di tutti. C'è però un prezzo da pagare; il nuovo disco sarà pieno di musica di ogni genere, ma il rock per ora è sospeso: confinato nel brano di esordio e nella ripresa sul secondo lato. Come se fosse un genere ancora troppo moderno per essere rivisitato.
65. You're Going to Lose That Girl (Lennon-McCartney, Help!, 1965)
"Mi farò un punto d'onore di portarla via da te". Cosa ci fa così in alto You're Going to Lose That Girl? Non lo so. È soprattutto colpa di Rolling Stone, nella loro classifica questo pezzo di Help! sta addirittura intorno al trentesimo posto. Eppure è uno dei brani meno innovativi del disco, un deciso sguardo indietro ai fasti della Beatlemania. Inserito nell'edizione inglese del disco tra due brani come Another Girl e Ticket to Ride, che mostravano ormai un approccio affettivo più adulto e libertino, You're Going ci precipita per un momento nella beatlesfera di due anni prima, quell'indistinta balera in cui i ragazzi vanno a corteggiare le ragazze con l'obiettivo di stringerne le mani tremanti. È il mondo che abbiamo iniziato a conoscere con She Loves You, di cui però You're Going to Lose rappresenta il capovolgimento: se in quel caso il cantante si dava da fare per ricongiungere due innamorati che un "l'orgoglio" aveva separato, qui la coppia ormai è entrata nella fase inerziale in cui non c'è neanche più bisogno di uscire. Salvo che il cantante non ci sta: se non la porti fuori stasera, amico mio, ci penserò io e la tratterò bene ("c-cosa stai facendo?" canta il coro, meno complice del solito). Sono passati soltanto due anni, eppure sembra già una rimpatriata, un pezzo alla vecchia maniera con John che si atteggia a corteggiatore consumato, salvo impennarsi verso il bridge con un falsetto che, l'avesse cantato qualsiasi altro cantante, ci lascerebbe parecchio perplessi.
Anche stavolta, il trucco per trovare un po' di profondità nella canzone è immaginare che Lennon sia entrambi i ragazzi (proprio come in This Boy): quello che tratta male la sua ragazza e quello che dice a sé stesso: se continui così, la perderai. (Qualche anno più tardi, ma è un dettaglio che non c'entra molto con la musica, Lennon avrebbe chiesto ad Alex Mardas di provarci con sua moglie, probabilmente per dargli un appiglio nella causa per il divorzio) (ancora qualche anno più tardi, quando non riusciva più a reggere il problematico partner, sarebbe stata Yoko Ono a chiedere alla segretaria di sostituirla nella complessa funzione di fidanzata) (ma questo è gossip alla fine, il rifugio del critico musicale che non sa più cosa raccontare) (non è neanche colpa mia, cosa ci fa questa canzoncina così in alto, appena sotto a...)
64. Sexy Sadie (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
Saxy Sadie, ma come hai fatto? Per te ogni uomo è uscito matto. C'è qualcosa che stona in Sexy Sadie. Probabilmente è il pianoforte, inciso più lentamente e poi accelerato – sì, Sexy Sadie fa parte di quel cospicuo insieme di canzoni che Lennon immaginava un po' più lente del risultato finale. La dissonanza del piano è il punctum del brano, la qualità che rende Sexy Sadie riconoscibile anche dopo pochi secondi. Un'altra qualità sconcertante di Sexy Sadie è l'inversione tra strofa e bridge – il secondo, se provate per una volta ad ascoltarlo da solo, è molto più cantabile e trascinante della prima, e porta un entusiasmo così solare che adombrerebbe persino certi brani di McCartney ("One sunny day, the world was waiting for a lover"). Eppure Lennon non ha mai pensato di invertire strofa e bridge: tutto questo entusiasmo solare, sin dall'inizio, era messo tra virgolette. Il risultato è un brano che per un minuto sembra prigioniero di una ruota di accordi scanditi dal piano che sembrano non avere un inizio o una fine – scivolano l'uno nell'altro in una matassa logica ma in cui non riesci a trovare il bandolo – finché il bridge non ti trova una possibile via di uscita che però ti riconduce presto allo stesso punto dove stavi annaspando un momento prima. Sexy Sadie, ma come facevi a saperlo?
Col Disco Bianco John Lennon diventa la persona che preferiamo tutti ricordare. Perfino da un punto di vista iconico, il Lennon più famoso resta quello sbarbato coi capelli lunghi nella foto ritratto – così diverso dal caporale baffuto di Sgt Pepper. È un uomo apparentemente più risolto di quello che incontreremo anche solo qualche mese più tardi, ed è molto ironico accorgersene proprio mentre canta la canzone più acida del disco contro un guru che lo aveva deluso. Viene quasi da rivalutarlo, questo Maharishi che invece di imporsi come un dio in terra si era lasciato scoprire come un uomo tra gli uomini, coi suoi difetti veri o presunti (le voci dei suoi approcci con le giovani ospiti, messe in giro da Alex Mardas, il personaggio più discutibile dell'entourage di Lennon, non sono mai state verificate). Lennon aveva bisogno senz'altro di meditare, di smetterla con qualche sostanza e di trovare il coraggio per chiudere il suo matrimonio; ma doveva anche recuperare il suo approccio disincantato che l'assunzione metodica di LSD aveva stemperato. E per quanto non ammetteremo mai di preferirlo al Lennon pop-surrealista di Strawberry Fields o di Walrus, il Lennon che amiamo è quello che mette l'umanità davanti al suo assurdo: quello di Happiness is a Warm Gun, di Bungalow Bill, di Sexy Sadie. Ci hai preso tutti in giro, ammette Lennon. Avremmo dato tutto quello che avevamo solo per sederci alla tua tavola. Come hai fatto a capire che stavamo cercando proprio te? È il Lennon in cui convivono al meglio il teppista di Liverpool ansioso di non farsi fregare, e il profeta internazionale con un messaggio per il mondo. Un equilibrio impossibile da mantenere se non per quei brevi istanti del Disco Bianco e i primi veri dischi solisti, Plastic Ono e Imagine. E tu lo sapevi per tutto il tempo, Sexy Sadie? O forse semplicemente sorridevi e fingevi di saperla lunga? Non importa, ha funzionato. Ma quanto è incredibile che a fine '68, all'apice del flower power, sul disco della band più importante del mondo ci fosse una canzone che sputtanava un guru indiano? Gli Stones, che ancora giocavano coi vecchi arnesi della religione occidentale in Sympathy for the Devil, sembrano a una rivoluzione di distanza.
63. Michelle (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)
Michelle/ma belle: sont les mots qui vont très bien ensemble. Perché ci proviamo con le straniere? Tu parli una lingua, lei un'altra: se malgrado questo state flirtando da mezz'ora, è abbastanza chiaro che entrambi cercate un'avventura. Non possono esserci equivoci su questo, per cui paradossalmente meno vi capite più è chiaro quello che desiderate l'una dall'altro e viceversa. È un modo di semplificare quel livello del corteggiamento che il romanticismo ha complicato in modo per molti insostenibile: il livello linguistico. È tutto molto più semplice, preumanistico: ci si guarda, ci si annusa si sorride, si ripetono frasi stereotipate che hanno un significato molto più basilare di quello offerto dal vocabolario ("I love you I love you I love you"). E poi per i maschietti ogni donna è un terreno da conquistare, il che rende la lingua straniera intrinsecamente sexy.
(Lo so che tutto questo è sessista. I Beatles sono un gruppo di ventenni degli anni '60: facevano notizia se nelle loro canzoni si parlava di droga, non di picchiare le donne. Non è colpa loro se oggi siamo diversi. Anzi in parte è anche merito loro).
La Francia è sempre stata un angolo cieco per i Beatles: il pezzo di continente europeo più vicino ma meno accondiscendente al loro fascino, così irresistibile altrove. L'Olympia aveva ricevuto i Beatles alla vigilia del boom degli USA, ma con freddezza, senza lasciarsi conquistare. Era anche un problema linguistico. Per fortuna dopo lo scoppio della Beatlemania la necessità di sfondare in mercati non anglofoni passò in secondo piano, per cui dopo avere re-inciso due singoli in un discutibile tedesco, Lennon e McCartney non dovettero ripetere l'exploit in altre lingue che conoscevano ancora meno (pensate se avessero provato a cantare qualche pezzo in italiano, come toccò fare persino ai Rolling Stones...)
E però la Francia restava lì, una frontiera vicinissima e solo apparentemente scontrosa. Non solo la Francia, ma un intero continente, un mercato di milioni di potenziali acquirenti di dischi, e un immaginario a cui i Beatles erano sensibili sin dagli anni del liceo, quel periodo in cui, spiega Paul, "tutti volevano essere Sacha Distel", ovvero chitarristi jazz prestati alla canzone confidenziale, ma soprattutto quel tipo di persona che passa da Juliette Greco a Brigitte Bardot con disinvoltura. "The bohemien French thing", insomma: Paul ha un chiaro ricordo di aver visto davvero a un festino di studenti d'arte (compagni di John) un ragazzo col pizzetto e la maglietta a righe cantare una languida chanson alla chitarra. In seguito lui stesso avrebbe cominciato a recitare per divertimento questa parte di chansonnier, ritirandosi in un angolo a bofonchiare in un francese immaginario di cui non abbiamo registrazioni – probabilmente era meno convincente del falso spagnolo di You Know My Name o Sun King. In queste situazioni suonava un arpeggio che gli aveva insegnato un compagno di classe, una cosa così antica che l'aveva imparata prima di invertire le corde della sua prima chitarra: il primo riff con linea di basso discendente della storia dei Beatles. Senza suonare particolarmente 'francese', era abbastanza diverso da tutto quello che i Beatles suonavano da poter sembrare, in un qualche modo, continentale.
Michelle nasce insomma nasce come farsa e non sarebbe neanche andata molto lontano se dopo il successo di Yesterday John Lennon non avesse proposto a Paul di ripescare "quell'arpeggio che suonavi alle feste", suggerendo anche il primo verso del bridge: "I love you I love you I love you". (Complimenti John, Paul probabilmente non ci sarebbe mai arrivato da solo...) Paul sceglie di conservare l'ispirazione vagamente francese del brano, facendosi dettare da un'amica un paio di frasi d'aggancio e creando la situazione di un idillio internazionale: idea semplice e geniale, che gli consente di bofonchiare il suo francese in modo credibile, o almeno non più ridicolo di qualsiasi giovane inglese in vacanza. Non sono in fondo tutte le canzoni d'amore dei Beatles che un grande frasario stereotipato per stranieri? Sin dai tempi di Love me Do / You know I love you / I'll always be true, i Beatles hanno riempito le loro canzoni di frasi d'aggancio per seduttori del sabato sera: e se nel 1965 il gioco cominciava a mostrare la corda, bastava postulare una ragazza straniera perché tutto tornasse miracolosamente semplice come due anni prima. Il testo di Michelle, se vi fermate a osservarlo, è demenziale: senz'altro il più scemo di Rubber Soul, ma anche il più furbo, perché si crea da solo una cornice in qui la demenzialità è perfettamente giustificata. Provate a immaginare la situazione se la voce narrante non fosse un divo del rock ma un tizio qualsiasi che approccia la tipa con una battuta sul suo nome: ti chiami Michelle? ah fa rima con ma belle! Ti amo ti amo ti amo, finché non trovo un altro modo te lo dico così. Ho bisogno, ho bisogno, bisogno... di farti capire cosa significhi per me, finché spero tanto che lo capirai. Ok, se la tizia non è scappata al primo bridge, evidentemente è interessata. Perché ci proviamo con le straniere? Perché possiamo spararle grosse, con la scusa che è l'unico modo di farsi capire. Ed ecco un'altra canzone autoperformativa: no, Paul non ci sta provando con una francese, ma con la Francia intera, e più in generale col mercato europeo. Il successo sarà spettacolare: numero 1 in Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, e... Francia, dove uscì in formato EP. Negli USA non uscì come singolo ma in compenso diede ai Beatles l'unico Grammy per la canzone dell'anno, nel 1967 (quando ormai l'avventura francese doveva essere un ricordo sbiadito). L'anno prima Yesterday aveva avuto una nomination, ma non ce l'aveva fatta.
Michelle viene spesso accostata a Yesterday, l'altro brano del 1965 con cui Paul si impose come l'ambasciatore dei Beatles nei vasti territori musicali non lambiti dal rock. Yesterday però è un'ossessione notturna a cui i Beatles non sapevano che forma dare, fino al punto di farsi sostituire da un'orchestra di camera; Michelle è un brano freddamente costruito a tavolino intorno a un fraseggio preso in prestito, inciso con una rapidità impressionante e mai più ripreso, mai suonato dal vivo, liquidato con la freddezza con cui a vent'anni si superano le avventure di una notte. Il risultato è comunque sorprendente. Non importa quanto siano sceme le parole e imbarazzante la situazione: Paul le canta con un trasporto che ci consente per due minuti la sospensione della credulità. Per due minuti lo yeh-yeh diventa esistenziale. I cori sono soffusi come nei brani del decennio prima (è come se John e George si tenessero fuori dal cono di luce); l'assolo ha la magniloquenza tipica degli inserti di George Martin, ma è il perfetto correlato musicale di un latin lover che alterna frasi appassionate a conclusioni spicce. L'idea geniale è quel timbro felpato che sa di radio a onde corte, di jazz anni Cinquanta ascoltato ballando stretti.
62. The Long and Winding Road (Lennon-McCartney, Let It Be, 1970).
Quante volte ci ho provato. Qualche anno dopo lo scioglimento dei Beatles, The Long and Winding Road avrebbe finalmente trovato la sua giusta collocazione al termine del doppio The Beatles 1967-1970, volgarmente conosciuto come il "Disco Blu". In quella posizione era molto più facile accettarla che nel bel mezzo di un disco come Let It Be, di cui tradiva tutte le premesse: doveva essere un ritorno al r'n'r, e sembrava Bacharach; doveva essere un disco suonato dal vivo, e invece era appesantita da un'orchestrazione tipicamente spectoriana – insomma, non c'entrava nulla col disco, era uno di quei brani che gli altri tre Beatles non apprezzavano e dopo che ci aveva messo mano Phil Spector sembrava che lo detestasse anche Paul.
Invece al termine del Disco Blu funziona, proprio perché non suona del tutto Beatles: persino al termine di un doppio in cui i Quattro sembrano aver tentato ogni stile musicale possibile, quando arriva The Long abbiamo la netta sensazione che la storia sia finita e i titoli di coda stiano correndo. È la sigla finale, così come Love Me Do è la sigla iniziale del Disco Rosso. E come succede con le sigle al cinema, ti fa venire una gran voglia di uscire prima che sia finita. Sembra sempre molto, molto più lunga dei suoi tre minuti e mezzo: meriterebbe un'indagine sperimentale il modo in cui infallibilmente riesce a far perdere la concentrazione dell'ascoltatore a metà brano. Ha a che vedere forse con il metodo Phil Spector, quella sua abitudine a saturare i solchi con una quantità di stimoli che però rimangono tutti vaghi, indistinti – lo chiamano muro del suono, ma io l'ho trovato sempre più simile a una nuvola, una nebbia che ti nasconde i dettagli e ti lascia libero di sostituirli con quelli che peschi dalla tua memoria; ma è anche facile distrarsi, se non proprio addormentarsi.
Sappiamo che Spector aveva qualche buon motivo per sovraprodurre il prodotto: per prima cosa il demo aveva qualche problema oggettivo: in particolare era necessario distogliere l'attenzione dal basso di Lennon (sempre il Fender VI). Ma soprattutto era Phil Spector, insomma se chiami Phil Spector non è che ti puoi lamentare della sovrapproduzione, è come invitare Sgarbi in tv e prendersela perché dice le parolacce. In effetti l'equivoco è questo: la canzone che ti fa pensare che tutto sia finito, e che Paul sia rimasto solo su una lunga strada tortuosa, in realtà fu prodotta nella situazione opposta: era McCartney a essersi ritirato in campagna, furono Lennon e Harrison a proporre a Phil Spector di prendere il malloppo e trasformarlo in un prodotto finito. Considerata la situazione e il personaggio bisogna riconoscere che fu più misurato del suo solito: l'idea di aggiungere cori e violini era autorizzata dallo stile del brano, che sin da quei quattro accordi sincopati iniziali sembra un tentativo di Paul di inseguire Bacharach sui sentieri delle radio AM ormai negletti dalla generazione di Woodstock. Il trattamento inoltre non è molto diverso da quello che George Martin aveva riservato a Good Night, la sigla finale del Disco Bianco. Sappiamo che Paul si arrabbiò molto, ma sappiamo anche che ormai Paul era alla ricerca di un casus belli per mollare la ditta. Il suo rapporto con la sua ultima canzone beatle resta ambiguo: nella sua versione "nuda" di Let It Be, il brano suona di nuovo come nel demo, con un breve assolo organistico di Preston nel punto in cui Spector più sfrenava i suoi orchestrali: però quando la suona dal vivo a quegli archi sovrabbondanti non rinuncia.
In The Long Paul riprende e rimescola due suggestioni di altrettante canzoni dell'album: dal Let It Be il ricordo della madre; da Two of Us l'immagine della strada. Il risultato è un testo molto più ispirato del solito, che purtroppo fatica a imporsi all'attenzione distratta dai violini e dalla sensazione di trovarci al termine del percorso. Per commuoversi basta pensare (come con Two of Us) che Paul la canti a John. Una bella forzatura, certo, nel 1970. Già qualche anno dopo la situazione era molto diversa. Oggi ormai è impossibile non pensarci. Quante volte sono rimasto solo, quante volte ho pianto. In ogni caso non saprai mai in quanti modi ci ho provato... solo per ritrovarmi di nuovo su questa lunga strada tortuosa dove mi hai lasciato tanto, tanto tempo fa. Non lasciarmi ancora qui, guidami alla tua porta.
61. I Should Have Known Better (Lennon-McCartney, A Hard Day's Night, 1964).
Se questo è amore me ne devi dare di più! Dammene di più! Ok, cosa ci fa questa così in alto? Chi si è bevuto il cervello stavolta? Sempre Rolling Stone – ma anche Entertainment Weekly – per farla breve: gli americani. È una cosa di cui tener conto: mentre da questa parte dell'oceano siamo tutti abbastanza persuasi che i Beatles migliori siano quelli maturi, almeno da Rubber Soul in poi, negli USA la Beatlemania ha lasciato un segno più indelebile che forse non siamo in grado di comprendere. Ci manca la percezione dello choc, insomma, questi venivano non da Marte ma quasi: da Liverpool. Con il loro buffo accento e quel taglio di capelli così europeo, arrivavano a riproporre una serie di stilemi della musica popolare americana ma stravolgendoli completamente. A conquistare gli americani dev'essere stata questa sensazione di spaesamento e insieme di familiarità: heimlich/unheimlich. Prendi questo brano che apparentemente è l'ennesima variazione yeh-yeh, salvo che la progressione è abbastanza originale e contiene soluzioni che sorprendono ancora oggi gli esperti.
Nel reparto parole, Lennon si sta già costruendo un personaggio più ambivalente di quanto possa sembrare: è un maschio che ha appena scoperto che l'amore è un'esperienza molto più interessante di quel che credeva. Nel brano successivo avvertirà che l'amore è "molto più che stringersi la mano", ma qui in un certo senso la situazione è opposta: il John di I Should Have Known di mani deve averne strette già molte, né dev'essere a digiuno di pratiche anche più spinte: ma non contano più perché... non erano autentiche. Di fronte al Vero Amore, anche un lavoratore dell'indotto del quartiere a luci rosse di Amburgo ritorna vergine, e questo è veramente un colpo di genio. "Poteva succedere solo a me", dice John, e in un colpo solo ammette: (1) un passato scapestrato da teddy boy impenitente e (2) la coscienza pura di un bambino nuovo alle gioie dell'amore. Questo volevano le ragazze dai Beatles: il brivido del proibito, la tenerezza del ragazzino. Questo volevano da John e John lo sapeva meglio di tutti, hey hey hey! Quando vi dirò che siete mie, voi mi direte che mi amate. Quella soddisfazione che solo l'amore corrisposto ti dà, come un improvviso sbocco di miele nelle vene.
Le canzoni dei Beatles (#80-70)
17-06-2020, 10:52beatles, Il Post, musicaPermalinkPuntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-81).
La playlist su Spotify.
80. And I Love Her (Lennon-McCartney, ma quest'ultimo ammette che andrebbe attribuita anche a George Harrison; A Hard Day's Night, 1964).
"L'ho scritta, l'ho portata in studio, l'ho mostrata ai ragazzi e poi George Martin, il produttore, ha detto: sarebbe bello se ci fosse un'intro, qualcosa che facesse partire la canzone, no? Ci siamo seduti a rifletterci e George Harrison ha detto: che ne pensate di du-du-du-dum..."
Come onestamente confessa Paul McCartney nello stesso video, senza quel "du-du-du-dum" non c'è la canzone. Certo, lui l'ha scritta, ma senza quelle quattro semplicissime note di George, non sarebbe valsa la pena registrarla: e Paul McCartney avrebbe di nuovo fallito nella missione di scrivere per i Quattro un pezzo confidenziale. Perché se si toglie l'acerba PS I Love You, lato B di Love Me Do, fino a questo momento era stato John Lennon con This Boy e If I Fell a dimostrare una certa dimestichezza con la materia. Paul quando voleva atteggiarsi a crooner era ancora costretto a ricorrere a canzoni non sue (pescate ai margini estremi del beatleverso, e non esattamente corrispondenti al modello del 'lento ballabile': A Taste of Honey, Till There Was You). Con And I Love Her finalmente fa centro in quello che tutti da qui in poi considereranno un suo reparto: ci riesce abbassando i volumi, mettendo in mano a Ringo bongo e legnetti, imponendo un ritmo vagamente latino (sua antica ossessione), e un attacco con un accordo in fa# minore che ti dà la sensazione di arrivare a canzone già cominciata, come se da qualche parte si fosse perso un Mi maggiore iniziale: che infatti arriva, ma soltanto al culmine della strofa, proprio sulla parola "love her" (non è questa gran coincidenza, c'è un "love" in un verso su due). Paul l'aveva scritta così, in dispregio delle convenzioni musicali (qui rappresentate dal pur ragionevole George Martin) che imponevano un minimo di introduzione. Da questo punto di vista il riff superminimale di George Harrison è un perfetto compromesso, un fragile ponte di note che evoca quel Mi maggiore iniziale fantasma (le prime due note sono proprio Si e Mi, fondamentali componenti dell'accordo in Mi maggiore), per condurre al Fa# minore. Funziona così bene che anche se siete convinti di averlo sentito in tutte le strofe di And I Love Her, in realtà compare appena in due su quattro, alternandosi a quell'arpeggio mandolineggiante, una triade semplice ma di sicuro effetto – in effetti il segreto dell'incanto di And I Love Her è il suo essere un quadro sofisticato fatto di pezzi facili.

Tra i tanti paradossi dei Beatles, vale la pena di notare stavolta quello chitarristico: mentre i riff più fragorosi e sovrabbondanti sono tutti di Lennon, il chitarrista meno tecnico (I Feel Fine, Day Tripper, And Your Bird Can Sing, Dig a Pony), mentre i contributi più chiassosi e rumoristici addirittura sono di McCartney (Taxman, It's All Too Much, Helter Skelter), quelli più essenziali e semplici sono di George, la chitarra solista, colui che più facilmente avrebbe rischiato di sbagliare qualcosa dal vivo – mentre in studio forse John aveva il problema opposto, ovvero dimostrare a sé stesso e ai colleghi di essere alla loro altezza. E può darsi che a sua volta Paul, le rare volte che si trovava una chitarra elettrica in braccio, sentisse un'esigenza complementare: mantenere un po' di credibilità rock, dimostrare di poter essere rumoroso quanto gli altri, anzi il più rumoroso di tutti. La chitarra come una sfida, per tutti e tre: a Paul chiede più confusione creativa, a John più tecnica, a George più disciplina.
La timidezza di George risulta anche dall'assolo, che alla quarta strofa costringe i colleghi a un bizzarro salto di tonalità di appena un semitono. La sua Ramírez acustica non fa molto più che ribadire il languido tema della strofa, condendolo ancora un po' di quella salsa mediterraneo-caraibica che in un disco ancora molto yeh-yeh come A Hard Day's Night poteva risultare un gradevole diversivo . Oggi invece risulta uno degli aspetti più datati: oggi del resto i dischi dei Beatles sono materia di ricerca accademica, nessuno li mette più sul piatto per fare quattro salti e attendendo il brano lento per strusciarsi un poco. Fino all'ultima sorpresa della canzone, quel Re maggiore imprevisto eppure necessario entro il quale ci conviene aver concluso quello che dovevamo concludere, perché la banda sta per ripartire in quarta. Tell Me Why-ay-ay-ay you cry...
79. It Won't Be Long (Lennon-McCartney, With the Beatles, 1963).
La prendo alla lunghissima: dopo aver piazzato qualche promettente cortometraggio a colori, nel 1933 la Walt Disney Production fece il botto con Three Little Pigs, l'esilarante capolavoro dei tre porcellini alle prese con un lupo cattivo con un debole per i travestimenti. La gente andava a rivederlo tutte le sere, non importa che lungometraggio ci fosse in programma: gli otto minuti dei Porcellini valevano il biglietto intero. Dopo un anno era ancora in molti cartelloni. Nel frattempo ovviamente Disney aveva commissionato alle sue maestranze un seguito con i Tre Porcellini, il Lupo sempre più drag, e un ospite d'eccezione: Cappuccetto Rosso. Fu un buon successo... ma non superò il successo di Three Little Pigs. Al che Disney pare che abbia detto l'immortale frase: "You can't top pigs with pigs", non puoi sorpassare i maiali con altri maiali: che è anche il motivo per cui se date un'occhiata al canone dei lungometraggi Disney, vi rendete conto che fino a qualche anno fa i sequel erano estremamente rari (la maggior parte erano sottoprodotti straight-to-video, che non venivano distribuiti nelle sale).
Certo, oggi non si ragiona più così. Oggi ormai ha vinto il modello Lucas, un tale che aveva un'idea per un film che se nel caso avesse funzionato sarebbe stato il quarto capitolo di una saga di nove, e il cinema è pieno di sequel e reboot e sequel dei reboot e reboot dei sequel. Disney ragionava in un altro modo e per più di mezzo secolo ha avuto ragione: i sequel sono per i mediocri. Chi vuole sempre fare di meglio, deve inventarsi qualcosa di nuovo. Lo aveva capito sul campo: proprio come i Beatles, che dopo aver fatto il botto riempiendo una canzone di "yeh yeh" stavano realmente domandandosi se il segreto del successo fosse tutto lì, nella loro capacità di spalmare qualche yeh e qualche woah in tutte le canzoni. Fino all'estremo di It Won't Be Long, il fulmineo attacco del secondo LP, dove "Yeah" viene pronunciato cinquantasei volte in duecentodieci secondi. Se il segreto del successo era il numero di "Yeah", It Won't Be Long avrebbe incendiato le radio. Non andò così. Il brano non fu scelto neanche come singolo – anche perché l'alternativa era I Want to Hold Your Hand.
Questo è forse il motivo per cui è il mio yeh-yeh preferito: non l'ho sentito milioni di volte tra i classici del Disco Rosso, l'ho scoperto più tardi e non me ne sono ancora stancato. Inoltre sono pur sempre un ascoltatore della generazione post-punk, in quella che nel 1963 poteva risultare sfacciataggine nel frattempo riconosco un senso dell'eccesso che sono stato educato ad apprezzare: questa canzone caricata di yeh yeh all'inverosimile, ascoltata magari in cuffia con gli yeh yeh che si fanno eco, è uno sballo, è ipnotica ed euforica allo stesso tempo. Lennon sta cominciando a stancarsi della 50s' progression (il giro di Do: I-VI-IV-V). Nel ritornello fulmineo trattiene soltanto i primi due accordi, li inverte e li ripete (VI-I-VI-I), ottenendo un effetto così moderno che gli ascoltatori dei Franz Ferdinand a metà anni Duemila probabilmente non si stavano accorgendo di ascoltare un pezzo dei nonni (un pezzo che i nonni suonavano più veloce). Nel primo bridge prende l'accordo IV e lo abbassa addirittura di un semitono, una cosa che è l'equivalente sul piano compositivo di afferrare una chitarra e spaccarla sul palco. Il secondo bridge – sì, perché ce ne sono due diversi che si alternano un po' a caso – è meno ardito ma contiene un coro di Paul e George che funziona come contrappunto. Il gioco di parole "be long / belong" conduce a loro insaputa i Beatles a una delle inversioni semantiche più interessanti della loro produzione: per John ritrovare una ragazza equivale ad appartenerle. "Non ci vorrò ancora molto... prima che sarò tuo". Non è nemmeno un rituale di seduzione: i due sono già assieme, ma il maschio si sente derelitto perché lei è lontana, e si gonfia di speranza perché sta tornando a casa! E quando accadrà "sarò buono come so che mi devo comportare". Sembra una gag.
Con la sua struttura insolita It Won't Be Long va dritta nella lista delle grandi hit mancate della Beatlemania, con Every Little Thing e poche altre. Definirli errori di percorso è difficile: sono spuntate al momento sbagliato, all'ombra di altre canzoni che era più facile scegliere come singoli. Probabilmente sarebbero stati anch'esse dei successi, se ci fosse stato il tempo. Eppure è davvero l'ultima canzone puramente "yeh-yeh": di lì a poco l'affermazione tipicamente liverpooliana sarebbe quasi del tutto scomparsa dalle loro canzoni, molto prima di annoiare l'ascoltatore. You can't top yeahs with yeh-yeahs.
78. I'm So Tired (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
I don't know what to do. Può risultare piuttosto ingenuo, quando parla di politica, John Lennon. Può risultare scorretto quando parla di donne. Ma quando parla di sonno, ecco: sa esattamente di cosa sta parlando. Che tu sia un morto di sonno o viceversa un insonne allo stadio della disperazione, se conosci I'm So Tired sai che è il tuo inno. I'd give you everything I've got for-a little peace of mind!
Lennon la concepì durante quel lungo soggiorno indiano che per lui dovette essere anche un'esperienza di disintossicazione. Niente più acidi, niente alcol (nel finale chiede a un immaginario barman francese di versargli un altro bicchiere), sigarette quante ne basta per maledire in eterno Sir Walter Raleigh che le aveva introdotte in Inghilterra: improvvisamente le notti non finiscono più e il pensiero di quella tizia giapponese diventa ossessivo. You know it's three weeks, I'm goin' insane! Qualche mese dopo, tutto quello che resta di quell'angoscia è una breve canzone che sembra quasi una paginetta di diario infilata tra le pagine del Grande Album Bianco – effetto forse voluto: d'altronde I'm So Tired è credo l'esempio più tipico di come i Beatles hanno lavorato al doppio disco.
Si parte da un progetto molto più articolato di quanto lascerebbe sospettare il prodotto finito, registrato da John su un multitracce e condiviso coi compagni alla riunione di Escher. Dura tre minuti e prevede tre strofe, una parlata – classico espediente del woo-dop, e ancor più delle parodie del doo-wop che Lennon e McCartney facevano sin da quando erano due ragazzini con due chitarre e un registratore. Questa strofa viene presto accantonata, anche perché Lennon ha intenzione di usare lo stesso trucco nella parte finale di Happiness is a Warm Gun. Così tagliato, il brano viene inciso a Abbey Road, e re-inciso, e sovrainciso fino all'esaurimento tutte le otto tracce disponibili, per ottenere un risultato che... sembra registrato da quattro tizi in un garage, uno dei quali sicuramente rimbambito dal debito di sonno. Ma appunto, sembra.
In realtà tutta questa immediatezza, questa apparente grossolanità del risultato finale, è il risultato di un'attenta cura al dettaglio. I'm So Tired somiglia a quelle poesie tornite per anni e anni che gli autori romantici sostenevano di avere composto di getto in una notte di plenilunio. Per rendersene conto è sufficiente confrontarla con l'Escher Demo, in cui risulta chiaro che Lennon ha già in mente quello che vuole esprimere, ma non ha ancora trovato i mezzi giusti per farlo: il ritmo era più lento, la voce più spinta sul falsetto, tutte scelte apparentemente logiche ma, confrontate col risultato finale, meno efficaci.
Il motivo per cui la versione finale di I'm So Tired sembra molto più grezza di quanto non sia sta nella prima impressione che ci fa: appena parte il basso (risalendo la scala appena discesa in Martha My Dear), John attacca "I'm so tired" e noi istintivamente abbiamo già un'idea dell'accordo che sta per suonare: se è partito in La, sta per arrivare il Fa diesis minore. Non può che andare così, lo sanno tutti i peggiori chitarristi. Sarà la solita parodia del doo-wop, la solita 50s' progression. E invece le dita di John si stringono sul capotasto sbagliato, regalandoci un Sol# che persino gli spartiti ufficiali si rifiutano di registrare, eppure è lì, e se non si può dire che stoni troppo con gli accordi successivi e precedenti, senz'altro stona con le nostre legittime attese: e sì che lo sappiamo che non c'è da fidarsi con Lennon e McCartney, che per loro il giro di Do è solo una base da cui scantonare appena qualcuno si distrae. Nel verso successivo del resto John suona davvero un giro standard col Fa# al posto giusto, il che ci rende se possibile ancora più perplessi: siamo noi che non siamo in squadra, o è lui? Siamo noi. Lui è John Lennon e nel 1968, mentre meditava in India, ebbe l'idea di descrivere l'angoscia dell'insonnia modificando un accordo nel giro di La. Il risultato è un brano che perseguita ancora le nostre notti insonni e c'è qualcuno che ha il coraggio di dire che la meditazione non serve. Oh m'sieur m'sieur, m'sieur, posso averne un altro?
77. Lovely Rita (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967).
 La canzone più sottovalutata del disco più sopravvalutato? Lovely Rita è una delle canzoni che traccia netto il solco tra ascoltatori occasionali e beatlemaniaci – i primi non se la ricordano, non ci fanno caso: i secondi vorrebbero vederla andare avanti il più possibile, tifano per lei, ma come si tifa per quella squadra che sai già che non può che deluderti. È una canzone fatta di tante cose fantastiche, che però per qualche mistero non riescono a comporre un quadro d'insieme.
La canzone più sottovalutata del disco più sopravvalutato? Lovely Rita è una delle canzoni che traccia netto il solco tra ascoltatori occasionali e beatlemaniaci – i primi non se la ricordano, non ci fanno caso: i secondi vorrebbero vederla andare avanti il più possibile, tifano per lei, ma come si tifa per quella squadra che sai già che non può che deluderti. È una canzone fatta di tante cose fantastiche, che però per qualche mistero non riescono a comporre un quadro d'insieme.La prima cosa fantastica è l'introduzione, uno di quei momenti fortuiti in cui tutto si combina in modo meraviglioso: chitarra, pianoforte, Lennon che vocalizza senza più vergogna per il timbro femmineo della voce, Ringo che scalpita con rullante e tomtom pronto a partire in quinta. Vuoi vedere che finalmente arriva un pezzo rock in Sgt Pepper?
La seconda cosa fantastica è il ritornello di John, anche se tradisce proprio quest'attesa – sembra vagamente un raga, ha un incedere ipnotico e forse in un altro contesto avrebbe funzionato anche come coro da stadio: Lovely Rita meeter maid, Lovely Rita meeter maid.
La terza cosa fantastica è Paul che finalmente prende il controllo, con un certo entusiasmo ma un'idea di canzone completamente diversa da quella che ci eravamo fatti fin qui: un bozzetto spiritoso su un'ausiliaria del traffico che gli fa sesso. Però all'inizio è talmente entusiasta che l'idea par buona. Provate a canticchiare la frase "when it gets dark I tow your heart away" (o "when are you free to take some tea with me"). È una gioiosa cascata di note, forse barocca, che evoca lo squillo di una tromba: è lo stile 'squillante' di Paul, che che illumina qua e là tutto il Concetto di Sgt. Pepper, anche quando la sezione di ottoni non è presente (invece c'è una specie di sezione di kazoo, un suono processato a base di pettini e carta velina che possiamo contare come quarta cosa fantastica).
Come la successiva Good Morning, Rita non è facilmente ricollegabile all'orchestrina dei Cuori Infranti, eppure è una tipica composizione pepperiana, che non si troverebbe al suo posto in qualsiasi altro disco precedente o successivo. E per una volta Paul riesce a mettere giù un testo genuinamente spiritoso, giocando addirittura con la sua figura pubblica di fidanzato d'Inghilterra. Quinta cosa fantastica.
La sesta è l'assolo pianistico di George Martin, molto più misurato dell'inserto barocco di In My Life, su cui riverbera la gioia di vivere espressa da Paul nel brano. E allora perché con tutte queste cose fantastiche il brano non decolla? La sensazione è che al netto di tutti gli effetti sonori, i kazoo e i bisbigli, il gruppo non stia suonando molto più che un quattro quarti lento, con un sottofondo chitarristico un po' involuto – come se la sperimentazione stesse prendendo la mano, e l'attenzione ai dettagli impedisse a Martin e ai ragazzi una vera visione d'insieme. Così il ritornello di John, quando finalmente si fa vivo verso la fine, sembra già molto meno interessante. Poi c'è l'angolo dei rantoli alla Freak Out!, che ai tempi doveva risultare uno dei mezzi minuti più coraggiosi del disco, un'ulteriore conquista per il fronte di liberazione giovanile mondiale, ma oggi la rende al massimo la canzone dei Beatles meno adatta da ascoltare coi bambini. Magari la mia insoddisfazione con Lovely Rita è tutto qui: che senso ha ascoltare i Beatles se non puoi farlo coi bambini?
76. Love Me Do (Lennon-McCartney, lato A del primo singolo Parlophone nel 1962, poi in Please Please Me, 1963).
"Amami un po' / lo sai ti amerò / fedele sarò / per sempre, perciò..." Kate Bush scrisse Wuthering Heights a diciott'anni. Mozart alla stessa età già componeva melodrammi. Lennon e McCartney a vent'anni erano già performer trascinanti, ma come compositori, ecco, diciamo che il loro genio era un segreto ben nascosto, anche a loro stessi. Questo li separa irreparabilmente da tutto il rock che è venuto dopo di loro (ed è venuto grazie a loro), legato in modo così indissolubile al concetto di gruppo-che-incide-le-proprie-canzoni: band fondate da artisti che in molti casi cominciavano a scrivere canzoni molto prima di imparare a suonarle. Ovvero, diciamo che da metà degli anni Sessanta in poi il rock diventerà per prima cosa un'urgenza creativa, un modo per esprimere i propri stati d'animo attraverso progressioni di accordi e testi più o meno ispirati.
Tutto questo era cominciato coi Beatles – eppure all'inizio i Beatles non erano così. Chiunque cerchi di considerare Lennon e McCartney due geni deve venire ai patti con l'evidenza: le loro primissime canzoni non contengono nulla di manifestamente geniale. L'urgenza creativa fino a tutto il 1962 sembra molto meno impellente di quella di suonare rock'n'roll e ballabili già disponibili nei negozi di dischi. Poi certo, qualche giro di accordi lo avevano già sperimentato, Paul in particolare sin da ragazzino, a volte semplicemente per recuperare una canzone che aveva ascoltato alla radio e di cui non possedeva né disco né spartito: ma senza produrre niente di paragonabile a Wuthering Heights o che lasciasse immaginare in lui il futuro autore di Yesterday. Ad esempio tutto quello che poteva offrire alla Parlophone nel 1962 era Love Me Do: forse il solo brano di Lennon–McCartney che sia Lennon sia McCartney hanno cercato non di attribuirsi ma di scaricarsi a vicenda. Per John era tutta "roba di Paul" e sosteneva di avergliela sentita canticchiare per anni; Paul da canto suo è sicuro che si sia trattata di una collaborazione alla pari, "50/50", e considerando l'importanza che nel brano ha l'armonica cromatica rubata da John sulla via di Amburgo si fa fatica a dargli torto.
All'inizio la voce di John era anche quella solista – nei rari momenti in cui non è prevista l'armonia a due voci; fu George Martin a spostare l'incombenza su Paul, perché John non avrebbe potuto staccare l'armonica in tempo. Ma in generale Love Me Do è l'esempio di scuola di come gli elementi "Lennon" e "McCartney" fossero miscelati nel composto iniziale: è stucchevole come Paul, sguaiato come John. C'è il blues e la polka, l'armonia e la dissonanza, e soprattutto non si può cantare da soli: provateci. Sembra facile, ma il risultato è sempre deludente. Non esiste una Love Me Do per solista: l'unico vero fascino della canzone sta nell'armonia, o meglio nel contrappunto: nella distanza tra le due linee cantate che si divarica e si incrocia in modo inatteso (e sconosciuto ai manuali). Love Me Do ha un senso soltanto se la canti in due. Se i maestri erano gli educati Everly Brothers, i Beatles si dimostrano da subito studenti irrequieti e disattenti: invece di mantenere il classico, everlyano intervallo di terza, John e Paul svirgolano in libertà suggerendo accordi molto più complessi di quelli che sta suonando George Harrison alla chitarra.
Con tutto questo, Love Me Do rimane un brano abbastanza sconcertante: chi di noi sentendolo alla radio per la prima volta, avrebbe scommesso sul futuro della band, e soprattutto degli autori? Tanto più suscita stupore la scelta di George Martin, che in quel brano vedeva qualcosa che oggi non vediamo con tutta la buona volontà del mondo, e coi migliori equipaggiamenti sonori, e mezzo secolo di senno del poi. A differenza di molte canzoni che stiamo ascoltando a quest'altezza della classifica, Love Me Do non è un classico – se per "classico" intendiamo un brano che si riesce ad apprezzare anche ignorando il contesto storico in cui nasce e il pubblico a cui si rivolgeva. Così come ad esempio possiamo apprezzare Don Chisciotte anche senza conoscere altro del siglo de oro, o i drammi di Shakespeare anche se sono concepiti per teatri diversissimi dai nostri. Love Me Do sta così in alto in classifica per motivi storici – per l'affetto che si riserva alle opere prime anche quando non sono un granché; perché una generazione intera si è abituata ad ascoltare i Beatles sui dischi Rosso e Blu, trasformando Love Me Do in una specie di sigla iniziale, a cui si torna sempre con nostalgia, anche se siamo tutti d'accordo che la vera storia inizia subito dopo.
Per capire un brano come Love Me Do, e le motivazioni che convinsero i Beatles e George Martin a preferirla a brani sulla carta più definiti come Hello, Little Girl o How Do You Do It, ci serve appunto conoscere il contesto; capire cosa stavano trasmettendo le radio inglesi in quel 1962. Scoprire per esempio che l'armonica di John, che pure ci sembra così idiosincratica, era un riferimento fin troppo chiaro e commercialmente parassitario al disco che stava vendendo di più in Gran Bretagna in quel preciso momento: I Remember You di Frank Ifield, un cantante anglo-australiano i cui virtuosismi vocali ricordano altri esperimenti tentati da Lennon e McCartney nel periodo. Altrettanto utile è scoprire che il fenomeno più dinamico in quel periodo erano i complessi strumentali alla Shadows – privilegiati dai discografici anche perché potevano essere esportati negli altri mercati europei senza la fatica di trovare un traduttore e una cover band locale. E questo forse potrebbe parzialmente spiegare (non scusare) lo sconfortante minimalismo del primo testo inciso dai Beatles, quella strofa ripetuta quattro volte che in fondo è il loro primo nonsense, anche se purtroppo un senso ce l'ha ed è di una banalità straordinaria persino per le canzonette anni '60; compreso quel terzo verso, "I'll always be true", il più irritante di tutti per la manifesta ipocrisia: come si può credere a un simile impegno proferito da voci così sbarazzine? No, è molto meglio assumere che i Beatles pensassero alle parole di Love Me Do come materiale astratto che consentiva di aprire e chiudere le bocche negli intervalli previsti.
Love Me Do è infine uno dei rari spaccati della preistoria dei Beatles: accanto a qualche fuggevole indizio della loro futura grandezza, contiene tracce di tante cose che stavano per accantonare per sempre. È uno skiffle, probabilmente, con qualche accenno alla polka e chissà, forse al Cavern si ballava pure la polka: la reticenza dei testimoni oculari è comprensibile. È il brano che mandò in crisi Pete Best, il batterista che durante l'audizione alla Decca tutto sommato se l'era cavata dignitosamente e invece su Love Me Do fu un disastro. È il primo brano dei Beatles che Ringo dovette imparare, per scoprire poi ad Abbey Road che George Martin aveva già scritturato un turnista, tale Andy White. Alla fine fu incisa sia una versione con White (con Ringo al tamburello) sia una con Ringo, e i Beatlemani non hanno smesso di discutere quale sia la migliore. I'll always be true, so plea-ea-ea-ease...
75. Golden Slumbers (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
Una volta c'era un modo di tornare a casa nel sonno. Quanto dev'essere fantastico svegliarsi nei panni di Paul McCartney, con una melodia in testa che magari è Yesterday? Quanto dev'essere angosciante svegliarsi nei panni di Paul McCartney, quando ti accorgi che è da un po' che non ti viene nessuna melodia nuova e magari non te ne verranno mai più, è finita, avevi un dono e qualcuno te l'ha sottratto, forse sei venuto meno a una promessa come i fratelli cattivi delle fiabe, e non lo sai perché è successo dall'altra parte del sogno. E da questa parte c'è la Più Grande Band del Mondo da portare avanti, con la sua corte dei miracoli e un socio in affari che non va d'accordo nemmeno con sé stesso e la colerebbe a picco per capriccio. Se solo ci fosse un modo per tornare a casa in sogno – d'altronde, sei pur sempre nei panni di Paul McCartney. Ti basta sederti al piano di tuo papà, c'è uno spartito di una ninna nanna del Seicento, tu non hai mai voluto imparare a leggere la musica proprio perché meno ne sai, più hai spazio per inventarne: e infatti te la inventi e scrivi... la ninna nanna più assurda di tutte. Soooooogni d'or negli oooocchi tuoooooi! Su Youtube c'è uno sketch di Sesame Street con Bocelli che canta una ninna nanna al recalcitrante pupazzo Elmo, sulle note di Partirò. Proprio quando Elmo comincia a chiudere gli occhietti, Bocelli attacca l'acuto. Ecco, Golden Slumbers fa la stessa cosa ma in questo caso è umorismo involontario, una delle tipiche incongruità di Paul. Come quando canta I'm Down ridendo a trentadue denti, o racconta la storia di un assassino seriale come se fosse una filastrocca divertente e non la è. Lennon racconta che Paul ci sapeva fare coi bambini, compreso suo figlio Julian, molto più di lui. Non c'è motivo per dubitarne ma confrontando le ninne nanne lennoniane del Disco Bianco con quella che Paul scrive per Abbey Road, non c'è dubbio su chi dei due conoscesse realmente l'esperienza di addormentare un bambino.
Con Golden Slumbers il Medley di Abbey Road muove il passo decisivo verso il finale. Se è un carosello finale – e ormai ne ha tutta l'aria – Golden Slumbers è il momento in cui entra l'orchestra, cioè George Martin. Insomma qui a congedarsi è la premiata ditta di Yesterday e Eleonor Rigby, e lo fa con un brano che ne mette in luce i pregi e i difetti: il gusto barocco si perdona volentieri, forse perché si dà dei tempi sempre più brevi. Questo a George Martin bisogna riconoscerglielo: tutte le sue pretese sinfoniche non hanno mai allungato un pezzo dei Beatles più di trenta secondi, di minutaggio ne ha sprecato molto più Lennon con l'avanguardia e col blues. Golden Slumbers può non corrispondere alla tua idea di canzone dei Beatles; McCartney che si tira fuori dal ventre un acuto da Motown in una ninna-nanna sembra l'ideale per svegliare del tutto un bambino sonnacchioso; però è appena un minuto e mezzo, non glielo vuoi lasciare a Paul un minuto e mezzo per salutare gli orchestrali? Ed è commovente, non dite di no. I bambini da addormentare li avremo sempre, ma i Beatles si sono sciolti una volta sola. Un bel peso da portarsi sulle spalle, per un bel po' di tempo.
74. Because (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
Siccome il mondo gira, mi fa andare su di giri. La prendo un po' lontana: una volta ho sentito dire che Abbey Road è il beatle-disco preferito da Elio. Forse anche dalle Storie Tese. (A rifletterci è ovvio, anche se non è così ovvio da spiegare). Sarà per questo motivo, la prima volta che mi è capitato di ascoltare Ignudi tra i nudisti io avevo già capito il trucco. Hanno rovesciato una canzone, ho pensato. L'ho capito perché Elio aspirava e bofonchiava proprio come i cantanti quando il nastro di una musicassetta si rovesciava; perché il bridge arrivava molto prima del necessario; e la struttura in generale sembrava strana eppure in un qualche modo necessaria, come se ogni nota suonata e cantata mi stesse chiedendo di essere ascoltata in un qualche modo diverso. Ma non ci sono poi molti modi diversi di ascoltare una canzone; un'immagine si sviluppa in uno spazio bidimensionale, puoi inclinarla in vari modi; ma una canzone si muove solo nel tempo, l'unico modo di vederla in un modo diverso è invertire il senso del tempo. O forse l'ho capito al volo perché mi ricordavo che il disco beatle preferito da Elio è Abbey Road, e in Abbey Road c'è Because, e tutti a un certo punto ci siamo convinti che Because fosse nata da una sonata di Beethoven incisa al contrario... salvo che non è vero.
L'equivoco nasce da un appunto di Lewisohn: nello studio Yoko Ono esegue la sonata – dimostrando probabilmente, nell'occasione, una perizia con lo strumento superiore a quella di ciascun Beatle. John, pensoso, le chiede di suonarla al contrario. Yoko esegue, ed ecco Because. Dunque niente nastri invertiti in questo caso – l'inversione è manuale, il che ci pone altri interrogativi: cosa ha rovesciato davvero Yoko? L'ipotesi più convincente la spiega questo signore su Youtube.
Yoko dunque inverte l'arpeggio degli accordi, ma la Because vera e propria nasce soltanto quando Lennon decide di ricombinare l'arpeggio originale con quello invertito: per cui più che di un Beethoven rovesciato bisognerebbe parlare di un Beethoven specchiato e raddoppiato: ecco spiegato il mistero di Because, la sua arcana corrispondenza con una sonata di sue secoli prima. Come molte soluzioni è abbastanza deludente, e ci fa rimpiangere il mistero. Perché abbiamo creduto per tanto tempo che suonando il disco al contrario ci avremmo sentito Beethoven? Perché i Beatles coi nastri invertiti erano stati i primi a giocarci, benché nel 1969 anche questo gioco li avesse stancati; e più in generale perché Because, come e più di Ignudi, si presenta con una struttura ambigua e irrisolta, e ti dà la stessa sensazione che ogni nota debba stare esattamente dove sta, ma debba essere ascoltata in una direzione diversa da quella in cui la stai ascoltando. Sei dal lato sbagliato delle cose.
Siccome il vento fischia, mi fischia la testa. Ho sentito dire che c'è un universo parallelo dove il tempo gira nella direzione contraria alla nostra. Se con gli alieni di quell'universo potessimo vederci in conferenza su Meet, li vedremmo fare magari tutto quel che facciamo noi ma al contrario: e anche se fossimo simili o addirittura identici, non riusciremmo a capirci: all'inizio li saluteremmo dicendo "ciao" e loro ci risponderebbero "addio" perché tutto quello che ci diremo dopo loro ce l'hanno già detto. Non riusciremmo nemmeno a far loro ascoltare i Beatles, tranne forse Because, una canzone che per qualche scherzo dell'entropia faceva parte del loro universo ma è rimasta intrappolata nel nostro, come una manciata di antimateria.
Siccome il cielo è azzurro, mi fa piangere. Ha un che di lugubre, Because: è un esercizio mirabile ma freddo, astratto, e lascia un senso di insoddisfazione che il brano successivo non consola, anzi. Tutti però la trovano incantevole per via dei cori (specie da qualche anno in qua, quando è stata isolata la traccia vocale), tutti fingono di non avvertire che sono cori funebri. Il testo è composto da un trittico di giochi di parole tipicamente lennonniani che in un'altra canzone sarebbero apparsi esilaranti, e invece qui sembrano gli esercizi freddi di un dadaista di laboratorio. Poi arriva un bridge che per un attimo ti convince che la canzone potrebbe finalmente risolversi, e invece no: rimane sospesa, gelosa del suo segreto. Because di solito non viene considerata parte del medley finale di Abbey Road, eppure è un brano che fa sistema come pochi altri: le sue terzine sono una reminiscenza di Here Comes the Sun (anche se l'accordo in maggiore è passato a un minore), che a loro volta preparano l'orecchio all'arpeggio più semplice e marziale che ascoltiamo nella chiusa di You Never Give Me Your Money. Non solo: lo stile vagamente romantico la ricollega al crescendo finale di She's So Heavy, che aveva chiuso il lato precedente. Se George Martin è il principale responsabile di un certo filone barocco nelle canzoni dei Beatles, è curioso pensare che Yoko Ono potrebbe essere l'ispiratrice del filone romantico.
73. Getting Better (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967).
I used to get mad at my school (No I can't complain). Vent'anni fa, quando finalmente uscirono le prime rilevazioni statistiche sulla qualità dell'educazione in Europa, scoprimmo con una certa sorpresa che il metodo educativo migliore era quello... finlandese. Sul serio, non se l'aspettava nessuno. Del resto è per questo che esistono le rilevazioni statistiche, no? Per farci scoprire cose che non ci saremmo mai immaginati. E quindi, cosa aveva di così innovativo la scuola finlandese? Non lo sapevano nemmeno i finlandesi, che peraltro in quel periodo stavano cambiando metodo, abolendo le classi statiche, le lezioni frontali, ecc.. Addirittura smisero di addestrarsi ai test – e sì che erano diventati un modello per il mondo proprio perché i loro studenti erano stati i migliori a fare i test. In effetti da lì in poi sono sempre peggiorati nelle rilevazioni. Non importa, ormai abbiamo deciso che sono i migliori del mondo e continuiamo a invidiarli e cercare (malamente) di copiarli, anche perché abbiamo il sospetto che nelle loro scuole ci si diverta molto. E dunque anche noi stiamo mettendo in discussione le classi statiche, le lezioni frontali, ecc.. E peggioriamo anche noi, più rapidamente dei finlandesi (anche perché partivamo già più in basso). A un certo punto a qualcuno è venuto il sospetto: ma vuoi vedere che in realtà è tutto un equivoco? Che i finlandesi siano diventati un modello non per la scuola che stavano inventando in quel momento, ma per quella che avevano prima, quella con le classi statiche e le lezioni frontali e i professori esigenti e gli studenti suicidi? E se è così, vale proprio la pena di dirlo in giro?
I Beatles, fino al 1967, rappresentavano tutto ciò che c'era di nuovo e di migliore nella prima generazione postbellica. Con tutta la loro svergognata esibizione di talento allo stato brado, a Lennon e McCartney bastava scuotere le chiome in tv per avvertire che l'epoca del rigore era finita, che le vecchie scuole non servivano più a nulla, che gli insegnanti che "ci riempivano di regole" avevano i giorni contati. E in effetti è proprio così. Ma i Beatles quelle scuole le avevano pur fatte... E oggi che ogni briciolo di talento in ciascun alunno è vezzeggiato dall'asilo nido fino alla maturità, oggi che l'idea di restare attenti a una lezione per più di trenta minuti è vista come un abuso di potere, e ogni lezione dovrebbe essere gamificata: oggi ne saltano fuori dalle nostre scuole dei talenti come Lennon e McCartney? Apparentemente no. Ma forse è solo un bias.
Me used to be angry young man. I bias (vorrei tanto che si potesse chiamarli ancora "pregiudizi") sono "pattern sistematici di deviazione dalla norma o dalla razionalità nel giudizio". Uno dei più importanti è il bias del sopravvissuto, e ne soffrono tutti quelli che vogliono diventare youtuber o influencer (compresi molti youtuber o influencer). Ai miei tempi ne soffriva chiunque mettesse in piedi una rock'n'roll band. Insomma, il pregiudizio che perturba la razionalità del nostro giudizio è che vediamo un sacco di gente che ce la fa. Partono da zero e diventano uomini o donne di successo, ai miei tempi diventavano anche dei divi del rock, persino in Italia ne abbiamo avuti tre o quattro che hanno fatto soldi seri. Se tutta quella gente ce le fa, perché non dovremmo farcela anche noi? Perché siamo dei poveri illusi e facciamo caso soltanto a quell'uno su un milione che ce la fa: non ai 999.999 che ricadono a terra malamente.
Quel che è terribile è che anche l'Uno su un milione talvolta soffre dello stesso pregiudizio/bias, ovvero pensa: beh, se ce l'ho fatta io non doveva essere così difficile. E quindi sceglie di ridiscendere tra i suoi simili nelle vesti insopportabili dell'ottimista programmatico, il ragazzo fortunato che invita tutti a "credere nei loro sogni", perché più ci credi più si avverano. È un pattern sistematico di deviazione dalla norma che lo trasforma in un maledetto irresponsabile che manda poveri falliti a sbattere contro il muro della Realtà. I più altruisti creano etichette, sindacati di artisti, enormi bolle di talento inutile che creano effetti indubbiamente artistici quando esplodono. Poi la gente scrive che ce l'ho con Paul McCartney ma è il contrario, provo una sincera pena per lui, per la generosa speranza con cui fondò l'Apple e per come la vide marcire e cadere. Qualcun altro dopo aver sognato la melodia di Yesterday si sarebbe convinto di essere un genio sovrumano, lui tutto il contrario: da bravo babyboomer, era convinto che quel genio ce l'avessero tutti, e che bastava snidarglielo. In fondo fino a quel momento stava andando tutto bene. Stava andando sempre meglio. Tutto sempre meglio, tutto il tempo.
I Beatles sono l'equivalente musicale del bias del sopravvissuto. Li ascoltiamo, li guardiamo e pensiamo: di gruppi così non ne possono esistere più. Vediamo solo loro, non tutti quelli che ci hanno provato nello stesso momento e per qualsiasi motivo non ce l'hanno fatta. Viste le premesse era quasi fatale che dovessero diventare gli alfieri di quell'ottimismo moderatamente socialdemocratico che fino a quel momento animava la società europea e americana degli anni Sessanta. Rilassati, divertiti, sta migliorando tutto. Getting Better è il secondo sguardo all'indietro di Sgt Pepper, dopo With a Little Help (da cui riaffiora lo stesso quattro quarti martellante, una soluzione ritmica platealmente reazionaria rispetto a quelle proposte nel primo brano e in Lucy). Dopo i colori acidi di Lucy, è un ritorno al bianco e nero – te l'immagini suonata dai quattro manichini neri di Madame Tussaud, più che dai loro avatar in carne ossa dai costumi sgargianti. Cosa sarebbe successo ai Beatles se dopo Revolver si fossero detti: torniamo indietro? Siamo solo un gruppo pop-rock con un seguito di ragazze che stanno crescendo e vogliono cominciare ad ascoltare brani cantati da fidanzati ideali con la testa sulle spalle? "Sto facendo del mio meglio, e devo ammettere che sono diventato una persona migliore da quando tu sei mia". Avrebbero potuto accontentarsi di essere questo, i Beatles? Forse sì.
Tranne uno.
I used to be cruel to my woman. I beat her and kept her apart from the things that she loved. Così, a secco, senza neanche avvertire – la musica cambia appena un po', si percepisce una vibrazione sinistra che forse è un sitar, e nel bel mezzo del pezzo più pop di un disco pop, un beatle ci informa che era abituato a picchiare la sua donna. E quel beatle, anche se si nasconde dietro la voce serena di Paul, è evidentemente John Lennon. Perché scegliere proprio l'inno alle magnifiche sorti e progressive, per ricordare a tutti di essere un mostro geloso? Perché forse è finita – la stessa Cynthia conferma che l'ingestione quotidiana di LSD aveva posto fine alle violenze domestiche, non ditelo ai servizi sociali. Ma insomma la vita sta migliorando anche per John, e del resto "più di tanto non può peggiorare" (It can't get much worse). Scegliete voi cosa vi irrita di più: il vittimismo esistenziale del milionario John che anche quando si concedeva le sostanze migliori sul mercato continuava a cantare "sono solo ho voglia di morire", o l'ottimismo programmatico di Paul che porterà i Beatles a sfracellarsi commercialmente contro quel monumento alle velleità di una generazione che fu l'Apple Corps. Alla fine è impossibile non compatirli entrambi, in fondo erano due orfani che avevano vinto alla lotteria il ruolo di eroi di una generazione. Non è sorprendente che abbiano buttato via tanti e soldi (e anche molto talento). È incredibile che siano riusciti a resistere per così tanto tempo. E per così tanto tempo, a migliorare. Getting so much better all the time.
72. Yer Blues (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
Esatto, sono solo e voglio morire. Ma mettetevi un attimo nei Rolling Stones. Nascete suonando blues nell'indifferenza generale, finché qualcuno non ha la pensata di promuovervi come i rivali dei Beatles. L'idea frutta immediata visibilità, ma vi condanna anche a un confronto schiacciante, perché i Beatles non stanno fermi un attimo e anche a voi ora viene richiesta la stessa cosa, un attimo prima eravate un gruppo di blues inglese che cominciava a suonare credibile e un attimo dopo eccovi a strimpellare strumenti rinascimentali e bonghi, ma sempre tenendo un occhio a quello che fa la concorrenza, sempre con l'affanno di inseguire chi è partito prima e non deve imitare nessuno. Finché non ce la fate più – anche perché lo showbiz vi mangia vivi e la polizia non ha con le vostre consuetudini tossiche la stessa tolleranza che ha coi quattro Membri dell'Ordine Britannico. Arriva il punto in cui più che sembrare i lato oscuro dei Beatles sembrate diventati una parodia. L'accoglienza tiepida riservata a Their Satanic Majestic Request muove Jagger e Richards a un ripensamento: basta andare a rimorchio, ritroviamo la nostra identità. Eravamo un gruppo blues, rimettiamoci a suonare il blues. Ottima idea. Probabilmente è quella che ha salvato gli Stones, diciamo per quattro quinti. A dicembre esce un ottimo album, Beggars Banquet – proprio nei giorni in cui il Disco Bianco trionfa nelle radio di tutto il mondo, ma che importa? Non è più una gara, ognuno faccia quel che sa fare: e non c'è dubbio che ormai gli Stones sappiano fare un ottimo blues. Per promuovere il disco hanno un'idea: uno special natalizio per la televisione, proprio come il Magical Mystery beatlesiano dell'anno prima, ma meno immaginifico: un concerto ambientato in un circo, con Mick Jagger vestito da impresario. Ottima idea. E si possono anche invitare gli amici: gli Who, i Jethro Tull (con Tony Iommi!), Taj Mahal, e John Lennon, sì, dice che viene se può portare Yoko Ono. Lo accompagnano Eric Clapton (i Cream si sono già sciolti) e il grandissimo batterista dei Jimi Hendrix Experience, Mitch Mitchell. Un bassista non c'è, ma si presta Keith Richards. È la prima volta in assoluto che Lennon suona in pubblico senza in un gruppo che non siano i Beatles. E cosa suona? Yer Blues, dal disco appena uscito. Dopodiché?
Dopodiché suonano anche gli Stones, ma non ha molta importanza. Il Rock'n'Roll Circus non verrà mai programmato, sono gli stessi Stones ad accantonarlo. Non erano soddisfatti della loro prestazione, avrebbero voluto lavorarci un po', ma poi succedono altre cose. Brian Jones (che si aggirava sotto il tendone già in evidente stato confusionale) viene licenziato e muore poco dopo. Se il Circus è rimasto inedito fino al 1995, girl... you know the reason why. Dopo essere andati vanamente all'inseguimento dei Beatles per tre anni, tre anni in cui dischi ottimi avevano comunque perso la sfida con Revolver e con Sgt Pepper, gli Stones avevano deciso di concentrarsi su quello che sapevano fare meglio: sul rock e sul blues. Ottima idea... poi però arriva in casa John Lennon con la fidanzata matta e due amici, sale sul palco, suona un solo blues e li stende. Non c'è giustizia a questo mondo.
Il gruppo improvvisato in quel pomeriggio si chiamava "Dirty Mac" ("Vecchio sporcaccione"), uno sberleffo all'ultima novità del blues inglese, i Fleetwood Mac di Peter Green appena sbarcati in classifica con Black Magic Woman. Prima di far entrare Yoko fa in tempo a suonare un pezzo solo, ma quel pezzo è Yer Blues, e non c'è gara. Non c'è gara coi Fleetwood Mac e non c'è gara coi Rolling Stones. (Gli unici a non impallidire sono gli Who, ma loro non fanno blues, ormai sono un genere a parte). Nel 1968 lo stato dell'arte del blues inglese è un pezzo dei Beatles – ma com'è possibile? Che siano sempre i migliori, anche quando sono in crisi, anche quando perdono un manager e una direzione artistica? Possibile che a John Lennon in ritiro indiano basti pensare "adesso faccio un blues" per alzare di colpo il livello di tutto il blues inglese? Pure è così.
Anche se magari non sembra. Yer Blues non è invecchiata bene come altri brani del Bianco. In un disco pieno di pastiche in effetti c'è il grosso rischio di non prenderla sul serio. Per Lewisohn è una parodia del blues inglese del periodo. Potrebbe anche darsi – bisognerebbe ascoltare il blues inglese del periodo. I Fleetwood Mac, senz'altro, e ovviamente i Cream, gli Yardbirds di Jeff Beck e Jimmy Page e anche gli Stones di Beggars Banquet. Ecco, chissà se Lennon si è dato pena di ascoltarli. Magari nemmeno. Gli basta intonare "Yes I'm lonely wanna die" per far sembrare tutta la scena una platea di poser. O sciocchi, cosa pensate che sia il blues? un rock'n'roll per esperti, per filologi, per virtuosi della scala pentatonica? Non avete capito niente e non perderò tempo a spiegarvelo. Il blues è disperazione e voglia di morire, il blues è un urlo primordiale. E se non sono già morto, non è grazie al vostro soul di plastica. Nei quattro minuti di Yer Blues Lennon accelera, rallenta, inserisce fraseggi tipici nei posti sbagliati, un assolo di due-note-due, si permette insomma tutte le libertà che un purista inglese del blues nel 1968 avrebbe esecrato: e il risultato è il pezzo più robertjohnsoniano mai inciso in Inghilterra. Non hai bisogno di maestri per suonare il blues (l'unico che Lennon riconosce è il Dylan di Ballad of a Thin Man): basta aver voglia di morire, e John "si sente suicidiario come il mr Jones di Dylan".
Yer Blues va presa sul serio. Fa parte di quel mazzo di brani del Disco Bianco che attestano un precoce desiderio di ritorno alle origini; viene incisa dal vivo, in uno sgabuzzino, da quattro musicisti che vogliono tornare a guardarsi in faccia mentre suonano. I cambi di tempo che Lennon non era riuscito a chiarire con sé stesso nel demo, Ringo e Paul li afferrano al volo. Per quattro minuti i Beatles partecipano al Blues Boom del 1968 e riportano tutto a casa. Per ascoltare un blues inglese altrettanto viscerale e disperato bisognerà aspettare un annetto – il tempo necessario a Jimmy Page per rilevare gli Yardbirds e ribattezzarli Led Zeppelin: il gruppo che nei primi anni Settanta venderà più dischi... dei Rolling Stones. Yer Blues è invecchiata peggio di altri brani del Bianco perché, in effetti, è l'anteprima di quello che diventerà il marchio di fabbrica dei primi LZ: un nuovo genere di blues, ritmicamente imprevedibile, melodrammatico e urlato, sofferto e sanguinante. È abbastanza clamoroso che i pionieri del genere non fossero gli Yardbirds o i Cream o i Fleetwood, ma... gli autori e interpreti di Obladì Obladà.
71. I'm Down (Lennon-McCartney, lato B del singolo Help!, 1965).
"Plastic soul man, plastic soul". Cosa intendeva Paul con questo commento finale alla take 1 (si sente in Anthology 2? Non è chiaro, ma all'inizio del brano aveva affettato un accento americano per esprimere un desiderio: "let's hope this one turns out pretty darn good, huh?" I due commenti racchiudono il brano come due parentesi, o forse due virgolette. Come se Paul pensasse ad I'm Down più come a una performance che a una canzone. All'inizio c'è un misterioso americano che dice: speriamo che funzioni. E alla fine, lo stesso americano scuote la testa, anche se in una direzione ambigua: cosa vuol dire davvero "plastic soul"?
Oggi diamo per scontato che la plastica sia il materiale "finto" per eccellenza, quello che può prendere tutte le forme senza averne nessuna in natura – ma nel 1965 la plastica era ancora qualcosa di entusiasmante che stava migliorando la vita a milioni di persone. Un soul di plastica è necessariamente un soul finto? O piuttosto un soul malleabile, capace di plasmarsi a piacere? I'm Down fu registrata 55 anni fa, in uno dei giorni più interessanti della storia della musica, per via che durante le stesse sessioni Paul registrò anche Yesterday e I've Just Seen a Face. Tre canzoni così diverse, e tutte e tre così felici. Yesterday è dal primo istante uno standard confidenziale, I've Just Seen un post-skiffle irresistibile che Paul si sarebbe portato con sé anche nelle esibizioni live dei Wings, e quanto ad I'm Down... beh, era una mossa quasi obbligata. Persino tardiva. Da sempre i Beatles chiudevano le loro esibizioni con un pezzo urlato, che mandasse a casa il pubblico col sorriso sulle labbra e la voglia di rivederli al più presto. Il più famoso è Twist and Shout, ma molto più spesso avevano usato Long Tall Sally. Sempre cover, in ogni caso: non avevano mai tentato di scrivere un brano così. Finché nel 1965 Paul rompe gli indugi e scrive I'm Down. È anche un modo per inserire nella scaletta dei concerti un brano in più della ditta Lennon/McCartney: ma perché non ci avevano pensato prima? Cosa li tratteneva? È come se urlare una propria canzone non fosse facile come urlare una canzone di qualcun altro. Paul non può più nascondersi in Little Richard: deve essere sé stesso, ma chi è davvero?
Un ragazzo fortunato. Ci sono canzoni performative: Here Comes the Sun è un mattino di sole anche se fuori piove. Help! è davvero un grido di aiuto. I'm Down è esattamente il contrario: la più smaccata bugia mai raccontata da un cantante al microfono. Paul non è mai "down", anzi non è mai stato così felice. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di vedere i filmati delle esibizioni al Sullivan Show o allo Shea Stadium, dove ridono tutti come matti e John si cimenta nel suo assolo di organo Vox col gomito; o quella in Germania dove Paul si ricorda come ringraziare il pubblico in tedesco e poi dimentica le parole della sua stessa canzone, un bel lapsus. Perché assegnare a una canzone così divertente un testo brontolone come I'm Down? Non c'è un vero perché, a volte le canzoni nascono con le prime frasi che ti vengono in mente, e quando provi a cambiarle non trovi niente di meglio. Due sono gli argomenti che non tradiscono mai il paroliere: l'amore e il sentirsi giù, (gli americani lo chiamano "blues"). Non c'è bisogno di inventare niente, le frasi sono già pronte all'uso con le rime già pronte. Del resto non ha la minima importanza: come in Dizzy Miss Lizzy, come in Long Tall Sally, come in Twist and Shout, le parole sono solo un pretesto per urlare. E tuttavia vedere John e George ridersi in faccia mentre si dividono il microfono cantando "I'm down" sembra quasi una presa di posizione. Siamo i Beatles, nessuno ci prenda sul serio. Produciamo oggetti di plastica, i dischi questo sono. Ricicliamo il blues e il rock'n'roll e lo trasformiamo in canzoncine ridanciane, ed è divertente. La cosa vi scandalizza? Ce ne faremo una ragione. Ma sul serio: come potete deprimervi, mentre noi ridiamo?
Le canzoni dei Beatles (#90-81)
02-06-2020, 02:52beatles, Il Post, musicaPermalinkPuntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-101), (#100-91).
La playlist su Spotify.
90. Yellow Submarine (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).
And our friends are all on board... La prendo un po' lunga: all'inizio di Amadeus c'è questa gag straordinaria del vecchio Salieri che suona i suoi più grandi successi a un giovane confessore che deve ammettere di non averli mai ascoltati. Finché Salieri con un sorriso amaro, intona un motivetto che la mia generazione associa inevitabilmente al coro "Sai chi è / quel giocatore che / gioca a calcio meglio di Pelè...", e quella il confessore la riconosce al volo, come noi del resto. La canticchia pure. A quel punto siamo tutti contenti finalmente di essere inciampati in qualcosa che conosciamo. Ma abbiamo anche già intuito che quel qualcosa non l'ha scritto Salieri: l'ha scritto Mozart. E così il film riesce a persuadere noi ignoranti che Mozart è davvero un genio, perché? Perché ha scritto il Requiem? il Don Giovanni? No: perché lo cantano anche allo stadio.
Yellow Submarine è la canzone da stadio dei Beatles. È l'unica che da bambino avrei saputo cantare anche se non ne avevo mai ascoltato la versione dei Beatles, anzi quando alla fine la incontrai rimasi un po' deluso, mi immaginavo un technicolor disneyano e invece è un numero artigianale, alla buona, una cosa tra amici. Davvero, Yellow Submarine è un coro di amici, ma anche di colleghi di lavoro: come quando si portano i pasticcini in ufficio per un compleanno e si stacca tutto dieci minuti prima. Perché poi i Beatles di Revolver sono ancora dei professionisti con un occhio all'orologio, e tutto questo popò di festa con megafoni e gavettoni e belle ragazze e anfetamine gialle è confinato in due splendidi minuti e mezzo. Nei dischi successivi i Beatles si prenderanno molto più tempo per lanciarsi coriandoli e altre sostanze, ma nessuna festa riuscirà mai meglio di questa.
È incredibile che Yellow Submarine non sia nemmeno tra le prime 89 canzoni in classifica, sotto ad I'll Follow the Sun, i critici hanno le pastiglie gialle nelle orecchie. Tra un paio di secoli magari i Beatles li conoscerà soltanto qualche vecchio all'ospizio. Ai giovani operatori assistenziali canticchierà A Day in the Life senza attirare nessuna attenzione, canticchierà Strawberry Fields Forever ottenendo soltanto sguardi perplessi. Finché non intonerà "In the town where I was born", e allora sì, allora sorrideranno anche loro: questa la conosciamo, l'ha scritta lei? Complimenti.
(Il Sottomarino Giallo si muove nelle profondità di un progetto più volte abbozzato e mai veramente intrapreso: un disco sull'infanzia a Liverpool. "There are places I remember", cantava John l'anno precedente; "In the town where I was born" riecheggia Ringo, e anche se nessuno è consciamente autorizzato a identificare il "man who sailed to sea", non c'è modo di scacciare dal fondale il pensiero del padre di John, il marinaio che voleva portarlo da bambino in Australia e a quel punto i Beatles non sarebbero mai nati. Yellow Submarine è anche il tentativo di trasformare un passato difficile, impestato di ricordi della guerra, in un paradiso infantile: come se un bambino avesse trovato una vecchia foto di uno degli ordigni più orribili mai concepiti dall'uomo, un cilindro pressurizzato dove qualche decina di uomini vivono gomito a gomito in attesa di uccidere o essere uccisi, e decidesse di colorarlo col pennarello più sgargiante che ha, quello giallo).
89. I'll Follow the Sun (Lennon-McCartney, The Beatles For Sale, 1964).
 Io non c'entro niente, non guardate me. I'll Follow the Sun è una vecchissima canzone di McCartney – una delle prime a essere composta dal ragazzino, e si sente; è riciclata dai Quattro nel momento più disperato della loro fulminea carriera, ovvero quando nel 1964 stanno per partire per l'ennesimo tour senza un LP da vendere, e decidono coerentemente di registrare le prime cose che gli vengono in mente: qualche cover di cui fino a quel momento si erano vergognati, qualche pezzo buono ma che finirà eclissato da tanta mediocrità, qualche pezzo strano che alla fine dà a tutta l'operazione quel senso di incompiutezza che lo distingue, e siccome comunque non si arrivava alla mezz'ora incisero anche I'll Follow the Sun, con quella tipica strumentazione acustica che per un pezzo lento è la scelta più facile: vogliamo anche dire la più paracula? Ok, l'abbiamo detto.
Io non c'entro niente, non guardate me. I'll Follow the Sun è una vecchissima canzone di McCartney – una delle prime a essere composta dal ragazzino, e si sente; è riciclata dai Quattro nel momento più disperato della loro fulminea carriera, ovvero quando nel 1964 stanno per partire per l'ennesimo tour senza un LP da vendere, e decidono coerentemente di registrare le prime cose che gli vengono in mente: qualche cover di cui fino a quel momento si erano vergognati, qualche pezzo buono ma che finirà eclissato da tanta mediocrità, qualche pezzo strano che alla fine dà a tutta l'operazione quel senso di incompiutezza che lo distingue, e siccome comunque non si arrivava alla mezz'ora incisero anche I'll Follow the Sun, con quella tipica strumentazione acustica che per un pezzo lento è la scelta più facile: vogliamo anche dire la più paracula? Ok, l'abbiamo detto.I'll Follow the Sun ha il sapore acerbo, indefinito ma inconfondibile del pezzo scritto da un principiante che aveva in mente una melodia ma non sapeva ancora metterci gli accordi giusti, e mentre li cercava si è dimenticato anche un po' della melodia. Sono brani sghembi che è facile trovare nelle opere prime di molti artisti, mentre i Beatles avevano inciso già quattro album prima di cominciare a svuotare i cassetti. È probabilmente l'unico brano dei Beatles con quella progressione di accordi, ma è abbastanza per trovarcela davanti al numero 89, davanti a Yellow Submarine? Non chiedete a me, non porto pena, in questo caso fu USA Today quattro anni fa a mettere in fila 188 canzoni dei Beatles e a dichiarare, senza spiegazione, che I'll Follow the Sun si era classificata 27esima. Secondo me se l'erano dimenticata e all'ultimo momento l'hanno infilata nel primo buco che hanno trovato.
88. I'm a Loser (Lennon-McCartney, The Beatles For Sale, 1964).
I'm a Loser contiene uno dei versi più necessari della letteratura mondiale, ovvero: is it for her or myself that I'm crying? Non dico che dovremmo recitarlo tutti ogni volta che stiamo per metterci a piangere – ma quando abbiamo finito sì, vale sempre la pena di porsi il problema: per chi abbiamo pianto davvero? Come abbia fatto la Saggezza nel tardo 1964 a impossessarsi di una rockstar impasticcata che cominciava a stufarsi del carrozzone non si sa, non è chiaro – nel Libro dei Proverbi c'è una strofa gustosissima in cui la Saggezza pur di arrivare agli uomini si reca agli incroci delle strade, un luogo dove si esercitava uno specifico mestiere, che per gli autori biblici era quasi un'ossessione, ecco, invece la nostra ossessione sono le rockstar e quindi semplicemente la Saggezza non fa altro che svendersi, nei secoli dei secoli.
I'm a Loser contiene un altro verso fondamentale per la carriera compositiva di John Lennon, ovvero I'm not who I appear to be, il primo tentativo di scrollarsi di dosso quel personaggio pubblico che in quel periodo gli stava stretto (non solo metaforicamente: in quei mesi aveva preso parecchi chili, va' a sapere per quale pillola o quale crisi di astinenza da). Il pretesto narrativo è ancora quello di una insoddisfazione amorosa, ma Lennon sta cominciando a credere in quel che canta: persino la scipita rima "crown/clown" già opzionata dai Platters in The Great Pretender che si era ripromesso di non usare mai adesso ha un senso, adesso può essere cantata senza sembrare una sciocchezza: di lì a Help! il passo è breve.
I'm a Loser segue No Reply e precede Baby's in Black in quella che i beatleologi chiamano la trilogia lennoniana, i primi tre pessimistici pezzi di Beatles for Sale. Se appare meno innovativa di No Reply è per un effetto ottico: l'armonica che irrompe nell'inciso non è un ritorno alle origini ma l'annuncio di un nuovo continente appena scoperto. È una diatonica, stavolta: quando uscì I'm a Loser era il primo brano ad avere un distinguibile sapore folk se non proprio dylaniano, benché già completamente stilizzato; come se Lennon fosse riuscito a distillare quegli aspetti che rendevano in un qualche misterioso motivo Bob Dylan il personaggio più cool della sua generazione anche se non era chiaro ancora a nessuno (a Dylan meno di tutti) in cosa consistesse tutta quella coolness. Qui, come quattro anni dopo in Long Long Long, il proposito è di estrarre da Dylan la quintessenza poetica o anche soltanto l'anima pop, tagliando tutto quel grasso folk, tutta quella cultura del Midwest che ai Beatles e ai loro acquirenti non interesserebbe. Paul suona la tipica linea del walking bass, proprio come un turnista di New York o Nashville che cerchi di stare dietro con professionalità a un folksinger dagli accordi imprevedibili. È un annuncio di cose a venire: Beatles for Sale esce a dicembre, Dylan registrerà la sua prima canzone elettrica in gennaio, Subterranean Homesick Blues. Gli accordi di John non sono così imprevedibili, ma I'm a Loser è un esperimento senza il quale non avremmo avuto nemmeno You've Got to Hide o Norwegian Wood. D'altro canto se fosse davvero un capolavoro non starei citando tutte queste canzoni – sul serio quanti altri titoli ho scritto in tremila battute? I'm a Loser non è nemmeno la prima canzone che mi suggerisce Google se scrivo il titolo, il che per una canzone dei Beatles è una vera umiliazione (so why don't you kill me).
87. You Won't See Me (Lennon-McCartney, Rubber Soul).
 Una delle cose che mi fa impazzire di internet è che puoi rivalutare qualsiasi cosa. Davvero, se getti via il primo strato di hater – come il primo strato di neve sporca quando ne cadeva un mezzo metro, ma che ne sapete voi millenial – ci trovi un universo di gente che ama qualsiasi cosa tu vada googolando. Prendi, che ne so, uno dei pezzi dei Beatles che ti piace di meno, prendi You Won't See Me. Vai su Beatles Bible e trovi gente che ne va matta, la gemma nascosta di Rubber Soul, dicono. Piaceva tanto anche a Bob Marley, forse per via di una cover giamaicana che a quanto pare ebbe un ruolo seminale nel definire quello ska rallentato che sarebbe diventato il reggae, ok, molto interessante, ma stiamo davvero parlando di You Won't See Me?
Una delle cose che mi fa impazzire di internet è che puoi rivalutare qualsiasi cosa. Davvero, se getti via il primo strato di hater – come il primo strato di neve sporca quando ne cadeva un mezzo metro, ma che ne sapete voi millenial – ci trovi un universo di gente che ama qualsiasi cosa tu vada googolando. Prendi, che ne so, uno dei pezzi dei Beatles che ti piace di meno, prendi You Won't See Me. Vai su Beatles Bible e trovi gente che ne va matta, la gemma nascosta di Rubber Soul, dicono. Piaceva tanto anche a Bob Marley, forse per via di una cover giamaicana che a quanto pare ebbe un ruolo seminale nel definire quello ska rallentato che sarebbe diventato il reggae, ok, molto interessante, ma stiamo davvero parlando di You Won't See Me?Tu invece non hai mai capito che senso avesse, a parte quello ovvio di ennesimo ultimatum di Paul McCartney a Jane Asher: perché te ne vai in tournée quando io sono a Londra? Perché resti a Londra quando io sono in tournée? Perché non ti rassegni al tuo ruolo di lady Beatle come Maureen che faceva la parrucchiera o Cynthia che fa, beh, fa la moglie di John? Perché non ti fermi semplicemente ad ammirarmi, come qualsiasi altra ragazza della tua età sarebbe felice di fare? Quando dico che Paul è disarmante mi riferisco a canzoni del genere. John quand'è geloso senz'altro fa più paura, ma è un sentimento che si lascia facilmente interpretare come senso d'inadeguatezza. Paul invece ti lascia senza fiato, tanto genuinamente è sorpreso che una persona non lo consideri il centro dell'universo.
Nel bridge di You Won't See Me c'è un bisticcio che ricorda quello di No Reply: "I wouldn't mind if I knew what I was missing". Se ci riflettete non ha nessun senso, almeno in una delle tre proposizioni Paul avrebbe dovuto mettere un "you" come soggetto, ma non gli viene spontaneo quanto ripetere costantemente io, io, io: e del resto Jane non sta più ascoltando. In comune le due canzoni hanno anche il telefono, strumento non già di comunicazione ma di tortura per il Maschio che non riesce a controllare la linea. (Il primo verso in effetti è memorabile: "When I call you up, your line's engaged. I have had enough, so act your age"). You Won't e No Reply disattendono uno dei luoghi comuni dei beatleologi – l'assioma per cui Lennon parla sempre di sé mentre Paul preferisce inventarsi personaggi e ambientazioni. Stavolta è proprio l'opposto: Lennon in No Reply costruisce un bozzetto smaccatamente fittizio – la ragazza alla finestra che si nega al telefono – mentre Paul in You Won't See Me sembra aver perso tutti i filtri narrativi. Sta parlando di sé stesso, di una relazione che non riesce a condurre nella direzione che vorrebbe: sta esprimendo la sua frustrazione, un senso di inesorabile estraniamento affettivo che si esprime anche nel contrappunto, quella scala cromatica discendente talvolta sottolineata dai coretti – persino gli ammiratori di You Won't See Me ammettono che quegli "ooh la la" in falsetto non sono la soluzione ottimale, anche perché nella versione europea di Rubber Soul precedono gli "ooh la la la" di Nowhere Man. La scala cromatica riappare poi ribaltata, ascendente, al termine della strofa, dopo che Paul ha cantato il titolo: "you-won't-see-me", come un trucco di scena di cui Paul non riesca a stancarsi; e in effetti questa sovrabbondanza cromatica è uno degli stilemi con cui anche il profano tende a identificare un 'suono Beatles'.
 Uno dei contributi inconsapevoli dei Beatles all'emancipazione di genere è il modo in cui certi verbi che definiscono il corteggiamento nelle loro canzoni diventino unisex: il caso più famoso è belong, "appartenere", usato per indicare una condizione passiva finché Lennon, ispirato dal suo amore per i giochi di parole, in It Won't Be Long, lo trasforma nel suo opposto, cantando "non ci vorrà molto prima che ti apparterrò", in luogo di "conquisterò". Anche in You Won't See Me assistiamo a un capovolgimento semantico, un lapsus dettato dal narcisismo di McCartney, che per tutta la canzone si dichiara sinceramente frustrato perché la ragazza non potrà vederlo. "Diventerò matto se tu non mi vedrai". Qualsiasi altro autore avrebbe scritto "se non ti vedrò", ma in questo specifico caso ha ragione Paul: il problema è proprio che la Asher non aveva tutto questo tempo per ammirarlo. Uno non può impedirsi di pensare che no, con un'attrice di teatro non avrebbe mai potuto funzionare; mentre per contro, una fotografa...
Uno dei contributi inconsapevoli dei Beatles all'emancipazione di genere è il modo in cui certi verbi che definiscono il corteggiamento nelle loro canzoni diventino unisex: il caso più famoso è belong, "appartenere", usato per indicare una condizione passiva finché Lennon, ispirato dal suo amore per i giochi di parole, in It Won't Be Long, lo trasforma nel suo opposto, cantando "non ci vorrà molto prima che ti apparterrò", in luogo di "conquisterò". Anche in You Won't See Me assistiamo a un capovolgimento semantico, un lapsus dettato dal narcisismo di McCartney, che per tutta la canzone si dichiara sinceramente frustrato perché la ragazza non potrà vederlo. "Diventerò matto se tu non mi vedrai". Qualsiasi altro autore avrebbe scritto "se non ti vedrò", ma in questo specifico caso ha ragione Paul: il problema è proprio che la Asher non aveva tutto questo tempo per ammirarlo. Uno non può impedirsi di pensare che no, con un'attrice di teatro non avrebbe mai potuto funzionare; mentre per contro, una fotografa...86. Revolution 1 (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
 |
| "Più famosi di Gesù" is for boys Più famosi di Mao, though... |
"Ma quando parli di distruzione sai che puoi includermi fuori". Lennon dice proprio "you can't count me out, in" (che forse si dovrebbe tradurre "escludermi dentro") lasciandoci la libertà di scegliere se si tratti di un'esitazione o di un lennonismo. Nessuno sa come si comporterebbe davvero in una rivoluzione, a volte basta un nonnulla per trovarsi sul lato sbagliato della ghigliottina. Nemmeno Robespierre, nemmeno Lenin sapevano come sarebbe andata a finire: tantomeno chi la rivoluzione se la trova già in casa e sta soltanto cercando di cavalcarla, spinto da un genuino interesse per il nuovo ma anche da uno strisciante terrore di perdersi qualcosa (Fear of missing out, la chiamano oggi). Per esempio Lennon era tra i tanti nuovi "rich men" che cominciavano davvero ad aspettarsi le Guardie Rosse alle porte, eppure con Revolution 1 di porte ne spalanca in tutt'altra direzione: potremmo dire che il glam rock nasce proprio con questa canzone. Non era esattamente la Rivoluzione prevista dal Libretto Rosso. Forse è una rivoluzione nel senso astronomico, quel moto che prevede che dopo una lunga rotazione ellittica un pianeta torni esattamente al posto dov'era partito, un posto dove ci sono ancora juke box che cantano shoo bee do bop, bop, shoo be doo bop...
Tra tante canzoni dei Beatles nate come parodie, Revolution 1 è forse l'unica a essere diventata la parodia di sé stessa. Non era l'intento iniziale di Lennon, che col brano inaugura le session ufficiali del Disco Bianco: com'era già successo con i due dischi precedenti, la prima fase della lavorazione è quella in cui si indulge di più negli esperimenti. Revolution è in assoluto il brano che sposta più lontano i limiti dell'indulgenza: Lennon a un certo punto sembra concepirlo come una lunga suite, in cui la struttura pop iniziale cede progressivamente a una lunga improvvisazione estemporanea su cui eventualmente montare qualche ulteriore esperimento di musica concreta prodotto insieme a Yoko Ono. Una suite del genere sarebbe stata una novità per i Beatles, ma un oggetto non così bizzarro in un disco del 1968: due anni prima i Rolling Stone avevano infranto il muro dei dieci minuti con Goin Home; i Mothers di Zappa avevano già inciso The Return of the Son of Monster Magnet, una lunga suite rumoristica molto apprezzata dallo stesso Paul McCartney; nel 1967 i Doors avevano sconvolto l'America con The End. I Beatles avrebbero potuto raccogliere la sfida della controcultura? Dipendeva soprattutto da Lennon, e Lennon era indeciso se contarsi dentro o fuori.
Al netto della diffidenza dei colleghi, la suite di Revolution avrebbe definitivamente portato i Beatles all'avanguardia, ma richiedeva il sacrificio di un brano che aveva potenzialità commerciali. E se c'era qualcosa che a Lennon dispiaceva buttar via, ancor meno che i soldi, era una buona canzone. Da cui una prima decisione di tagliare Revolution in due parti, la 1 e la 9: quel tipo di segregazione che poi avrebbe continuato a praticare anche una volta sciolti i Beatles, per cui malgrado il tanto sbandierato sodalizio artistico, il suo materiale e quello di Yoko sarebbero stati quasi sempre venduti in confezioni separate. Estremismo artistico, pragmatismo commerciale.
Anche nella sua versione breve, Revolution 1 non era il singolo che Lennon avrebbe voluto dare ai Beatles nel pur rivoluzionario 1968: da cui la scelta di distorcerlo, accelerarlo, com'era successo con Please Please Me e Help!, ma soprattutto prenderlo sul serio, sconfessando l'atteggiamento disincantato e ironico che dominava la versione lenta; eliminando anche l'ambiguità di quel gioco di parole, per un più franco "count me out". Così trasformata, Revolution divenne il lato B di Hey Jude e ottenne a quanto pare il risultato di confortare molti studenti in rivolta sull'appoggio 'esterno' di John Lennon: un fratello maggiore che dimostrava attenzione per le loro rivendicazioni ma resisteva alla tentazione di spararsi pose rivoluzionarie (Mick Jagger con Street Fighting Man non aveva resistito). "E comunque non capisci che andrà tutto bene..." Sì, ma bene come? Nessuno ancora lo sa, ma fidati fratello, andrà bene. È John Lennon, come fai a non fidarti.
Verso la fine dell'anno però uscì il doppio LP con la versione originale, che ora per contrasto sembrava ancora più rallentata e parodica. Anche chi conosce la storia deve farsi un minimo di violenza per ricordare che il Lennon rilassato e ieratico di Revolution 1 è anteriore a quello grintoso del singolo. Questo credo succeda proprio perché nella versione dell'album Lennon gioca con la sua canzone come fanno molto spesso gli interpreti successivi, quando provano ad aggiungere stilemi diversi ma non originali. Così anche stavolta nel Nuovo che non ti aspetti ci sono tante tracce di un Vecchio che credevi rimosso: quel ripescaggio di vecchi stilemi del rock'n'roll di cui faranno tesoro Marc Bolan e David Bowie, gli shoo-bee-doo-bop che attendono inesorabili la fine della psichedelia e il ritorno del caro vecchio juke box; quei fiati che invece di suonare una fanfara rivoluzionaria sembrano volerti ripiombare in una balera odorosa di brillantina. Non suonano nemmeno Elvis ma la sua versione ancora più bianca e reazionaria, proprio il Pat Boone di Love Letters in the Sand: La, Reb Mi Reb Mi La. E chi è il Divo che coi maoisti alle porte decide di selezionare Pat Boone sul suo juke box e sedersi in posa contemplativa a godersi lo spettacolo in attesa dell'Eterno Ritorno, magari con un basso in mano che per un'intera strofa suona una nota sola? Questa rockstar indecisa davanti al suo destino tragico di Messia della nuova Apocalisse? No, non è Ziggy Stardust, ma nemmeno ci manca molto. "E quindi non capisci che andrà tutto bene..." Sì, ma bene come? Nessuno ancora lo sa, ma ora è impossibile fidarsi.
85. Things We Said Today (Lennon-McCartney, A Hard Day's Night, 1964).
Da-da-dan. Essere Paul McCartney significa, ad esempio, trovarsi in vacanza su uno yacht con Jane Asher, e invece di passare il tempo con Jane Asher, sprecarlo sottocoperta a sperimentare nuovi giri d'accordi e a comporre una canzone a proposito di quanto rimpiangerà il tempo passato con Jane Asher. In inglese la chiamano "reverse nostalgia", la nostalgia per quando avremo nostalgia di adesso, e in Italia l'ha brevettata Giacomo Leopardi col Passero Solitario. Però Leopardi quando scriveva "sconsolato volgerommi indietro" barava, il Passero l'ha scritta tardi e poi l'ha retrodatata. Invece Paul nel '64 aveva già la sensazione che le cose si sarebbero messe peggio – inoltre si era preso un'insolazione, la stanza puzzava di carburante, insomma la vita da ricchi non stava dando tutte queste soddisfazioni. Things We Said Today forse non suonerebbe così tetra se non si ritrovasse in un album sgarzolino come Hard Day's Night: è una delle prime canzoni in cui si inverte una delle convenzioni fin qui adottate dalla ditta Lennon-McCartney, il bridge in minore dopo due strofe in maggiore: qui è l'esatto opposto, un preludio alle atmosfere più problematiche del disco successivo. La schitarrata iniziale è una gran trovata: in una frazione di secondo ci informa che la canzone ha intenzione di suonare più acustica del solito, e prepara il terreno per il colpo di scena del bridge, quel passaggio da minore a maggiore che dà l'impressione che sottocoperta qualcuno abbia acceso la luce. Il futuro incerto sbiadisce e Paul riafferra gioioso il presente fortunato: Me I'm just the lucky kind, sono un ragazzo fortunato.
84. She Came in Through the Bathroom Window (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969)
Domenica è al telefono fino a lunedì; lunedì è al telefono con me. Il medley di Abbey Road assomiglia alla scarica finale dei fuochi artificiali. Per quanto meraviglioso, è abbastanza chiaro che è stato realizzato con gli avanzi. Tutti i colpi in canna che da soli non avrebbero detto molto, sparati a batteria, senza lasciare all'ascoltatore/spettatore il tempo di prendere fiato. Sono tutti pezzi o combinazioni di pezzi a cui mancava qualcosa, e il senso di ineluttabilità forse è dato proprio dal loro accumulo, senza un vero criterio che non sia quello di incastrarsi nello stesso contenitore lasciando meno spazio possibile al vuoto, insomma c'è uno sgombero in corso e nulla dev'essere lasciato indietro. L'unica apparente eccezione è She Came in Through, il solo pezzo completo di strofe e ritornello (anche se combinate in modo insolito). E malgrado Lennon non la trovasse un granché, fu il primo brano a trovare un interprete che la elevasse alla dignità di canzone completa, Joe Cocker nientemeno.
E allora perché anche She Came risuona in qualche modo incompiuta? Forse è solo una suggestione, la vicinanza con altri numeri più frammentari. Oppure è il testo, che sembra non avere senso ma non ha neanche quelle esibite caratteristiche di nonsense tipiche di molti brani lennoniani. Il problema con Paul è che da lui il nonsense non te lo aspetti, e lui d'altra parte non ha intenzione di avvisarti: te lo dispensa con la stessa flemma con cui ti snocciola una canzone d'amore o una filastrocca per bambini, così da lasciarti sempre il dubbio: forse ho capito male io. Quando John vuole fare il surrealista ti avverte con la musica, a volte accenna un passo di valzer o spinge la voce su territori ipnotici. Paul invece vuole mettere il surrealismo sul rhythm'n'blues e ti spiazza, è un rebus autobiografico o un brogliaccio con le prime parole che gli venivano in mente?
Così lei che "entrò dalla finestra del bagno" può senz'altro riferirsi a una delle fan che facevano picchetto fisso davanti al suo villino in Cavendish Avenue e poi davanti alla Apple. Magari è la stessa Polythene Pam del brano precedente, e a questo punto il medley comincerebbe a raccontarci una storia; ma se è "protetta da un cucchiaio di argento" è un'eroinomane che lo usa per cuocerci la dose? più probabilmente una giovane ereditiera che può permettersi qualsiasi effrazione; nel frasario idiomatico inglese "nascere col cucchiaio d'argento" significa crescere viziati. Del resto possiede una "bank", che però forse è solo il "banco" di una palude ("lagoon"). D'altro canto è una ballerina che lavora in quindici club al giorno, il che provoca a Paul una smorfia repressa, perché conosce la risposta indicibile a una domanda che nessuno ha formulato – che sia la stessa mitomane di Drive My Car? Ma esiste un posto dove si può ballare in quindici club al giorno? Pare proprio di sì, ed è la Reeperbahn di Amburgo. E mentre ci chiediamo tutto questo, la Les Paul di George commenta il cantato, squillante e impassibile, come se tutto avesse un qualche senso. Così alla fine Paul ha lasciato il dipartimento di polizia per trovarsi un lavoro fisso – ma qui è fondato il sospetto che il nonsense mascheri una censura: forse all'inizio Paul aveva "chiamato" la polizia, per denunciare un'effrazione, una cosa veramente poco hip da raccontare in un disco nell'anno di grazia 1969. Uno non può fare a meno di notare che nei due brani più memorabili del Medley, Paul non fa che parlare di furti. Qualcuno "non gli dà mai i suoi soldi", qualcun altro gli entra in casa dalla finestra, è un'angoscia. Anche se qui sembra molto più tranquillo, si sforza di prenderla in ridere, insomma è rientrato nel personaggio.
83. The Fool on the Hill (Lennon-McCartney, Magical Mystery Tour, 1967).
E lui non li ascolta mai, lui sa che i matti sono loro. Nell'ottobre del 1967 Paul McCartney sparì per due settimane. Non disse niente neanche ai compagni. L'unico forse a sapere qualcosa era Peter Brown, il manager subentrato temporaneamente a Brian Epstein, a cui Paul a un certo punto telefonò dalla Francia perché il suo cameraman, Aubrey Dewar, aveva bisogno di un'ottica particolare per un filmato che stava realizzando – una cosina da quattromila sterline. Quando tornò, aveva pronto il video di The Fool on the Hill, da inserire in quel Magical Mystery Tour che era già in fase di montaggio, e di cui rappresenta l'unico spezzone girato con un equipaggiamento professionale. Il che ci dice varie cose, magari non tutte vere ma verosimili: che Paul si stava rendendo conto che il filmino improvvisato coi colleghi era un pasticcio, e sentiva la necessità di raddrizzarlo un po', come un manager neopromosso che di nascosto corregge le magagne dei dipendenti che non riesce a dirigere; il numero che sceglie di raddrizzare è non casualmente il più mccartneyano di tutti, ma è anche il più ambizioso e cinematografico, quello che prosegue la svolta 'technicolor' di Sgt Pepper con un'accelerazione sensibile. È un brano che aveva bisogno del giusto corredo d'immagini: con Walrus e Blue Jay Way si poteva benissimo buttarla in buffonata artistoide, ma con The Fool Paul si sta misurando con Tin Pan Alley se non con la stessa Hollywood: se non sta davvero scrivendo lo standard per un musical, vuole perlomeno dimostrare di esserne capace. I tre colleghi, anche se non stanno già boicottando, rischiano comunque di essere di intralcio. The Fool è una questione tra Paul e il pubblico: deve farcela da solo. La canzone del resto parla proprio di questo: di un personaggio preso per matto che non se ne cura, lui è l'unico che vede le cose nel modo in cui devono essere. Da questo punto di vista anche il filmato avrebbe potuto essere un campanello d'allarme: bella fotografia, d'accordo, senz'altro superiore al resto del film, ma in sostanza di trattava di un reportage su Paul che saltellava e ammiccava su uno sfondo agreste, tutto solo appassionatamente.
Poche canzoni come The Fool on the Hill spaccano il fronte dei critici e dei beatleologi. È la peggiore canzone che i Beatles hanno mai inciso, scrisse Robert Christgau su Esquire; la negazione di tutto quello che i Beatles avevano rappresentato fino a quel momento per John Landau su Rolling Stone; uno dei brani migliori dei Beatles per il beatleologo Nicholas Schaffner. A John piaceva, o perlomeno non l'ha mai osteggiata, sin dalla prima volta che Paul gliela fece ascoltare al pianoforte e lui gli consigliò di scriversela ("sennò te la dimentichi"). A chi la detestasse in effetti consiglio di riascoltarla proprio nella versione per solo piano di Anthology, senza il corredo orchestrale e quel flautino irritante.
Dite la verità: magari non è il vostro genere, ma non sareste orgogliosi di avere in squadra un elemento che tira fuori numeri così? È certo una canzone che riporta alla luce qualche traccia di un inconscio archivio musicale che Lennon e McCartney condividevano: una specie di cantina che da poco avevano iniziato a esplorare, incoraggiati da George Martin. Nel passaggio dal re maggiore della strofa al re minore del ritornello Alan W. Pollack riconosce un cliché dei compositori romantici; Ian MacDonald fa notare come il passaggio da maggiore a minore (che abbiamo già più volte paragonato al giocare con l'interruttore della luce) restituisca perfettamente la sensazione del sole al tramonto proprio sulle parole "sees the sun goes down", il momento in cui in un film si stacca dall'oggetto pienamente illuminato per inquadrarlo di nuovo, ma controluce. Il che è suggestivo, ma anche un po' didascalico.
Ancora più didascalico è il ricorso al flauto, anzi pare sia un flagioletto: Lennon lo avrebbe ripreso sarcasticamente in Glass Onion, ma a modo suo l'irritante flauto acuto di The Fool è già una parodia degli strumenti esotici che ultimamente impreziosivano i alcuni dei brani più ambiziosi dei Quattro: l'ottavino di Penny Lane, il sitar, il finto clavicembalo di In My Life. Abbiamo veramente bisogno di tutte queste cose?, si domanda Paul verso la fine dell'anno di Sgt Pepper. Non ci basta un flauto da tre penny? (In inglese il flagioletto si chiama anche "threepenny flute"). Ed è un po' la contraddizione in cui si sta dibattendo Paul, sospeso tra ambizioni da compositore adulto e un'insofferenza per tutti gli aspetti tecnici del suo mestiere: proprio come... come un regista che decidesse di fare un film senza avere la minima idea di cos'è una sceneggiatura.
82. You Never Give Me Your Money (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
Oh, quel magico feeling, ma dov'è finito. Capita a tutti gli autori di volersi ripetere: una canzone ha funzionato, proviamo a farne un'altra più o meno così. Apparentemente, non va mai a finir bene; oppure: quando finisce bene, gli ascoltatori nemmeno se ne accorgono. Non è il caso di You Never Give Me Your Money, che nemmeno ci prova a non sembrare il tentativo di Paul di rifare un numero alla Happiness Is A Warm Gun, un brano realizzato attraverso la giustapposizione di elementi autonomi, che trasgredisce una delle fondamentali convenzioni della musica pop e popolare: tutto deve ripetersi almeno una volta. Strofa, ritornello, bridge, la gente vuole ripetizione e solo John Lennon, nel 1968 aveva deciso di non dargliela. Ma quello che per lui era stato un esperimento estemporaneo (un'operazione di avanguardia) dal 1969 in poi diventerà una delle specialità dell'ex collega, che dopo You Never Give userà lo stesso procedimento per scrivere alcune delle sue canzoni più memorabili (e vendute) nel decennio successivo: Uncle Albert / Admiral Halsey, Band on the Run, la stessa Live and Let Die.
Quella che per Lennon era una semplice sfida (che una volta vinta con Happiness non aveva più senso replicare), in McCartney diventerà una tecnica, magari funzionale a stemperare la stucchevolezza dei motivetti che produce con ritmi quasi fisiologici. Prendi la frase iniziale iniziale di You Never Give, un tema quasi bacharachiano che si fischietta al primo ascolto. In altri casi McCartney aveva ceduto al richiamo dell'easy listening: stavolta no, vuole fuggire, e in effetti la canzone parla di questo. Ma parla anche del suo contrario, paradossalmente: la canzone che descrive la voglia di Paul di alzarsi da una incomprensibile riunione di affari e scappare in limousine è anche l'ennesimo tentativo di Paul di ribadire che i Beatles esistono come insieme. Tornare alle partiture difficili, ai cambi di tempo e di tonalità, come era successo un anno prima con Happiness, uno dei momenti di maggiore collaborazione durante la lavorazione del Disco Bianco. I Beatles avevano bisogno di sfide per andare avanti – un trucco escogitato nello stesso periodo era stato invitare musicisti in presenza dei quali sarebbe stato imbarazzante litigare: Clapton, Preston. Un'altra possibilità era arrivare con qualcosa di complicato, che richiedesse impegno e coordinazione. Lungo questa via prima o poi i Beatles sarebbero arrivati al prog – uno degli aspetti più sorprendenti di You Never Give è che dura soltanto quattro minuti. Qualsiasi altro gruppo del periodo con un materiale simile ce ne avrebbe messo almeno il doppio, ma d'altronde siamo nel Medley, no? Anche se forse non ce ne siamo ancora accorti.
Se il Medley finale di Abbey Road è un album-nell'album, una specie di miniatura in cui tutto sembra muoversi più velocemente, You Never Give Me è un medley-nel-medley. Al tema iniziale – l'unico destinato a tornare più tardi – subentra un movimento vagamente ragtime, con un pianoforte accelerato da Paul per dare quella qualità da pianista-nel-bordello, e un cantato quasi recitativo in cui dichiara con qualche licenza poetica che la ditta è fallita. Ma c'è ben di più nell'aria e Paul non perde tempo a dircelo: tempo sedici battute e la musica cambia di nuovo, mentre Paul ci informa che è finito il feeling, oh, quel magico feeling. Ora è solo una progressione di tre accordi, e i cori di George e John (vagamente evocativi di A Day in the Life) ci danno l'impressione che i Beatles siano finalmente arrivati in quello che fino a quel momento poteva sembrare l'ennesimo siparietto vintage di Paul. Proprio a questo punto cominciano i forsennati cambi di tempo che portano all'ultimo momento, quello della fuga in limousine: un sogno di evasione che se non "è diventato vero oggi", come canta Paul, comunque si sta già realizzando nella musica. Se You Never Give riesce a riscattarsi dal suo destino di "Happiness Is a Warm Gun 2" è anche perché compie il tragitto inverso: se Happiness è un brano sperimentale che alla fine collassa in un doo-wop anni '50, You Never Give è un brano confidenziale che poi diventa un ragtime, poi un brano dei Beatles e nel suo ultimo mezzo minuto non assomiglia più a niente, è in fuga da tutto: è rock, è una filastrocca ("1-2-3-4-5-6-7...") scandita da un funereo arpeggio che suona Beatles senza assomigliare a nient'altro i Beatles abbiano mai inciso; è la libertà che ci aspetta in campagna quando tutta questa pazzia sarà finita. Questione di mesi, di settimane ormai.
81. I Will (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
"It verges from the sublime to the ridiculous!" (Paul McCartney, all'inizio della take 13). Chi sa da quanto t'amo / lo sa che t'amo ancor. I Will è una delle poche canzoni del Disco Bianco (1968) che avrebbe potuto essere incisa anche un paio di anni prima, se non addirittura nel 1964 – con un arrangiamento più convenzionale, ovviamente, ma I Will l'avremmo potuta ascoltare persino in Help! o in Beatles for Sale. All'interno di un lungo doppio album centrifugo, ripieno di trovate e canzoni che si sforzano tutte in un qualche modo di sembrare diverse, I Will è il brano meno eccentrico, quello che gira più vicino al centro di gravità del gruppo: i Beatles fanno brevi canzoni d'amore, le hanno sempre fatte e non possono smettere nemmeno adesso, Rivoluzione o no.
Se Paul torna al limitatissimo frasario amoroso di qualche anno prima non è ancora per nostalgia: I Will non è una citazione dei 'vecchi Beatles', né una parodia. Allo stesso tempo, gran parte dell'incanto di I Will sta proprio nel suo ritrovarsi in mezzo a quel gran pasticcio che è il Disco Bianco, tra un inno protofunky all'Amore dei Macachi e un'invocazione di John alla Moglie-Madre. In altri dischi sarebbe un numero abbastanza convenzionale: tre strofe, due bridge e pedalare. Una formula che tanta fortuna aveva portato ai Beatles, ma che nel 1968 li aveva comprensibilmente annoiati e questo è uno dei paradossi del Disco Bianco: una lunga festa dove a volte si perde tempo a fare cose stupide e inutili, e in altri casi si taglia anche più corto del necessario. Raramente si ricade nel giusto mezzo ma questo è il caso di I Will. Perché farla durare due minuti e mezzo se ne basta uno ad allestire tutto il necessario? Così la strofa dopo il bridge contiene già le variazioni che preparano il finale, che pure arriva a sorpresa, camuffato da secondo bridge. Una costruzione piuttosto sofisticata, per un mini-brano che si presentava come l'ennesima variazione sul giro di do. La chitarra acustica ribadisce con fraseggi puntuali la sua prominenza sul Disco Bianco, mentre la scelta di doppiare il basso con la voce lascia perplessi ma diventa il punctum della canzone, il motivo per cui te la ricordi al primo ascolto e non la dimentichi più. Sappiamo che la notte in cui la registrò, Paul forse cercava qualcosa di diverso: aveva in mente forse un arrangiamento più latineggiante e tentò di condurre John e Ringo sui sentieri impervi della bossanova (George era assente). Ma lo sappiamo perché abbiamo ascoltato Anthology: il risultato finale è una canzoncina apparentemente semplice, non molto latineggiante. Paul sapeva fare un passo indietro, ogni tanto.
Le canzoni dei Beatles (#100-91)
14-05-2020, 02:21beatles, Il Post, musicaPermalinkPuntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#115-96)
La playlist su Spotify.
100. Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
Take it easy! Il Disco Bianco è una festa. Non delle più riuscite, ma avresti comunque voluto esserci. Comincia a razzo, sbanda quasi subito, c'è chi è ubriaco prima della torta, c'è chi si apparta per fare sesso o farsi, chi litiga davanti a tutti e non gliene frega più un cazzo, chi se ne sta in un angolo a pensare alla mamma, chi ha preso la pastiglia sbagliata e vede tutto distorto, chi ha il mal di mare, e in mezzo alla stanza ci sono John e Yoko che ballano e sudano come due bambini in overdose da zucchero filato. Forse sono fatti anche loro, forse sono solo felici e spudorati. Non hanno niente da nascondere. Take it easy!
C'è del metodo in questa allegria. Di tutti i brani del Bianco che predicano un ritorno al rock, Everybody è (con Birthday) il più programmatico. Sarà un rock libero dalle gabbie tradizionali, non più strutturato su un giro blues, ma imbastito intorno a riff di chitarra semplici e graffianti raddoppiate dal basso, e un Ringo scatenato (se Ringo torna). Sarà deliberatamente spensierato: basta lagne, la vita è già difficile, ora facciamo festa. È un rock che non assomiglia né a quello d'importazione delle cover beatlesiane fino al '65, né a quello post-psichedelico, più torrido ma ancora blueseggiante che a questa altezza stanno perfezionando i Rolling Stones e gli altri gruppi della Seconda Invasione, Small Faces o Yardbirds. È un rock che se non fosse così gioioso sarebbe un filo più simile al quello melodrammatico di Tommy, che uscirà solo l'anno dopo, ma in linea di massima è un unicum, qualcosa che solo i Beatles stavano facendo in quel momento, e neanche loro ci credevano del tutto. È il rock di Everybody's Got Something, Birthday, Hey Bulldog, I've Got A Feeling, Dig A Pony. È un prodotto più lennoniano che mccartneyano, ma Lennon non aveva più le forze per imporlo e Paul tradiva un approccio più derivativo: vogliamo fare un rock? Possiamo farlo alla Chuck Berry (Back in the USSR), o alla Fats Domino (Lady Madonna), o perfino alla Beatles prima maniera (One After 909).
Se invece avessero deciso che quella di Everybody's Got Something era la direzione giusta (e non si fossero sciolti), forse verso il 1969-70 avrebbero codificato un loro preciso stile rock, proprio come fecero i Rolling Stones tra Beggars' Banquet e Sticky Fingers. Che rock sarebbe stato? Non possiamo saperlo, non è successo, e probabilmente non sarebbe potuto succedere. È una domanda oziosa. Ma tutto è ozioso qui, quindi take it easy e proviamoci: che rock avrebbero suonato i Beatles a cavallo tra Sessanta e Settanta, se invece di spaziare tra tutti i generi musicali di Occidente e Oriente fino a disperdersi, avessero deciso di delimitare un sound preciso e cristallizzarlo, come gli Stones e gli Who e tutti i ragazzini che negli anni '60 avevano avuto la botta di culo di scalare le classifiche e negli anni '70 volevano farne un mestiere? La butto lì: sarebbe stato un rock simile a quello dei primi Led Zeppelin. Estremo, spensierato, basato su riff graffianti, grandi esibizioni vocali e un Ringo fracassone e scatenato. Non ho ovviamente argomenti per sostenere questa cosa, ma provate nella vostra testa a immaginare Robert Plant che canta Everybody's Got Something to Hide. Nel momento in cui prende la canzone in gola e la porta un gradino più su: Take it easy! e un altro gradino: Take it easy! Everybody's Got Something è la finestra aperta su quello che avrebbero potuto diventare i Beatles, se avessero ancora potuto accontentarsi di diventare qualcosa. Il punto è che no, non era così facile, e lo sapeva John per primo.
99. Long Long Long (George Harrison, The Beatles, 1968).
C'è voluto tanto, tanto, tanto tempo. Ogni canzone dei Beatles, abbiamo detto, è un esperimento. Long Long Long ne contiene parecchi, tra cui forse uno sul principio di indeterminazione, ovvero: esiste Long Long Long prima che la ascoltiamo? Probabilmente sì, ma dipende molto da cosa abbiamo ascoltato prima: i Beatles o Dylan? Il Disco Bianco o Blonde On Blonde? Siamo tra quelli che abbiamo semplicemente alzato il volume al massimo e pensato beh, ma questa canzone brevissima è stupenda! O siamo quelli che abbiamo riconosciuto con una smorfia di soddisfazione il riferimento, e ci siamo compiaciuti con George, bravo George, che idea infilare proprio alla fine del terzo magico lato una versione supercondensata di Sad Eyed Lady of the Lowlands. Un riferimento che non era così scontato nemmeno nel 1968 – certo, Dylan era già il recalcitrante Divo della Controcultura, e Blonde era il suo disco più venduto. Era una indiscussa celebrità, ma non paragonabile a quella dei Beatles. I Beatles se la giocavano con Gesù, Dylan poteva dirsi contento se Johnny Cash lo invitava in tv. Più che un plagio è l'ennesimo rimpallo di una lunga partita: quando Lennon aveva scritto Norwegian Wood Dylan aveva risposto con Fourth Time Around; quando i Quattro lo avevano cartonato sulla copertina di Sgt Pepper, Dylan li aveva nascosti in quella di John Wesley Harding. E insomma a partire dalla fine del 1968, per la maggior parte degli ascoltatori Sad Eyed Lady diventerà la versione estesa di Long Long Long.
Un altro esperimento riuscito con Long Long Long ha a che vedere con la relatività, non nel tempo ma nello spazio, ovvero: sarebbe ancora la stessa canzone se non si trovasse esattamente dov'è, seminascosta al termine di quell'incredibile terzo lato che è tutto un saliscendi di pezzi fracassoni e intermezzi acustici, e proprio al termine del pezzo più frastornante di tutti, un pezzo che sembra non voler finire? Avrebbe ancora lo stesso significato, quel Long Long Long scandito eterealmente da George, se non venisse subito dopo l'urlo sdegnato di Ringo, "Ho le vesciche alle dita?" Il terzo esperimento ha a che vedere col volume, perché è probabile che durante Helter Skelter molti scandalizzati ascoltatori del 1968 l'abbiano abbassato, e che quindi non stiano ascoltando George, se non a livello subliminale. Long Long Long è la classica canzone di cui ti accorgi dopo un po' che è iniziata, e forse l'ingresso rumorista di Ringo, oltre a riecheggiare sulle macerie di Helter Skelter, serve proprio ad avvertire: ehi, alzate il volume, c'è ancora una canzone su questi solchi. È incisa pianissimo, ma c'è. Era un espediente abbastanza originale per i tempi (e oggi nell'era della compressione dinamica lo è ancora di più): dopo aver dimostrato di poter suonare più forte di tutti, i Quattro decidono di suonare più piano di sempre, insomma di potersi permettere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. In realtà il momento è calcolatissimo e forse l'esperimento tiene anche conto di una variabile ormai sconosciuta: la fragilità dei solchi di vinile più vicini al centro del disco. Long è una canzone fragile nel punto più fragile del supporto. Qualcosa di simile alla pudica Sad Eyed Lady che Dylan aveva rinchiuso in un lato del disco tutto per lei, come una dama nella torre più alta del castello. Sarà la prima a rovinarsi dopo decine di ascolti, la prima su cui la puntina annegherà nel fruscio o svirgolerà verso il perno prima del finale. È come se non volesse davvero essere ascoltata, e quando decidiamo che invece vogliamo farlo davvero, quando alziamo il volume come si punta un faro su un fuggitivo, Long si ribella ed esplode nell'ennesimo esercizio di caos.
98. Magical Mystery Tour (Lennon-McCartney, Magical Mystery Tour, 1967).
That's an invitation. Quando ho iniziato questa cosa, volevo semplicemente scrivere di un argomento che conoscevo abbastanza bene. I Beatles credevo di conoscerli, a causa di una frequentazione iniziata nella prima adolescenza. Ovviamente sbagliavo: primo perché tutto sommato tante cose mi sfuggivano (e mi sfuggono ancora), secondo perché non è una buona idea scrivere sulle cose che hai conosciuto nella prima adolescenza. Come ho potuto dimenticare uno degli assiomi fondamentali della mia esistenza, ovvero che gli adolescenti non capiscono niente? Come posso fidarmi delle mie opinioni sulle canzoni dei Beatles se molte di esse nascono da prime impressioni scaturite in un momento in cui non capivo niente e ascoltavo le cassette su un registratore portatile panasonic mono? Per dire, non sarà colpa del mio acerbo orecchio, della mia scarsa strumentazione, se ho sempre avuto la sensazione che Sgt Pepper sia mixato male? Come se non riuscisse a soddisfare le pretese che lo costruiscono – mentre Revolver è un superbo disco in bianco e nero, e Magical Mystery Tour è già una gioia di colori, sin da questo brano che è poco più che una sigla ma è splendido, la premessa di un mondo fantastico in cui sarebbe potuto succedere di tutto e i Beatles avevano la possibilità di farlo succedere. Cambia tempo, cambia timbro, cambia tutto e tutto ancora funziona. Poi un bel giorno scopro che il brano Magical Mystery Tour fu inciso durante le sessioni di Sgt Pepper – possibile? Anche solo gli ottoni, senti come squillano, dovrebbero essere gli stessi che barrivano in Good Morning?
A me continua a sembrare che siano passati mesi, è come se lo stesse già citando, e allo stesso tempo suonasse già più addomesticato, più vicino al nostro orecchio, più technocolorato. Ho sempre immaginato nella mia testa Sgt Pepper come il primo disco a colori, e ho sempre immaginato i colori di Sgt Pepper un po' maldestri, sbiaditi o ingialliti come le polaroid o i film mal restaurati del periodo. Invece Magical Mystery Tour comincia con quel suono di fanfara che mette per un attimo tutto a fuoco. O forse nel frattempo mi ero comprato uno stereo decente? Waiting to take you away – take you today.
97. When I'm Sixty-Four (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Heart's Club Band, 1967).
Doing the garden, digging the weeds: who could ask for more? Granny songs, le definiva John. Le canzoni del nonno, il debole di Paul. When I'm 64 è la prima vera granny song ed è anche il manifesto di tutte quelle che seguiranno. Quello che stava iniziando come un divertimento, in realtà era una presa di posizione: io sono Paul McCartney, e un giorno avrò 64 anni. Come il Sergente Pepe, come mio padre. Forse capiterà anche a voi, ma non ci state pensando. Io invece ci penso da sempre. Hope I die before I grow old, cantava Roger Daltrey. You'll be older too, risponde Paul. When I'm 64 è l'anti-MyGeneration, molto più di quanto Helter Skelter sia l'anti-I Can See For Miles. Io non rappresento una generazione, ci spiega Paul. Faccio rock perché sono giovane: quando sarò vecchio farò le cose che piacciono ai vecchi, musica inclusa. Gli ascoltatori ridacchiano, sembra uno scherzo. Ma non finisce con le risate, come il pur seriosissimo brano precedente.
 Paul scrisse When I'm 64 a 16 anni. La strimpellava col piano già al Cavern Club, mentre gli altri tre erano in pausa a fumare. Prima o poi avrebbe voluto registrarla, ma coi Beatles per molto tempo sembrava impossibile. Bisognava creare le premesse, trasformare una rock'n'roll band in qualcosa d'altro: ma anche dopo aver aggiunto i violini in Yesterday, il sitar in Norwegian Wood, questo brano sembrava unbeatlable. Da cui forse l'idea geniale di Sgt Pepper: e se invece di fare il solito disco dei Beatles, facessimo finta di essere un altro gruppo, un gruppo più eclettico? Poteva essere un modo per riciclare idee valide ma fino a quel momento troppo eccentriche. Alla prova dei fatti tuttavia l'unico vero ripescaggio operato in Sgt Pepper fu questo vecchio brano di Paul in cui Paul si immagina nonno: questo appunto poteva essere uno dei sensi della casacca del Sergente Pepe, un tizio che se "ha insegnato la banda a suonare", lo ha fatto comunque almeno "vent'anni fa oggi".
Paul scrisse When I'm 64 a 16 anni. La strimpellava col piano già al Cavern Club, mentre gli altri tre erano in pausa a fumare. Prima o poi avrebbe voluto registrarla, ma coi Beatles per molto tempo sembrava impossibile. Bisognava creare le premesse, trasformare una rock'n'roll band in qualcosa d'altro: ma anche dopo aver aggiunto i violini in Yesterday, il sitar in Norwegian Wood, questo brano sembrava unbeatlable. Da cui forse l'idea geniale di Sgt Pepper: e se invece di fare il solito disco dei Beatles, facessimo finta di essere un altro gruppo, un gruppo più eclettico? Poteva essere un modo per riciclare idee valide ma fino a quel momento troppo eccentriche. Alla prova dei fatti tuttavia l'unico vero ripescaggio operato in Sgt Pepper fu questo vecchio brano di Paul in cui Paul si immagina nonno: questo appunto poteva essere uno dei sensi della casacca del Sergente Pepe, un tizio che se "ha insegnato la banda a suonare", lo ha fatto comunque almeno "vent'anni fa oggi".Il Sergente potrebbe essere il vecchio Paul, coi baffi che lo fanno somigliare un po' di più al padre (che aveva appena compiuto 64 anni). La Band del Club dei Cuori Spezzati potrebbe essere i Beatles tra vent'anni, barbuti e impolverati, molto oltre la parabola del loro successo, relegati a suonare marcette nei piovosi parchi del Merseyside. Gli altri tre non l'hanno ancora capito, sono convinti che il disco parli del loro passato; Paul lo sa, che passato e futuro sono illusioni: tutto era già scritto sin dall'inizio. Ringo è nato battendo il tempo col piede sbagliato, George era un guru a 16 anni, John un rocker che per sopravvivere doveva diventare un compositore, Paul un compositore che per sopravvivere doveva atteggiarsi a rocker. Alla fine hanno tutti regalato qualcosa agli altri: forse le migliori canzoni le ha composte John, e Paul ha cantato la migliore Long Tall Sally. Ma era tutto già predisposto, compreso forse chi dovesse soccombere a un successo insostenibile, e chi dovesse sopravvivere per raccontarcelo.
96. Within You Without You (Harrison, 1967, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band).
Stavamo parlando dello spazio tra di noi. Avete presente il film Inception, quel trucco per cui ogni sogno rallenta un po' il tempo, quindi se all'interno del sogno sogno di sognare un altro sogno, alla fine posso vivere cento anni in un istante? Within You Without You non dura cent'anni ma è come se. È un sogno di George, chitarrista della banda di Sgt Pepper, che a sua volta è un sogno di Paul.
Come tutti i brani harrisoniani del 1967, Within You è tra le canzoni più divisive dei Beatles. C'è chi all'inizio non capisce cosa ci faccia in Sgt Pepper e magari vent'anni dopo la trova l'unica cosa ascoltabile in tutto il disco, e chi fa il percorso inverso e speriamo tutti di incontrarci in qualche punto del percorso. Se Sgt Pepper è una parentesi (facciamo finta di essere un altro gruppo), Within You Without You è un inciso nella parentesi, uno spettacolo nello spettacolo: ci viene chiesto di immaginare che la Banda ceda temporaneamente il gazebo a un guru venuto dall'Oriente a predicare la vanità dell'Io.
Era stato Paul McCartney il primo a forzare il concetto di gruppo al punto da introdurre nei dischi dei Beatles veri e propri siparietti solistici, canzoni come Yesterday registrate senza contributi dei tre colleghi. A questo punto però il gioco si fa escheriano: Within You è un siparietto di George al centro di un siparietto di Paul. Se i Beatles in Sgt Pepper sono temporaneamente sospesi, Within You è il momento in cui sembrano completamente dimenticati. Concentriamoci sulle cose più importanti, ci suggerisce George, e in qualsiasi altro contesto il suo tono saccente riuscirebbe irritante, ma inserito tra due numeri di varietà come Mr Kite e When I'm 64 risulta quasi un sollievo: finalmente c'è qualcuno che sta prendendo sul serio qualcosa. Qualsiasi cosa. Within You è il risultato della collaborazione della più improbabile coppia di compositori della Ditta Beatles: Harrison e George Martin. Il primo porta tre raga cuciti assieme, da suonare su sitar e tabla; al secondo tocca l'ingrato compito di traslitterare la composizione in qualcosa di suonabile per un'orchestra occidentale, e bisogna dire che ci riesce sorprendentemente bene: certo, tutti ricordiamo Within You per il suono così ben distinguibile del sitar: ma sono i violini a creare un salto di qualità rispetto all'esperimento, già riuscito, di Love You To: non sappiamo se Harrison se ne stesse rendendo conto, ma Within You è il suo divano occidentale-orientale: un tentativo di conciliare due universi musicali che sorprende ancora oggi. Per cinque minuti George si concede una seduta di meditazione, prima di congedarsi tra le risate: nessuno è profeta in patria, che ci fa quel guru seduto su un tappeto sotto il chiosco del Sergente Pepe? Ma lo conosciamo, suo padre non guidava l'autobus? Appena un istante di silenzio, e poi riparte la banda. Tutto ok, salvo che siamo invecchiati all'improvviso. Un istante fa eravamo giovani, ora di anni ne abbiamo... 64.
95. You Can't Do That (Lennon-McCartney, A Hard Day's Night, 1964).
"Sono tutti verdi [di invidia] perché sono quello che ha vinto il tuo amore. Ma se ti vedono parlare in quel modo, mi rideranno in faccia!" In seguito Lennon avrebbe sostenuto di non aver mai scritto una canzone su sé stesso almeno fino al 1965: fino a Help! o Nowhere Man non era che un "professional songwriter", un tecnico che monta qualsiasi combinazione di parole, purché funzioni. Il che significa semplicemente che fino al 1965 Lennon non si rendeva conto di scrivere di sé stesso: ed è proprio questa inconsapevolezza ad averlo portato a comporre alcune delle liriche più sincere. You Can't Do That, il primo vero brano in cui Lennon riesce a comunicare attraverso la musica una genuina sensazione di frustrazione, inquadra perfettamente l'aspetto sociale del problema: la gelosia non è un istinto primario tragicamente insopprimibile, come in Run For Your Life. A provocarla è una preciso comportamento provocatorio (rituale, si direbbe) commesso davanti a un pubblico che il Maschio Alfa non può permettersi di deludere. Tutto qui, non c'è altro: perlomeno non c'è amore e in questo senso You Can't potrebbe essere considerata la prima vera lirica non-d'amore dei Beatles: la ragazza non è particolarmente desiderata, è un puro bene posizionale che John ha conquistato e ora deve difendere, spalleggiato da coretti mai così gregari. ("I'm going to let you down and leave you flat"). Come nella di poco successiva No Reply, il cantante non fa che sottolineare che la questione non è nuova, ma si è ripresentata almeno una volta: il problema non è tanto che Lei sia sensibile al fascino di un altro maschio, ma che la cosa sia già successa dopo una prima severa reprimenda, il che è intollerabile. Non c'è nessun cuore spezzato di fronte alla constatazione che qualcun altro può essere più affascinante: c'è la stizza di padre-padrone che si aspetta di essere obbedito al volo e di non dover ripetere gli ordini due volte. Del resto è proprio questo insistere sul fatto che "non puoi farlo" a farti sospettare sin dall'inizio che Lei lo rifarà.
94. I've Got a Feeling (Lennon-McCartney, 1969, Let It Be).
"Everybody had a hard year". Che inizio straordinario per una grande canzone, pensateci. In quanti casi funzionerebbe. "Abbiamo tutti avuto un anno difficile". Non sentite come ci assolve e ci accomuna tutti, ci fa sentire meno soli? I giornalisti potrebbero farci titoli per un secolo, tanto di anni difficili ne avremo sempre. Potrebbe tranquillamente essere il primo verso di canzone più citato al mondo, al posto di, boh, Imagine? Peccato che nessuno l'abbia scritta, una canzone che comincia così. Cioè Lennon l'aveva scritta, ma poi stava per buttarla via, e alla fine l'ha appiccicata in coda a una canzone di McCartney. Poi uno dice perché vi siete sciolti, oh yeah.
C'è la musica dei Beatles e c'è la leggenda dei Beatles, e ho la sensazione che entrambe siano talmente interessanti che si reggerebbero da sole, ovvero: tante canzoni dei Beatles sarebbero meravigliose anche se non conoscessimo nulla di chi le ha scritte e suonate; e allo stesso tempo certi libri sui Beatles sono appassionanti anche se la loro musica non la conosci o ti lascia indifferente. Musica e leggenda a volte si intersecano ma senza disturbarsi – almeno fino a Let It Be. L'ultimo disco dei Beatles è il momento in cui la leggenda prende il sopravvento sulla musica, schiacciando col suo peso canzoni come I've Got a Feeling, come I Me Mine, o Two of Us, che chissà, forse sarebbero anche belle canzoni, ma persino dopo centinaia di ascolti il critico coscienzioso si può domandare se le ha mai davvero ascoltate. Che sarebbe di I've Got a Feeling se non l'avessero suonata i Beatles sul tetto della Apple, e proprio nel momento più delicato della loro carriera? Esiste I've Got a Feeling a prescindere dal contesto, come la Terza di Beethoven senza Napoleone?
Probabilmente no. I've Got a Feeling – decisamente non paragonabile a una sinfonia di Beethoven – è un brano interessante ma non abbastanza da far dimenticare il suo ruolo narrativo; se quella dei Beatles fosse una storia inventata, come forse qualche postero comincerà a credere tra qualche anno, I've Got a Feeling sarebbe un necessario snodo di trama, di quelli che a una prima visione non sembrano memorabili, ma un esperto di sceneggiature approverebbe l'economia. In tre minuti e mezzo I've Got a Feeling ci racconta che (1) i Quattro vogliono tornare al rock'n'roll, ma (2) vogliono anche suonarlo meglio di sempre, meglio dei concorrenti che rispetto al 1962 si sono fatti agguerritissimi, e a questa cosa (3) Paul ci crede anche più di John, e però (4) per essere una rock'n'roll band dovrebbero tornare a essere una band: scrivere i pezzi assieme, suonarli assieme fino a ridiventare una cosa sola. Peccato che (5) non ce la stiano facendo: ormai Paul ha la sua storia, John ne ha un'altra, puoi anche provare a sovrapporle ma non funziona più, e (6) non è colpa di nessuno, accettiamo la cosa e andiamo avanti, oh yeah, ho questa sensazione. Ecco, la grandezza di I've Got a Feeling sta tutta qui, in quello che ci racconta, mirabilmente e sinteticamente, più con la musica che con le parole. Incastrare canzoni era una cosa che Lennon e McCartney facevano da sempre, e non è nemmeno la prima volta che il risultato finale mantiene qualcosa di artefatto: ancor prima di A Day in the Life, We Can Work It Out era già una canzone a due facce, che esibiva il suo carattere composito.
Proprio come nella hit del 1965, Paul e John si allineano istintivamente sulle due metà del bicchiere mezzo pieno. Più che ottimista, stavolta Paul è proprio entusiasta: è innamorato, è felice di esserlo, suona nella rock'n'roll band più grande di sempre e vuole dimostrarlo sgolandosi nel bridge mentre al basso snocciola qualcosa che sembra sempre più un virtuosismo: ovvero il futuro del rock, per quanto lo si poteva vedere in quel freddo gennaio 1969. Cream e Hendrix mostravano la via e Paul qui sembra voler raccogliere la sfida con una tensione agonistica, e che almeno questa volta non riusciamo a ricollegare all'invidia per il collega/rivale John. John, dal canto suo, ha un personaggio da rispettare: il teddy boy che se c'è da suonare duro non si tira indietro. Eppure il suo contributo a un brano hard rock come I've Got a Feeling è una filastrocca, "Everybody Had a Hard Year" già registrata in casa l'anno precedente – sì, l'"anno difficile per tutti" è proprio quel mitologico 1968. Nelle prime registrazioni che abbiamo, John la canta su quell'arpeggio ostinato e ipnotico che da Dear Prudence porta a Julia, da cui due possibilità: che si trattasse di un testo scartato proprio per far posto all'inno alla madre-moglie Julia, oppure che John in quel periodo usasse l'arpeggio (appreso in India) come un vero e proprio raga, un tappeto di note impassibili che lo aiutava a mantenere la concentrazione. Sia come sia, è comprensibile che John fosse restio a buttarlo via. Era un'idea interessante, descrivere il passaggio collettivo del tempo e delle mode e delle angosce proprio nel momento in cui gli anni cominciavano a farsi complicati, le barbe crescevano e poi d'un tratto sparivano, le droghe cambiavano all'improvviso. Inserita in coda ad I've Got a Feeling, la filastrocca introduce quel solito elemento di pessimismo che aveva già speziato altre canzoni di Paul (We Can Work, Getting Better). Tutto già collaudato, eppure... qualcosa non va. Non c'è più una sintesi finale, ognuno continua a cantare la propria canzone, l'unica cosa su cui si riesce ancora a convergere è "Oh yeah". Manca il feeling... (oh, quel magico feeling).
93 I've Just Seen a Face (Lennon-McCartney, Help!, 1965)
Prima delle granny songs ci fu almeno un'auntie song, o perlomeno Paul l'aveva soprannominata "Auntie Gin's", perché piaceva tanto a sua zia Gin. Ecco uno di quei dettagli che tutti i testi riportano ma che per molto tempo non sai bene dove sistemare, mentre cerchi di parlare di una breve canzone che sembra celare un segreto. I've Just Seen a Face è un brano tipico dei Beatles che non assomiglia a nessun altro brano dei Beatles, già questo non è fantastico?
Voglio dire, hanno scritto duecento pezzi in otto anni quei benedetti ragazzi, ma I've Just Seen a Face la riconosci a colpo sicuro. Qualcuno la trova country ma no, è acustica ma non suona così country. E a parte l'introduzione, molto più lunga e complessa del solito (soprattutto rispetto alla brevità del pezzo), è fatta di ingredienti così semplici che sin dal 1963 i Beatles erano consapevoli di non poterli spiattellare su disco senza modificarli un po': ad esempio la strofa è un giro di Do, una cosa talmente anni '50 che in inglese la chiamano proprio così, "Fifties progression". È una soluzione che perseguita Lennon e McCartney sin dai primi tempi, ma che i due giovani compositori sono quasi sempre riusciti a eludere, introducendo deviazioni e altri trucchi. Qui no, la strofa di I've Just Seen è un giro di Do rapido e senza vergogna, o forse una spia della vergogna è proprio la fretta dannata, sembra che Paul non veda l'ora di arrivare al brano successivo, e se avete presente il brano successivo sapete che è proprio così.
Se aggiungi che il ritornello prende la progressione del blues, beh, sembriamo davvero arrivati al raschiamento finale del barile: eppure il risultato non suona né anni '50 né blues, come mai?
Ecco, la prima risposta del critico in erba di fronte a domande del genere è gridare al miracolo. McCartney è un genio, ecco fatto. Facile e appagante – anche perché di solito scrivi per un pubblico che non vede l'ora di sentirtelo dire. Con oggetti di scena frusti dall'uso si è inventato un meccanismo efficace, che aggiunge a un disco già ricco di trovate due minuti irresistibili. Bravo, grazie.
Poi una sera ti imbatti in un vecchio filmato di McCartney che la suona coi Wings – non sono poi molte le canzoni dei Beatles che riproponeva in quel periodo – e di colpo è tutto più chiaro. I've Just Seen a Face è un numero skiffle, tutto qui. Lo skiffle era il rock'n'roll artigianale che suonavano John e Paul e George quando ancora si chiamavano Quarrymen, e strimpellavano tre chitarre per fare più baccano possibile. Ecco perché piaceva alla zia – probabilmente era una di quelle cose che canticchiava già da ragazzo e aveva portato in dote al complessino. Ecco perché già la versione di Help! è unplugged, senza basso, con due o tre chitarre e Ringo forse suona con le spazzole. Non c'è nessun mistero: bastava unire i puntini. Quelli che scambiamo per colpi di genio molto spesso sono soltanto riferimenti che non abbiamo ancora trovato.
92. No Reply (Lennon-McCartney, Beatles for Sale, 1964).
This happened once before. Pochi mesi prima, il terzo favoloso album dei Beatles si era aperto con un accordo esplosivo, avvolgente, e un grido di entusiasmo: lavoriamo come dei cani ma siamo troppo su di giri per dormire. Pochi mesi dopo, il quarto interlocutorio disco dei Beatles comincia in sordina, con Lennon che attacca un pezzo senza introduzione: ed è un brano rancoroso, introspettivo, sviluppato su un ritmo abbastanza nuovo che rasenta la bossanova. Cosa sta succedendo. C'erano brani senz'altro più energici persino in Beatles For Sale, ma l'idea di iniziare tutto nell'ombra di No Reply è probabilmente la trovata migliore del disco. Per la prima volta i Quattro decidono di mettere a disagio l'ascoltatore.
No Reply è un brano curioso, complesso, forse non del tutto riuscito, ma che meglio di tanti altri illustra la tendenza dei Beatles a non accontentarsi, a spostare il confine delle cose possibili, prendendosi non pochi rischi. È un pezzo che forse per la prima volta evoca una determinata atmosfera, uno spazio oscuro in cui si dibatte un personaggio vittima della propria gelosia. È una sensazione creata più dalla musica che dalle parole – queste ultime abbastanza meccaniche, ispirate a Lennon da altre canzoni più che da un'esperienza vissuta (l'idea di spiare la ragazza dalla finestra proviene da un classico doo-wop, Silhouettes; quanto a quel "I tried to telephone", lui stesso avrebbe chiarito di non aver mai telefonato a una ragazza in vita sua, le case inglesi non erano ancora equipaggiate di telefoni fissi). E allora perché John sembra così sincero mentre la canta, così plausibile nel ruolo del maschio sconfitto – un ruolo in aperto contrasto con quello che i Beatles avevano impersonato fino a quel momento sui media?
Forse è il modo in cui la canta. Senonché abbiamo a disposizione su Anthology 1 di un paio di out-takes (la prima particolarmente spassosa) che ci confermano un'antica sensazione, ovvero: No Reply non nasce come una canzone cupa.
La progressione armonica della strofa è quasi tutta in maggiore: la melodia è una delle variazioni pentatoniche amate da John, anche quando rischiano di risultare un po' zuccherose e No Reply nella sua prima versione correva esattamente questo rischio: era ancora una canzone yeh-yeh, anche se abbinata a un testo più drammatico. Bisognava trovare un modo per adeguare la musica alla storia e credo che è a questo livello che bisogna ringraziare Paul McCartney. Non per il bridge un po' lungo e anticlimatico, che in qualche ultima dichiarazione ha lasciato intendere di poter avere inventato lui (negli ultimi anni Paul ha lasciato intendere molto senza offrire pezze d'appoggio). A mio trascurabile parere i veri interventi di Paul possono essere stati altri, e determinanti. Per esempio, potrebbe aver suggerito il ritmo, che Ringo suona con qualche espressiva esitazione: è un'ipotesi ma in tutti gli altri rari casi in cui i Beatles hanno costeggiato la bossanova, Paul era sempre il colpevole. La bossanova era una scelta incongrua ma almeno impediva al brano di suonare troppo yeh-yeh: costringeva le chitarre ad abbassare i toni e questo andava nella direzione giusta: ma il vero colpo di genio è quel passaggio di accordi in minore a metà strofa, che nella prima versione non c'era. Il momento in cui John grida "I saw the light" (e "I nearly die"), e la sua disperazione si associa immediatamente a un accordo che sembra inventato in quel momento e invece... boh pare che sia un semplice la minore.
Uno è abituato a identificare sia i Beatles che la bossanova con gli accordi assurdi, per cui può persino rimanerci male, ma come? Sembra molto più sofisticato. Probabilmente c'è una lieve dissonanza con quello che nello stesso momento fa Paul, con la seconda voce (e forse anche col basso). C'è come una sensazione di minore settima che prosegue subito dopo col mi minore – sono come due rintocchi a morto su una storia d'amore, e poi finalmente un accordo strano, ah ecco almeno uno c'è – un Famaj7. Niente di eccezionale eppure è come se i Beatles energetici di A Hard Day's Night avessero aggiunto un'intera dimensione alle loro composizioni. No Reply è forse il primo loro brano che lascia un sapore amaro in bocca, qualcosa con cui è difficile riconciliarsi. Anche il titolo è uno dei più ambigui mai messi in nero su bianco da Lennon: "nessuna replica" indica sia il silenzio-assenso della ragazza fedifraga davanti alle accuse, sia la reazione finale del Protagonista: non ci sarà replica, la storia è finita. Il disco invece è iniziato. Non sarà il solito allegro disco dei Beatles, questo è già abbastanza chiaro. (Ma se fosse stato tutto coraggioso e innovativo come No Reply, che disco fantastico sarebbe stato).
91. From Me to You (Lennon-McCartney, singolo, 1963).
Da da da, da da dumb dumb da. A volte bisognerebbe avere il coraggio di dare anche a Neil Sedaka ciò che è di Neil Sedaka – quando gli chiesero, ehi Neil, ma i Beatles, lui si limitò a rispondere: "The Beatles? No good". Piuttosto laconico ma anche diplomatico, da parte di un tizio la cui carriera è stata devastata da quella di quei Quattro come da uno schiacciasassi.
Molto spesso, quando parliamo dei Beatles gli storici della musica e del costume sono tentati dall'affermare che siano stati i primi a fare questo, i primi a fare quello. Il che non è mai vero al cento per cento e in molti casi è il risultato di un effetto ottico: se quello che fecero i Beatles ci sembra rivoluzionario rispetto al pop precedente è soprattutto perché non vediamo i passaggi intermedi: e se non li vediamo è perché in molti casi i Beatles se li sono mangiati. È capitato pure a me, quando ho sottolineato la questione del gender-swap: i Beatles fecero faville negli USA proponendo una versione mascolina, inedita, del teenpop americano femminile. Il che non è sbagliato: quel che non è vero è che questa idea sia venuta solo ai Beatles, o ai Beatles per primi. Nello stesso periodo c'erano fiori di autori e interpreti che stavano tentando una via maschile al teenpop: Sedaka, Paul Anka, mettiamoci pure i Beach Boys.
Magari questo coincideva con un'ideale di mascolinità davvero molto addomesticato, il classico ragazzo acqua e sapone e felpa del college, o giacca e cravatta, questa sì completamente spazzata via dalle irruenti chiome esistenzialiste dei Quattro teppistelli. Ma se i Beatles invasero l'America, facendo letteralmente fuggire Sedaka e soci dalle top10, fu perché malgrado tutta la loro attitudine da teddy boy proponevano esattamente gli stessi garruli ritornelli, per esempio a chi si chiede meravigliato come mai il passo successivo all'esplosione di Please Please Me fosse una cosa molto più tranquilla e confidenziale come From Me to You, vale la pena di notare che nelle classifiche inglesi, in quel '63, languiva dolcemente Neil Sedaka con Breaking Up It's Hard to Do, meglio conosciuta con l'immortale verso "Come on come on down doo bee doo down down". Davvero stupisce che i Beatles rispondessero con quel "Da da da, da da dumb dumb da"? Ma come, cioè i Beatles, questi geniali innovatori, stavano semplicemente mettendosi sulla scia del singolo pop che stava andando più forte in quel momento? Precisamente. Senza scrupoli – quelli che un anno prima li avevano trattenuti dall'incidere How Do You Do It: ecco, non ne avevano più. Era bastato cominciare ad annusare un po' di soldi seri.
From Me To You fu già salutata da alcuni critici come una delusione, il segno che la meteora era già entrata nella fase discendente, e ancora oggi risulta essere il Lato A più basso in classifica dopo The Ballad of John and Yoko, nonché il primo brano in assoluto del Disco Rosso che ascoltiamo risalendo. Il Disco Rosso è la storica antologia The Beatles 1962-1966, la più grande collezione di hit da classifica messe assieme da un gruppo solo su un LP doppio. Ci sono tutti i singoli di quei cinque anni commercialmente incredibili, ci sono altri classici come Yesterday ed Eleonor Rigby, e a quanto pare il brano più debole è From Me To You. Che comunque è un brano interessante, con quel riff cantato e fin troppo cantabile sottolineato dall'armonica (cromatica), che irride comunque le convenzioni melodiche: se i "Da" sono semplici note, i "Damb" slittano per un intero tono; c'è quel bridge che parte in Sol minore creando una profondità confidenziale a un brano fino a quel momento semplicissimo, e finisce con un tocco da maestro imprevedibile, quel "whooo" acuto cantato a due voci. Insomma dopo lo choc di Please Please Me, qui c'è l'altro lato del mestiere: la stoffa con cui si riesce a produrre qualcosa di interessante anche con poco tempo a disposizione e non molte idee originali. I Beatles sono i Beatles perché tra un colpo di genio e l'altro riuscivano anche a mandare a segno cose come From Me to You. Whooooo...
Le canzoni dei Beatles (#110-101)
03-05-2020, 13:19beatles, Il Post, musicaPermalinkPuntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111).
La playlist su Spotify.
110. If I Needed Someone (Harrison, Rubber Soul, 1965)
Se avessi bisogno di qualcuno da amare, tu sei la persona che mi verrebbe in mente – e sottolineo "se". Fino a questo momento George Harrison era riuscito a incidere coi Beatles quattro sue canzoni, di cui qui riporto i titoli perché messi in fila mi hanno sempre fatto ridere: Non seccarmi, Ho bisogno di te, Ti piaccio troppo (e anche tu mi piaci), Pensa per te (perché non sarò con te). Insomma per George fino a tutto il 1965, scrivere una canzone significa rivolgersi direttamente a qualcuno, con lo scopo specifico di prendere le distanze. Se la musa del giovane John è la gelosia, potremmo dire che quella del primo George è l'autonomia: anche quando la sacrifica, come in I Need You, lo fa proprio perché la considera il suo bene più prezioso. If I Needed è l'ultima canzone del periodo, l'unica che Harrison sia riuscito a portare nelle scalette dal vivo, e riassume felicemente tutta la striminzita ma coerente poetica ur-harrisoniana: magari mi piaci, ma non ho bisogno di te. Siamo autorizzati a leggerci un sottotesto autoironico: in fondo se John con I'll Cry Instead stava prendendo in giro il sé stesso geloso, anche Harrison aveva abbastanza spirito per sorridere di questo personaggio che ufficialmente non ha bisogno di nessuno, non ha tempo per nessuno, ma ti chiede comunque di scribacchiare il numero di telefono sulla tappezzeria (molto rock'n'roll quest'esigenza di dissimulare l'interesse) (e poi, certo, George si stava per sposare e sentiva l'esigenza di chiedere scusa a tutte le ragazze che se solo si fossero fatte vive un po' prima di Pattie, chissà).
Se Rubber Soul è il disco centrale dei Beatles, If I Needed si trova in particolare in un affollatissimo crocevia. Da una parte c'è una strada che arriva dritta dalla California: George non si preoccupa di far sentire il tipico jingle-jangle dei Byrds, e a buon diritto, visto che i Byrds erano stati i primi a riconoscere l'influenza degli accordi spennati da George sulla Rickenbaker a 12 corde in A Hard Day's Night: la strada insomma si percorre in due sensi e a quest'altezza il giovane Harrison ha più bisogno che mai di mostrare che anche lui ha uno stile distintivo che vantava tentativi d'imitazione. La canzone andò anche in classifica, grazie a una cover degli Hollies che a Harrison non piaceva troppo.
Sull'altro lato dell'incrocio c'è una via che porta ancora più lontano, verso l'India: If I Needed è la prima canzone di Harrison a suggerire un'interesse per i raga indiani, senza nessun bisogno di appariscenti oggetti di scena come il sitar o la tabla – fondamentali, invece, i cori e il basso ipnotico di Paul McCartney, e bisogna dire che sia qua che in Taxman che in I Want to Tell You sembra essere Paul il guru che sviscera l'essenza dravidica di canzoni apparentemente ancora del tutto occidentali. È come se Paul sapesse già che la strada di George porta verso l'India, quando ancora George sta fingendo di guardare da tutt'altra parte.
109. Birthday (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
Yes we're going to a party, party. Prima di lanciarsi in pista, un po' di numeri a caso: abbiamo già scoperto qual è il disco in assoluto meno apprezzato dai critici (With the Beatles). In particolare, il secondo lato di quel disco lo abbiamo già completamente coperto: nessuna canzone compare nelle prime 110. Sembra insomma il lato di 33 giri più scarso di tutta la storia dei Beatles. E invece qual è il lato migliore? Onestamente non lo so – bisogna fare la media e non credo che ne valga la pena – però posso dirvi qual è l'unico lato dei loro dischi che non abbiamo ancora cominciato ad ascoltare, ovvero quello in cui non c'è neanche una canzone sotto il 110: ebbene sì, è proprio quello che comincia con Birthday, il terzo lato del Bianco. L'avreste mai detto?
In generale non credo che nessuno lo consideri il miglior lato di quel disco: non contiene nessun grande classico, la canzone più famosa è Helter Skelter e non è famosa per i motivi giusti. Però non c'è nessun riempitivo inutile – a meno che non sia proprio Birthday, il primo brano che incontriamo risalendo. E però come si fa a considerare inutile Birthday? È veramente il punto centrale del Disco Bianco, quello che mette le cose in chiaro una volta per tutte: questo album è una festa, e come in tutte le feste non è che tutto vada alla perfezione, anzi. Fanculo alla perfezione, Birthday arriva a metà, dopo il minuto di raccoglimento per Julia, ed è più o meno il momento in cui accendono la luce e servono la torta con le candeline, il che significa che un sacco di gente è già ubriaca. E va bene così, sono felice che è il tuo compleanno. Se Sgt. Pepper era la risposta a Pet Sounds, questo pezzo è un breve e fortunato tentativo di fare qualcosa di paragonabile all'altro disco iconico dei rivali californiani, Beach Boys' Party. Nei primi anni le feste erano lo sfondo in cui si incontravano i personaggi del beatleverso, più che altro per ballarsi o tenersi la mano o evitarsi. I tempi passano, i ragazzi crescono, ora sta ai Beatles non tocca più partecipare a una festa, ma organizzarla. E ci riescono alla grande, secondo me, come quelle famiglie che sprizzano energia anche quando litigano.
Birthday può sembrare un brano inciso alla svelta e lo è, ma è anche il vero manifesto del disco, la dichiarazione d'intenti: per quanto ci abbiano messo mesi a registrarlo, la maggior parte delle canzoni suona proprio come Birthday, che invece fu scritta e incisa in un giorno, buona la prima. Considerato che erano il gruppo più famoso del mondo e stavano scrivendo una canzone sul compleanno (giova ricordare che Tanti auguri a te è stata per lungo tempo una delle canzoni più redditizie), la scelta di buttar giù un rock'n'roll ridanciano non era affatto scontata. Da un punto di vista musicale poi Birthday è molto più interessante di quanto sembri. La prima parte è un solido blues basato su un riff semplice e martellante, suonato all'unisono da chitarra e basso. Niente di strano, insomma, salvo che è il 1968. L'idea di costruire canzoni sui basici riff di chitarra non era originalissima e aveva già regalato grandi soddisfazioni ai primi Kinks (You Really Got Me) e ai Rolling Stones (Satisfaction), ma nel 1968 sia Kinks che Stones facevano già altro – la fiaccola è passata ai Cream. Al termine della sbornia psichedelica, i Beatles tornano ai riff col Disco Bianco. Di lì a poco, un altro quartetto inglese imporrà i riff semplici e potenti su progressioni blues sempre più ossessive: stanno già provando da qualche parte a Londra, a un certo punto decideranno di chiamarsi Led Zeppelin. Ebbene sì, Birthday è il brano che assomiglia più a Heartbreaker.
108. The Word (Lennon-McCartney, Rubber Soul)
In the beginning I've misunderstood. But now I've got it, the word is good. Quelli che preferiscono Rubber Soul, hanno buon gusto. Forse troppo buon gusto per essere veri beatlemani. Rubber Soul è il disco cool, quello che pur senza smettere di fare passi avanti, non ne fa nemmeno uno falso, nemmeno uno più lungo della gamba. Gli esperimenti sono tutti controllati e rigorosi e somministrati a un pubblico già testato dai due dischi precedenti. I rischi (che ci sono), sono minimizzati, e forse è l'unico caso in cui Lennon e McCartney si sono detti ok, contentiamoci di fare al massimo quello che sappiamo già fare. Per esempio il blues come lo facciamo noi – un po' di plastica? E sia. Un blues, però col bridge. Non era nemmeno la prima volta che ci provavano: quel che cambia è una maggiore consapevolezza dei limiti e delle capacità, una coolness che si taglia col coltello e ti può anche lasciare un po' freddo se ti piacciono i Beatles maldestri e scavezzacollo.
Più di un compositore, al massimo delle sue capacità, si è lasciato tentare da quell'esibizione di coolness suprema che è la canzone su una nota sola. Rossini il più rigoroso, Elio il più situazionista, e chissà se Lennon aveva in mente l'esempio di Jobim: in comune con la Samba de uma nota só c'è l'idea di variare il monomelodismo della strofa con un bridge più movimentato. E se Jobim si faceva scrivere un testo autoreferenziale, Lennon è più sottile: la canzone che gira intorno a una nota sola anche dal punto di vista del contenuto dovrà girare intorno a un solo concetto, a una sola Parola. Questa Parola – ne siamo sicuri ben prima del ritornello – non può che essere "amore", l'argomento del 99% delle loro canzoni fin qui. Sarebbe incredibile a questo punto che Lennon avesse qualcosa di nuovo da dirci, eppure succede.
La necessità di trattare l'"amore" come una parola astratta lo porta sugli imprevisti sentieri retorici del predicatore, da cui il divertente paradosso: la prima canzone composta durante l'assunzione di cannabis (secondo la testimonianza di McCartney) è anche la prima canzone in cui compare nei testi di Lennon una reminiscenza evangelica: "Say the word" viene nientemeno che da Matteo 8,8, la sfida tra Gesù Cristo e i Beatles è appena stata lanciata e Lennon comincia già a scopiazzare. Nel vago messianismo del testo sarà poi riconosciuta la profezia del flower power prossimo a sbocciare.
107. Mother Nature's Son (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
All day long, I am sitting singing songs for everyone. Quando viaggi non sai mai cosa ti porti a casa, ma qualcosa comunque te lo porti. I Beatles andarono in India a cercare l'Assoluto; non lo trovarono; ci rimasero male; se la presero con il Maharishi. Tornarono a casa con splendide canzoni arpeggiate alla chitarra acustica. Niente assoluto, ma in compenso avevano scoperto il Fingerpicking. Buttalo via. Ne sarebbe valsa la pena anche solo per quello: non per le sedute col guru, ma per le pause sigaretta-chitarra con Donovan.
Il motivo per cui ho iniziato questa cosa è che riascoltando i Beatles mi sono accorto che per me ogni canzone era una storia. A volte anche più storie. Mi sembrava un'idea interessante raccontarle. Quasi sempre può essere un modo per convincere qualcuno ad ascoltarla, o riascoltarla, quindi perché no. Ci sono però casi in cui le storie danneggiano la canzone. Mother Nature's Son è un breve idillio campestre tratteggiato da Paul alla chitarra e sostenuto da un'orchestrazione minimale (suggerita da Lennon), se posso usare "incantevole" una volta sola ogni venti canzoni me la gioco con questa. Una splendida mattina sotto un cielo terso, con appena qualche nuvola all'orizzonte, bianca, inoffensiva. Qualsiasi cosa io possa aggiungere la renderà più incantevole?
Per esempio: è la canzone che ha buttato fuori dal Disco Bianco Child of Nature di Lennon, perché erano entrambe ispirate a un sermone del Maharishi e quindi decisero di tenerne una sola. E a questo punto il cielo comincia ad annuvolarsi, cominciamo a domandarci se è stata la scelta migliore, ovvio che no! Child era più ispirata... ma forse proiettiamo, perché più che Child abbiamo in mente quello che sarebbe diventata, ovvero Jealous Guy, ma alzi la mano chi si immaginava nei primi anni '70 che Jealous Guy sarebbe diventata una delle più iconiche canzoni di Lennon? Non è stato un po' grazie ai Roxy Music? Non è stata la somiglianza a Imagine, la perfetta aderenza all'immagine di sé che Lennon volle dare da un certo momento in poi? Potremmo aggiungere che Mother's Nature Son è la prosecuzione di The Fool On the Hill, che contribuisce a costruire quell'immagine eremitica di Paul che a sua volta sarebbe diventata la sua identità 'pubblica' nei primissimi anni postbeatlesiani; che sviluppa con più serenità più o meno le stesse trovate di Blackbird e all'interno del Disco Bianco si trova in una curiosa dialettica con Sexy Sadie, il brano che irride lo stesso Maharishi. Nel frattempo il cielo si è fatto plumbeo, si vedono già i primi fulmini dietro a quelle nuvole nere là in fondo, ecco fatto. Ogni canzone ha una storia, ma certe canzoni non ne hanno alcun bisogno.
106. This Boy (Lennon-McCartney, lato B di I Want to Hold Your Hand, 1963).
Quel ragazzo mi ha portato via l'amore, ma se ne pentirà; questo ragazzo invece ti rivuole. Cosa ci fa così in alto questa? This Boy prosegue la tradizione del lato B lento da suonare dopo aver stancato la ragazza saltellando sul lato A; in particolare è il lento che accompagna I Want to Hold Your Hand, il 45 giri che proiettò i Beatles nel mercato americano: e questo credo spieghi l'affetto particolare dei critici americani che la beatlemania fecero in tempo a viverla nei suoi primi giorni acerbi e incomprensibili, la loro passione per certi precoci momenti della ditta Lennon-McCartney che noi ascoltatori europei troviamo francamente datati. Abbiamo un orecchio diverso: This Boy per noi sembra un tentativo non troppo originale di muoversi sui sentieri del doo-wop, dei quartetti vocali anni Cinquanta – il che tra l'altro fa a pugni con l'idea abbastanza inglese e in generale continentale, secondo cui i Beatles costituirebbero una frattura tra i Cinquanta e i Sessanta, il pop dei nonni e il rock dei padri, il medioevo e la contemporaneità. Che Lennon possa essere stato tentato di ricostruire le atmosfere languide di qualche emulo dei Platters ci sembra un dettaglio secondario, da nascondere sotto il tappeto. In America non la pensano così. In America questo tipo di emulazione suonava così strana, quasi oltraggiosa, da costituire qualcosa di nuovo. Come scrive Dylan di I Wanna Hold Your Hand: quegli accordi erano un oltraggio, ecco, anche l'idea che i coretti vocali potessero farli tre zazzeruti ragazzi inglesi, aveva qualcosa di inconciliabile col buon gusto. Noi vorremmo che la Storia procedesse a scatti: vorremmo dimostrare che i Beatles hanno fatto la Storia inventando qualcosa di nuovo, il che è un po' vero ma equivochiamo il senso di cosa sia un'invenzione: per noi dovrebbe essere una specie di creazione dal nulla. I Beatles non creavano dal nulla: prendevano tutto quello che sapevano, lo mescolavano un po', lo eseguivano al meglio delle loro capacità ma fraintendendo questo o quell'elemento, e non facendo attenzione a dettagli che invece per gli ascoltatori tradizionali erano fondamentali. Il risultato è sì, qualcosa di nuovo, ma ottenuto attraverso un procedimento accidentale, evolutivo.
Un aspetto originale di This Boy è che parla di un triangolo: una ragazza e due ragazzi: uno la rifiuta, l'altro la rivuole. Situazione abbastanza topica per le canzoni pop, ma non per i Beatles (mi viene in mente solo You're Going to Lose That Girl, forse You Can't Do That), e questo malgrado la gelosia, lo abbiamo già detto quella dozzina di volte, sia la musa specifica di John Lennon. Ma forse è una gelosia talmente insofferente che non tollera la presenza di un rivale: è una gelosia preventiva, la ragazza deve stare attenta anche solo a guardarli, i potenziali concorrenti. Al punto che ascoltando This Boy può venire il dubbio che "that boy" e "this boy" non siano che figure dello stesso Lennon, sospeso tra le due polarità del suo carattere: quel ragazzo non ti vuole più, quest'altro sì. This Boy è il fantasma che opprime Paul McCartney mentre si danna per registrare Oh! Darling, un'altra canzone in cui il triangolo è troppo imbarazzante e penoso per essere esplicitato.
105. The Ballad of John and Yoko (Lennon-McCartney, singolo, 1969).
Succede tutto all'improvviso. Un mese prima Paul McCartney ha sposato Linda Eastman a Londra con una piccola cerimonia civile. Pochi giorni dopo, John Lennon, in vacanza a Parigi, chiede a Yoko Ono di sposarlo. Lei dice di sì, ma si scopre che in Francia due sudditi di Sua Maestà non si possono sposare. Che scemenze, bisognerebbe fare qualcosa per tutte queste frontiere inutili, che ne so, un'Unione Europea, seh, campa cavallo. Comunque contattano i loro agenti, che contattano le ambasciate e i consolati, che contattano qualcun altro e insomma alla fine si trova per questa capricciosa coppia di artisti-VIP una soluzione di compromesso: Lennon e Ono si sposeranno a Gibilterra, che non è Parigi neanche per sbaglio ma è abbastanza vecchia romantica Europa senza smettere di essere territorio britannico. Il viaggio prosegue ad Amsterdam, dove i due novelli sposi organizzano uno dei loro primi e più riusciti happening, il bed-in. Tornato da quella che a questo punto è una luna di miele, John porta una canzone da registrare ai Beatles, salvo che non è affatto chiaro se esistano ancora, i Beatles.
Dopo la deprimente conclusione del progetto Get Back! si erano dati una pausa: George Harrison è in vacanza, Ringo è impegnato sul set di un film; a Londra c'è solo Paul ma, a differenza di quello che succederà mesi dopo con Cold Turkey, Paul un singolo con John ha voglia di inciderlo. Suonerà il basso ma anche la batteria, che aveva già inciso in qualche pezzo del Bianco quando Ringo se n'era andato temporaneamente via. Sono momenti difficili per la Apple Corps: un singolo targato Beatles è comunque una rassicurante fonte di entrate, e una garanzia che tutto sta ancora in un qualche modo funzionando. E qualcosa sta funzionando. Non è certo la prima volta che gli artisti ancora noti col nome di Beatles incidono qualcosa in fretta e furia: non è più un'esigenza contrattuale ma forse è diventata un'esigenza esistenziale. Possiamo davvero immaginarci Paul che ascolta la canzone e pensa: se non lo assecondo stavolta, questo molla la ditta. E quindi Lennon avrà la sua canzone nuziale targata Beatles. Forse non ci teneva nemmeno. D'altro canto è probabile che se non l'avesse registrata con Paul, l'avrebbe mandata fuori da solo o con Yoko ai cori. Chi ha scritto su wikipedia che The Ballad non è una vera ballata non ha capito il senso del riferimento: Lennon ha in mente il senso del termine nel folk americano, in cui la Ballata è un brano più cronachistico che narrativo, che serve per informare il pubblico di qualcosa di importante e di appena successo; e quello che rende un filo imbarazzante l'ascolto di The Ballad of John and Yoko è che chi canta sembra davvero continuo di aver vissuto una genuina avventura, qualcosa di romantico e appassionante che dovrebbe interessarci. "Se vanno avanti così le cose, mi crocifiggeranno", dice, e non è chiaro se stia scherzando o no.
The Ballad è un'instant song, la prima di un mazzetto di instant song che Lennon comporrà nei mesi successivi con varie denominazioni: qualche mese dopo ci sarà Give Peace a Chance targata Plastic Ono Band (ancora attribuita a Lennon-McCartney!), in autunno Cold Turkey che avrebbe potuto essere ancora un brano dei Beatles se McCartney non si fosse opposto; in febbraio Instant Kharma, la sua prima collaborazione con Phil Spector. I brani – registrati sempre al volo, con un'urgenza che è percepibile nell'esecuzione – erano parte di una strategia di occupazione dei media da parte della coppia Lennon-Ono, insieme con gli happening per la pace. Oltre alla pace nel mondo, Lennon stava anche lottando più o meno consapevolmente per costruire la sua immagine pubblica post-Beatles, e col senno del poi stupisce quanto Paul fosse pronto ad assecondarlo, perlomeno fin qui. La canzone d'altro canto è piacevole, anche e soprattutto per quell'aria di fatto-in-casa: e dire che, con l'eccezione di un brano sui generis come All You Need Is Love, è il primo vero Lato A di Lennon dopo un biennio di trionfi di Paul. Il rischio che diventi una hit è comunque parzialmente scongiurato con l'inclusione di quella sillaba blasfema nel ritornello, "Christ". Alle radio inglesi e americane fu distribuita una versione decristizzata, il che trasformava il primo ascolto del singolo appena acquistato in uno choc, una specie di esperimento sociale, condotto per lo più sullo stesso bacino di ascoltatori che non avevano gradito quella famosa uscita di Lennon sull'essere più famosi di Gesù.
Possono passare decenni dal primo ascolto prima di accorgersi che il testo è molto meno ironico di quando il tono di quella voce non autorizzi a pensare. A riscattarlo è l'attitudine con cui lo canta, quel tono beffardo con cui sembra prendersi gioco anche di sé stesso – come se da qualche parte nella sua testa ci fosse ancora quel ragazzo sfrontato che scrolla la testa davanti alle mattane dei due milionari.
104 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise) (Lennon-McCartney, nel disco omonimo, 1967).
Ha un senso trattare la Reprise del brano che dà il titolo a Sgt. Pepper come una canzone a parte? Secondo qualche critico sì, e chi siamo noi per opporci. Ultimate Classic Rock la inserisce in classifica più di cento posizioni sotto il primo brano; Vulture invece la mette quaranta posizioni più avanti! Al di là di tutto, è pur sempre il pezzo che ha introdotto nei dischi di musica leggera il concetto di reprise. Se non lo avessero fatto loro molto presto ci avrebbe provato qualcun altro, però oh, niente da fare, anche stavolta sono arrivati prima loro. Del brano iniziale mantiene soltanto il bridge, che si era sentito sul primo lato appena per ventiquattro battute, e lo ripresenta un po' accelerato, quasi funky, come se Ringo avesse già capito che in certi casi più che un batterista serve una drum machine. Nella traccia vocale il falsetto di Lennon prende il sopravvento, causando nell'ascoltatore un misto di soddisfazione e rimpianto; soddisfazione, perché viene ripreso con più agio un tema che nel primo lato era stato abbozzato ma subito soppresso per introdurre altre cose più barocche e vistose ma non necessariamente migliori; rimpianto perché accidenti, allora è vero che sotto i costumi colorati c'è ancora una rock'n'roll band, e dispiace avere così poco tempo per sentirla. "We're sorry but it's time to go", ma come? Siete appena arrivati!
Sgt Pepper (il disco) funziona "perché noi abbiamo detto che funzionava" (Lennon): in un certo senso è vero; il momento preciso in cui l'ascoltatore ha la sensazione che il Concetto funzioni è proprio quello in cui i suoni della fattoria si mescolano al "One-Two-Three-Four" della banda. Per un minuto, tutto sembra al suo posto. Ascoltando la Reprise abbiamo la sensazione di aver trovato la cornice intorno al quadro – e di aver capito che è un quadro-nel quadro, una mise en abyme, una band dentro la band. Poi comincia A Day in the Life, ed è subito chiaro che siamo fuori dalla cornice, quasi fuori dal disco, in uno spazio nuovo che i Beatles stanno appena iniziando a creare. Non c'è più bisogno di travestirsi – ma è stato divertente.
103. Run For Your Life (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)
Non posso mica passar la vita a metterti in riga. Il disco più rappresentativo della band più di successo di tutto l'Occidente, nell'anno di grazia 1965, si conclude con un abbozzo di femminicidio. Il disco che vola in classifica ed entra in gran parte delle case dei possessori anglofoni di giradischi comprende il verso: you know that I am a wicked guy and I was born with a jealous mind. Sì, senz'altro il rock and roll da classifica si era già dato un'aria da maudit, ed Elvis aveva anche ventilato trascorsi carcerari, ma qui davvero Lennon non si sta bullando, non recita, non si atteggia: sta tirando fuori da sé un'ossessione con una spietatezza che capovolge il senso di Run for Your Life: quella che al primo ascolto ci può sembrare la canzone più datata del mazzo (anche per l'arrangiamento country che dopo i primi cinque dischi associamo istintivamente ai brani tappabuchi) si rivela il brano più contemporaneo. Come suggerisce fortuitamente la copertina, Lennon fora la quarta parete, abolisce tutti i filtri tra il suo vissuto e il suo personaggio pubblico, si toglie per la prima volta la divisa da Beatle e confessa di essere un mostro, un un tizio da cui stare lontano. Oltre alle parole, è fondamentale il tono con cui le dice, il timbro quasi stridulo, satanico, di un tizio che ha deciso che è pazzo e che tutto sommato gli sta bene così. Non possiamo non pensare a Cynthia ma anche in questo caso, ricordiamo: Lennon canta soltanto di sé stesso ed è da sé stesso che propone a sé stesso di scappare. Certo, finire il disco con The Word sarebbe stato molto più rassicurante. Ma chi preferisce Rubber Soul forse ha ragione, c'è qualcosa di potente nell'idea di finire il disco con la canzone meno conciliabile, meno socializzabile: l'anno che era iniziato con un grido di Aiuto finisce con un Lennon braccato dalle proprie ossessioni: corri fanciulla, se vuoi salvare la pelle.
In seguito ovviamente lo stesso Lennon si sarebbe pentito di tutta questa sincerità. In un'intervista si sarebbe addirittura ridotto a puntare il dito verso un compagno – l'atteggiamento tipico del molestatore messo davanti alle proprie responsabilità: non la volevo incidere, ma sapete, George ci teneva tanto. George Harrison in effetti aggiunge un buon assolo e un tocco di falsetto nei cori che aumenta il senso di dissociazione. Ma è buffo pensare che John avesse bisogno di essere istigato da lui, per incidere Run for Your Life. E allo stesso tempo, dietro a ogni bullo c'è sempre un gregario che istiga e pungola, che ha voglia di veder scorrere il sangue.
102. I'll Cry Instead (Lennon-McCartney, A Hard Day's Night, 1964).
Quando sarà ora vi conviene nascondere tutte le ragazze del mondo, perché spezzerò il cuore a tutte, glielo spezzerò in due. Ma nel frattempo... invece piangerò. Non avrà portato la pace nel mondo, John Lennon, ma ha comunque fatto qualcosa di politicamente prezioso: è stato uno il primo macho a calare la maschera e rinunciare a un ruolo patriarcale che era stato quasi progettato per ricoprire. Sia all'interno del gruppo che nella sua vita privata, Lennon è stato un non-leader: il primo degli antieroi, il primo a svelare ed esibire la fatica che costa al maschio alfa nascondere dubbi e le paure sotto un ghigno. Lo ha fatto nel momento stesso in cui ha accettato nel gruppo una forza creativa come Paul, ben sapendo che non l'avrebbe mai potuta dominare. Come notava Philip Norman, tutti i gruppi del periodo si chiamavano "Tal dei Tali e Compagnia Bella", vedì Gerry and the Pacemakers. Anche i Beatles avrebbero potuto chiamarsi John and the Moondog, o John and the Silver Beatles, e se non successe fu perché John, malgrado le sue pose da leader, non lo voleva. Fu John Lennon a inventare il concetto di Band che diamo per scontato da mezzo secolo, un pool di artisti-compositori legati da un sodalizio artistico senza nessun leader apparente: fu lui che lasciò a Paul la libertà di incidere Yesterday quando ancora poteva esercitare un qualche diritto di veto, e addirittura gli suggerì di ripescare l'arpeggio di Michelle: se i Beatles esplosero creativamente in modo incontrollabile, fu John che lo permise.
Costa qualche fatica ammetterlo, visto che nessuno dei due John estremi risulta così simpatico: né quello femminicida di Run for Your Life, né quello ripiegato a larva sulla moglie-madre Yoko. E allo stesso tempo bisogna riconoscergli di essere stato l'autore che a un certo punto ha smesso di considerare la gelosia un simpatico argomento per canzoni da teenager, e si è accorto che somigliava più a una malattia. Questo in realtà succede all'altezza di Getting Better, non certo con I'll Cry Instead, che è una più semplice variazione su un tema tipico di molte hit r'n'b: dietro la maschera da uomo c'è un ragazzino che piange. Ma nei brani di Smokey Robinson si tratta di un meccanismo funzionale a conferire al personaggio del cantante una maggiore profondità: mi vedi qui tutto allegro ma in realtà in segreto mi struggo, ecc.. In I'll Cry Lennon va più avanti in direzione dell'autoparodia, anche a causa dell'arrangiamento country: musica e parole sono esattamente quelle che ci si aspetterebbe dal solito macho possessivo che Lennon ha appena interpretato con molta convinzione in You Can't Do That. La rivelazione arriva inattesa nel ritornello, proprio come una maschera che casca all'improvviso: tutto quello che posso davvero fare è... piangere.
101. The Night Before (Lennon-McCartney, Help!, 1965)
Quando penso alle cose che abbiamo fatto, mi viene voglia di piangere. The Night Before descrive con più versi a disposizione la stessa situazione di Yesterday: ieri ero felice e innamorato, oggi è successo qualcosa di irreparabile. E come in Yesterday qualcosa non torna nella verbalizzazione: "trattami come mi trattavi la notte prima" non è meno incongruo di "Ieri arrivò all'improvviso" o "credo nello ieri". Ma insomma siamo nella fase in cui Paul comincia ad accorgersi che le relazioni sono cose complicate, e "Treat me like you did the night before" è un verso di una goffezza disarmante e spietata: non potresti comportarti con me come se rispetto a ieri non fosse successo niente? Il machismo è finito, almeno sul versante di Paul: i personaggi maschili sono sempre più insicuri e smarriti. Sul versante John c'è ancora spazio per qualche scenata di gelosia, ma ormai si è capito che è quasi tutta scena.
The Night Before è uno di quei brani composti e incisi dai Beatles col pilota automatico, al punto che gli stessi protagonisti hanno ricordi molto vaghi. Lo spezzone dedicato di Help!, ambientato a Stonehenge, colpisce per lo scarto sempre più notevole tra immagine e contenuto: anche quando cantano di amori difficili, i Quattro devono sorridere e scambiarsi smorfie di entusiasmo e soddisfazione. Che importa se la bruma è fredda e il vento soffia, ridete perdio, siete i Beatles. Lennon è ormai accreditato come l'organista del gruppo; Paul canta e doppia l'assolo di George (su un'ottava diversa). Probabilmente era una soluzione di compromesso per lasciare a George il ruolo di chitarra solista anche nei casi in cui Paul arrivava con un assolo già pronto; da un punto di vista stilistico però è un modo di far sentire l'assolo come qualcosa di diverso; non più lo sfogo esibizionistico di un solista, ma un breve movimento coordinato, una variazione. Più un riff che un assolo, ormai.
Le canzoni dei Beatles (#120-111)
21-04-2020, 18:47beatles, Il Post, musicaPermalinkPuntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121)
La playlist su Spotify
120. Good Morning Good Morning (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club's Band, 1967).
Lo sanno tutti che non c'è niente da fare. È tutto chiuso, tutto una rovina. Tutti quelli che vedi sono mezzi addormentati e tu sei da solo, sei in strada. Ma è ancora Sgt Pepper questo? Sì e no. Per quanto sia ancora considerato unanimemente il "concept album" dei Beatles, non è poi così chiaro quale sia questo Concetto. Né fu di molto aiuto John Lennon in una delle sue ultime interviste: lo chiamano il primo concept album, ma "non va da nessuna parte: funziona perché noi abbiamo sempre detto che funziona". Il che alla fine è un po' vero, non dite di no. L'idea di un carosello di canzoni cantate da un complessino, il Club dei Cuori Spezzati del Sergente Pepe, è una suggestione che funziona soprattutto grazie al packaging, la copertina e gli accessori, insomma è una cosa che ci è stata venduta (e siamo stati tutti felici di comprarcela). La suggestione è sostenuta dalle prime due canzoni, la prima delle quali dà il titolo e viene ripresa verso la fine del disco: tutti gli altri pezzi avrebbero potuto stare in qualsiasi altro album, sosteneva Lennon 13 anni più tardi; in particolare le sue non le aveva certo scritte per il Club del Sergente Pepe. O no?
 |
| L'artista Peter Blake posa di fianco a una copia dell'album dei Beatles Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, di cui disegnò la copertina nel 1967. |
Sembra facile liquidare il "concept" come la classica idea di Paul, sviluppata solo a metà e accettata abbastanza passivamente dai colleghi: quel che succederà senz'altro di lì a pochi mesi col Magical Mystery Tour. E quindi avremmo Paul tutto eccitato dall'idea di travestirsi (in qualcuno vagamente simile al padre da giovane), Ringo sempre pronto a recitare il suo siparietto, John e George ancora disposti a sopportare i travestimenti anche perché mentalmente un po' lontani, John a causa della quotidiana ingestione di LSD, George in piena fase trascendentale-orientale. Se queste sono le premesse non è nemmeno così paradossale che le canzoni più estreme e memorabili siano quelle degli ultimi due: Lucy, Within You Without You, A Day in the Life sono decisamente i numeri in cui il travestimento dell'orchestrina cade del tutto.
E invece Good Morning Good Morning cos'è? È un brano di John, con un importante contributo di George alla chitarra e ai cori, che ci racconta una storia completamente diversa: in realtà un Concetto unitario c'era (anche se non è esattamente quello che siamo soliti associare al disco), e John cercò di svilupparlo, sforzandosi almeno quanto Paul: ci sono almeno un paio di brani di John che tutto sommato sarebbe stato difficile trovare in altri dischi dei Beatles, e che sono funzionali a creare e mantenere una determinata atmosfera: uno è Being for the Benefit of Mr Kite, l'altro è Good Morning. E per quanto la classifica ci dica che sono i due brani più deboli del disco, credo siano anche fondamentali per arrivare al famoso Concetto. Che senso aveva travestirsi, nel 1967, per i Beatles?
Apparentemente è un modo per osare qualcosa di più, e da questo punto di vista Good Morning non delude: è probabilmente il brano con più salti di tempo registrato dai Quattro fino a quel momento (se non in assoluto), anche se Ringo accetta qualsiasi sfida senza fare una piega. Quello che l'ascoltatore di oggi rischia di non percepire – in particolare l'ascoltatore italiano – non è tanto lo sperimentalismo quanto la declinazione sentimentale di tutto il progetto: una specifica atmosfera settentrionale, che in questo brano è resa, per esempio, dagli ottoni. In realtà dovremmo saperlo sin dall'inizio che la Banda del Club dei Cuori Eccetera è una vera banda con gli ottoni – anche se dopo il primo brano non si sono sentiti poi così spesso. Quello che forse ci sfugge è che questo tipo di banda evoca, almeno nei Quattro, i chioschi nei parchi delle città dell'Inghilterra del Nord: proprio come le aiuole fiorite nella copertina, e gli spettacoli itineranti: tutto un folklore di provincia di cui i Quattro sentivano la nostalgia già da qualche tempo (almeno da In My Life), e che aveva già ispirato Penny Lane e Strawberry Fields. Se assumiamo che il Concetto originale non fosse tanto l'orchestrina del Sergente con le sue buffe casacche, ma il luogo che quelle buffe casacche evocavano, ovvero Liverpool (e più in generale il Nord), molti più pezzi vanno al loro posto, sia sul versante di Paul (She's Leaving Home), sia su quello di John, che con Good Morning ci consegna un interessante commiato, prima della reprise finale (A Day in the Life è un bonus di lusso: era stata incisa prima del concepimento del Concetto).
Good Morning è in effetti un modo abbastanza interessante di terminare quell'escursione nella nostalgia che avrebbe potuto essere Sgt Pepper: è il momento in cui in certi film il bianco e nero cede ai colori e si passa dallo ieri all'oggi. Salvo che si tratta di un oggi distopico in cui John non è diventato il cantante più famoso del mondo ma più naturalmente un modesto impiegato di Liverpool che suona per hobby la tromba nell'orchestrina al sabato pomeriggio. Good Morning è la giornata qualsiasi di quest'uomo qualsiasi: colazione alle sette, un jingle alla tv che ti rimane in testa tutto il giorno (Good Morning era il jingle di una marca di cereali), una modica dose di disperazione da centellinare fino a sera, la consapevolezza che tutti alla fine stanno male come lui, e una passeggiata fino alla vecchia scuola. Chissà se John ha mai potuto tornarci, alla vecchia scuola: giusto per constatare che non era cambiato nulla. L'incedere sbilenco della strofa è una dichiarazione di inadeguatezza: Lennon non ce l'avrebbe fatta, a vivere la vita di tutti noi. Per lui ogni tanto serve una battuta in più, quella in cui Ringo picchia la grancassa. Non è la banda ad accelerare all'improvviso ("People running round it's five o'clock"): è lui che a un certo punto s'incanta e tutto intorno a lui sembra mettersi a correre.

Di solito si racconta che McCartney concepì Sgt Pepper's come risposta a Pet Sounds, ma l'idea di partire col canto del gallo e fare entrare le bestie sul finale fu di John, e sembra decisamente una bonaria presa in giro del finale di Pet Sounds. Un'altra cosa che si racconta è che Paul voleva anche raccogliere la sfida di Freak Out!, lo sconcertante esordio dei Mothers di Frank Zappa, ma se c'è un brano vagamente freakouteggiante in Sgt Pepper's, è proprio Good Morning. Insomma John c'era ancora, nella Banda: più di quanto in seguito avrebbe preferito ricordare. Tutto questo ricordare Liverpool del resto non gli impediva di vivere il suo presente di divo a Londra, ovvero di andare alle feste sperando di trovare quella giapponese benedetta. Go to a show, you hope she goes. Ma d'altro canto non era sempre stato così? Anche ai vecchi tempi di Liverpool, non era sempre stato il ragazzo che se ne andava dalle feste perché "lei" non c'è?
119. There's a Place (Lennon-McCartney, Please Please Me).
There'll be no sad tomorrow. Quante rime "sorrow/tomorrow" sono concesse a un cantautore? Lennon e McCartney si giocarono la prima relativamente presto, ma forse ne valeva la pena. Nel loro album di esordio There's a Place è il trampolino su cui John monta lasciandosi alle spalle A Taste of Honey e prende la rincorsa prima di tuffarsi in Twist and Shout; comincia con un gorgheggio che sembra prendersi gioco di quelli della canzone precedente ("the-e-e-ere") ma rivela subito dopo al suo interno l'irresistibile vitalità di quella progressione I-IV-V che trionferà nel brano successivo. È il breve intermezzo tra due cover che segnalano gli estremi raggiunti dai due interpreti: le ambizioni confidenziali di Paul che intona Honey e la deriva sciamannata di John in Twist and Shout. In mezzo c'è questa canzone apparentemente semplice che testimonia i punti di forza e quelli deboli dei due apprendisti autori. Se dando un'occhiata al testo lo vogliamo considerare un brano introspettivo, un tentativo di dimostrare che sotto quelle allegre zazzere c'erano cervelli pensanti e occasionalmente sofferenti, There's a Place è abbastanza un fallimento (e dimostra anche perché i Quattro ritenessero necessario ricorrere a cover come Honey per presidiare anche questo specifico settore). Nel 1963 i Beatles non ce la fanno proprio a sembrar tristi – e dire che il loro look ad Amburgo era stato modellato su quello dei giovani esistenzialisti che si portavano i testi di Sartre e Camus al caffè. Ecco, tra i tanti stimoli captati un po' dappertutto, questo aveva lasciato i segni più superficiali: a questa altezza l'idea di un "luogo nella mente" in cui ritrovare la serenità interiore è declinato nel modo più trito e adolescenziale possibile: è il luogo dove penso a te, alle parole che mi dici (e alle "cose che fai"). Insomma magari quando si erano messi a scrivere There's a Place si erano veramente detti: proviamo a fare qualcosa di un po' più serio ("we were getting a bit more cerebral", scrive McCartney nella sua biografia). Niente da fare. Più che le parole, è la musica che tradisce un'impazienza, una gioia di cantare in coro con l'usuale spregio per le convenzioni armoniche e ritmiche (quelle terzine servite qua e là da Ringo e assecondate dai cori).

Ricapitolando There's a Place è un tentativo di canzone confidenziale che scade quasi subito nel teenpop: d'altro canto: che razza di teenpop. Da un punto di vista musicale, quel che combinano i tre cantanti coi cori è particolarmente sofisticato (quando John canta "when I'm alone", Paul lo lascia solo davvero); quanto al testo, con una straordinaria economia di parole inquadra una definizione di amore comprensibile e accettabile per gli adolescenti – e non era poi così scontato, nel 1963, che due ventenni sessualmente svezzati nei quartieri portuali di Amburgo riuscissero a conservare uno sguardo così ingenuo, fresco, sulla questione. Quell'idea di amore che ci si crea rimuginando nella propria cameretta interiore sulle cose che lui/lei ha detto, che lui/lei ha fatto. Il bridge è un po' più retorico, con quella rima sorrow/tomorrow che, potrei giocarci del denaro, è una trovata di Paul.
118. I'm Looking Through You (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965)
Pensavo di sapere tutto di te, ma cosa sapevo? Quanti versi scemi può farsi perdonare Paul McCartney anche solo per avere scritto questo (e anche quel "Love has a nasty way of disappearing overnight" non è così male). I'm looking through you fa parte di quelle che potremmo definire le sue liriche del disamore, un gruppo che include senz'altro What You're Doing e For No One. Sia Paul e John stavano sperimentando il disamore in quegli anni, anche se partendo da posizioni divergenti. È un sentimento molto meno cantabile dell'amore: quest'ultimo si può tranquillamente fingere se c'è da scrivere un successo al volo, gli scaffali sono pieni di frasi fatte da montare a piacimento. Ma se scrivi di disamore è perché proprio non ne puoi fare a meno: ti tocca di essere sincero, e I'm Looking Through You possiede proprio quella caratteristica lucidità disarmante dei testi più sinceri di Paul, dove il problema non è tanto il fatto che una ragazza non lo ami più, ma una più generica sensazione di fastidio: le cose non stanno andando come Paul aveva previsto che andassero e questo rende Paul nervoso. Magari gli complica il sonno, e sappiamo che Paul compone quando dorme.
La lavorazione di I'm Looking Through You è una storia complessa e non del tutto chiarita: se fosse stata incisa come nell'outtake di Anthology 2 sarebbe stata una delle più strane canzone dei Beatles fino a quel momento. Da una parte una strofa melodica, arpeggiata, con una progressione vagamente barocca, in cui Paul esprime con disappunto la sua frustrazione e la sua diffidenza – e benché dica cose come "You don't sound different but I've learned the game", non ci viene il minimo sospetto che possa finire male come capita nelle coeve canzoni gelose di John. Finché però Paul urla "You're not the same!", e a questo punto inopinatamente partiva un giro di blues strumentale in dodici battute, scandito dalla chitarra solista di George e da un accordo di Hammond suonato da Ringo (sul quale dovremo tornare perché, per usare un'espressione che prima o poi sul Post volevo scrivere, è un giallo). Forse un tentativo per esprimere un certo tipo di rabbia virile in modo non verbale? C'è un tipo di rancore che John riusciva a esprimere a parole e che Paul preferiva affidare al blues?
Questo tipo di incastri erano una relativa novità per i Beatles – forse il primo in assoluto fu We Can Work It Out, a cui stavano lavorando nello stesso periodo. E mentre ci lavoravano non potevano sapere che We Can Work It Out sarebbe piaciuta alle radio più dell'altro brano del singolo, Day Tripper, per cui lo stesso Paul a un certo punto potrebbe essersi domandato se non stava guardando un po' troppo oltre, se non era meglio togliere il giro blues e introdurre un classico bridge alla Beatles. Rimane comunque nella versione finale l'idea abbastanza originale di terminare la strofa con questo La-La martellante, suonato, ripeto, da Ringo all'organo Hammond. Lo ripeto perché c'è tutta una corrente di pensiero che si rifiuta di credere che Ringo suoni l'Hammond in I'm Looking Through You, malgrado le note di copertina (che del resto in tanti altri casi non risultano affidabili). Non si tratta di beatlemani della domenica: persino Mark Lewisohn non lo sente, e chi sono io per smentire il supremo Lewisohn? Però Pollack lo sente, e con le mie umili orecchie lo sento pure io: è un organo che fa semplicemente LA-LA, ha una funzione eminentemente ritmica, per cui davvero non ci vuole molta fantasia nell'immaginare che lo suoni Ringo, magari perché in studio aveva finito i fumetti da leggere e si annoiava. Questa idea della tastiera suonata come uno strumento di percussione mi piace troppo per dare non dare retta a Pollack, anche se avrei preferito che fosse l'unica sperimentazione percussionistica della canzone (quei battiti di mano che nella versione rimasterizzata mi frastornano). D'altro canto, che ne sappiamo? "Pensavo di conoscervi, ma cosa ne sapevo?"
Mentre componeva Paul potrebbe persino non essersi accorto che "to look through" in inglese ha due significati: "ti guardo attraverso", nel senso che ti guardo dentro (e ti vedo cambiata), oppure che non ti guardo affatto, è come se tu non ci fossi, non sei più quella di una volta e quindi ormai sei invisibile, sto già guardando qual che mi aspetta dopo.
117. Fixing a Hole (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club's Band, 1967).
"I'm painting the room in a colourful way". Per quasi tutte le canzoni dei Beatles c'è almeno una storia sbagliata, inventata in fretta da qualcuno che doveva sollevare una polemica. Nel caso di Fixing a Hole, l'idea davvero bizzarra che "riparare un buco da cui entra la pioggia" fosse un modo per descrivere un'iniezione di eroina. Non ha senso la metafora, non s'intona col mood della canzone, è veramente un'idea sciocca.
Per quasi tutte le canzoni dei Beatles c'è una storia che sembra più verosimile, messa in giro da qualche osservatore più attento e che però – come succede spesso alle storie troppo verosimili – è altrettanto falsa: l'idea che Fixing alludesse ai lavori di restauro necessari per rendere abitabile la fattoria scozzese che Paul si era comprato. E già ci immaginiamo un Paul neorurale che irride le complicazioni londinesi, le vaghe lusinghe del successo e si consacra alle gioie virili del bricolage – salvo che Paul in Scozia ci si sarebbe ritirato con Linda solo due anni dopo.
Per quasi tutte le canzoni dei Beatles, infine, c'è una testimonianza dell'autore, che però non è sempre il testimone affidabile: e così scopriamo infine che Paul stava parlando della gioia di passare del tempo con sé stesso e una generosa scorta di cannabis nel suo appartamento in Cavendish Avenue. Ma sarà vero? Perché sembra proprio una soluzione di compromesso tra le due storie precedenti, come se qualcuno si stesse impegnando a non deludere nessuno, e Paul a volte lo sappiamo che ha paura di deludere qualcuno. In ogni caso è una canzone che difende un approccio positivo e rilassato, scritto da una star che non deve più preoccuparsi di...? Jane Asher? Di far parte di un gruppo da cui fino a pochi prima ci si aspettavano centinaia di concerti e due dischi all'anno? In effetti se pensiamo alla loro agenda ci dev'essere stato un notevole rallentamento tra 1966 e 1967, una bolla di pace tra i tumulti della Beatlemania e la crisi successiva alla morte di Brian Epstein. Gli altri tre si dedicano alla famiglia, Paul si ritrova lo scapolo d'oro del gruppo e ne approfitta. Si rilassa e mette nel cassetto tutta quella poetica sulla frustrazione sentimentale che pure gli aveva dettato ottime canzoni negli ultimi dischi, da Yesterday a I'm Looking Through You a For No One. Rimane invece sulla tavolozza quell'ottimismo sgargiante che da solo rischia di frastornare gli ospiti, ma Paul non sempre se ne rende conto. Il mondo sta per prendere fuoco, ma lui non se la passa così male e non capisce cos'abbiano gli altri per tormentarsi.
 |
| Paul e Heather tra i fiori (Linda sta scattando). |
Fixing è un manifesto all'ottimismo in un momento in cui la scena musicale/giovanile non ne sente il minimo bisogno: nell'anno in cui incuba la rivolta, escono i primi dischi di Jimi Hendrix e dei Doors, Paul sembra proiettare già un sé stesso pronto a un buen retiro in campagna, incredulo che qualcuno non venga a chiedergli una mano per sistemare qualcosa. Fixing è un paradosso: è una canzone che rappresenta assolutamente i Beatles di Sgt Pepper, ovvero i Beatles del 1967, e allo stesso tempo è un brano che in Sgt Pepper non si capisce bene che cosa ci faccia. Incisa abbastanza rapidamente all'inizio dei lavori, prima che perfezionismo e sperimentalismo prendessero la mano, Fixing costituisce con il solco precedente, Getting Better, una specie di Dittico dell'ottimismo, ma laddove Getting poteva ancora vagamente rientrare nel Concetto di un disco liverpooliano, rivolto a rileggere il passato ("I used to be angry at school") per fare la pace col Presente, Fixing a Hole col Passato non ha più niente a che vedere: è Paul che ci tiene a farci sapere che sta bene anche se è da due anni che non suona più dal vivo – insiste un po' troppo su questo fatto di stare bene, perché l'ascoltatore non cominci a farsi tentare dal dubbio. Fixing, ad ascoltarla senza pregiudizio, è una partitura abbastanza complessa: contrappone una strofa vagamente jazz a un bridge molto più semplice e cantabile e sono esattamente quei due aspetti di Paul con cui gli ascoltatori non mccartneyani fanno più fatica a riconciliarsi: le ambizioni jazz e i ritornelli leziosi – in altre canzoni Paul li miscela con elementi più eterogenei, un rock qua, un blues là, in Fixing no. A tenergli compagnia c'è la chitarra di Harrison che invece di stemperare, sottolinea i contrasti: sofisticata nella strofa, pedestre nel bridge. Alla fine Fixing rimane per me un piccolo mistero. Non mi è mai sembrata degna di Sgt Pepper, ma forse da Sgt Pepper mi aspettavo troppo. Forse in un altro disco l'avrei apprezzata di più, ma non riesco a immaginare un altro disco adatto a lei.
116. Glass Onion (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
I've told you about Strawberry Fields. Nasce tutto da quel verso, magari buttato fuori al volo in attesa di sostituirlo con qualcosa di nuovo (come ai tempi di "Scrambled Eggs"), e che invece ad ogni prova rispunta sempre più necessario, icastico, non c'è niente da fare, la canzone dovrà parlare di nuovo di Strawberry Fields. E a questo punto tanto vale saltare lo squalo, costruire tutta una continuity, come si dice oggi, infilarci anche il Tricheco e Lady Madonna, rimescolare con qualche elemento nuovo, e trasformarla in una parodia dei Beatles più lisergici ("glass onion" è qualsiasi vetro a forma di bulbo, sia caraffa che lampadina, ma ovviamente possiamo anche immaginare una "cipolla di vetro"). Anzi no, una satira di chi cerca di capire i testi dei Beatles, chi non si rassegna al fatto che siano soltanto grumi di parole messe insieme in dormiveglia da due o tre ventenni con ampio accesso a sostanze ricreative. John Lennon ha sempre disprezzato chi cercava di intellettualizzarlo, sin da quel povero critico musicale che aveva trovato una cadenza eolia in Not A Second Time. Lennon non poteva sapere nel 1968 che alla fine sarebbe stato costretto lui stesso a trovare significati per quegli stessi grumi di parole: che per più di un decennio nessun intervistatore lo avrebbe lasciato parlare senza chiedergli il significato recondito di questa o quella canzone. Così, dopo aver preso in giro gli ascoltatori con un testo deliberatamente nonsense, Lennon sarebbe stato costretto di lì a poco a strizzare il nonsense come una rapa per trovarci una stilla di senso: a rivelare che "the walrus was Paul" alluderebbe in un qualche modo al suo proposito di lasciare i Beatles: un modo per salutarlo (ma anche per liquidare una ditta in cui si riconosceva più, con tutte le suppellettili e quel costume da tricheco che nel film era stato proprio Paul a indossare, perché ci entrava meglio).
Un'altra possibilità – che rientra nella casistica delle storie un po' troppo verosimili per essere vere – è che dopo aver buttato lì citazioni carroliane a caso in I Am the Walrus, Lennon avesse riletto Alice (o almeno visto il film) e riflettuto sul fatto che il Tricheco era il grasso profittatore. "Avrei dovuto cantare I am the Carpenter", disse per scherzo in una delle ultime interviste, ed erano già 13 anni che continuava a spremere senso dai testi che aveva improvvisato al microfono da ragazzo. Un contrappasso più che sufficiente, per chi aveva irriso i suoi interpreti con Glass Onion.
(Molti avranno già notato che "il joint a coda di rondine", oltre a uno specifico tipo di plinto molto apprezzato in carpenteria, potrebbe essere un doppio joint, un doppio cannone. Ma qualcuno ha osato aggiungere che "trying to make a dove-tail joint", cioè "tentare di rollare un doppio cannone", un cannone che possa essere fumato da due bocche contemporaneamente, potrebbe alludere alle difficoltà di proseguire il sodalizio compositivo tra Lennon-carpentiere e Paul-tricheco? La scrivo io, dai. Ricordatevi di linkarmi).
La tendenza a sovrainterpretare è innata. È l'effetto collaterale di un vantaggio evolutivo, come la pareidolia. Se siamo al mondo in questo preciso momento è perché molti nostri antenati seppero interpretare dei segni prima di altri che magari finirono travolti da milioni di catastrofi naturali – o semplicemente non sapevano interpretare i comportamenti dell'altro sesso e quindi ebbero meno opportunità di trasmettere i loro geni. I nostri progenitori invece tendevano a interpretare tutto, magari a volte esageravano e al minimo rumore nella valle scappavano per paura di una valanga, ma in questo modo effettivamente evitarono abbastanza valanghe e magari commisero anche parecchie gaffe durante i rituali di accoppiamento, ma chi non fa non falla e loro fecero abbastanza da portarci qui, e adesso noi non è che possiamo liberarci di Glass Onion dicendo semplicemente che non ha senso, eh no. Tutto deve avere un senso, siamo programmati per trovarne uno, abbiamo persino inventato la psicanalisi per trovare un senso ai sogni e ai lapsus e alle canzoni scritte con le prime parole che ti vengono in mente. Per cui se nel 1968 John Lennon si mette ad abbozzare una canzone partendo da un'altra canzone, "I've told you about Strawberry Fields"; se poi non riesce a sostituire quella frase e alla fine decide di inciderla, è perché evidentemente ha la sensazione di non riuscire a trovare niente di meglio.
Non è che non abbia più niente da dire, ma c'era un filone preciso della sua ispirazione che si stava esaurendo (in coincidenza magari casuale con la fine della storia d'amore con l'LSD): il surrealismo psichedelico. È un genere che Lennon in realtà praticò appena per una manciata d'anni e una manciata di canzoni – diciamo da Tomorrow Never Knows ad Across the Universe: ma sono tra le sue più apprezzate, dai critici ancora più che dal pubblico (vedrete quanto troveremo in alto Strawberry Fields o A Day in the Life). È un genere comunque da cui Lennon sentiva già di volersi allontanare dopo I Am the Walrus, anzi forse I Am the Walrus era già un'autoparodia, o comunque un tentativo di far esplodere il congegno dall'interno. Glass Onion è il terzo brano del Disco Bianco, e coi due precedenti sembra volerci dire che la musica è davvero cambiata: alle giocolerie armoniche di Walrus subentra una gabbia di accordi non banale ma molto più limitata, che ci lascia insoddisfatti come forse è previsto che ci dobbiamo sentire. È l'arrangiamento, soprattutto, a dirci che la psichedelia è finita: al diradarsi delle nebbie acide ritroviamo la cara vecchia formazione a quattro, due chitarre un basso e la batteria. C'è ancora qualche intruso orchestrale, e quando nel finale prendono il sopravvento, sembrano già un souvenir del passato: quel tipico suono che tutti identificano coi Beatles, si era ascoltato per la prima volta nel dicembre 1966 (Strawberry Fields) e nel novembre 1968 suonava già vecchio.
115. Cry Baby Cry (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
Fa' in modo che tua madre sospiri. Lei è grande, la sa lunga lei. Non so se mi è già capitato di scriverlo, ma il Disco Bianco è una festa. Almeno per un'ora è un disco pieno di gente allegra che fa casino e combina disastri. Poi succede qualcosa – come succede sempre alla fine di una festa. Niente di necessariamente drammatico: magari sono semplicemente tornati i genitori e bisogna pulire. Oppure siamo noi i genitori e mentre salutiamo gli ultimi amici dobbiamo salire a cantare qualche ninna-nanna. Il quarto lato contiene effettivamente un paio di ninne nanne, intervallate da quegli interminabili otto minuti di caos che potrebbero anche rappresentare il primo dormiveglia, il momento in cui dai rumori in sottofondo prende forma un sogno. È un'idea come un'altra, ma non mi sarebbe mai venuta se prima di quegli otto minuti non ci fosse Cry Baby Cry, la canzone che condensa tutta l'atmosfera del quarto lato, una malinconia che lascia un sapore amaro e ti fa veramente venir voglia di buttarti a letto e sperare che domani le cose vadano meglio. Lenonn cerca di usare la linea di basso cromaticamente discendente che Harrison sta sfruttando in While My Guitar e Savoy Truffle, ma pasticcia gli accordi e il risultato è più inquietante. Cry a dire il vero è la più ironica delle ninne-nanne: invece di dire "dormi", dice "piangi, sveglia tua madre, lei è abbastanza grande per saperne di più", un ritornello che suonerebbe angoscioso anche se non fossimo al corrente del complicato rapporto di Lennon con la madre: qual è il problema per cui vale la pena di svegliarla? Un brutto sogno? ce la siamo fatta addosso? ci sentiamo soli in un mondo ostile? abbiamo capito che la festa è finita e non saremo più Beatles a lungo – anzi non lo siamo mai stati, è stato tutto un sogno, una recita di marionette, di re e regine di cartone? E qualcuno può riportarmi nel posto in cui provengo, chiede Paul all'improvviso, ed è l'ultima volta che sentiamo la sua voce in tutto il disco, mentre comincia il rumore. È anche l'ultimo vero brano del disco suonato dai Quattro come un gruppo, con la stessa professionalità un po' passiva dei famigliari che sparecchiano in silenzio. George suona poche note ma ci stanno tutte, Paul armonizza poco ma ma al momento giusto, e la sua coda fa venire i brividi. Non so che dire, per quanto caotico il Disco Bianco sembra avere una vita propria, molto più di tanti concept album – d'altro canto non siamo tutti pasticciati e caotici? Quante domande. Meglio svegliare la mamma, lei è grande, ne saprà di certo qualcosa.
(E ora mettiamo in giro un altro po' di sovrainterpretazioni: il Re è John, o almeno tale si considerava all'interno del gruppo, da cui la strisciante sensazione di essere stato spodestato e ritrovarsi sempre più spesso in cucina a lavorare per la Regina, la quale ovviamente è Paul, tutta presa a compiacere i "bambini del Re", ovvero i fans dei Beatles; nota: John non dice che siano figli anche della regina. La duchessa è Ringo, sempre sorridente ma in ritardo; il duca è George, i suoi problemi coi messaggi potrebbero alludere alle sue pretese di entrare in comunicazione con il Trascendente, o anche solo di farsi sentire dai colleghi in sala di registrazione. Tutto questo non può andare avanti molto, e a mezzanotte una tavola rotonda al buio decreterà che la farsa e finita: piangi, bambino, piangi, e fa' in modo che tua madre sospiri).
114. Oh! Darling (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969)
Quando hai detto che non avevi più bisogno di me, lo sai? Sono quasi crollato, e ho pianto (o ho "quasi pianto"?) Oh! Darling è una seduta di coppia sotto forma di pastiche doo-wop, dove ovviamente per "coppia" bisogna intendere il sodalizio artistico e umano Lennon-McCartney. Tutto chiaro adesso? bene, passiamo alla prossima – no, scusate, ma ci sono canzoni in cui ho paura di addentrarmi perché davvero ci si potrebbe scrivere un breve saggio sopra, o un lungo romanzo, e non sono necessariamente le più famose o le più complicate.
Prendi Oh! Darling: all'apparenza è solo un numero doo-wop; ti immagini davvero Paul dire: facciamo un pezzo alla Platters, e John rispondere Beh, perché no. Non è banale rammentare che John amava il doo-wop e apprezzava Oh! Darling, e almeno una volta espresse il rimpianto di non averla cantata lui "Era più il mio stile che il suo. Ma l'aveva scritta lui, quindi al diavolo, l'ha cantata lui. Però se avesse avuto un po' di buon senso, me l'avrebbe fatta cantare". Dopo aver detto questa cosa all'intervistatore, John ride, e ci spezza il cuore perché davvero, come poteva non capire? Come poteva rifiutarsi di capire che Paul stava cantando Oh! Darling proprio a lui? "When you told me you didn't need me anymore, you know I nearly broke down and cried..." poteva essere più esplicito di così col suo partner, questo povero ragazzo? Oh tesoro, se mi lasci io non ce la farò mai da solo, credici se te lo dico. John non solo non ci crede, ma neanche si accorge che la canzone parla di lui, parla a lui.
È la tragedia di Paul: si è inventato così tante storie che nessuno si aspetta più da lui la verità. D'altro canto Oh! Darling sembra volersi presentare esattamente come un algido esercizio di stile: non tanto una parodia, quanto una celebrazione, un monumento al doo-wop eseguito con tecniche innovative ma rispettose dei contenuti storici. La chitarra di George, in particolare, al primo ascolto sembra quasi voler sabotare l'operazione, e invece è funzionale a creare il particolare pathos della canzone. Sembrerebbe tutto comunque molto meccanico se al di sopra degli strumenti non divampasse la voce di Paul, nella sua prestazione più sofferta ed efficace. Sappiamo che ci mise settimane a registrarla; che veniva ad Abbey Road in anticipo ogni apposta per mantenere la voce roca tipica delle prime ore del mattino; e forse per non farsi vedere dal collega ed ex amico mentre si strappava il cuore a forza di urla.
La complessa relazione tra John e Paul, se fossero due millenial, si definirebbe bromance. In Oh!, Darling c'è quasi tutto quello che puoi aspettarti da una storia di bromance. La nostalgia per il passato irripetibile vissuto assieme quando ancora il sesso non era così importante da poterli allontanare: Paul tornava ogni mattina davanti al microfono nella speranza di poter ritrovare anche solo per un momento quella voce roca che ai bei tempi gli era valsa i complimenti di Little Richard ("anni fa l'avrei fatta in un attimo"). Il cameratismo, diciamo pure l'amore fraterno, ma attorcigliato inestricabilmente a una radice d'invidia: Paul vuole cantare una canzone alla John, la vuole cantare per John, ma la vuole cantare anche meglio di lui. Oh! Darling è un progetto lungamente studiato a tavolino che dovrebbe consentirgli di ottenere finalmente una prestazione vocale paragonabile a quella ottenuta in fretta e furia una notte di sei anni prima dal John febbricitante che al primo colpo aveva inciso Twist And Shout.
E di tutto questo John nemmeno si accorge, preso com'è dai suoi problemi che non sono più i problemi di Paul. Ce lo eravamo sempre immaginato, ma poi lo abbiamo sentito in Anthology 3: al termine di una versione cantata in coppia nei giorni difficili delle prove ai Twickenham Studios (una versione in cui davvero quei due sembrano di nuovo intendersi al volo come ai vecchi tempi) John si rimette di nuovo davanti al microfono e con un tono serioso, quasi da cronista, annuncia: ho appena sentito che la pratica del divorzio di Ono si è conclusa. Per poi riattaccare con Oh Darling, ma cambiandone le parole – ed è una coltellata alla schiena, tanto più dolorosa quanto inconsapevole: Sono libero! Stamattina! La ragazza, dice l'avvocato, è tutto OK! Credimi quando ti dico, I'll never do you no harm. Ora rifletteteci. C'è gente che si porta l'amante nel letto nuziale, sono cose che possono capitare a chiunque; ma avete mai visto una persona a cui hanno scritto una canzone d'amore riprendere la stessa canzone e usarla per dichiarare il proprio amore a qualcun altro? E tutto questo farlo in presenza di chi quella canzone l'ha scritta? Quanto bisogna essere crudeli per fare uno scherzo del genere? E a John venivano spontanei.
113. Mean Mr. Mustard (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
Uno dei pezzi meravigliosamente sghembi composti da Lennon in India; scartato per il Bianco, ripreso a Twickenham durante le session per il progetto Get Back!, montato poi nel medley di Abbey Road e liquidato quasi subito da Lennon come "a bit of crap". Mean Mr Mustard in effetti è uno di quegli episodi che sconfessa una delle leggi fondamentali della beatlologia, ovvero: John parla in prima persona, Paul in terza. Paul si inventa storielle buffe su personaggi immaginari, John li detesta e vuole solo essere sincero su quel che sente e vede intorno a sé – beh, non è così vero. Non c'è dubbio che Paul sia il più bozzettistico dei due, ma di personaggi ne ha inventati anche John e non dobbiamo pensare che siano tutte proiezioni del suo ego: dopotutto il tricheco era Paul. E poi c'è Doctor Robert, Mr Kite, Polythene Pam... Il Sordido Signor Senape ci trattiene per appena un minuto, ma lascia il segno: sembra già pronto per diventare il cattivo di un musical (cosa che tra l'altro gli sarebbe successa, ma è una circostanza che i beatlemani preferiscono dimenticare). C'è una corrispondenza diretta, felice, tra musica e contenuto: ci sembra di vedere il Signor Senape incespicare mentre ascoltiamo John che canta Mean Mister Mustard sleeps in the park
Shaves in the dark trying to save paper. Quattro sillabe atone e poi un accento (sleeps), tre sillabe atone e un altro accento (shaves). È una prosodia dinoccolata e irresistibile che non ha veri precedenti, e riavvicina Lennon ai coetanei inglesi più stralunati: il Syd Barrett di The Madcap Laughs, certe cose dei Kinks di quel periodo. Sono cose strambe e simpatiche che venivano abbastanza spontanee a Lennon quando Lennon era nella cabina di comando di un gruppo che valeva milioni di sterline e da cui ci si aspettava un successo radiofonico ogni tre mesi. Quando finalmente ne uscì fuori, quando infine fu libero di cantare quel che voleva... non ne scrisse praticamente più.
112. Martha My Dear (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
Sei sempre stata la mia ispirazione, ricordati di me. Non è ironico che una delle più disarmanti e sofisticate canzoni d'amore Paul l'abbia scritta per il suo bobtail? Sì e no, in fondo non abbiamo inventato gli animali domestici proprio per sembrare più simpatici a noi stessi e agli altri mentre li vezzeggiamo? O forse per dare sfogo ai lati meno presentabili delle nostre necessità emotive. Chi si lascerebbe carezzare all'infinito e grattare dietro le orecchie, chi si lascerebbe dire "hold your head up you silly girl" (un attimo prima di "you have always been my inspiration"?)
Martha My Dear è una delle canzoni di Paul in cui molti ascoltatori non riescono a sentire gli altri tre Beatles (George c'è di sicuro, Ringo molto probabilmente, John non pervenuto). Non solo, ma Paul ha sempre sentito la necessità di precisare che il pianoforte lo suonava lui, malgrado fosse un pezzo difficile per lui, e in questo paradosso (comporre canzoni che non sempre si è in grado di eseguire) sta probabilmente il segreto della musica dei Beatles: in un mondo dove ogni appartamento rispettabile aveva un pianoforte, nessuno dei Quattro sentì mai l'esigenza di imparare a suonarlo decentemente – quello che lo suonava più spesso era il più tecnicamente limitato, John Lennon, e forse proprio perché per suonare quell'affare nei Beatles ci voleva più imprudenza che tecnica. E ciononostante il pianoforte rimase fino alla fine lo strumento preferito da John Paul e George per comporre: come se scrivere musica significasse dimenticare anche quel poco che della musica si sa, e aprirsi un varco nel silenzio, alla cieca.
Stavolta ad esempio Paul scopre (o riscopre) l'incanto speciale degli accordi in minore settima e costruisce un brano che ancora oggi è la croce e la delizia dei beatlemani col pianoforte in casa. La sua partitura viene trasformata dagli orchestrali di George Martin in un tripudio in technicolor in cui basta chiudere gli occhi per immaginare i titoli iniziali di un film di quegli anni; l'atmosfera è forse un filo più bacharachiana che beatlesiana, ma in un carosello come il Disco Bianco non stona affatto, anzi: i colori per un attimo sono quelli giusti, ingialliti esattamente come li sbiadiva una polaroid. Anche il fatto che la sinfonia duri così poco – e in quel poco concentri così tante trovate – la rende a mio avviso uno dei brani più deliziosi del disco, e quindi dei Beatles. Sì, Paul ha scritto cose più ambiziose, ma chiedetelo a un fotografo: è più facile ritrarre una persona mentre accarezza una fidanzata o mentre accarezza un cane? Col cane si viene meglio, è tutto più spontaneo, più allegro, lo spettatore si sente meno terzo incomodo, va' a sapere.
111. Polythene Pam (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
Yes, you could say she was attractively built... John Lennon è stato punk prima di te: ha composto Polythene Pam. È anche stato indierock prima di te (And Your Bird Can Sing), è stato grunge (She Said She Said), è stato jungle (Tomorrow Never Knows). Potrebbe anche avere inventato lo ska bianco, se è davvero sua l'idea di ritmare Obladì Obladà in quel modo. E in quasi tutti questi casi non aveva affatto chiara la direzione che stava prendendo, e non è mai apparso molto soddisfatto dei risultati. Che differenza con l'autocompiacimento di Paul mentre, poniamo, progetta a tavolino di battere il record mondiale di distorsione con Helter Skelter. Gli esperimenti di Paul, molto più ragionati, ottengono sempre qualcosa di compiuto ma finiscono quasi tutti per guardare al passato, mentre quelli di John a volte non portano a niente e a volte aprono finestre sul futuro.
Ci sono precisi motivi sociali, estetici, persino economici, per cui per passare dai power chords degli Who a quelli dei Sex Pistols ci sono voluti quasi 10 anni e un cambio generazionale. Oppure semplicemente era un gradino che toccava salire a John Lennon, e John Lennon ha preferito ritirarsi a vita privata. In Polythene Pam c'è l'attitudine, la voglia di graffiare, la fissa per i fetish, insomma è già tutto pronto per le spille e per le borchie... e invece niente, scusate, stavamo solo scherzando, passiamo ora la linea a zio Paul, vai col liscio. Polythene Pam è il pepe del medley di Abbey Road e uno dei minuti più belli e irruenti del disco: uno squarcio su un universo musicale molto di là da venire che Lennon avrebbe appena fatto in tempo a vedere e ascoltare. Una delle cose più incredibili è che per quanto faccia tutto per sembrare un brano semplice di tre accordi, ne contiene più del doppio e combinati in modo molto più complesso di quanto possa ascoltare al primo, al secondo, al millesimo ascolto, è da trent'anni che ci provo e continuo a sbagliare gli accordi di Plythene Pam. Si dice spesso che per fare punk bastano tre accordi, ma è un'idea abbastanza accademica: c'è gente che studia sodo per anni per imparare a martellare quei tre accordi in modo rigorosamente punk. John ce ne ficca otto perché se ne frega, di accordi ne ha quanti ne vuole e se gli va li mette tutti, yeah! yeah! yeah!
Il più efferato eccidio
06-04-2020, 12:32Americana, Bob Dylan, epidemia 2020, Il Post, musicaPermalinkMurder Most Foul (singolo di Bob Dylan, pubblicato all'improvviso il 27/3/2020)
giorno d’infamia per l’eternità...
Buongiorno a tutti, mi chiamo Leonardo e se leggete il Post da un po' forse mi conoscete per quella menata interminabile che sto facendo sulle canzoni dei Beatles – ecco, prima di quella ce ne fu ancora più interminabile sui dischi di Bob Dylan: l'idea era scrivere un pezzo su tutti i dischi del premio Nobel più pazzo della storia della Letteratura, uno alla settimana, e dopo un anno non era ancora finita. Gettai la spugna in occasione di Tempest, il suo ultimo disco di inediti. Davanti a me avevo ancora i suoi tre dischi di cover di Sinatra (il terzo dei quali, appena uscito, era triplo) e non sapevo davvero come affrontarli. Del resto intuivo già che sarebbe stato uno sforzo vano: anche se avessi avuto la velocità di reazione di Achille, sapevo che Bob la Tartaruga avrebbe continuato ad allontanarsi: qualche mese dopo uscì un cofanetto imprescindibile sul suo periodo gospel, qualcosa tipo otto cd.
In seguito che altro è uscito, dunque: #1, un'antologia doppia dei live '62-66 (i ventenni che lo andavano a fischiare al tempo oggi si svenano per acquistare i cofanetti deluxe); #2, un disco con le versioni alternative di Blood On the Tracks, che oltre ad avere un indubbio valore storico sono anche un ascolto gradevole per chi non dedica a Dylan la sua esistenza; #3, la colonna sonora del film che Scorsese ha dedicato alla sua Rolling Thunder Revue; #4 un'altra collezione di versioni alternative del suo periodo country, con tanti duetti con Johnny Cash... e poi qualche giorno fa, forse ne avete sentito parlare, sulle piattaforme di streaming è comparsa all'improvviso una cantilena di 16 minuti intitolata Murder Most Foul ("il più efferato delitto" in inglese shakespeariano). Ora, per quanto non sia il più semplice degli ascolti, si tratta del primo inedito di Dylan dopo otto anni: una pausa ancora più lunga di quella che si prese quasi per tutti gli anni Novanta, tra Under the Sky e Time Out of Mind. Non che nel frattempo se ne sia stato zitto e fermo, il Bardo: ha inciso cover su cover e continuato il suo cosiddetto "tour infinito", che negli anni buoni lo ha portato a suonare più di cento concerti all'anno. Murder Most Foul è comunque il primo brano dopo una lunga astinenza volontaria e... dobbiamo proprio dirlo? Potrebbe anche essere l'ultimo.

Dylan in maggio compirà 79 anni. Non è un periodo semplice per gli anziani, questo: soprattutto per gli anziani che non sanno restare fermi e Dylan a volte è sembrato quel tipo di anziano. Un suo ex chitarrista si è già preso il coronavirus dopo aver suonato a un concerto: ci suonava anche Jackson Browne e pare l'abbia preso pure lui. Speriamo che Dylan abbia preferito stare in casa, memore magari di quella brutta istoplasmosi che nel '97 rischiò di fare di Time Out of Mind un disco postumo.
E però anche questa scelta di pubblicare una canzone all'improvviso, proprio adesso... è un brano su Kennedy, realizzato "qualche tempo fa", il che potrebbe voler dire in qualsiasi momento degli ultimi otto anni. Ci sono molti dettagli che fanno pensare che Murder sia più vicino a Tempest di quanto la data di uscita non ci faccia credere. Il più appariscente è il shakespearismo, se il titolo di Tempest era (come Dylan negò) un'allusione all'ultima opera di Shakespeare. Ultimamente Dylan pensa spesso a Shakespeare, non tanto come a un autore da cui prendere in prestito soluzioni, quanto a uno dei pochi colleghi col quale si può ancora confrontare – vedi quel brano spassoso e molto illuminante del suo bigliettino di ringraziamento agli accademici di Svezia, in cui confessa candidamente che dopo aver ricevuto la notizia del premio il primo autore che gli era venuto in mente era quello dell'Amleto, con le sue preoccupazioni più e meno banali (“Voglio veramente ambientarlo in Danimarca?” [...] “Dove posso procurarmi un cranio umano?”). L'avvicinamento ideale a Shakespeare spiega in parte un certo gusto per le descrizioni violente, gli eccidi e le stragi, che è un altro aspetto di Tempest che ritroviamo echeggiato in Murder (l'insistenza sul dettaglio di quel cervello a pezzi). E come in Tempest, Dylan non si preoccupa di esercitare un minimo di violenza anche sull'ascoltatore, infliggendogli un brano lunghissimo in cui la gabbia delle strofe si ripete uguale all'infinito. Murder potrebbe persino essere uno scarto di Tempest, per quel che ne sappiamo: e allora perché pubblicarlo proprio adesso?
 |
| Amleto (nel senso di Laurence Olivier) |
Un manager accorto – quel tipo di persona che Dylan non ascolta da mezzo secolo – gli avrebbe suggerito di aspettare un anniversario, se non il classico 22 novembre almeno il 29 maggio in cui l'ex presidente avrebbe compiuto 97 anni. Avrebbe avuto senz'altro più copertura, oggi che le canzoni si ascoltano in streaming e un link giusto da un organo d'informazione può voler dire milioni di ascolti in più... ma Dylan non ascolta nessuno, appunto (nemmeno sé stesso: continua a fare concerti proibendo a tutti di registrarli: tra tutti i dischi che pubblica, non esiste un'incisione ufficiale degli ultimi vent'anni di esecuzioni dal vivo). Può darsi che sia il modo tutto suo che ha trovato Dylan per dirci che sta bene – vi ricordate nei primi giorni del lockdown, quando un sacco di vip faceva le dirette streaming? Poi immagino abbiano smesso, io ricordo soltanto Jovanotti che suonava la chitarra per chiunque passasse, una cosa anche simpatica in fondo, una specie di panopticon però coi like e i cuoricini, se uno ha voglia di vedere come sta Jovanotti si sintonizza, ah ecco, suona la chitarra, sembra tutto ok, e Dylan invece? Dylan pubblica sedici minuti di peana sulla morte di Kennedy. Ok.
Ok cosa?
Ok boomer.
Cioè davvero mentre il mondo trema e si domanda come fronteggiare la prima vera pandemia mondiale e tutte le altre crisi economiche e ambientali che ne seguiranno – davvero questo epico reduce dei Sessanta è ancora lì a girare intorno al suo eterno chiodo fisso? Esatto, Dylan è ancora lì e non si muove. La sensazione è proprio quella di non potersi muovere, all'interno di un lockdown mentale che fa impallidire il nostro: poverini, siete in casa da un mese? Io sono rinchiuso nella mia testa da quasi 60 anni. Vi guardate le serie su Netflix? Io guardo il filmato di Zapruder 33 volte in una sera ("È orrendo, un inganno, è crudele, è cattivo, la cosa più brutta che si possa vedere..." ed è l'unica che gli manda in onda il cervello). Murder è una cantilena, non lo dico per offenderla, mi sembra la definizione tecnica più precisa. Una filastrocca tirata per le lunghe da un bambino posseduto. E va bene, illustre Dylan, abbiamo capito che è stato un trauma, il vero choc, la Fine di tutte le Speranze, ma anche l'Inizio, o forse l'Inizio di una cosa che era Finita sul nascere? Un'omega travestita da alfa? L'inizio di una linea temporale sostanzialmente sbagliata da cui Bob ha sempre voluto prendere le distanze – la tempolinea in cui ha rinnegato la sua militanza politica, ha incontrato i Beatles e si è improvvisato rockstar, ha fatto i veri soldi, poi si è quasi ammazzato in moto, ha tentato di nascondersi nel country, eccetera eccetera eccetera. Ecco, tutto questo Dylan sembra considerarlo completamente sbagliato, la deriva inevitabile di quel singolo momento ignominioso in cui spaccarono il cranio al presidente che sfilava per Dallas. Il peccato originale. Siamo perduti da quel momento, sembra volerci dire Dylan: e anche se avesse ragione, sentirla ribadire per sedici minuti non fa esattamente bene all'umore. Non potrebbe semplicemente strimpellare qualcosa come un Jovanotti qualsiasi, giusto per farci sapere che sta bene? No, Dylan è prigioniero di un incubo che torna sempre al momento dello choc primigenio. Se i sintomi nevrotici avessero diritto a una canzone, a Murder Most Foul toccherebbe la coazione a ripetere.

Anche l'ascoltatore che ha una certa esperienza delle interminabili litanie di Tempest, ci mette almeno un minuto su sedici a rassegnarsi all'idea che la filastrocca non è l'inizio in sordina di una canzone un po' più strutturata, e che basso chitarra e violoncello continueranno a cincischiare così all'infinito. Murder Most Foul non è solo una canzone che non finisce mai: è anche una canzone che non inizia mai, un'epica interrotta sul proemio, un Amleto senza vendetta, la storia di un Cavaliere che partiva per liberare l'America ma gli sparano alle spalle quando è appena uscito dal ponte levatoio. Ricorda un poco l'ultima uscita di un altro grande vecchio la cui strada si era appena incrociata con la sua, Martin Scorsese: o perlomeno la mia reazione di fronte a The Irishman non è molto diversa da quella che ho provato ascoltando Murder: cioè, aspetta, lo stai facendo di nuovo? Ancora mafiosi italoamericani, ancora ammazzamenti barbari, ancora le collusioni tra sindacato e malavita, ancora i teamsters? Ancora Hoffa? Dopo Stallone, dopo Jack Nicholson, ma non ce l'hanno avuto un altro sindacalista gli americani che ci dovete sempre raccontare della misteriosa scomparsa di Hoffa? Ma insomma illustre Scorsese, cosa potrai dirmi che non so già proprio perché me l'hai raccontato tu o qualche tuo sodale? Che altro potrò notare se non che la tua mano si è fatta più statica e pesante, i tuoi attori più legnosi e segnati da rughe contro cui poco può la computergrafica?
Ecco: Dylan, come Scorsese, sembra rassegnato a non poterci raccontare più di quello che ci ha già raccontato – è come l'anziano che proprio nel momento in cui cominciamo ad aver voglia di ascoltare le sue storie, scuote la testa sconsolato: le ha finite, può solo tornare su quelle che ha già raccontato e raccontarle in tono più greve, ogni volta un po' più greve. E sia nel caso di Dylan che nel caso di Scorsese la cosa è vera solo fino a un certo punto, ovvero: Scorsese di film sulla mafia non ne ha girati poi così tanti (eppure sembra l'autorità in materia); prima di The Irishman non aveva in realtà mai raccontato una storia di collusioni tra malavita e sindacato (eppure è come se lo avesse fatto), non aveva mai diretto Al Pacino (che sembra fatto apposta per i suoi film). E anche Dylan, quante canzoni aveva dedicato al caso Kennedy prima di Murder? Forse neanche una. Alcune poesie dattilografate a caldo (la più toccante dedicata a Jacqueline Kennedy), che non si trovano nemmeno nel sito ufficiale, e poi un apparente silenzio di 60 anni. L'idea che Dylan sia da sempre ossessionato dall'assassinio Kennedy è uno strano effetto ottico, un trucco di prospettiva. Proprio come Scorsese, che oltre a tornare su un tema già sviluppato (la mafia), si affida a elementi che già altri hanno reiterato prima di lui, non cita soltanto sé stesso ma anche il Padrino di Coppola e il Sergio Leone di C'era una volta in America; in un modo simile Dylan non sta raccontando l'assassinio Kennedy, ma attingendo dall'enorme mole del racconto collettivo che ne esiste già, piazzando qua e là veri e propri indovinelli per i conoscitori più esperti (nel distico “Slide down the banister, go get your coat/Ferry cross the Mersey and go for the throat" c'è un criptico riferimento a due agenti FBI coinvolti nell'inchiesta, Guy Banister e Dave Ferry).
 |
| Chi? |
Proprio come Scorsese che non si preoccupa di raccontare un'epopea mafiosa già cristallizzata da altri autori, allo stesso modo Dylan non si preoccupa affatto di ratificare, con Murder Most Foul, una leggenda smentita dagli storici ma in qualche modo più forte dell'evidenza: l'idea che la Beatlemania sia stata la reazione morale del popolo americano – o almeno della gioventù americana – alla morte di Kennedy. È un'idea affascinante che abbiamo sentito raccontare tante volte, forse mai tanto icasticamente quanto nella beatle-biografia di Philip Norman, Shout!
L'America – Brian [Epstein] non lo sapeva ancora – era già sua: si stava avvicinando alla sua conquista, senza accorgersene, mentre, lontano nel Texas, qualcuno puliva e controllava il meccanismo di un fucile ad alta velocità e sceglieva un punto favorevole da cui far fuoco. L'America si arrese a lui quella mattina di Dallas in cui il corteo presidenziale si mise in moto, estremamente fiducioso e aperto alla luce del sole, e un cineamatore, sul bordo del marciapiede, rivolse la sua cinepresa verso la limousine che trasportava un giovane uomo col capo scoperto. Era il 22 novembre, il giorno in cui, in Inghilterra, fu messo in vendita il secondo album dei Beatles...Questa idea – la Beatlemania come elaborazione del lutto, o forse come mancata elaborazione collettiva del medesimo – è ormai un luogo comune della storia del costume americano; un po' l'equivalente di quando in Italia si racconta che il Sessantotto è finito con Piazza Fontana o gli anni di Piombo col Mundial 1982. Avevo trovato un nome per queste cose – forrestgumpismo, ecco, non era proprio un gran nome, ma Dylan non è mai stato tanto forrestgumpista come in Murder Most Foul, quando dopo due minuti di elegia sembra per un attimo voler ingrandire il campo: "Hush little children you'll understand: the Beatles are comin’, they're gonna hold your hand". A questo punto se non avessimo sentito la stessa leggenda da decine di altre bocche, forse il riferimento ci sfuggirebbe, e invece lo diamo per scontato: hanno ucciso Artù, e ora dal mare arriveranno questi simpatici cavalieri del disimpegno, a incantare e perdere un'intera generazione. E sappiamo anche che Dylan non si sente affatto incolpevole di tutto questo, perché c'era anche lui ad aspettare i Beatles, a offrirgli il primo tiro di joint, convinto che i Beatles conoscessero già le proprietà lenitive della cannabis e che I Want to Hold Your Hand nascondesse riferimenti a tali proprietà. Sappiamo, perché l'abbiamo letto e straletto, che anche se Dylan non ha mai scritto una canzone su Kennedy, ne ha scritte due o tre sulla figuraccia che fece almeno un mese dopo, quando a una cena progressista volevano premiarlo in quanto cantante progressista e lui si mise a dire che si sentiva un po' Oswald e capiva i suoi giovani amici che andavano a Cuba a prendere lezioni di rivoluzione. Sappiamo che quell'episodio non fu (solo) la tipica tirata di un ubriaco che si autopunisce, ma il momento topico di una drammatica svolta di carriera che l'avrebbe portato in pochi mesi da principe del folk militante ritratto su seriosi LP in bianco e nero a rockstar sbruffona con gli occhiali scuri e 45 giri in classifica. Sappiamo tutto questo perché è stato già scritto e riscritto, in una marea di testi che si citano a vicenda, ovvero si tratta di un vero e proprio Canone: il canone dei boomer americani. C'era Kennedy che portava un certo tipo di speranza, ma gli spararono e allora vennero da Liverpool quattro ragazzini con un altro tipo di speranza, e poi fu Woodstock e poi Altamont, Dylan le cita entrambe e chi è previsto sappia non ha bisogno di note a pie' di pagina: è già stato tutto inciso sulla Colonna Traiana dei boomer. In effetti ci sono momenti in cui il citazionismo sembra prendergli la mano, e l'ascoltatore comincia ad avere il sospetto che il vecchio Dylan stia cercando di fare quello che trent'anni fa fece, con più sintesi e sfoggio di virtuosismo, Billy Joel in We Didn't Start the Fire: la storia di una generazione per citazioni, un affresco realizzato con la tecnica del namedropping.
Ci sono in effetti momenti in cui Dylan sembra adottare la stessa tecnica di evocazione di un periodo mediante nomi e frasi fatte, ma in modo meno meccanico e consapevole – a volte sembra condannato a ricorrervi, come il personaggio non troppo secondario della storia che sta raccontando. Lo si sente in alcune citazioni incongrue, che hanno un senso ma allo stesso tempo sembrano maldestre – la più eclatante per me è quella da Tommy degli Who, che se non sbaglio è la prima prova che abbiamo che Dylan abbia mai ascoltato Tommy o qualsiasi altro disco del gruppo di Pete Townshend.
Tommy, mi senti? Sono la Regina dell’Acido,L'idea che nel percorso verso l'oltretomba il presidente abbia potuto incontrare l'Acida Regina di Tommy sorprende come l'orologio da polso in un peplum romano. Più in là Dylan invita Wolfman Jack, il Dj Lupo Solitario di American Graffiti, a suonare per il funerale: segue una lunga playlist che prende una buona parte del pezzo e identifica un altro canone, quello della musica popolare americana prima della caduta (prima della beatlemania). Tutto abbastanza chiaro salvo che a un certo punto esce fuori... Another One Bites the Dust. A questo punto confesso di avere googlato in lungo e in largo alla ricerca di una canzone americana con lo stesso titolo perché l'idea che in un elenco simile, tra la sigla di Twilight Zone (Ai confini della realtà) e il gospel The Old Rugged Cross, ci fossero i Queen, mi urtava più del proverbiale cavolo a merenda. E invece no, e invece Dylan probabilmente ha in testa proprio i Queen e in particolare quel ritornello decontestualizzato: Eccone un altro che morde la polvere.
viaggio in una Lincoln limousine, lunga e nera,
sul sedile posteriore di fianco a mia moglie
e per destinazione l’aldilà.
Sono dettagli dissonanti, sbavature più o meno consapevoli che in un certo senso ci confortano sul fatto che Dylan è ancora il vecchio Dylan, e non è stato sostituito da un generatore di testi di Dylan. Murder Most Foul ricorda, infine, quella che fino a un mese fa in quanto ultima nella scaletta di Tempest bisognava considerare l'ultima canzone di Bob Dylan, Roll On John. E se da una parte era commovente pensare che Dylan si congedasse dalla scena letteraria con un omaggio all'amico e collega John Lennon, dall'altra lasciava perplessi la confezione dell'omaggio, una specie di trasfigurazione mitica della sua breve vita in cui ogni tanto si infilavano citazioni lennoniane risaputissime e abbastanza fuori contesto ("Come together right now over me" non è proprio la prima cosa che ti verrebbe da cantare a un amico caduto), e poi alla fine senza nessun apparente motivo al mondo un celeberrimo verso di Blake, Tyger, tyger, burning bright... Ecco, in Murder Most Foul c'è la stessa volontà di creare una mitologia partendo da riferimenti che tutti i coetanei di Dylan possono cogliere al volo, con qualche dettaglio dissonante che in un altro autore stonerebbe e basta, ma che in Dylan ci conforta in qualche modo sulla genuinità del prodotto – in fondo è Dylan, ha sempre fatto un po' di casino con nomi e date e luoghi. E quindi insomma alla fine sta bene. Il nostro vecchio Dylan. Sì, da qualche parte nello spaziotempo c'è un Dylan migliore che non ha mai dichiarato di essersi sentito Oswald perché Oswald non ha mai assassinato Kennedy, un Dylan che ha continuato a credere nelle canzoni che cambiano il mondo e magari l'ha pure cambiato e adesso è ministro per l'Agricoltura della Repubblica Socialista Democratica Panamericana. Ma anche il nostro Dylan qualcosa di buono l'ha fatto, dai. Abbiti cura, Stay safe stay observant and may God be with you.
Gli altri dischi di Bob Dylan: 1962: Bob Dylan, Live at the Gaslight 1962, 1963: The Freewheelin’ Bob Dylan, Brandeis University 1963, Live at Carnegie Hall 1963, 1964: The Times They Are A-Changin’, The Witmark Demos, Another Side of Bob Dylan, Concert at Philharmonic Hall, 1965: Bringing It All Back Home, No Direction Home, Highway 61 Revisited, 1966: The Cutting Edge 1965-1966, Blonde On Blonde, Live 1966 “The Royal Albert Hall Concert”, The Real Royal Albert Hall 1966 Concert, 1967: The Basement Tapes, John Wesley Harding, 1969: Nashville Skyline, 1970: Self Portrait, Dylan, New Morning, Another Self Portrait, 1971: Greatest Hits II, 1973: Pat Garrett and Billy the Kid, 1974: Planet Waves, Before the Flood, 1975: Blood on the Tracks, Desire, The Rolling Thunder Revue, 1976: Hard Rain, 1978: Street-Legal, At Budokan, 1979: Slow Train Coming, 1980: Saved, 1981: Shot of Love, 1983: Infidels, 1984: Real Live, 1985: Empire Burlesque, Biograph, 1986: Knocked Out Loaded, 1987: Down in the Groove, Dylan and the Dead, 1988: The Traveling Wilburys Vol. 1, 1989: Oh Mercy, 1990: Under the Red Sky, Traveling Wilburys Vol. 3, 1991: The Bootleg Series Vol 1-3 (Rare and Unreleased), 1992: Good As I Been to You, 1993: World Gone Wrong, 1994: MTV Unplugged, 1997: Time Out of Mind, 2001: “Love and Theft”, 2006: Modern Times, 2008: Tell Tale Signs, 2009: Together through Life, Christmas in the Heart, 2012: Tempest, 2020: Murder Most Foul.
Di che ti vanterai, San Lalemant
17-03-2020, 22:54Americana, Il Post, santiPermalink"Piccolo Prete, Piccolo Prete".
"Vecchio Falco, che c'è?"
"Oggi noi moriamo".
"Oggi?"
Di che ti vanterai col tuo Signore? Anche se fossi il più forte tra gli uomini, è Lui che così ti ha creato. Del resto si fa per dire, Gabriel Lalemant: tu non sei certo il più forte degli uomini. Sei miope e hai la scoliosi. I polmoni, potessi sputarli a primavera, li vedresti spugnare sangue. Dio ti ha scelto missionario in Canada e ti ha regalato un'allergia a un parassita della corteccia degli aceri, a maggiore sua gloria. Un premolare ti pulsa impazzito, il dentista più vicino è a una settimana di marcia dal villaggio. Hai sempre freddo, hai sempre fame, in un altro secolo saresti depresso; nel diciassettesimo stai per morire.
Gli irochesi, dice Vecchio Falco. Stanno arrivando, sono in tanti. Hanno i colori di guerra ma se volessero combattere avrebbero aspettato che tornassero dalla caccia i maschi atti alle armi. Sono venuti a distruggere il villaggio, Piccolo Prete. Ammazzeranno noi vecchi, stupreranno le donne, adotteranno qualche bambino. È così che fanno gli irochesi.
"Sei ben informato sui loro costumi".
"E va bene, Piccolo Prete, anche noi uroni facevamo così, ma Grande Prete mi ha dato il Perdono".
"Sì sì il Perdono".
Di che ti vanterai al cospetto di Dio? Anche se fossi il più coraggioso tra gli uomini, è Lui che l'ha deciso. Tu ti saresti semplicemente trovato col coraggio necessario al momento giusto. Del resto si fa per dire, Gabriel Lalemant; tu non sei il più coraggioso tra gli uomini. C'è un punto preciso del basso ventre che te lo sta confermando, la pelle ti si fa d'oca come quando al collegio nell'ora di latino cercavi in qualche modo di non fartela addosso.
"Ma c'è una qualche maniera di... non so, è previsto che possiamo arrenderci?"
"Arrenderci, Piccolo Prete?"
"Sì, non combattere".
"Non credo che possiamo combattere".
"E quindi ci arrendiamo e loro..."
"Ammazzano noi vecchi, violentano le donne e rapiscono i bambini".
"Anche se ci arrendiamo".
"Arrenderci, Piccolo Prete?"
"Non conosci la parola, vero?"
"Mi perdoni, Piccolo Prete".
"Ti perdono, ti perdono, possiamo scappare almeno?"
"Le donne e i bambini possono scappare".
"Le donne e i bambini".
"Ma i guerrieri irochesi sono più veloci".
"Sono più veloci".
"Allora Piccolo Prete dobbiamo fare la... non so come si dice in francese, Piccolo Prete".
"Dobbiamo chiuderci nelle capanne e sparare e lanciare frecce e tenerli occupati".
"Anche fare urla di donna nel frattempo, io credo che Piccolo Prete le sa fare".
"Urla di donna?"
"Io ho sentito Piccolo Prete cantare la messa e credo che gli irochesi crederanno di sentire una donna. Anche molte donne".
"Cioè fammi capire".
"Grande Prete ha già radunato le donne, che portino via i bambini nella foresta. Gli altri vecchi saremo una dozzina. Abbiamo frecce e il fucile di Grande Prete, io forse lo so usare".
"No no no, lascia perdere quell'affare, prima che ti esploda in m-"
"Se fa chiasso è comunque utile, e comunque oggi io muoio. Intanto Piccolo Prete canterà per noi".
"Cantare? Cosa dovrei cantare?"
"Quella che più sembra un verso di donna... alla fine della messa, lei sempre canta quella cosa che fa tedeeeeeu...."
"Il Te Deum".
"Aspetta però. Prima Piccolo Prete deve essere sicuro di una cosa. È importante".
"Cosa c'è"
"È sicuro che non Si arrabbierà?"
"Chi?"
"Il Signore nella Grande Casa".
"Ah, Lui".
"Non si arrabbierà se ti sente cantare il Suo Nome? Mentre noi tiriamo frecce e cerchiamo di uccidere gli irochesi, che Grande Prete ci disse essere peccato".
"Sì beh, ecco, io..."
"Piccolo Prete per favore non m'importa di morire oggi, sono vecchio e sono urone. Ma nel Fuoco Eterno non ci voglio andare, quindi la mia domanda è più seria della vita, capisce?"
"Capisco Vecchio Falco, capisco".
"Se tu canti forte e Lui ti sente, Si arrabbierà?"
"Io... io non lo so".
"Come non lo sa?"
"È complicato".
"Ma tu sei Prete! Tu devi sapere".
Di che ti vanterai col tuo Signore? Anche se fossi il più saggio degli uomini, da chi viene tutta la saggezza? Chi l'ha dispensata agli uomini, dandone tanta ad alcuni, poca o punta a molti, e calcola quanta ne deve aver passata al malaticcio Gabriele Lalement, il giorno in cui gli ha instillato la voglia pazza di fare il missionario in America, che non sembra un'idea saggia da qualsiasi parte tu la guardi, e specialmente all'alba di quel 17 marzo 1649 in cui si muore, e davvero bisogna morire cantando il Te Deum in falsetto, chi può dire se a Nostro Signore la cosa piacerà? Magari era persino il giorno in cui Gabriele ci credeva poco – la gente pensa che la Fede scorra sempre copiosa come un grande fiume in chi ne è degno: e invece no, troppo spesso è uno di quei torrenti capricciosi che in inverno sono rivoli quasi secchi e d'estate vanno in piena, o viceversa; e metti che Gabriele fosse in secca proprio in quel giorno in cui gli toccava di morire, Vecchio Falco, che ti dico?
Non solo Dio è imperscrutabile, ma voi indiani chi vi capisce, e io sto qui in culo al mondo a fare l'interprete tra due entità che non ho mai capito, che vita assurda, che mal di denti, chissà quanti me ne caveranno al palo della tortura prima di trovarmi quello che mi pulsa –
– Entra in scena un ragazzo, spalanca l'uscio senza bussare. Zoppica e mugola una cosa che nel dialetto del villaggio vuol dire porcaputtana Vecchiofalco le merde sono qui. È quel tipo di maleducazione che ti sorregge nei colpi di sfortuna. Non fosse caduto su un ginocchio la scorsa settimana starebbe già cacciando col padre o al limite scappando nella foresta con la madre, ma zoppica e quindi anche lui deve morire oggi. Vecchio Falco gli bisbiglia qualcosa del tipo: ma vergognati, non vedi che sono qui col Prete? Il ragazzo fa finta di accorgersi che c'è il prete. China la testa e congiunge le mani in un tentativo di saluto ossequioso, ma è così nervoso che gli salta fuori un applauso, clap!
"Chiedo perdono, Piccolo Prete, io..."
Questi chiedono perdono continuamente, Grande Prete (Jean de Brébeuf) ha messo loro addosso una paura dell'inferno che in certi casi magari è utile; non in questo.
"Ti perdono, Scoiattolo che c'è?"
"Le mer... Gli irochesi sono qui".
"Lo so".
Zang!
(O qualsiasi sia il rumore di una freccia che si conficca nella fessura tra due pali di una capanna).
"Giù la testa" dice in dialetto Vecchio Falco, ma lo dice e non lo fa, e la capanna non ha vetri, quindi un attimo dopo averlo detto sta fissando la punta di una freccia che gli esce dalla spalla, dunque oggi si muore così? Beh, meglio che restare al palo per un giorno di torture. Sul serio, se è una vita che ci pensi, quando arriva magari ti sollevi. Resta quella questione del Fuoco Eterno da chiarire ed è sempre più impellente, Vecchio Falco già ne annusa la fuliggine. Gabriele sta strisciando verso la cassapanca, lì dentro c'è l'archibugio di Père Jean, un affare arrugginito che con ogni probabilità gli esploderà in mano, d'altro canto gli irochesi ti cavano gli occhi e te li rimettono di brace; scottano una punta di freccia e ti ci sodomizzano, e Scoiattolo? Scoiattolo è in un angolo che piange e chiama la mamma perché questo fanno gli esseri umani, in tutte le civiltà, in tutte le latitudini, quando hanno dodici anni e fuori ci sono i cattivi. Oh mamma mamma mamma mamma mamma ma...
Più forte! Grida Vecchio Falco.
"Oh mamma mamma mamma mamma mamma mamma!"
L'archibugio ora è carico, ma bisogna dar fuoco alle polveri. Sul comodino nell'angolo, c'è ancora la candela accesa...
"Oh mamma mamma mamma mamma mamma mamma!"
"Non basta! Devi piangere come dieci! Fuori devono credere che dieci bambini sono qui!"
"Ma io ho una bocca sola! Non posso..."
"E invece Scoiattolo tu devi. Per tuo fratello, per tua madre, ora tu piangi –
BANG!
Gabriele ha dato fuoco a una carica e si è ustionato una mano e ora sta strillando in falsetto, a maggior gloria di Dio. Bravo Prete, bravo, strilla forte, strilla, anche di più, Vecchio Falco approva con tutto il fiato che gli resta. Qualcuno magari un giorno tirerà fuori un romanzo da tutto questo, o una scena da film, un vecchio un bambino e un prete che eroici resistono nella sagrestia che è l'avamposto del villaggio. Ma questo non è ancora un romanzo, questa è una baracca con un ragazzino in un angolo che piange, un prete in un altro angolo che si tiene una mano e strilla, e un vecchio urone al centro del pavimento che sanguina e approva con la testa, più strilli, più strilli per favore. Ci prova anche lui, auauauauauauauauauauau, ma gli manca il fiato di nuovo. Gli irochesi si sono fermati per un istante, forse un fucile non se l'aspettavano. E non va bene, bisogna fare baccano, bisogna far credere chissà cosa. Dalle altre case si sente il sibilar di frecce, qualche altro vecchio risponde, qualche altro ragazzino terrorizzato grida dalle finestre, quanto tempo riusciremo a fargli perdere mentre le donne scappano? Non si sa, non importa, ogni respiro è un dono di Dio.
"Te Deum laudamus: te Dominum confitemur..."
"No, Piccolo Prete, no".
"E perché no".
"Se non ne è sicuro, Piccolo Prete non deve cantare".
"E perché non dovrei esserne sicuro? Sono un prete".
"Giura, Piccolo P..."
"Te lo giuro".
"Sulla tua anima, giura che il Signore non si arrabbierà".
"Vecchio Falco, sulla mia anima ti giuro che il Signore non si arrabbierà se canto il suo nome mentre i tuoi fratelli combattono per salvare le nostre donne e i nostri bambini. Nel nome del Signore".
"Allora mentre Piccolo Prete canta, io posso andare".
"Te aeternum patrem, omnis terra veneratur..."
"...Mi perdona?"
"Tibi omnes angeli... di che ti devo perdonare?"
"Non lo so Piccolo Prete, non lo so".
"Grazie".
"Tibi caeli et universae potestates:
tibi cherubim et seraphim,
incessabili voce proclam..."
Di che ti vanterai col tuo Signore? Anche se tu fossi il più forte, il più coraggioso, il più saggio degli uomini – ma tu non lo eri. Invece eri Gabriele Lalement: eri malato, e hai salvato un villaggio. Avevi paura e hai combattuto col fucile in braccio, cantando lodi a Dio, e magari era uno di quei giorni in cui nemmeno ci credevi. E sei morto dopo ore di torture, e quando hanno finito ti hanno strappato il cuore e lo hanno mangiato come si mangia il cuore dei condottieri coraggiosi: e al posto dei tuoi occhi miopi avevi due tizzoni ardenti, e di tutto questo quanti possono vantarsi davanti al Signore? Ma se c'è un Regno dei Cieli, è il regno in cui il più forte, il più coraggioso, il più saggio, si chinano al passaggio di San Gabriel Lalemant. E come Scoiattolo giungono le mani, così in fretta che parte l'applauso.
Dov'è la scuola digitale (quando serve)
13-03-2020, 00:22epidemia 2020, Il Post, internet, scuolaPermalinkGli insegnanti fanno quel che possono, che non è sempre abbastanza. Probabilmente in questi giorni avete sentito parlare in tv o alla radio di docenti smart che già da settimane organizzano videocorsi interattivi on line e somministrano e correggono verifiche digitali a distanza. Ecco. La maggioranza non è così – il che non vuol dire che non si stiano dando da fare. Molti che non erano preparati all'emergenza, ora stanno cercando di lavorare da casa sui supporti digitali, e di conseguenza stanno impazzendo. Improvvisamente tentano di usare le piattaforme digitali che gli editori scolastici hanno realizzato negli ultimi anni. I rappresentanti avevano garantito che fossero facili da usare. Magari in una situazione normale sarebbero davvero facili da usare, ma indovina: non è una situazione normale, e i server dei principali editori scolastici italiani non stanno reggendo il colpo.
Aggiungi che ogni insegnante anche in questo frangente non ha nessuna intenzione di rinunciare al principio costituzionale della libertà di insegnamento, ovvero nello stesso consiglio di classe non sarà infrequente trovare insegnanti che intendono usare due o tre piattaforme diverse e lo hanno già comunicato autonomamente ai genitori. Non che faccia molta differenza: le piattaforme funzionano tutte a strappi, e anche quando funzionano, sono pur sempre prodotti editoriali, anche nel senso che considerano l'utente una fonte di dati da estorcere. Per usarli bisogna aprire l'account. Ed ecco consumarsi la tragedia quotidiana: gli insegnanti, tramite la scuola, informano i genitori che per fare lezioni a distanza bisogna registrarsi presso la tale piattaforma. I genitori reagiscono perplessi: un'altra registrazione. Un altro account. Altra gente che vuole i miei dati. Ma soprattutto: un'altra password da ricordare.
Anche quando gli insegnanti più tecnologicamente sgamati suggeriscono di passare a infrastrutture più universali e affidabili – Google e Dropbox è più difficile che vengano giù – ormai il genitore è esasperato, ha già aperto due o tre account diversi, e adesso che c'è? Volete che scarichi un'app di Google per le videoconferenze? Come se il genitore medio avesse la fibra in casa. A volte non ce l'ha neanche l'insegnante, che magari si concede generoso una prima videolezione di un'ora con lo smartphone per poi scoprire che ha prosciugato il suo piano dati mensile. A quel punto, c'è sempre qualcuno che insorge: "Ma non potevate mettere tutto sul registro elettronico?"
Qualcuno ci ha pure provato. Ci sono registri elettronici che stanno proponendo alle scuole le loro piattaforme digitali, e sì, sono gli stessi benedetti registri elettronici che si piantano ogni mattina alle otto quando qualche migliaia di insegnanti prova a usarli per fare l'appello in classe. Non è tanto il fatto che non siano pronti all'emergenza – nessuno lo era – ma sembra quasi che non se ne rendano conto. È come se tutti gli aeroplani i treni e i tram non potessero più partire e l'autista del pulmino delle medie venisse a dirti che se vuoi ci pensa lui. Chi ha permesso che succedesse questa cosa? (Continua sul Post).
Le canzoni dei Beatles (#135-121)
03-03-2020, 18:55beatles, drogarsi, Il Post, musicaPermalinkLa playlist su Spotify
135. Blue Jay Way (Harrison, Magical Mystery Tour, 1967).
C'è un nebbione sopra L.A... Derek Taylor, dove sei?
L'unica canzone dei Beatles ambientata in California parla di nebbia. L'unica canzone dei Beatles che parla di nebbia è ambientata in California. George Harrison veniva dal Merseyside e doveva atterrare sulla West Coast per trovare la nebbia interessante. Era arrivato per assistere a uno show di Ravi Shankar, approfondire la meditazione trascendentale, dare un'occhiata a questo nuovo milieu hippy che sembrava promettente e badare a certi suoi affari, da ometto adulto quale stava diventando. Ma doveva anche aspettare Derek Taylor, che arrivava con un altro aereo e facilmente nel labirinto della Sun Valley si sarebbe perso. Per fortuna nell'albergo c'era un organo, lo strumento che George non sapeva suonare e proprio per questo usava per comporre, e così, per combattere il jet lag, George improvvisò una canzone di argomento occidentale su una progressione indiana. Una canzone sulla noia, ha scritto qualcuno, e in effetti è un altro esempio di performatività: come Good Day Sunshine e Here Comes the Sun incarnano due giorni di sole, Blue Jay Way è nebbia e angoscia e rischio di addormentarsi: non ci crederesti mai che dura soltanto tre minuti. Sarà perché uno su tre George lo trascorre a ripetere please, don't be long e tu potresti risvegliarti all'improvviso e non sapere se sono passati secondi, ore, secoli.
(Brian Epstein non ha mai fatto in tempo ad ascoltarla. Hanno iniziato a lavorarci in quel settembre, lui è rimasto in agosto).
In Magical Mystery Tour George la canta seduto per terra, su una tastiera disegnata coi gessetti che è una delle idee più carine del film, finché dalla nebbia non emerge il pullman e potrebbe investirlo, ma George si riscuote in tempo per raggiungere i compagni sul veicolo. Uno si domanda quanto George e John abbiano preso sul serio il Magical Mystery Tour: se per loro non si trattasse semplicemente di una goliardata, un modo di tenere occupato Paul e prendere tempo, mentre decidevano che fare delle loro vite adulte e se non fosse il caso di trovarsi un nuovo manager. Certo, sia Walrus che Blue Jay Way sembrano pezzi ambiziosi. Ma, ecco, potrebbero anche essere degli scherzi riusciti particolarmente bene. Perché in fondo la macchina era ancora perfettamente rodata (anche se Brian era sceso), ormai con George Martin si capivano al volo e riuscivano a dar forma anche alle cose più vaghe, ectoplasmiche. Prendi Blue Jay Way: musicalmente non è poi molto lontana da Within You Without You. Anche l'arrangiamento è tutto tranne una cosa buttata lì: ci si sono messi d'impegno, c'è un'orchestrazione, ci sono trovate tutt'altro che banali, c'è Ringo in primo piano che ci mette l'anima. E però Within You era un pezzo sulla meditazione trascendentale, Blue Jay Way una filastrocca sulla fatica di rimanere svegli mentre si aspettano gli amici.
 |
| Brian Epstein (Box of Pin-Ups), 1965 © David Bailey |
George non aveva sempre voglia di prendersi sul serio. Con poca fatica avrebbe potuto cambiare due strofe e fare di BJW una canzone seria, magari mantenendo il vero "my friends have lost their way" per esprimere la profonda delusione sperimentata proprio in California nei giorni successivi, di fronte a una scena alternativa molto più materialista e opaca di come gliel'avevano venduta. In effetti c'è chi alla ricerca di profondità nei testi di George, la trova persino nel mantra Please don't be long, che secondo un tipico gioco di parole lennoniano potrebbe anche leggersi Please don't belong, "per favore, non appartenere". D'altro canto, è proprio quando tutti si aspettano da te parole di saggezza che ti viene voglia di scrivere di banalissimi fatti tuoi, e in questo se volete possiamo trovare il senso profondo di Blue Jay Way: il passo indietro di George, prima di diventare definitivamente il guru di una generazione che sembrava averne un disperato bisogno.
In Regno Unito l'ultimo lunedì d'agosto è festivo. Sabato Brian nel suo cottage in Sussex si annoiava; aspettava un gruppo di amici che si era perso (secondo Philip Norman erano ragazzi forniti da un'agenzia specifica). Alla fine arrivarono, ma lui si era già messo in macchina per Londra, un po' ubriaco. I suoi collaboratori lo sentirono il giorno dopo, aveva la voce un po' sfatta ma sembrava tranquillo. Lunedì lo trovarono nella sua camera, chiusa dall'interno. Troppi barbiturici per dormire. Please don't you be very long, or I may be asleep.
134. Another Girl (Lennon-McCartney, Help!, 1965)
Col tempo scopri che è più facile tollerare il maschilismo lennoniano di Run for Your Life che con quello pragmatico e socialmente più presentabile di Another Girl. Cioè ok, non c'è dubbio che dei due sia il maschio più pericoloso, il potenziale femminicida. Ma è anche una vittima di trauma di abbandono, un malato, e in definitiva un essere umano che si osserva con angoscia e si domanda se potrà mai riscattare il suo destino ("You know that I am a wicked man and I was born with a jealous mind"). Paul invece. Paul a volte sembra un alieno. Aveva una ragazza, non lo soddisfa più in determinati aspetti, se ne procura un altra che gli garantisce un'esperienza più appagante. Non sono mica un pazzo, dice. Prendo solo quello che mi va. Non sto mica dicendo che ero infelice con te, eh? Ma adesso ne ho una che è nuova. Un'altra ragazza che mi amerà fino alla fine; nella buona e nella cattiva sorte sarà sempre mia amica. C'è qualcosa di così sfacciato in quel bridge smagliante. Another Girl è uno di quei brani in cui senti che Paul ha messo il pilota automatico, avrebbe potuto scriverne un centinaio così. Ad ascoltarla subito dopo She's a Woman ti fa pensare che sono proprio i testi banali, quelli scritti senza troppo preoccuparsi di altro che non sia riempire i versi, quelli in cui rischi di svelare più cose di te. Paul, lo sanno tutti, nel 1965 aveva un indirizzo per Jane Asher e un altro per tutte le altre ragazze con cui usciva. Nulla mi leva dalla testa che nel ritornello John stia cantando "A lot o' girl" (molto più facile da sentire di "rich fag jew" in Baby You're a Rich Man).
(Nella sequenza del film, Paul finge di non capire la differenza tra una ragazza e uno strumento musicale. Finge? La chitarra solista è sua ed è tutto fuorché impeccabile, ci sono sbavature che a George non sarebbero state consentite).
133. Love You To (Harrison, Revolver, 1966).
A lifetime is so short, a new one can't be bought. Quelli che preferiscono Revolver, forse non sono davvero beatlemani, forse non lo sono abbastanza. Forse la beatlemania gli sta passando, come un virus che comunque lascerà preziosi anticorpi. Uno dei motivi per cui preferiscono Revolver – non lo confesseranno mai, ma è così – è che è rapido e brutale, non fa prigionieri, sono due caricatori con sette pallottole l'una, vuoi il capolavoro dei Beatles? Pam pam pam pam pam pam pam, eccotelo. Poche menate, vuoi il pezzo un po' sperimentale di George? Pam, beccati Taxman, prova a trovarne uno migliore. Vuoi il pezzo coi violini? Pam, ecco Eleonor Rigby, dimmi se c'è di meglio. Vuoi John psichedelico e sincero? Pam, I'm Only Sleeping con l'assolo alla rovescia. E non sono passati neanche sei minuti ed è già girato un mezzo mondo di musica. Vuoi il richiamo dell'Oriente, vuoi il pezzo coi sitar? Sbrighiamo anche questa pratica. In tre minuti. Love You To dura tre minuti e c'è già tutta l'India che i Beatles potevano mettere su un disco. In seguito George Harrison si prenderà più tempo e più libertà, ma forse più in là di Love You To i Beatles non potevano andare. Chi preferisce Revolver forse ha semplicemente fretta: Within You Without You non finisce mai, The Inner Light non fa che ribadire cose già sentite. Love You To è il livello base, ecco, quelli che preferiscono Revolver non hanno più voglia o tempo per andare oltre. Restano in superficie. E ho notato questa cosa col tempo, che più invecchi e preferisci stare in superficie. Da giovane ti immergi, vuoi ascoltare le cose più strane, ti metti a litigare con i tuoi affetti più cari per un lato B. Invecchiando, ti accorgi che eri un coglione. Revolver è un capolavoro, ha tutto quello che gli serve, perché cercare altrove? La vita è così corta, e il nuovo modello non è in vendita.
132. Baby You're a Rich Man, Lennon-McCartney, lato B di All You Need Is Love.
Devono averci messo un po' a rendersene conto, ma verso la metà degli anni '60 erano diventati tutti ricchi, tutti Bella Gente. Quasi tutti. I Beatles avevano sfondato la porta, ed essendo stati i primi non avevano spuntato le condizioni migliori. Anzi avevano preso la loro buona dose di fregature, ma a quel punto potevano tutti permettersi il villino con sei stanze, la tv che cominciava addirittura a trasmettere film a colori, le sostanze sintetiche più alla moda, feste col caviale al buffet, il frigo-bar-mappamondo, e poi? Che ne faremo di tutti questi soldi? Certo, passarli tutti al governo non suona bene, e quindi cosa?
(E se arriva la rivoluzione? Perché, insomma, ne ha tutta l'aria. Gran cosa la rivoluzione, per carità, contateci... Ma di tutti i momenti in cui doveva scoppiare, proprio adesso che siamo appena diventati ricchi noi?)
Ogni canzone ha il suo mistero. Quando non ce l'ha il redattore trova un modo di inventarselo, qualcosa bisogna pur scrivere. Io per esempio vorrei tanto capire cosa credesse di fare John con quell'organo, il clavioline. Cioè aveva un criterio, stava provando qualche trucco indiano, o pestava solo tasti a caso per fare scena, confidando che in seguito avrebbero sepolto la traccia nel mix sotto quella di un pianoforte? Ma siccome non ci sono vere risposte, e in generale non sono gli arrangiamenti ad appassionare i lettori, il più delle volte si preferisce indagare sull'arcano mistero del destinatario: a chi è rivolta Baby You're a Rich Man? Chi è il nuovo ricco che ancora stenta a rendersene conto? Qualcuno che continua a intascarsi percentuali e ha pure il coraggio di lamentarsi?
Brian Epstein è l'obiettivo più gettonato, un po' perché sarebbe morto di lì a poco, un po' per riempire quel desolante spazio vuoto del fascicolo "canzoni dei Beatles in memoria del loro manager". Da qui la leggenda che Lennon alla fine della canzone si metta a cantare "Baby you're a rich fag jew", un ricco frocio ebreo. Una cosa che John avrebbe anche potuto fare mentre registrava i corsi su un multipiste verso la fine di un pezzo che sapeva già sarebbe andato in dissolvenza, con la stessa nonchalance con cui cazzeggiava con il clavioline. Resta il fatto che quel verso lì non c'è. Puoi sentirlo soltanto se prima te ne hanno parlato, è un'allucinazione uditiva come quel "fuck you like a superman" in coda ad A Day in the Life. La gente ci tiene a sapere a chi sta cantando John, come se quel che canta John debba sempre per forza avere un senso preciso e specifico, laddove da sempre lui programmaticamente aveva scelto l'ambiguità, e si riducesse a improvvisare le parole più spesso di quanto non gli capitasse di suonare note a caso su una tastiera.
Lennon sapeva da sempre che il senso di una canzone è nell'uso che ne fa l'ascoltatore, e non nell'origine più o meno aneddotica dell'ispirazione. Puoi cantare Baby you're a rich man all'amico terzomondista che dorme solo nei grand hotel; puoi cantarla a tutti i boomer che per in quegli anni stavano giocando alla rivoluzione in attesa di ereditare le sostanze del padre o almeno il posto; puoi cantarla a te stesso mentre ti domandi dove investire quel gruzzolo che in banca sgocciola tot spese al trimestre e certo, meglio avere problemi del genere, ma sono comunque problemi. Lennon probabilmente la cantava a sé stesso, ed è questo come sempre a renderlo convincente, mentre si specchia in una cornice che non riesce a prendere sul serio: davvero, che ne farò di questi soldi. Non che abbia importanza: il senso di una canzone sta nell'uso che se ne fa, e dal 2010 in poi Baby you're a rich man è la canzone che Fincher ha usato per i titoli di coda di The Social Network. Davvero come fare ad ascoltarla senza pensarci.
131 One After 909 (Lennon-McCartney Pubblicata nel 1970 in Let It Be, ma scritta più di dieci anni prima).
Move over once, move over twice. "Abbiamo sempre odiato quelle parole", disse Paul. "Non sono fantastiche?" A una delle canzoni più banali firmate Lennon-McCartney, un r'n'r senza infamia/lode, è capitata la sorte di diventare una specie di Leitmotiv della storia del gruppo, per il semplice fatto che la troviamo all'inizio e alla fine della storia: a fine anni Cinquanta, quando il giovane Lennon la mette insieme mescolando suggestioni rock and roll e dettagli della sua vita quotidiana (gli autobus di Liverpool); e a fine anni Sessanta, quando i Quattro la ritrovano come una diapositiva sbiadita nel baule del solaio, la rispolverano col non piccolo aiuto di Billy Preston e la includono nella scaletta del loro ultimo concerto. In mezzo ai due estremi, c'è quel giorno del 1963 in cui i Beatles freschi del successo di Please Please Me cercano di inciderla e tutto va storto: John se la prende con Ringo che sbaglia, con Paul che comincia senza plettro e poi si ferma, con George che sbagli assolo, e poi alla quarta take sbaglia anche lui. Le take sono state ricomposte su Anthology I, ottenendo così una versione completa della One After 909 del 1963, che i Beatles però non sono mai stati capaci di suonare dall'inizio alla fine. Eppure non sembra una canzone difficile. Può darsi che i Quattro sentissero inconsciamente che non era adatta. Eppure è solo un r'n'r; perché non avrebbe dovuto funzionare in Please Please Me o With the Beatles?
In apparenza è un problema di testo, che risulta non finito; forse è costruito su un gioco di parole che Lennon non riesce a spiegare. A quel punto viene messa in un cassetto e, quando viene tirata fuori sei anni dopo, l'incompletezza del testo non è più un problema, anzi è quasi una prova della genuinità del prodotto vintage. Ma più profondità credo che ci sia un problema con Elvis. One After 909 è la canzone più presleyana di tutto il repertorio Lennon-McCartney: è quasi una parodia, un genere che fino al 1966 non si sarebbero mai sognati di praticare. In particolare quel "move over once, move over twice", che è il punctum di tutta la canzone, è qualcosa di troppo presleyanamente teatrale per non imbarazzare un po' Lennon (c'è almeno un'intervista, che ovviamente non riesco più a trovare, in cui Lennon spiega che certe cose teatrali alla Presley avevano espressamente deciso di non farle: One After 909 è un brano che precede anche una scelta del genere).
Per saltar fuori dal cassetto il brano doveva aspettare il momento in cui i Beatles avessero cominciato a praticare la parodia, il che avviene più o meno da Sgt. Pepper in poi, ed è curioso che il disco che segna la momentanea eclissi del rock sia anche quello che contiene le prime parodie. Il ritorno del r'n'r è annunciato dal singolo Lady Madonna, un manifesto tributo a Fats Domino, e confermata dal brano di apertura del Disco Bianco, Back in the USSR, un Jerry Lee Lewis traslato in Russia coi cori alla Beach Boys così, a caso, per vedere l'effetto che fa. One After 909 diventa il passo successivo: i Beatles che prendono in giro i sé stessi teenager che cercavano di copiare Elvis con gli autobus di Liverpool al posto dei treni. Ma siccome la parodia di solito è un rovesciamento carnevalesco e consente al povero di invertire per un attimo le gerarchie, questi Quattro milionari a corto di ispirazione che si fanno aiutare da uno dei più grandi turnisti del mondo a prendere in giro quattro squattrinati teenager di Liverpool... non sono così divertenti. (Ciò non toglie che dal vivo spaccassero. Col freddo che doveva esserci. Non è così facile suonare le chitarre col vento addosso).
130. I Need You (George Harrison, Help!, 1965)
I Need You è quella classica canzone che credo tracci un solco tra chi ascolta i Beatles da anni e chi li conosce giusto per sentito ascoltare, e dopo qualche secondo di I Need You ti domanderà se per caso le casse non sono guaste, o gli auricolari hanno un problema – aspetta, forse è una demo, no? Cioè quella chitarra in ritardo l'hanno sistemata, no?
No.
"Vuoi dire che nel disco più venduto nel 1965 c'era una chitarra così palesemente in ritardo?"
Sì, era un esperimento di George con un pedale che alzava e abbassava il volume, voleva farci sentire gli accordi come se arrivassero da lontano.
"Guarda, credo di avere capito cosa intendeva fare questo George, e la trovo anche una cosa interessante, un po' da Brian Eno dieci anni prima, però è fastidiosa, capisci. Bisognava lavorarci di più, possibile che nel 1965 il gruppo più famoso del mondo non avesse il tempo o l'equipaggiamento per lavorarci di più?"
Beh forse lo possiamo dire noi dopo anni di ascolto di Brian Eno, ma in quel momento ad Abbey Road non è che ci fossero Brian Eno o Robert Fripp a dare consigli al giovane George. Nemmeno John e Paul abbondavano di consigli a George. Tieni poi conto che fino al 1965 questa cosa di essere il gruppo più famoso del mondo i Beatles la vissero come una specie di Grande Truffa, o meglio di Grande Rapina al Treno, ma non di quelle attentamente preparate in laboratorio, anzi, insomma quattro ragazzi di Liverpool entrano per caso nel caveau della musica pop e si accorgono che è aperto, i custodi si erano distratti. Per cui su ogni preoccupazione prevale l'entusiasmo e la fretta: bisogna portare via più tesori possibile. Così verso il 1965 poteva ancora succedere che George dicesse: qui ci voglio una chitarra così, e non ci fosse il tempo né l'esigenza di dirgli ehi, non sta suonando bene. Oggi siamo abituati ad ascoltare rapsodie rumoriste che nel 1965 avrebbero sconvolto l'ascoltatore più disinibito (che forse era proprio George Harrison): in compenso quel che combina George con il pedale del volume in I Need You oggi lo consideriamo un errore, un ritardo, qualcosa da rispedire al mittente. Ma a volte mi chiedo se quello che mi ha legato ai Beatles sin da subito non fu proprio questo aspetto: gli apparenti errori. Buffo perché uno dei motivi per cui i Beatles dovrebbero piacere alla gente è il fatto che siano facili da ascoltare, no? Beh sì e no.
Già negli anni Ottanta c'era un'idea molto precisa e radiofonica su come si dovessero arrangiare le canzoni (un'idea che oggi ci sorprende per quanto sia invecchiata male) e in mezzo ai campionamenti e alle batterie saturate, erano i Beatles a suonare non solo artigianali, ma in un certo senso dissonanti. Che era il motivo per cui poi da ragazzi ci si metteva ad ascoltare prima il punk, poi il postpunk meno intellettualoide, e l'indie, e in generale chiunque si ostinasse a difendere una certa idea di imperizia musicale. I Beatles però non è che abbiano mai suonato male apposta (almeno fino al Disco Bianco): quel che li rende alla fine più genuini è che loro non volevano davvero creare incidenti (almeno fino al Disco Bianco). I loro errori, e ne facevano tanti, sono gli errori genuini di qualcuno che sta cercando di imparare a suonare qualcosa che ancora nel 1962-1967 non stava suonando nessuno. Errori di esplorazione. Quel che sto cercando di dire è che non riesco neanche per un istante a immaginare George bullarsi, mentre pasticcia col pedale in I Need You, ed è solo questo alla fine che riscatta I Need You. Non voleva sfidare l'ascoltatore, non bluffava, non aveva ancora assunto quell'atteggiamento fottiti-sono-un-Beatle che lui stesso irriderà in Only a Northern Song. George stava semplicemente cercando di ottenere qualcosa di nuovo, di mai sentito, con gli strumenti che aveva a disposizione e col tempo che i colleghi gli concedevano. Il risultato non è proprio riuscito, ma anche questo è interessante: il fatto che nella nostra testa noi riusciamo per qualche modo a correggere le imperfezioni di I Need You. Capiamo quel che George voleva fare, e lo completiamo con la nostra immaginazione, dopodiché ci autocomplimentiamo per la nostra immaginazione e abbracciamo George che ci ha aiutato a salire un gradino più in alto di lui. Tutte queste cose si possono fare con le opere di tantissimi altri artisti, però in un modo o nell'altro è più facile descriverle quando le trovi in una canzoncina dei Beatles.
129. I Want to Tell You (Harrison, Revolver, 1966)
My head is filled with things to say... George è didascalico. Se la canzone è triste, la chitarra piange. Se il protagonista della canzone rischia di addormentarsi (Blue Jay Way), si dovrà addormentare anche l'ascoltatore. Se non sa cosa scrivere, ci scrive una canzone (Only a Northern Song). Se non riesce a trovare le parole, fingerà di non trovare nemmeno gli accordi: ed ecco I Want to Tell You. George deve ancora crescere come compositore, ma non avrà mai tanto spazio come su Revolver: tre pezzi su quattordici, più di un quinto del mazzo. Sono tre esperimenti. I Want to Tell You è solo apparentemente più convenzionale di Taxman e Love You To. L'idea portante è l'ineffabilità: ci sono cose che il protagonista non sa esprimere a parole, e anche in musica avrà bisogno di nuovi accordi (l'epico Mi7b9, che George inventa per l'occasione), di nuove note (le due ostinate che Paul suona al piano sono un'approssimazione inevitabile ma insoddisfacente: serve una frequenza diversa che gli strumenti occidentali non possono esprimere: serve la sapienza orientale, serve il sitar, la canzone ne è priva ma Paul con quel melisma finale te lo fa desiderare).
L'ineffabilità è un tema coerente con il personaggio che George ha impersonato fino a quel momento, sia nelle composizioni di Lennon-McCartney che nelle proprie (Don't Bother Me, If I Needed Someone): il "Quiet Beatle", il ragazzo di poche ma meditate parole che sta per assumere il ruolo di guru del gruppo, ma in I Want to Tell You ammette semplicemente di non sapere come esprimere i propri sentimenti davanti a una partner: oppure è appena tornato da un trip lisergico e non sa come spiegarsi. Le sostanze sono il leitmotiv degli ultimi quattro brani di Revolver, da Doctor Robert a Tomorrow Never Knows passando per l'euforica Got to Get You Into My Life, di cui I Want to Tell You diventa una specie di introduzione. Si indovina l'orecchio di Paul dietro la decisione di accostare in scaletta due canzoni che in qualche modo si riecheggiano.
128. Savoy Truffle (Harrison, The Beatles, 1968)
Lo sai che sei quello che mangi? E quindi attenzione ai dolci, ti svuotano i denti. Una canzone sulla carie, vi immaginate. Non è il contrappasso perfetto, per un gruppo costantemente tentato (e spesso vinto) dal pop più zuccherino? "Magari non lo senti adesso, ma quando il dolore ti taglierà, te ne accorgerai eccome. Madido di sudore, quando sarà troppo griderai". Harrison stesso non sembra inconsapevole che la sua filastrocca tratta da una scatola di cioccolatini può esser letta in senso metareferenziale, e di tutte le canzoni che poteva citare per completare un verso, sceglie esattamente quella che col suo saccarosio stava minando la dentina interna del gruppo. "Conosciamo tutti Obladì obladà, ma tu mi sai mostrare dove sei?" Davvero Paul, sai dirci dove sei? Sei sicuro che sei ancora nel gruppo? Non è che hai già cominciato una carriera da cioccolataio solista, e nemmeno te ne sei accorto? Siamo ancora i tuoi colleghi o siamo i tuoi turnisti? Per quanto sapesse essere molto franco, se voleva (anche nelle canzoni), stavolta forse George non voleva. Nascose le sue riflessioni in una scatola di cioccolatini, dove soltanto qualcuno molto goloso l'avrebbe trovata.
Oppure sovrainterpreto. Magari è vero quello che racconta George, e la canzone è solo uno scherzo ispirato alla devastata cavità orale di Eric Clapton, che di tutte le dipendenze disponibili in quel periodo aveva pure quella da caramelle – del resto tutti questi Nuovi Ricchi alla fine sono solo ragazzini a cui nessuna mamma può più controllare lo stipo più alto della credenza. Insomma i Beatles nel 1968 si erano stancati delle solite canzoni d'amore e anche il pubblico si era parzialmente stancato di ascoltarle. A quel punto avrebbero potuto diventare visionari, surrealisti, politici, esistenziali, e non è che ci provarono, ma la facilità con cui si riempie una pagina di frasi d'amore qualsiasi e si riesce comunque a produrre un testo sensato era perduta per sempre. A un certo punto insomma sembrava normale che nel momento di trovare un testo per una canzone, George si risolvesse a riempire una paginetta con nomi di cioccolatini veri o falsi. Magari era il testo provvisorio, come "Scrambled Eggs" per Yesterday, e questo ce la dice lunga perché appena tre anni prima i Beatles non avrebbero mai inciso davvero una canzone sulle uova strapazzate, mentre quella sui truffles savoiardi passò tranquillamente il controllo qualità Lennon-McCartney, che pure nei confronti dei prodotti harrisoniani restava abbastanza severo.
 |
| Eric Clapton coi Cream, nel 1967 |
A proposito, vi rendete conto di dove siamo? Il prossimo brano è il #127, il che non significa niente, tranne che avevamo cominciato dal #254, e quindi... siamo a metà. Savoy Truffle e Being for the Benefit sono il punto mediano della produzione dei Beatles, il che è abbastanza buffo (sono tutto tranne due brani 'medi'). Tra le tante considerazioni che si potrebbero fare, avete notato quanti pezzi di George troviamo anche a questa altezza? Oggi sei su quindici, sono proprio tanti. E sapete quanti pezzi di George incontreremo da oggi in poi, fino al #1?
Sette.
127. Being for the Benefit of Mr. Kite! (Lennon-McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 1967).
E stanotte Harry il cavallo danzerà il valzer. Di tutti i salti dai quattro ai tre quarti, che sono uno stilema tipico di John Lennon (un chitarrista ritmico con un ben strano senso del ritmo), quello centrale di Being for the Benefit è il meno sorprendente, il più didascalico: il testo dice che c'è un cavallo che balla il valzer, quindi vai col valzer, siamo i Beatles, no? Queste cose le facciamo. È un siparietto perfetto per quel mago degli effetti artigianali che era George Martin, qui all'organo ad acqua. Ma insomma anche l'eversione dal 4/4 a questo punto è un numero di varietà: non ti sorprende in coda a un ragionamento come in We Can Work It Out, non ti spezza le gambe come il disarmante ritornello di She Said She Said, non ti manda in confusione come la strofa di All You Need Is Love, non ti tiene sulle corde come la schizofrenia di Happiness is a Warm Gun.
Being for the Benefit vola più bassa, è 100% John ma è un John che prova a lavorare come Paul, allontanandosi da sé stesso, nascondendosi nelle suppellettili (in questo caso il manifesto di un circo), anche solo per dimostrare che se vuole ne è capace. È un tipico bozzetto alla Sgt. Pepper, anzi il più tipico di tutti: messo in posizione strategica, a metà show, ribadisce quell'aspetto teatrale-circense che dopo i primi due brani si era attenuato molto, per non dire del tutto. Il quale Sgt. Pepper's, almeno a mio avviso, prima di diventare il capolavoro che tutti decisero che doveva essere, era per Paul e John un passo laterale, dopo tanti passi avanti: un modo per scrollarsi dalle spalle l'etichetta sempre più pesante di band più famosa del mondo. Proviamo a scrivere canzoni come se non fossimo noi, come se fossimo ancora un complessino di stronzi, anzi una banda di paese che si arrangia sui chioschi al sabato pomeriggio. Che dire: funzionò.
A volte per sbloccarti devi immaginare di essere qualcun altro con meno pretese; è un suggerimento che farei a tutti se fossi qualcuno da cui tutti si aspettassero un suggerimento. Lennon ha scritto molti pezzi migliori di Being, ma io sono contento che l'abbia scritta, sono sempre abbastanza felice di ascoltarla, specie quando deve ripassare ai quattro quarti e fa: tatatatà-tatan! The band begins at 10 to 6.
È il primo brano di Sgt. Pepper che incontriamo risalendo la classifica, e come sapete siamo già a metà. Insomma sembra chiaro che Sgt. Pepper sia il disco migliore dei Beatles, ovvero quello che sommando tutte le posizioni dei brani e dividendo per il numero dei brani restituisce la media inferiore, no? E invece no. E quale disco osa essere migliore di Sgt. Pepper? Eh eh, non solo un disco. Più di uno. Eresia, lo so, ma è così.
126. Do You Want to Know a Secret (Lennon-McCartney ma la canta Harrison in Please Please Me, 1963).
 |
| John e Cynthia Lennon a Londra nel 1965 (Evening Standard/Getty Images) |
Ma è poco credibile. Nessuno parlava di matrimoni riparatori nelle canzoni del 1963. Di sicuro non i Beatles agli esordi. Lennon e McCartney non parlavano di sé stessi nelle loro canzoni, ci avrebbero messo anni di pratica per capire come si fa. In quel momento stavano semplicemente montando su progressioni prese da altre canzoni d'amore frasi tratte da altre canzoni d'amore, o film, sperando che il patchwork finale funzionasse: e spesso funzionava, anche perché la materia prima era buona e coerente. Solo a volte venivano introdotte spezie un po' esotiche o incongrue, per esempio le frasi Do You Want to Know a Secret / do you promise not to tell sono prese di pacca da un brano di Biancaneve e i Sette Nani. Che poi inconsciamente John stesse riflettendo sui suoi sentimenti per Cynthia, ci può stare. Che a un certo punto le abbia detto che l'aveva scritta per lei, anche. Ma vuoi conoscere un segreto? John parla solo di sé stesso.
125. Yes It Is (Lennon-McCarney, lato B del singolo Ticket to Ride, 1965).
Ma che roba è. Anche chi ama i Beatles, non necessariamente li ascolta tutti i giorni o conosce tutti i pezzi a memoria. Ce ne sono alcuni che fatalmente spariscono sotto il radar – molto spesso i lati B dei singoli, se non hanno un titolo bizzarro o una storia strana dopo un po' te li dimentichi. Poi un giorno la funzione shuffle te li mette davanti e mio dio, ma cos'è questa cosa? Sono i Beatles, sul serio? Hanno fatto anche questa? Ma è stranissima! E beh, è un'emozione, è come se all'improvviso avessero mandato fuori un inedito. (Sul lato B di Ticket to Ride, quindi prima di cedere al mccartneysmo di Yesterday c'è stato almeno un caso in cui uscì un singolo con un pezzo di Lennon su entrambi i lati).
Yes It Is è il classico pezzo che puoi snobbare per vent'anni, tanto lo capisci dal titolo che è il classico riempitivo del periodo in bianco e nero. Poi un giorno lo riascolti e non ci credi. Ovvero, sì, non può essere che una canzone del periodo in bianco e nero, i Beatles post-Revolver a colori aumenteranno il campo delle possibilità musicali, ma certe cose smetteranno del tutto di farle: niente più teenpop, soprattutto, e Yes It Is è ancora una distortissima, drogata idea di teenpop. Non ti vestire di rosso stanotte. Lo fanno apposta a steccare i cori qua e là, è un correlativo oggettivo del falso affetto del cantante che ammette alla sua partner di rimpiangere ancora la Signora in Rosso, di provare addirittura dell'orgoglio per lei... o è una certa noncuranza tipica dei lati B? Fa l'effetto di certe lenti deformanti su una foto in bianco e nero. George ancora in fissa col pedale di I Need You (il brano fu inciso lo stesso giorno) è decisivo nel creare una nebulosa cacofonia diversa ma non meno frastornante di quella di Blue Jay Way.
Un frammento del secondo volume di Anthology ci aiuta a capire, o almeno a inserire Yes It Is in una storia del Lennon confidenziale, in un punto mediano tra This Boy e Julia. John forse ha capito che anche la fragilità può essere esibita in una canzone, John forse vorrebbe già incidere un brano sottovoce, ma è pur sempre John e non ne ha il coraggio: quando arriva al bridge si burla di sé stesso, canta in falsetto e lì il frammento sfuma sulla versione finale, come fanno a volte gli archeologi quando restaurano un pezzo antico. E così abbiamo una nuova ipotesi sulle armonie: servono a questi maschietti per sentirsi meno soli, per farsi forza l'un l'altro, e non è un problema se uno dei tre stona, meglio stonare che farsi sorprendere soli con gli occhi lucidi. Che altro posso dire di questa canzone assurda? Che è probabilmente quello che succede quando riempi Lennon di pasticche, gli fai mandare giù due calici di bianco e poi gli rimetti sul naso gli occhiali e gli dici, ehi Mr Burt, si sente bene adesso? Perché un attimo fa credeva di essere John Lennon, ora stai bene? Ora per favore ci può scrivere la canzone per il lato B, maestro Burt Bacharach? Eh? Cosa? Ma io non sono... Boh vabbe', proviamo questa.
124. Doctor Robert (Lennon-McCartney, Revolver, 1966)
 |
| He's a man you must believe, helping anyone in need. No one can succeed like... Doctor Robert (Scusate ma mi sta cantando in testa da due settimane). |
Doctor Robert non è la solita canzone d'amore, ma nemmeno è ascrivibile a quel bozzettismo crepuscolare che Paul stava iniziando a imporre al gruppo con Eleonor Rigby: personaggi mediocri in contesti piccolo-borghesi, un trend che proseguirà in She's Leaving Home e When I'm 64 e contagerà fatalmente i Kinks. Il dottor Robert non c'entra niente con questa gente: forse è un dottore californiano molto amato dal jet-set perché ha la prescrizione facile. Forse. (Oppure invece lavora per la mutua, la "National Health". Non è chiaro, è pur sempre un testo dei Beatles). Ma è comunque un tentativo non banale di guardarsi un po' attorno senza fingere di aggirarsi ancora per i sobborghi del Merseyside; dopotutto se il tuo quotidiano ormai è popolato di spacciatori di pillole (o avvocati fiscalisti come in Taxman) non è più sincero parlare di quelli? Alla voce sincerità rileviamo anche il fatto che l'ironia di Lennon qui non senta nessuna necessità di graffiare: non sembra che il Dottore stia facendo nulla di male dopotutto; e qui per la prima volta, e forse per l'unica, dobbiamo ammettere che Mick Jagger aveva saputo inquadrare con un più cinico realismo la questione anfetamine in Mother's Little Helper, segnalando che anche i piccoli borghesi crepuscolari nelle loro piccole case dei sobborghi stanno mandando giù pillole peggio delle rockstar. John è più blando. Abbiamo già notato quanto peso assumano le sostanze nell'ultimo quarto d'ora di Revolver: Doctor Robert prescrive le pillole, George in I Want to Tell You è lisergicamente perplesso, Paul in Got to Get You Into My Life vota la sua vita alla cannabis (o almeno è quello che racconterà più tardi), John in Tomorrow Never Knows è già nel nirvana. Per cui insomma se qualcuno si fosse chiesto di cosa avrebbero cantato i Beatles quando avessero smesso con le solite canzoni d'amore, beh, la risposta sembrava abbastanza chiara. Ma non sarebbe durato (e meno male, più ossessivo dell'amore nelle canzoni c'è solo la droga).
123. It's All Too Much (Harrison, Yellow Submarine, 1968).
È tutto troppo. In effetti una cosa interessante dell'LSD è che di solito dopo un po' la gente smette da sola. È una droga impegnativa. Richiede di essere già di buon umore, ovvero non nella situazione in cui la gente ha l'impulso di drogarsi. Non è semplice da gestire, devi stare lontano dai volanti e dalle finestre aperte. Ma anche nella situazione ottimale, alla fine si tratta di un congegno rivelatorio e non è che hai sempre voglia di sperimentare rivelazioni, ogni tanto sì ma pochi aneddoti sui Beatles lasciano perplessi come la storia di John che ne assumeva tutti i giorni. Tutti i santi giorni per due anni, e poi a un certo punto decise di smettere perché faceva troppi bad trip. E se n'è accorto dopo due anni? Boh. George aveva già smesso da un pezzo, non prima di avere avuto alcune intuizioni sulla vanità dell'io che la meditazione trascendentale avrebbe platealmente confermato. It's All Too Much si lascia anche leggere come un addio di George all'acido, ma non è il motivo per cui al primo ascolto di solito ci fa balzare dalla sedia. Il motivo di solito è la chitarra. Sembra incisa l'altro ieri – mmmno, diciamo che sembra incisa in un garage negli anni '90. Cosa stava succedendo?
Non è molto chiaro, non si è mai capito cosa avessero realmente intenzione di registrare i Beatles agli studi De Lane Lea. Era forse dai tempi di Can't Buy Me Love che non lavoravano nei familiari ambienti di Abbey Road, e a quel tempo erano stati costretti dalla logistica, erano sempre in tour. Invece It's All Too Much sembra l'esperimento estemporaneo di chi ha molto tempo da perdere. Sgt. Pepper era appena uscito, e alla presentazione Jimi Hendrix and the Experience avevano sconvolto il pubblico con una cover distorta del brano di apertura (qui sotto la ricostruzione, nell'unica scena che valga la pena guardare di questo film). Ecco, It's All Too Much sembra incisa di corsa da qualcuno che sia appena uscito dalla festa gridando wow, ma hai sentito quella chitarra, sbraaaaaan! Voglio anch'io suonare una chitarra così. E per quanto si legga un po' dappertutto che quel tizio dovrebbe essere George Harrison, George stesso almeno una volta ha ammesso che avrebbe invece potuto essere Paul McCartney. Se ci pensate ha perfettamente senso: tutti i pezzi di chitarra più chiassosi e feedbackanti da Helter Skelter a Revolution non sono mai responsabilità sua. Invece giocare a fare l'Hendrix bianco, è proprio la reazione che ci aspetteremmo da Paul dopo aver ascoltato Hendrix. Lennon suona un basso semplice, Ringo ci dà dentro ma questi pezzi infiniti, che qualsiasi altro batterista adorerebbe, non sono i suoi più congeniali: lui dopo un po' si annoia.
It's All Too Much potrebbe anche essere la risposta alla domanda: bello Sgt. Pepper, ma dov'è finito il rock? Dopo le prime sedici battute del primo brano è come se scompaia, irriso dagli ottoni e dai violini e dai sitar e da tutti gli altri ammenicoli. Quel rock che ancora traboccava da Revolver, nel 1967 sembra ormai ai margini della tavolozza. Ecco dov'era: si era rifugiato in It's All Too Much. È un modo di vederla, ma può anche significare che i Beatles sono a un punto di svolta: con Hendrix e coi Cream il rock rischia diventare "too much", troppo duro per restare mainstream. Bisogna scegliere, o il rock o i soldi veri. Magical Mystery Tour (da cui It's All Too Much fu scartata, se fu anche solo presa in considerazione) avrebbe indicato molto chiaramente quale via era stata scelta, anche se ci sarebbe stato tempo per i ripensamenti.
Il verso più famoso del brano "Mostrami tutto quello che c'è da vedere, e riportami a casa per l'ora del tè" è quanto di più harrisoniano si possa immaginare. In effetti l'idea che tutto quello che stava succedendo là fuori in quegli anni si potesse sperimentare entro il tardo pomeriggio aveva già ricevuto una definizione nel lessico beatle: non erano i day tripper, i turisti della rivoluzione? E a quel punto l'ambiguità si specchia in sé stessa come in un caleidoscopio: Harrison sta riconoscendo in sé stesso un day tripper? Sta ammettendo di non poter reggere tutto il nuovo in una volta sola. Qualsiasi senso avesse la canzone al culmine del 1967, senz'altro doveva essere cambiato un anno e mezzo dopo, quando alla fine il pubblico poté sentirla (e guardarla, in Yellow Submarine). A quel punto i Beatles non avevano rinnegato soltanto l'LSD, la psichedelia, il rock più duro e distorto. Dopo un po' tutto fatalmente diventava troppo.
Quando si tratta di incrociare il parere dei critici It's All Too Much è una delle canzoni con lo spettro più alto tra i pareri positivi e negativi – per Time Out sta al trentunesimo posto, Rolling Stone e NME non la considerano nei primi cento. È il brano di George Harrison preferito da molti ascoltatori di George Harrison di non stretta osservanza beatlesiana; per qualche anno fu nel repertorio dei Grateful Dead cui calzava come un guanto sformato dal tempo e dall'uso. Quanto a George, in seguito disse che non gli dispiaceva, ma non sapeva perdonarsi di aver lasciato che ci suonassero sopra gli ottoni. La canzone non è neanche male, ma ah, quegli ottoni.
122. Money (That's What I Want) (Janie Bradford / Berry Gordy, incisa in With the Beatles, 1963)
“C'è chi dice, ma i Beatles erano antimaterialisti. Questo è solo un grande mito. Io e John ci sedevamo dicendoci, letteralmente: Adesso scriviamo una piscina". Quando lasciò pubblicare questa cosa sul Rolling Stone (era il 1990), Paul McCartney doveva ancora giustificarsi perché si faceva sponsorizzare un tour dalla Visa. Perché c'è stato un periodo in cui i musicisti si vergognavano dei soldi che facevano, ve lo ricordate? Più o meno tra il 1968 e il 2000 c'è stato un periodo in cui gli artisti, in particolare quelli che avevano lavorato duro per anni per ottenere un po' di successo dovevano poi passare una parte considerevole del loro tempo a difendersi dall'accusa di essersi "venduti" (un'accusa che veniva loro rivolta in particolare da chi comprava i loro dischi, sì, il consumismo al suo apice veniva vissuto con molta ipocrisia). Una che comincia a essere difficile da comprendere oggi, quando sul vassoio sono rimaste soltanto le briciole, nell'era dello swag in cui qualsiasi rapper con le pezze al culo deve fingere di averle firmate Versace; era difficile anche nel 1963, quando la torta era ancora tutta da tagliare e i Beatles letteralmente urlavano: adesso dammi i soldi! mucchi di soldi! è tutto quello che voglio! No, non l'avevano scritta loro, ma lo senti che ci stavano davvero credendo. Il vostro amore non ci paga le bollette, adesso dateci i soldi!
Il capitalismo è la vera musa dei Beatles '63. Non c'è una sola ragazza che si agiti nelle loro canzoni che non sia che una figura mortale dell'unica vera dea riverita dai Quattro: la Fortuna. Non c'è nulla come sentirla girare dalla tua parte, dopo anni di umiliazioni. E non c'è conflitto interiore, non c'è vergogna, non c'è nessun dispositivo morale che impedisca loro di gioire per i soldi che stanno facendo (così velocemente che non li hanno ancora visti, e non sanno nemmeno chi li sta spendendo per loro). Arricchirsi è la rivoluzione, perché dovrebbero vergognarsene? Anzi. Money potrebbe essere il primo brano dei Beatles non ad argomento amoroso, e malgrado non sia firmata da Lennon e McCartney, sembra il più sincero del loro repertorio di allora. È un rock'n'roll rallentato (già nella versione di partenza, di Barrett Strong) particolarmente congeniale a Lennon a cui è chiesto di replicare l'exploit di Twist and Shout: terminare l'album con il sacrificio delle proprie corde vocali. Lennon non si tira indietro e Money diventa uno degli esempi più felici del sentimento panico con cui i Beatles si lasciano possedere dalle energie del r'n'r: specie nel finale, dove urlano come atleti sotto la doccia. Dammi i soldi! Troppo sfacciati? Poche settimane dopo Paul avrebbe sentito l'esigenza di puntualizzare con Can't Buy Me Love che no, tecnicamente i soldi non fanno la felicità. Non convinse nessuno – anzi, cosa c'è di più swag di cominciare un disco cantando: ti comprerò anelli di diamanti, amica, se questo ti fa stare bene? Per quanto l'incisione di Money non sia impeccabile (chitarra e pianoforte non sembrano troppo accordati tra loro) questa è quasi la cover beatlesiana più apprezzata in assoluto – nella classifica generale è la seconda. Esatto, da qui in su troveremo un solo brano non originale. Avete già capito quale.
121. Sun King (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969)
La prendo un po' da lontano, dunque, come forse sapete io vivo in una zona periferica che però per qualche motivo ha deciso di calamitare l'attenzione dei giornalisti, per cui non si perde un'emergenza: terremoti, alluvioni, babygang, meteoriti, e indovinate qual è il primo posto in Emilia dov'è arrivato il coronavirus. Davvero sembra che lo facciamo apposta, comunque eccomi a casa per una settimana, poi per due, e a un certo punto piuttosto di correggere temi mi sono detto: facciamoci una playlist sulle malattie infettive. Ecco, salvo che i cantanti hanno pochissimo da dire sulle malattie, di solito le usano soltanto come metafore per l'amore o per la droga. Canzoni in cui qualcuno ha davvero la febbre, dove la febbre non è una metafora di questo o di quello, me ne vengono in mente pochissime, ma una delle prime che mi viene in mente è Cold Turkey. Che forse è un'intossicazione alimentare e forse è una crisi d'astinenza dall'eroina; forse Lennon aveva paura di parlare dell'eroina in un brano dei Beatles (infatti Paul la rifiutò) e s'inventò la storia sull'intossicazione alimentare; forse Lennon pensava che non sarebbe mai riuscito a vendere una canzone sull'intossicazione alimentare e quindi raccontò in giro che era una canzone sull'eroina. Sia come sia, Cold Turkey è veramente una canzone sullo stare male. Funziona, ti fa sentire il dolore. È anche il motivo per cui non ti viene voglia di sentirla spesso (e Paul preferiva non sentirla proprio). Una caratteristica davvero specifica di Lennon è la schiettezza con cui riesce a comunicarti le sue emozioni/sensazioni, anche le meno socializzabili. Le parole non sono sempre sincere, ma i sentimenti sono radiografati e riprodotti senza nessuna pietà. In You Can't Do That e Run For Your Life tu senti la gelosia, in I'm Only Sleeping senti l'accidia, in I'm So Tired l'ansia da insonnia, e in Sun King, cosa senti in Sun King?
Niente. Non senti niente.
Questa è una canzone sull'eroina.
Dovessi fare una playlist sull'eroina invece avrei solo l'imbarazzo della scelta, vero? Ma in realtà se ci fai caso sono quasi tutte concentrate sui preliminari e sui postumi e su quel disastro che sono gli effetti collaterali individuali e sociali. Così se volessi trovare una canzone che parli esclusivamente della beatitudine da oppiacei, ancora una volta finirei per chiedere a Lennon. Lui non poteva negarci l'evidenza: prima e dopo l'ero è un casino, ma durante si sta bene. Sun King galleggia sul vuoto e se ne frega, non ha niente da dirti che non sia tantopaparazzi miamore chichaferriparasol. Tutti sono felici, tutti stanno ridendo, ecco qui Re Sole, ciao Luigi accomodati su un cuscino, siamo tremila chilometri sopra i tuoi problemi fistolari, l'atterraggio è previsto tra milioni di anni. No, in realtà tra un minuto parte Mean Mr Mustard (i tempi si sono fatti serrati come ai tempi di Revolver, ogni storia per quanto delirante non può superare i due minuti), ma se ci concentriamo io e te secondo me in questo minuto possiamo farlo durare un milione di anni. Proviamo.
Sun King è il primo vero brano che incontriamo tra quelli che compongono il medley finale di Abbey Road. Non è che mi aspettassi qualcosa di diverso – è un brano opaco, e soffre la vicinanza con un'altra creazione lennoniana ed eterea, Because – però a riascoltarla è comunque una composizione affascinante, e tra l'altro una prova di quanto potevano ancora essere affiatati quei Quattro quando finalmente si decidevano a registrare qualcosa. Anche un'inezia, un piccolo delirio con parole a caso, si svela una struttura mirabile dove il contributo misurato di ogni musicista si incastra alla perfezione. Il basso che rimbalza sull'ottava, le chitarre che arpeggiano e fraseggiano in perfetta sincronia, le percussioni accarezzate da Ringo, l'organo e i cori armonizzati, hai la sensazione che possa durare davvero per sempre, e invece no: è già finito.
(Provate ad ascoltare la playlist di questa puntata senza avvertire, alla fine, la necessità fisica di completare l'ascolto con Mean Mr Mustard. Una cosa molto pavloviana).
Nessuno invoca Policarpo
23-02-2020, 01:33dialoghi, Il Post, santiPermalinkVoi siete gente di rango e di gusto, chissà che santi vi appaiono se saltate un pasto. Santi importanti, santi di riguardo: a me capita al massimo San Policarpo (con un grappolo in mano).
"Ehi ciao".
"Ancora tu?"
"Passavo. Vuoi dell'uva?"
 |
| Chiesa di San Policarpo a Roma (quartiere Appio Claudio) |
"Sono allergico, te l'ho detto".
"Ah scusa".
"E poi cosa vuol dire passavo, Policarpo, dov'è che sei diretto che passi sempre da qui".
"Cosa vuol dire allergico?"
"Storia lunga".
"È un problema? Magari ti posso aiutare, sai, io sono un Santo".
"Lo so Policarpo, lo so".
"Ti va un'albicocca?"
"Mi brucia lo stomaco".
"Sei sempre così pallido, secondo me dovresti mangiare più frutta, te lo dico".
"Policarpo, sto lavorando".
"E io no?"
"Cioè il tuo lavoro consisterebbe nel convincermi ad assumere vitamine? te lo contano come miracolo?"
"Non lo so, in confidenza non è che mi abbiano spiegato come funziona".
"Ma come non ti hanno spiegato, scusa. Tu sei San Policarpo".
"Eh lo so".
"Sei uno dei Padri Apostolici".
"Ah sì?"
"Hai ascoltato il Vangelo direttamente dalla bocca di San Giovanni evangelista".
"Ma pensa".
"Te lo ricordi?"
"Ma sì, cioè, insomma, San Giovanni, quel... quel vecchietto".
"Vecchietto?"
"Non era un vecchietto?"
"Dovresti averlo incontrato quando aveva al massimo cinquant'anni".
"Ah sì, certo".
"Ma come fai a esserti dimenticato, Policarpo".
"Che vuoi, sono pur sempre cose successe centinaia e centinaia di anni fa".
"Io pensavo che in paradiso vi ricordaste tutto".
"Non sarebbe più il paradiso, se ci rifletti".
"Sì? Ma insomma non ti hanno spiegato cosa devi fare? Non c'è, che so, Pietro all'ingresso che dà un vademecum".
"Oh, quello".
"Mi sembra di capire che non c'è molta stima".
"Per carità, è davvero un sant'uomo. Ma sempre così indaffarato".
"Eh beh, un ruolo di responsabilità".
 "Tutto il giorno su e giù a sovraintendere, non un attimo di respiro, mi domando come faccia. Sempre gentile, eh? Non si dimentica mai di salutare, buongiorno Policarpo, come va Policarpo, cioè si ricorda persino come mi chiamo".
"Tutto il giorno su e giù a sovraintendere, non un attimo di respiro, mi domando come faccia. Sempre gentile, eh? Non si dimentica mai di salutare, buongiorno Policarpo, come va Policarpo, cioè si ricorda persino come mi chiamo"."Perché gli altri no?"
"Gli altri? Mica tanti".
"Ma San Giovanni?"
"Giovanni quale?"
"Il tuo Giovanni, l'evangelista".
"Per carità, quello non esce mai dal suo ufficio".
"Un ufficio? A farci cosa?"
"Ma la cosa che fanno i santi di solito, come dite qui voi, l'intercessione".
"Cioè esaudisce le preghiere".
"Oddio esaudire è una grossa parola. C'è un... come faccio a spiegarti, c'è questo flusso di richieste che arriva dalla Terra, e il santo le ascolta, fa una specie di cernita, elimina le impresentabili, e le altre le indirizza a un ufficio più in alto, magari con una raccomandazione se pensa che sia veramente il caso. I santi fanno questa cosa, sono degli... degli intermediari, ecco".
"Quindi Giovanni è molto indaffarato perché deve smistare tutte le preghiere che gli rivolgono".
"Esatto".
"E anche Pietro".
"Ma un po' tutti, ti dirò".
"Ma per dire Sant'Ireneo, ce l'hai presente Ireneo".
"Ehm... Ireneo, certo".
"Era di Smirne come te, ha questo ricordo di lui bambino che ti vede nel foro che insegni il Vangelo. Rammenta "la maestà del tuo portamento; la santità della tua continenza", cioè eri una specie di torre di guardia, per lui".
"Eh ma ai bambini facciamo un po' tutti questa impressione".
"Ma voglio dire, Ireneo di Lione ce l'avrà bene un attimo per te, per darti una mano".
"Non lo so, anche con lui bisogna prendere appuntamento".
"Per vedere Ireneo? È così popolare?"
"In un qualche modo sì, c'è un posto nelle Gallie dove è vissuto dopo essere partito da Smirne..."
"Lione".
"Lì c'è ancora una comunità che lo invoca con frequenza, insomma un lavoraccio".
"Mentre tu..."
"Io? Io non mi lamento".
"Comincio a capire.Tu sei sempre qua perché in paradiso ti annoi".
"Ma che dici".
"E ti annoi perché nessuno ti invoca. Gli altri santi hanno tutti le preghiere da smistare. Ma nessuno prega più per Policarpo da Smirne".
"Smirne, già. Che poi alla fine dov'è Smirne? Non mi ricordo più".
"In Turchia".
"Mai sentita".
"Per forza, i turchi sono arrivati secoli dopo, ai tuoi tempi era una provincia dell'Asia Minore di lingua greca".
"Ecco, sì, il greco lo so parlare. Ti va un πορτοκάλ?"
"Adesso si dice arancia. Con la dominazione turca si è imposta la fede musulmana, e così tu, che all'inizio eri uno dei santi più importanti, sei rimasto senza il tuo nocciolo duro di fedeli e adesso ti aggiri smarrito per il cielo senza nessuno che t'invochi, nessuno che ti dia un senso".
"Si dice arancia ma ne ho anche di rosse, e poi ci sono le amare e..."
"E basta con questa manfrina della frutta, ho controllato. Non sei neanche il patrono dei fruttivendoli".
"Ah no?"
"No, probabilmente è un'idea che ti è venuta ragionando sul tuo nome, che in greco vuole appunto dire..."
"Tanti frutti".
"A-bop-bop-a-loom-op a-lop-bop-boom".
"Eh?"
"Scusa, non ho resistito. Vabbe' Policarpo, hai della frutta secca almeno?"
"Noccioline?"
"Sono allergico".
"Pistacchi".
"Vada per i pistacchi".
"Però mi devi promettere che..."
"Uffa Policarpo, eddai, gli altri santi non fanno così".
"...devi scrivermi un pezzo, dai".
"Ma mi piacerebbe, guarda. Però non vorrei fare di te una macchietta".
"Meglio una macchietta che niente".
"Non sono d'accordo".
"Li vuoi tostati i pistacchi".
"Si capisce".
Voi siete gente di un certo livello, chissà che santi in fila al vostro cancello. Io invece ho San Policarpo di Smirne, cui mai nessuno chiede di esaudirne. Ripeto: ho San Policarpo da Smirne, cui mai nessuno chiede di esaudirne.
Ho guardato a ponente, ho guardato a levante: non ho trovato un santo meno interessante. Policarpo, oh carpo. Policarpo, oh carpo. Policarpo, oh carpo. A-bop-bop-a-loom-op a-lop-bop-boom.
Le canzoni dei Beatles (#145-136)
19-02-2020, 21:06beatles, Il Post, musicaPermalinkLa playlist su Spotify.
...Sì scusate, cosa mi era successo? In settembre avevo promesso che avrei messo in fila tutte le 250 canzoni dei Beatles prima del 50esimo anniversario dello scioglimento, e poi? Sono successe tante cose, sapeste, le elezioni in Emilia, Sanremo, comunque tecnicamente i Beatles erano ancora attivi nel 1995, questo mi dà qualche margine. No, scherzo, prometto che la finirò prima. Nel frattempo, tenetevi forte, perché stavolta esce il brano che dà più soddisfazione a chiunque odi i Beatles, cioè... Revolution 9? Sì, esce anche quello (ed era ora). Ma in realtà stavo pensando a...
145. Ob-La-Dì Ob-La-Da (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
 |
| Il testo è agghiacciante |
Peccato che sia una leggenda.
Lo so, tutti i libri la raccontano più o meno così. Del resto tutti i libri si copiano un po' a vicenda (e citano la stessa fonte diretta, Geoff Emerick). Ma provate ad ascoltare la prima versione di Obladì, quella ancora con Scott Emuakpor alle conga. Anzi, fate un esperimento: provate a farla partire nello stesso momento in cui parte la versione del Disco Bianco, quella che sarebbe stata accelerata dopo il provvidenziale intervento di John. Notate qualcosa? La versione definitiva non è più veloce. È più lenta. John non ha accelerato: magari addirittura ha rallentato. Del resto se ci pensate non è mai stato lui l'acceleratore dei Beatles, tutt'altro. Lui di solito le canzoni le portava lente: Ain't She Sweet, Please Please Me, Help!, sono tutti i pezzi che Lennon avrebbe cantato con più calma, se glielo avessero permesso. L'altra cosa che fa Lennon – se davvero è stato lui – è imprimere quel forte taglio in stile ska, quel pianoforte in levare che contraddistingue la canzone e la rende il primo ska bianco inglese (ma non il primo ska europeo: Peppino De Capri era sul pezzo già nel 1966!) Salvo che la volontà di comporre uno ska era già evidente dall'inizio, no? Insomma qualcosa non torna.
Proviamo a ricostruire. Paul potrebbe essere stato affascinato da alcuni aspetti delle culture tropicali, dai ritmi e da una certa cultura del prendi-la-vita-così-come-ti-viene (anni dopo avrebbe scelto inopinatamente di incidere Band on the Run in Nigeria). Ci scrive una canzone, ma gli viene una cosa molto poco caraibica, se non addirittura kinksiana, un bozzetto che sembra preso dal disco mai realizzato sulla vita quotidiana di Liverpool: malgrado il nome questo Desmond ha le stesse aspirazioni tranquille e borghesi del tizio che canta When I Am 64. Di esotico rimane soltanto l'intervento di Scott Emuakpor, ma in questo modo la canzone non funziona, e continua a non funzionare finché John non propone di rallentarla e aggiunge quel caratteristico fraseggio in levare che con cui in passato aveva ridisegnato un altro brano di Paul, She's a Woman. Anche così, il brano continua a non convincere Paul, che qualche giorno dopo si rimette a farlo provare agli altri rischiando un'insurrezione: tanto che alla fine preferirà non correggere nemmeno l'errore dell'ultima strofa, l'inversione dei nomi "Desmond" e "Molly". I suoi interventi successivi dimostrano un senso d'insoddisfazione: il sassofono che suona durante il ritornello una melodia diversa rasenta il sabotaggio, e comunque non smette di suggerirci: guarda che questa canzone potrebbe anche essere diversa, potrebbe essere meno banale. Tanto quanto l'idea di Paul di urlare sopra il ritornello, esecrata da George Martin, e devo confessarlo: sono le due cose che da sempre mi riconciliano con Obladì: il sax che se ne va per i fatti suoi e Paul che urla come se avesse deciso all'improvviso che questa canzoncina è un brano soul. È autoparodico, è un po' patetico, è Paul che cerca di cavare il sangue da una canzone che gli era venuta troppo dolce. Perché poi si fa presto a criticarlo, ma fosse capitato a voi, di scrivere Obladì Obladà, l'avreste buttata via? Certo, rimane uno dei brani dei Beatles più stucchevoli, forse l'unico che preferisco a 45 giri anche se il supporto è un 33: Paul diventa un chipmunk, ma per il resto è davvero più ballabile. I Beatles se ne vergognavano al punto che si rifiutarono di farla uscire come un singolo nei Paesi anglofoni. Andò comunque in testa alla Top 10 del Regno Unito, ma nella versione di un gruppo scozzese, i Marmelade. Anche in Italia uscì una cover, molto probabilmente il momento più basso della traiettoria artistica di Demetrio Stratos.
144. Piggies (George Harrison, The Beatles, 1968).
Hai mai visto i maialini razzolar nel fango? Tutti questi maialini, io non li compiango. In ogni guru c'è un nazista: se gli pungoli il chakra giusto prima o poi salta fuori, ma perché mai vorresti fargli uno scherzo del genere? Non si sveglia l'ariano che dorme. Viene il sospetto che molti se ne rendano conto; che la meditazione e lo zen e tutte le altre liturgie del silenzio non siano che un modo di tacitare il nazista che hanno dentro, di ipnotizzarlo. E se funziona, complimenti. Per me George Harrison resterà sempre l'amabile artista che sopportò le angherie dei colleghi fino alla fine, che non soltanto doveva scriversi le canzoni da solo ma in più casi scrisse anche quelle di Ringo, che invece di invidiare l'amico Eric Clapton per via che era più bravo, gli fece suonare un assolo nella sua canzone migliore (sul serio, ma vi rendete conto?), che organizzò il concerto per il Bangladesh, che finanziò un intero film dei Monty Python soltanto perché aveva voglia di vederlo. Il fatto che mentre dispensava tutto questo bene all'umanità, George Harrison contenesse in sé un misantropo intollerante, me lo rende soltanto più simpatico: perché in realtà ci detestava tutti, George Harrison, con un disprezzo che cominciava a trapelare già nelle sue prime canzoni (Don't Bother Me, Think for Yourself) e che era stato completamente eclissato nel 1967 dalla meditazione trascendentale, che al massimo gli ispirava testi seriosi ma non arroganti, come Within You Without You.
Il nazista interiore però non era morto, e mentre il Guru George proseguiva i suoi trip trascendentali, persino in India riuscì a trovare il modo di sussurrargli quella simpatica canzoncina che è Piggies – l'odio per l'umanità non era mai stato così pucci. Porci a far vite da porci, guardali ogni dove. Puoi vederli fuori a cena con le loro scrofe. Piggies è il ritorno del rimosso, anche da un punto di vista musicale: dopo le sperimentazioni a tutto campo del 1967, proprio durante il soggiorno presso il Maharishi, George si rimette a scrivere strofe e ritornelli di chiara ispirazione occidentale. Nel giro di pochi mesi comporrà tutte le canzoni per cui lo amiamo, da While My Guitar a Something, ma Piggies è un brano a sé: l'unico vero pastiche della sua produzione beatlesiana, perfetto per quella collezione di pastiche che è l'Album Bianco. Si annuncia come una filastrocca, per trasformarsi speditamente in una grottesca partitura per clavicembalo e archi: una soluzione tutt'altro che inedita per i Beatles e in generale per i gruppi che a metà anni Sessanta stavano riscoprendo le orchestrazioni, ma abbastanza nuova per George. Eppure è esattamente quel che gli serve per confinare il suo nazista interiore sul palcoscenico di un teatrino improvvisato. Puoi ascoltare Piggies per centinaia di volte prima di ammettere che sotto la simpatica filastrocca ribolle una fanghiglia inquietante. Il dettaglio più espressionista, ancora una volta, lo aggiunge al volo John Lennon con lo stesso tipico gusto per il grottesco dello sketrch degli spaghetti in Magical Mystery Tour, suggerendo i due versi "con le forchette, i coltelli e il bacon", insomma l'idea che i maialini, oltre ad amare il fango, siano pure cannibali. Piggies potrebbe per qualche verso essere debitore delle filastrocche stralunate incise l'anno prima ad Abbey Road da Syd Barrett per completare il primo disco dei Pink Floyd (a loro volta debitrici degli esperimenti di studio di Lennon), ma allo stesso tempo ha qualcosa che ricorda i Pink Floyd molto più tardi ed espressionisti di The Wall: quelli che il nazista interiore volevano stanarlo, esibirlo, processarlo. George, più modestamente, si limita a metterlo su un palco e si unisce subito al coro che gli fa il verso. Che roba, però. In soli due minuti di un disco pop.
143. Rocky Raccoon (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968)
"Now somewhere in the black hills of Dakota there lived the young boy named Rocky Raccoon..." Quante volte l'ho cantata questa. Davvero. Quando ti porti in gita scolastica gli spartiti dei Beatles succede questa cosa, che dopo qualche Let It Be e Hey Jude d'ordinanza, a un certo punto qualcuno propone Rocky Raccoon ed è fatta, passerai tre giorni a cantare Rocky Raccoon. È vero che la conoscono in tre, ma quei tre si divertono. È facile (quattro accordi!), è buffa, è suggestiva, ti dà una soddisfazione immediata, riesci ad arpeggiarla mentre canti e persino a mimare con la voce l'assolo honky tonk. Con un po' di impegno riesci anche a fare l'introduzione da cowboy – come tante canzoni del Disco Bianco, è facile rendersi conto che è stata composta alla chitarra acustica, in quella specie di gita scolastica per miliardari che fu il viaggio in India dal Maharishi. Dei tanti travestimenti proposti da Paul, quello western dovrebbe essere il meno opportuno e invece è quello che si ricorda con più effetto. In teoria Rocky non è meno inutile di Honey Pie; in teoria i Beatles avrebbero avuto da fare cose più importanti che scenette in costume. Ma Rocky è irresistibile, tutto qui (Honey Pie è resistibilissima). Il nonsense regala a Paul due o tre versi memorabili, ma riesce ancora a contenersi – Il dottore che entra "puzzando di gin" sembra non aver subito chiaro cosa deve stendere sulla tavola, o magari avrebbe voglia di stendersi lui; non è invece affatto chiaro cosa succeda al biblico Gedeone nell'ultima strofa, ma i Beatles ci hanno abituati ad enigmi ben più inquietanti.
142. I Me Mine (Harrison, Let It Be, 1970).
L'ultimo valzer, eccolo qui. Leggerete sui libri che è l'ultimo brano registrato dai Beatles, e l'unico da loro inciso nel 1970. John Lennon si era definitivamente chiamato fuori: I Me Mine fu incisa dai tre superstiti decisi ad aggiungere un brano al disco in uscita che giustificasse una scena del film in cui proprio John accennava un passo di valzer con Yoko Ono. Proprio per questo si potrebbe considerare il primo brano dei Beatles postumi, i Beatles delennonizzati, venticinque anni prima di Free As a Bird e Real Love a cui assomiglia più di quanto siamo disposti a riconoscere, perlomeno come concetto: anche I Me Mine viene registrata partendo da un vecchio nastro scartato, anche se in questo caso era di Harrison e non di Lennon. Anche I Me Mine serve a completare un prodotto audiovisivo, ovvero il film Let It Be, e viene corredata di immagini di repertorio, proprio come Free e Real Love. In un certo senso I Me Mine è perfino più finta, visto che l'originale durava meno di due minuti e fu allungato dal produttore Phil Spector col più sfacciato e disperato degli espedienti: il copia-incolla. Credo che sia evidente a chiunque l'ascolti con un minimo di attenzione: il secondo intermezzo rock è identico al primo, dopo il primo minuto e mezzo la canzone torna sui suoi passi, solo gli archi e gli ottoni aggiunti da Spector suggeriscono uno sviluppo. I Beatles smettono di essere un gruppo che suona e diventano un materiale di archivio che può essere smontato e ricomposto: è davvero la fine.
Più che appropriato che si tratti di un valzer: una cadenza che sin dal suo ingresso nel repertorio dei Beatles (Baby's in Black) aveva portato un sentore di dissoluzione e morte. Altrettanto appropriato che si tratti di un'accigliata riflessione di George Harrison sulla vanità dell'egotismo, riflessione che rischierebbe di sembrare fin troppo seriosa se George non sentisse per primo la necessità di riderci sopra, slittando improvvisamente dal valzer al rock'n'roll: il che gli consente non soltanto di introdurre l'autoparodia (nello stesso senso in cui aveva chiesto di terminare Within You Without You con un coro di risate), ma anche di ricondurre la canzone al senso del progetto Get Back!, il ritorno alle origini. Se Lennon era stato il primo dei Beatles a incontrare sui suoi passi il tre quarti, George era stato il primo a proporre l'eretica idea di slittare dai quattro ai tre quarti in una canzone, e non in una canzone qualsiasi, ma We Can Work It Out (anche in quel caso, il valzer aggiungeva un imprevisto rintocco funebre alle riflessioni di John: "life is very short"...) Il brano in realtà era stato uno dei tanti proposti da George nel 1969 e boicottati da Paul e soprattutto da John. Eppure se alla fine I Me Mine divenne una canzone dei Beatles fu proprio in virtù della reazione beffarda di John, che sentendo i tre quarti si era messo a volteggiare nella sala di registrazione con Yoko, ripreso dal regista. E fu così un brano che a John non piaceva, e che John non aveva mai suonato finì in Let It Be, soltanto per consentirci di vedere John nel suo ultimo siparietto. Di me, di me, di me, si parla solo di me.
141. I Wanna Be Your Man (Lennon-McCartney, With the Beatles, 1963).
| I Rolling Stones nel 1964, e altri ortaggi |
In ogni caso per gli Stones fu il decollo: non potevano saperlo, ma Lennon e McCartney si erano appena procurati i rivali più insidiosi, se non da un punto di vista commerciale almeno sul piano dell'immagine: di lì a poco gli Stones sarebbero stati accreditati dalla stampa come gli antibeatles, i poli contrari di una serie di contrapposizioni arbitrarie ma efficaci. Gli Stones erano i cattivi, rispetto ai Beatles gentili e rassicuranti: se questi ultimi cercavano di dare l'immagine più pulita, gli Stones erano accusati di non lavarsi: ma allo stesso tempo gli Stones erano percepiti come più raffinati, di nicchia, e senz'altro prediletti dalla Londra più modaiola, mentre i Beatles restavano un prodotto pop di massa per i proletari del Nord (e del Midwest). E mentre i Beatles si tenevano stretti il loro zoccolo duro di fan di sesso femminile, gli Stones furono il primo gruppo a suonare davanti a file di ascoltatori maschi.
Tutto questo, di lì a pochi mesi: nel settembre del 1963 per gli Stones un brano di Lennon e McCartney era manna dal cielo, e pazienza se si trattava di un brano originariamente pensato per le limitate capacità vocali di Ringo Starr. L'idea iniziale era sostituire l'antico cavallo di battaglia del batterista, dai tempi degli Hurricanes, Boys, con un brano altrettanto energico e meno sessualmente ambiguo. Boys era un brano teenpop americano, in originale cantato da una ragazza e rivolto alle ragazze: I Wanna Be Your Man è un affermazione perentoria di virilità sin dal titolo (con quell'americanismo, "wanna", un vezzo da vecchio bluesman o da cowboy). Ringo e Mick non vogliono più stringerti la mano o fissarti negli occhi o rivelarti un segreto od offrirti la loro fiducia: vogliono essere i tuoi uomini baby, vogliono essere i tuoi... amanti! E poi basta, il testo è semplicissimo perché Ringo dietro a piatti e tamburi aveva ben altre preoccupazioni che ricordarsi un testo a memoria, e poi si sa che i duri parlano giusto l'essenziale.
Il brano non riuscì a sostituire Boys, che continuò a resistere nelle esibizioni dal vivo: forse perché era più alla portata di Ringo, ma più facilmente perché tutto questo machismo non si addiceva al suo personaggio. Che è anche il motivo per cui I Wanna è la meno ringhiana delle sue canzoni: la sua voce di solito così inconfondibile è raddoppiata o triplicata da John e Paul, molto più entusiasti: il secondo si mette persino ad abbaiare nel finale. Un assolo brutale e arrogante, urla da spogliatoio, è proprio una cosa da ragazzi. Ma ecco, i ragazzi preferivano ascoltare i Rolling Stones. I Beatles invece erano roba da femmine. Riascoltandoli, non sembra difficile capire chi avesse più gusto nel 1963. Magari nel 1969 no, ma nel 1963 le ragazze avevano decisamente ragione, e l'avrebbero avuta ancora per parecchio. Che vergogna.
140. Baby's in Black (Lennon-McCartney, Beatles for Sale, 1964).
 |
| Astrid Kirchher e Stuart Sutcliffe |
Sono i brani in cui Lennon prende le distanze dalla beatlemania e comincia a lavorare consapevolmente a un personaggio meno superficiale. Ma se No Reply e I'm a Loser sono due tentativi più che convincenti, Baby's in Black è il passo più lungo della gamba: invece di dilungarsi ulteriormente sulle sue frustrazioni di maschio non sempre corrisposto, John vuole parlarci dell'elaborazione del lutto e... non ne è ancora capace. La ragazza potrebbe davvero essere Astrid Kirchherr, che amava vestire in nero ancor prima di perdere il suo fidanzato Stu Sutcliffe, compagno di liceo artistico di John, pittore molto promettente e improbabile contrabbassista dei Beatles ai tempi di Amburgo. La Kirchherr a Berlino aveva trasformato i rockabilly di Liverpool in un quintetto di esistenzialisti in frangetta e vestito nero regolamentare. Uno stile che era una completa rottura rispetto agli anni Cinquanta, a cui i Beatles continuavano a essere affezionati (vedi la copertina di With the Beatles) anche se non avevano ancora composto un genere di musica che la giustificasse. Per ritrarre il lutto di Astrid, John avrebbe bisogno di una tavolozza che nel 1964 semplicemente non possiede: ha in mano solo un pennarello di grana grossa con la quale abbozzare due rime abbastanza banali: what can I do? Baby's in black, and I'm feeling blue. I tre quarti sarebbero anche una scelta interessante, ma Lennon non riesce a rallentare quanto vorrebbe e invece di un valzer funebre gli esce un liscio da balera. Cosa posso fare? Gli immaginiamo sul volto la smorfia d'ordinanza dei nostri amici ai funerali. Lennon ha passato tutta la sua vita a scansare la morte ostentando indifferenza. Quando Jann S. Wenner per il Rolling Stone gli chiese: come hai reagito alla morte del tuo manager, Brian Epstein?, lui diede quella disarmante risposta che da quel momento rintocca funebre nella testa di tutti i lennonologi:
Mi sono sentito come ci si sente quando ti muore qualcuno vicino. C'è una specie di risolino isterico, ih ih, sono felice che non sia toccato a me, quel buffo sentimento quando muore qualcuno vicino a te. Non so se ti è mai capitato, ma intorno a me sono morte molte persone, e l'altro sentimento che provi in questi casi: è "cosa cazzo...? cosa ci posso fare?".
"What can I do?" Il piccolo John aveva perso il padre, ma poi un giorno era tornato. Poi aveva perso la madre, ma poi un giorno era tornata. Poi la madre se n'era andata e stavolta non tornava più. Poi se n'era andato anche Stu, il suo amico pittore. E Astrid ancora lo aspettava, ad Amburgo, e io cosa posso fare? Niente, John, non puoi farci niente. E nessuna canzone può cambiare le cose.
139. Revolution 9 (Lennon-McCartney, con la collaborazione non accreditata ma non trascurabile di Yoko Ono, The Beatles, 1968).
Numero nove, numero nove. Finalmente ci siamo. Un po' di rumore montato a caso, dicevamo – no, sul serio, dobbiamo parlarne seriamente? Questa è una classifica di canzoni, Revolution 9 risponde al criterio "canzone" dei Beatles unicamente perché uno dei Quattro si impuntò per inserirla nella scaletta di un album, dove occupa un'oscena quantità di tempo – tempo che poteva essere impiegato con Child of Nature, o Not Guilty, o qualsiasi altro brano che avrebbe reso il Disco Bianco il più grande disco doppio della storia della musica leggera; e invece verso la fine c'è questa lunga sequenza di registrazioni (per lo più prese da brani di musica classica destrutturati, con lacerti di dialoghi tra John Yoko e qualcun altro). Quasi nessuno l'ascolta per intero – compreso i critici, sospetto, tra cui quelli di Mojo, che sono comunque riusciti a far salire Revolution 9 quasi a metà classifica, ebbene sì, per questi esperti di musica metà del repertorio dei Beatles è inferiore a un po' di rumore montato a caso, e voi cosa aspettate? Uscite a registrare gli affanni delle automobili nel traffico, entro sera potreste aver prodotto un brano superiore a un terzo della discografia dei Beatles, eh, ma non è così che funziona, vero?
E come funziona?
La reazione tipica del visitatore tipico di una mostra d'avanguardia è: questo avrei potuto farlo anch'io. L'arte d'avanguardia consiste, più che nelle opere, nelle implicite risposte a questa domanda. In troppi casi la risposta è: già, però non l'hai fatto. Potevi pensarci prima. Ora è troppo tardi, l'avanguardia appunto consiste nell'arrivare per primi. È il catalogo di tutte le cose che potrebbe fare una persona se solo ci pensasse, per fortuna che di solito non ci pensa: quelli che ci pensano fanno gli artisti e non è sempre chiaro di cosa campino. Quando vai a una mostra non sai mai cosa aspettarti: masticheranno uova per poi sputartele addosso? Spiegheranno la filosofia a una lepre morta? Si faranno montare nella faccia delle protesi a forma di corna perché sì? In ogni caso potevi pensarci prima di loro: non l'hai fatto, paga il biglietto.
Quel mi fa rabbia di Revolution 9 (una rabbia che molti ascoltatori, temo, tendono a trasferire su Yoko Ono), è che Lennon mi sta prendendo in giro. Ci crede meno di me. Davvero ti piacciono i Beatles, ti sta chiedendo? Perché per me dopotutto sono una merda – oh sì, li ho fondati, e ci ho fatto anche parecchi soldi, ma se mi va posso scioglierli anche stasera. Non me ne frega un cazzo, hai capito? Ti piacciono i Beatles? Quattro scemi ancora dietro al rock'n'roll nel 1968? Perdio, ma cresci.
Tra i pochi concetti estetici che ho trattenuto dai miei studi universitari c'è la differenza tra arte sperimentale e arte d'avanguardia, che è una specie di trasferimento sul piano estetico dell'eterna lotta tra progressismo e massimalismo. E così come in politica molto spesso i massimalisti finiscono male ma vengono poi ritratti nei monumenti che i progressisti fanno costruire quando vanno al potere, così nella Storia dell'Arte quando arrivi negli ultimi capitoli trovi un sacco di riferimenti alle Avanguardie – ma il libro che stai leggendo, proprio quello, è stato impaginato e realizzato grazie alle innovazioni di artisti più sperimentali che avanguardisti. (Tutti dicono futurismo futurismo, ma vogliono quello simpatico e industriale di Depero e dei cataloghi Campari, non quello esplosivo e frastornante di Marinetti. Tutti vogliono il Dada purché sia un simpatico oggetto di arredo, quando dicono Dada pensano alle simpatiche manine di Max Ernst, gli inquietanti nonsense di Tzara non li vuole più ascoltare nessuno). E allora che ci fa un grande sperimentatore come John Lennon tra gli avanguardisti? Perché ci hai tradito così, John?
Sperimentare significa, banalmente, cercare di portare nel tuo campo qualcosa di nuovo: allargarlo. I Beatles sono sempre stati sperimentali, anche perché sono partiti praticamente da zero: o si allargava il campo o si soffocava. Sono nati sperimentali e si sono sciolti perché a furia di sperimentare non riuscivano più a riconoscersi e andare d'accordo. I primi a portare il teenpop americano negli UK, e a cantarlo con voci maschili. I primi a pettinarsi in un certo modo, i primi a scriversi canzoni da soli, i primi a mescolare i generi, i primi a incidere solchi al contrario, i primi a usare certi pedali, certi effetti, ecc. ecc. Non sempre i primissimi, ma quasi sempre tra i primi. Non c'è un album che non includa uno strumento in più, un accordo mai usato prima, un genere che fino a quel momento non sapevano suonare. È quello che rende i Beatles unici o comunque molto rari: suonare per loro significa sempre imparare a suonare, più o meno da autodidatti; ogni canzone è un esperimento e non sono tutti riusciti, anche quello è il bello.
L'avanguardia è un'altra cosa: non si pone il problema di allargare il campo, ma di chiuderlo, in un certo senso esaurirlo. Il pitale di Duchamp non è un'evoluzione della scultura, ma è un tentativo di mettere la parola fine al concetto di arte museale e di arte da collezione. Altri artisti, sperimentando, erano arrivati a produrre opere che lasciavano perplessi gli spettatori, ma che comunque venivano apprezzate dai critici e cominciavano anche a essere valutate dagli estimatori, con la conseguente deriva speculativa. Perché il problema non è soltanto che Picasso si fosse messo a dipingere i due occhi da una parte del naso: il punto è che queste cose Picasso cominciava a venderle bene. A quel punto arriva Duchamp e si pone il problema: ma davvero i critici hanno capito queste opere, le intenzioni sperimentali dell'autore ammesso che ne abbia o non stia soltanto facendo le facce a forma di cubo perché le fa già Picasso e funziona? davvero i collezionisti le stanno comprando perché ne condividono lo stile sperimentale? Non sarà soltanto una moda, una bolla, non si staranno tutti fidando dell'aura dell'artista, della sua firma, del brand? E se io, a questo punto, che possiedo la mia firma d'artista, il mio brand, decidessi di esporre un pisciatoio, cosa direbbero i critici? Sarebbero costretti a incensare anche me? Qualcuno se lo comprerebbe? Per quanti anni il museo si sentirebbe costretto a esporre il mio "object trouvé"? L'avanguardia va oltre la sperimentazione, è un insomma un metadiscorso al quale ogni tanto tutti dovremmo dedicarci: ha senso quel che stiamo facendo? La sperimentazione è un modo di evolversi, di trasformare l'arte in Storia dell'arte; l'avanguardia è un modo di astrarsi, e di domandarsi se quella Storia per caso non sia già finita o non sia da stracciare e ricominciare da capo. In questo senso, soltanto in questo senso, l'Avanguardia è antistorica, ovvero non si evolve: ogni strappo, ogni rottura, ogni desacralizzazione è definitiva e quindi non ha nemmeno senso prendersela se gli avanguardisti di oggi non hanno molte idee in più di quelle di ieri (i critici obietteranno ma hanno i loro libri da vendere). Perché in effetti il Fontana che sfregia la tela, il Manzoni che caga nel barattolo, il Banksy che distrugge il suo quadro con un telecomando dopo l'asta, o un Cattelan che espone una banana, non ci dicono molto di più di Duchamp e non è nemmeno previsto che lo facciano: semplicemente ci ricordano che è tutta una farsa e che qualcuno si sta prendendo troppo sul serio. La stessa cosa decide di fare John Lennon con Revolution 9 e questo ovviamente mi disturba. Non dovrei? Perché in effetti ho un'età. Tutti questi anni ho studiato per ridurmi a scrivere trecento pagine in onore di un gruppo pop-rock del secolo scorso che ha suonato otto anni e poi si è sciolto e mezzo secolo dopo milioni di persone in tutto il mondo non si danno pace? Davvero: non ho nient'altro di meglio da fare?
Ovviamente da un punto di vista psicanalitico sarà abbastanza facile trovare qualcosa di irrisolto nell'avanguardista: molto spesso sarà un bambino che non sopporta l'arte degli adulti perché non la capisce. Come c'è qualcosa di represso nell'artista sperimentale, nella maggior parte dei casi un giovane adulto convinto che la macchina sferragliante ereditata dai genitori si possa ancora aggiustare cambiando magari qualche pezzo. A me piacciono i Beatles perché sono sperimentali: invece Yoko Ono fa avanguardia e posso capirne la necessità, ma non posso far finta che mi piaccia o anche solo che m'interessi, non scrivo mica su Mojo. Piuttosto di ascoltarmi Revolution 9 mi riascolto di nuovo Obladì Obladà accelerata a 45 giri, che mi fa ridere.
138. Any Time at All (Lennon-McCartney, A Hard Day's Night, 1964)
In qualsiasi momento, tu basta che mi chiami e sarò lì. Adesso, davvero, secondo voi quante canzoni hanno scritto Lennon e McCartney nel 1964? Sparate un numero... intanto io ho fatto il conto: ventiquattro. Due al mese. E come hanno fatto? Beh, possiamo continuare a ripeterci che sono due geni incomparabili e arrenderci al mistero. Oppure dare un'occhiata un po' più da vicino e scoprire che a volte anche loro dovevano ricucinare la stessa canzone, magari cambiando un po' i condimenti ma nemmeno così tanto. Per esempio Any Time at All, nel terzo disco, è per ammissione di Lennon una rifrittura di It Won't Be Long, la hit mancata del disco precedente. La progressione armonica, almeno, è molto simile: invece i versi dimostrano un gigantesco passo avanti. It Won't Be Long era stato l'ultimo vero brano yeh-yeh, quasi un'autoparodia o comunque un esperimento abbastanza audace: vediamo quanti "yeh" riusciamo a infilare in una canzone, vediamo se le vendite sono davvero proporzionali al numero di "yeh". Ma persino all'apice della beatlemania, quando qualsiasi canzone sembrava miracolosamente funzionare, a un certo punto era stato chiaro che It Won't Be Long non stava funzionando come gli altri brani infiocchettati di "yeh". Non fu nemmeno scelta come singolo. A questo punto John potrebbe essersi rimproverato di aver affondato una buona canzone, caricandola di "yeh" fino all'inverosimile. E se c'era una cosa che John detestava era sprecare le canzoni, quindi riecco in A Hard Day's lo stesso non banale giro armonico, senza più "yeh" e con contenuti completamente diversi: in luogo del machismo fatalista di It Won't Be Long, un rapporto paritario e basato sulla disponibilità, già prefigurato in All I've Got to Do e ruotante intorno a una parola centrale: "sympathize". John Lennon non ne ha la minima idea, ma sta scrivendo l'inno di un esercito che ancora non esiste, e che di lì a una generazione sarà legione: i friendzonati, i servi della gleba, i ragazzi che se hai bisogno di una spalla da piangere, o anche due, chiamami a qualsiasi ora io ci sono. Detto questo, è impossibile canticchiare Any Time at All senza cedere all'impulso di mixarla con It Won't Be Long e coi suoi "yeh" ossessivi. In fondo la prima canzone è la cattiva coscienza della seconda: l'uomo in ginocchio che canta "if you're feeling sorry and sad I'd really sympathize" sotto sotto sta pensando: "non ci vorrà molto (yeah! yeah! yeah!)... prima che sarò tuo. Yeah! Yeah! Yeah!
137. Good Day Sunshine (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).
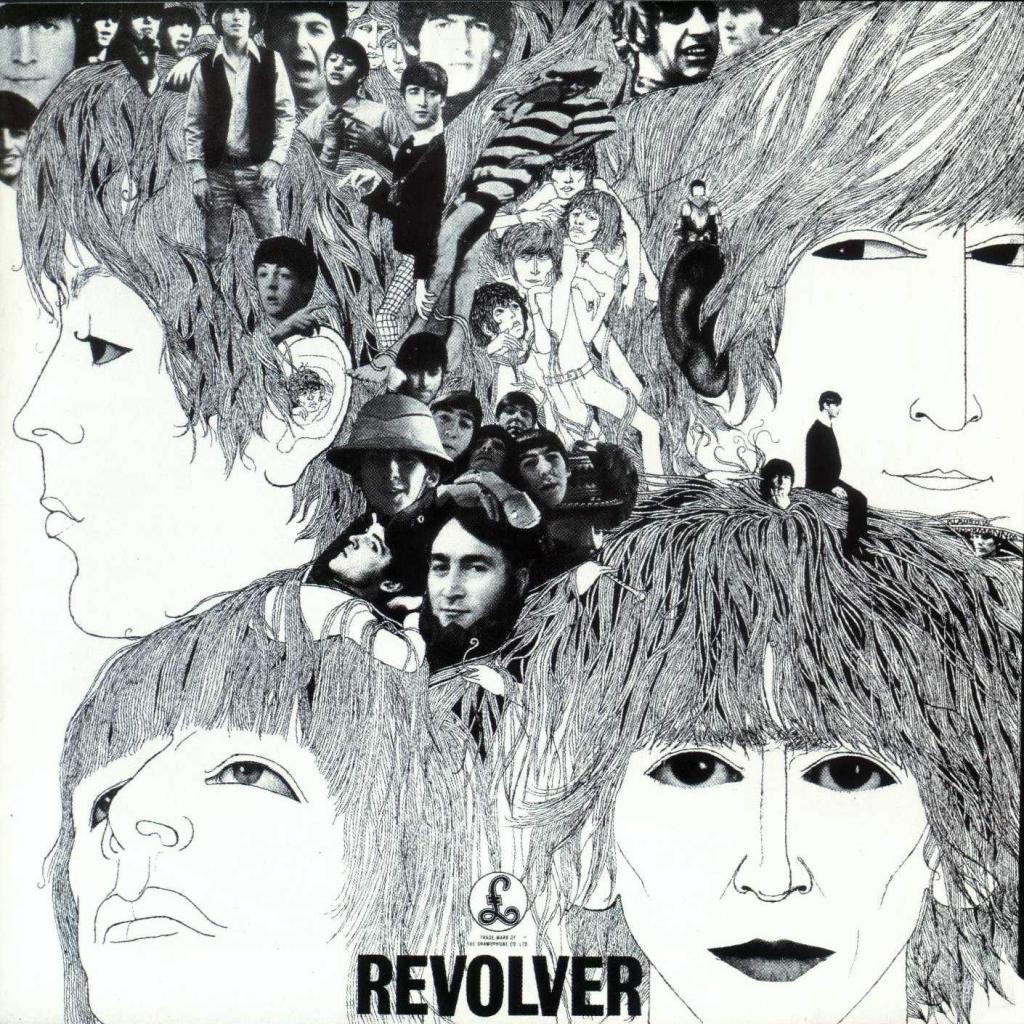 Ci siamo arrivati. Risalendo dal basso, siamo arrivati al primo brano di Revolver, l'album del 1966 che tradizionalmente si gioca con Sgt Pepper il controverso titolo di miglior disco dei Beatles. (Lo so che c'è chi preferisce Abbey Road o persino il Bianco, ma lo avete notato? Ci siamo già lasciati dietro parecchie canzoni dell'uno e dell'altro. Di Sgt Pepper invece fin qui nessuna traccia). Good Day Sunshine inaugura con contagiosa allegria il secondo lato di Revolver (dopo che il primo si era chiuso coi funebri presagi di She Said She Said, per inciso: un'altra canzone che flirta con la morte e coi tre quarti). Se vi sembra strano incontrarla così in basso, e soprattutto incontrarla per prima, dovete prendervela coi critici di Vulture che la odiavano al punto di inserirla al duecentrotredicesimo posto in una classifica di 213 brani dei Beatles. Un giudizio così drastico, va detto, non è condiviso dagli altri compilatori: Ultimate Rock la inserisce tranquillamente a metà classifica, Rolling Stone all'89esima posizione, insomma è uno dei casi in cui la bassa posizione di una canzone dipende unicamente dall'idiosincrasia di un critico.
Ci siamo arrivati. Risalendo dal basso, siamo arrivati al primo brano di Revolver, l'album del 1966 che tradizionalmente si gioca con Sgt Pepper il controverso titolo di miglior disco dei Beatles. (Lo so che c'è chi preferisce Abbey Road o persino il Bianco, ma lo avete notato? Ci siamo già lasciati dietro parecchie canzoni dell'uno e dell'altro. Di Sgt Pepper invece fin qui nessuna traccia). Good Day Sunshine inaugura con contagiosa allegria il secondo lato di Revolver (dopo che il primo si era chiuso coi funebri presagi di She Said She Said, per inciso: un'altra canzone che flirta con la morte e coi tre quarti). Se vi sembra strano incontrarla così in basso, e soprattutto incontrarla per prima, dovete prendervela coi critici di Vulture che la odiavano al punto di inserirla al duecentrotredicesimo posto in una classifica di 213 brani dei Beatles. Un giudizio così drastico, va detto, non è condiviso dagli altri compilatori: Ultimate Rock la inserisce tranquillamente a metà classifica, Rolling Stone all'89esima posizione, insomma è uno dei casi in cui la bassa posizione di una canzone dipende unicamente dall'idiosincrasia di un critico.Succede di solito alle canzoni di Paul. O le ami o le odi, si dice, ma non è vero. Paul gioca spesso, è il suo modo di comporre. Salvo che non sempre hai voglia di stare al suo gioco. A volte non capisci le regole, a volte le capisci ma non ti sembrano interessanti, a volte ti annoi davanti alla lista dei personaggi, il che succedeva spesso a John: chi è questa Rita, chi è Desmond, chi Molly, perché dovrebbe fregarmi qualcosa di loro? A volte invece il gioco sembra divertente e lo accetti, ma davvero è una cosa molto soggettiva, per dire a me piace Rocky Raccoon e detesto Honey Pie, ma capisco che per alcuni possa essere l'esatto contrario. E Good Day Sunshine? Non mi ha mai dato nessun fastidio, davvero. Non capisco come Vulture possa dire che rovina Revolver: mi sembra anzi un'ottima scelta per cominciare il lato B su una nota positiva. È un brano autoperformativo: non solo parla di quanto sia bella una giornata di sole, ma vuole essere quella giornata di sole. Ho sempre trovato brillante il gioco che fa Paul intorno al solito giro di Do, nella strofa, mentre mi ha sempre lasciato perplesso il ritornello, un po' irrisolto, anche se credo che subisca l'influsso della musica indiana ed è uno dei primi tentativi di Paul di introdurre in una canzone un raga (senza che si senta troppo odore di spezie, come nei contemporanei esperimenti di George). Ma in effetti ripensandoci ha proprio un senso questo ritornello inusuale, lievemente ipnotico, come una preghiere al dio Sole. Ok, non è un capolavoro. Forse è davvero la traccia più debole di Revolver, ma al 213esimo posto, davvero? Cento posizioni sopra il collage di rumori a caso? Siamo seri, su.
136. She's a Woman (Lennon-McCartney; lato B del singolo I Feel Fine, 1964).
 |
| Dal paesello ci verrai tu (Jane Asher nel 1963). |
Con questo brano, caratterizzato da una secca spennata in levare di Lennon che era piuttosto inusuale per i tempi, Paul pensava di avere trovato il singolo per il Natale 1964: finché Lennon non si inventò I Feel Fine, che parte in fondo dalle stesse premesse di She's a Woman: una strofa blues corretta da un bridge più pop, un testo maschilista e possessivo e allegramente materialista che dà forma ancor meglio di She's a Woman alle gioie della vita di coppia, vere o presunte che fossero ("her baby buys her things, you know, he buys her diamond rings"). È l'ultima volta che Paul perderà il derby per il singolo contro il collega: a partire dal 1965 e praticamente fino alla fine non sbaglierà più un colpo. We Can Work It Out segnerà il sorpasso sulla Day Tripper lennoniana, Paperback Writer manterrà il distacco su Rain, Penny Lane non eclisserà Strawberry Fields, ma Hello Goodbye, Lady Madonna, Hey Jude sanciranno una posizione di preminenza che John non riuscirà più nemmeno a contestare: dal 1965 Paul è l'uomo dei singoli. Nel frattempo Jane Asher lo aveva lasciato ma ehi, non si può sempre avere quello che si vuole, cantava il tizio.
Le canzoni dei Beatles (#155-146)
05-01-2020, 22:00beatles, Il Post, musicaPermalinkLa playlist su Spotify.
(Cinquant'anni fa i Beatles erano già abbastanza convinti di essere sciolti, anche se il pubblico non lo sapeva (ma sospettava). Cinquant'anni dopo continua la nostra carrellata con dieci pezzi di metà classifica abbastanza brevi che non potrebbero essere più diversi tra loro. C'è il manifesto del rock'n'roll e il canto del cigno del foxtrot; la prima traccia fantasma della storia della musica, e quello che poteva essere il primo vagito del funky (sommerso in una canzone sull'amore dei macachi). C'è la canzone che John Lennon odiava di più, tra quelle che aveva scritto John Lennon, ma anche una delle sue canzoni preferite (l'aveva scritta Smokey Robinson). C'è un passaggio dal maggiore al minore che avrebbe intrigato Sigmund Freud, e tante altre illuminazioni improvvise.
155. Rock and Roll Music (Chuck Berry; incisa in Beatles For Sale, 1964).
Dev'essere rock and roll, se vuoi ballarlo con me. Se Little Richard è il dio del r'n'r, Chuck Berry è il profeta; e come spesso capita ai profeti, ha più parole del necessario. Non ho veramente voglia di controllare, ma sospetto che il testo di una canzone media di Chuck Berry contenga quattro volte il numero di parole di una canzone media di Lennon e McCartney. Questo spiegherebbe in parte come mai i Beatles in tre dischi non avessero ancora inciso un suo pezzo: chi vuoi che si ricordasse tutto il testo a memoria? (Però Johnny B. Goode dal vivo la suonavano, e anche Memphis e Carol). Per di più sono testi complicati, perché l'ex barbiere di Memphis aveva una passione per gli incastri di parole ricercate e per esempio in Rock and Roll fa rimare "jamboree" con "jubilee" (ma anche "modern jazz" con "too darn fast"). Più in generale: i Beatles cercano nel rock'n'roll l'energia pura, l'urlo primordiale, qualcosa che è molto più facile ritrovare in Little Richard o persino in Larry Williams. Chuck Berry è tutta un'altra idea di rock and roll, meno lirica e più narrativa. Dopodiché è pur sempre r'n'r, il meglio che puoi registrare in mancanza di meglio, e così il 18 ottobre del 1964, durante una sessione fiume di dieci ore, dedicarono una manciata di minuti a Rock and Roll Music. Lennon la canta alla Lennon, cioè senza risparmio di corde vocali: ed è l'unica sostanziale differenza tra la versione beatle e quella originale. Al piano c'è un personaggio misterioso: nelle note del disco Derek Taylor sosteneva che fosse suonato a sei mani da John, Paul e George Martin, un'idea divertente che nella realtà avrebbe portato a un risultato mostruoso (se non è un modo garbato per suggerire che Martin abbia sovrainciso la traccia). Secondo Geoff Emerick era Paul McCartney, mentre George suonava il basso. È triste dover diffidare di Emerick, ma è anche difficile pensare che Paul nel 1964 si trovasse già tanto a suo agio con un pianoforte.
154. Honey Pie (Lennon/McCartney, The Beatles, 1968).
"I like this hot kind of music..." I Beatles sono il Titanic, il Disco Bianco è l'iceberg, Paul è il cantante dell'orchestrina. È come se alla fine di una festa non riuscita, nello scazzo generale, me lo vedessi arrivare bello lucido nella sua paglietta anni Dieci tirata fuori dall'armadio dei travestimenti e pronto a intrattenere un pubblico che non gli ha chiesto niente. O di sicuro non gli ha chiesto Honey Pie. Non vien voglia di afferrare con due mani quella paglietta e sfondargliela sulla testa, non vedi che stiamo per affogare, ti sembra il momento? Sei un Beatle, non un pagliaccio. O credevi che le due cose potessero stare assieme? maledizione, no.
Vedi come almeno per me è impossibile ascoltare le canzoni dei Beatles come se fossero semplicemente canzoni e non sequenze di una storia che procede verso la tragedia. Honey Pie in sé alla fine non ha nulla che non vada. Può anche darsi che Paul scrivendola stesse intercettando un certo spirito dei tempi, quel gusto per il vintage che era nato un paio d'anni prima tra Portobello e Carnaby Street. Riflettendoci, tutto il concetto di Sgt Pepper, l'idea carnevalesca di travestirsi da genitori di sé stessi (in un mondo parallelo e colorato in cui non è mai scoppiata la guerra) era venuta a Paul nel 1967: lo stesso anno in cui la Nuova Hollywood faceva le prove generali, e le faceva tuffandosi nel vintage con Bonnie and Clyde. Insomma se calata in un contesto preciso, l'ossessione rétro di McCartney ha anche un senso commerciale: non era soltanto lui a guardare indietro, c'era c'era una nuova sensibilità per questo tipo di cose. C'era mercato per un'idea del passato ormai depurata dalla nostalgia, ridotta uno sfondo fantastico, depurata dal rimosso conflitto mondiale. Honey Pie potrebbe davvero quel tipo di canzone che negli anni Settanta sbucava da un film in costume con Paul Newman o Robert Redford, e se fosse così probabilmente l'ascolterei con piacere, ah ah, vecchio Paul, sei così avanti anche quando guardi indietro. Persino se l'avessero incisa gli stessi Beatles, ma magari in Sgt Pepper's, al posto di When I'm 64 – non avrei nulla da eccepire, davvero, mi sta simpatica When I'm 64.
Ma il contesto è tutto. Quando provava When I'm 64 con la banda Paul stava ancora sperimentando, cercando di capire fino a che punto si poteva spingere. Con Honey Pie non sperimenta più, sta controllando il territorio. È come se stesse piantando una bandierina, una cosa puerile anche quando la fanno i generali: John fa la musica concreta? Io faccio foxtrot, toh. È l'annuncio della fine dei Beatles, che anche quando suonavano male suonavano come i Beatles, mentre in Honey Pie suonano... professionali. È il momento in cui la maschera diventa più importante del personaggio, il che forse consente a John di rilassarsi e incidere il suo migliore assolo di chitarra – per poi magari chiedersi: ma io voglio davvero diventare un turnista di Paul? Finché non ne troverà uno migliore? E senz'altro prima o poi lo avrebbe trovato.
153. Tell Me Why (Lennon/McCartney, A Hard Day's Night, 1964).
"C'era bisogno di un'altra canzone, così l'ho scritta". Perché piangi? Perché mi dici le bugie? A Hard Day's Night è un giorno vissuto talmente di corsa che è diventato notte in un istante. La Beatlemania gira così veloce che non c'è letteralmente tempo di capire cosa si sta scrivendo – tanto alla fine funziona tutto. Tanta è la fretta che in Tell Me Why i Beatles a momenti si dimenticano del bridge, che arriva in coda dopo due strofe quando ormai non lo aspettava nessuno, come l'ultimo a salire su un treno in corsa. È una canzone arrabbiata? È una canzone frustrata ? Probabilmente sì, nelle intenzioni, ma Lennon non ha ancora capito come si comunichino rabbia e frustrazione: la progressione è una cavalcata persino più rapida del solito, John si mette in bocca frasi come "Tutto quello che posso fare è tenermi la testa e mugugnare" ma le canta sbarazzino come se stesse invitando una ragazza a ballare. È chiaro che non vuole essere né allegro né lamentoso – non stavolta almeno – è chiaro che sta cercando da qualche parte un colore che sulla sua tavolozza ancora non c'è: il colore della rabbia. Ma è anche abbastanza chiaro che stavolta non lo trova, e finisce per consegnare ai solchi l'ennesimo numero yeah-yeah, in cui i tormenti del fidanzato offeso (è qualcosa che ho fatto o che ho detto? dimmi cos'è e mi scuso subito!) hanno le stesse movenze ipercinetiche delle cerimonie del corteggiamento. Un brano che poteva benissimo finire sul disco più festaiolo dei Beach Boys senza che nessuno facesse caso alla sostanza rancorosa del testo – del resto chi li ascoltava i testi nel 1964? persino John non aveva ancora iniziato ad ascoltare sé stesso.
152. You Really Got a Hold On Me (Smokey Robinson, incisa in With the Beatles, 1964).
Tu hai veramente presa su di me. Quando la intona Lennon, a inizio 1969, durante una delle session filmate del progetto Get Back!, sono passati appena cinque anni – a noi che guardiamo sembrano venti. I Beatles hanno smesso da così tanto tempo di essere la boy-band che setaccia i dischi di Smokey Robinson alla ricerca di pezzi da copiare, che sembra incredibile che Harrison e McCartney si ricordino ancora di questa vecchia canzone, che seguano Lennon al volo. Purtroppo la Apple Corps ha appena bloccato il video su Youtube, ma è un momento commovente – si vede dalle espressioni dei volti che You Really Got a Hold era stata importante per loro, forse in qualche misterioso modo che non sappiamo e a questo punto non sapremo mai. Da quel tumultuoso 1964 i Beatles si sono reinventati più e più volte, hanno cambiato faccia e strumenti e attraversato vittoriosi la psichedelia e il vaudeville. Ora sono veri musicisti, e anche compositori, e profeti: ma la gioia di cantare Smokey Robinson – senza copiarlo, per una volta, ma di riprenderlo e riuscire a farlo suonare più fresco dell'originale – quella l'hanno dovuta perdere per strada, quella non torna più. (Molti anni dopo George Harrison citerà di nuovo il titolo in Fab).
(Questo mi è riuscito un po' corto? No, sono gli altri che stanno diventando troppo lunghi, finirò lo spazio così. Si può finire lo spazio sul Post? Non vorrei essere il primo che lo scopre. Finirà che i primi venti pezzi me li sbrigo in tre righe, vi immaginate? Questa è Yesterday, bella melodia, un tizio sostiene che è copiata da una romanza napoletana, lo stesso McCartney la notte si strugge ancora chiedendosi dov'era quando l'ha ascoltata, e se c'è un modo di tornarci. Ecc.).
(Seguono 4000 battute su un pezzo di 50 secondi):
151. Her Majesty (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
Sua Maesta è una davvero una bella ragazza, ma non ha poi molto da dire. Qualche mese fa, in occasione del Cinquantesimo Anniversario, è uscita la tanto attesa versione deluxe di Abbey Road (dove "deluxe" ormai è un modo di dire: dopo qualche giorno era già accessibile anche ai poveri mortali su Spotify). Finalmente abbiamo potuto ascoltare Her Majesty dov'era previsto che fosse fino a pochi minuti dal taglio finale, ovvero nel bel mezzo del Famoso Medley del Secondo Lato, tra i due numeri in assoluto più lennoniani del carosello: Mean Mr Mustard e Polythene Pam. Finalmente abbiamo potuto verificare un'antica intuizione, vale a dire che il vero merito acquisito da Paul McCartney con Her Majesty non era stato tanto nel comporla (probabilmente non ci aveva messo più di cinque minuti), ma nel tagliarla via di netto, zac! ottenendo con un'opera di pura sottrazione una delle svolte più intense di tutto il disco. Non ci si può impedire di pensare: ah, se soltanto Paul avesse imparato a censurarsi un po' prima. Certo, eliminando l'unico scarso minuto mcartneyano nel blocco lennoniano si sacrificava una delle ultime illusioni di coesione, ma a quel punto, davvero, chi aveva più bisogno di illusioni?
Col taglio si sacrificava anche quell'abbozzo di un minuto scarso che Paul non aveva mai realmente desiderato trasformare in una canzone. È dal Disco Bianco che Paul sta esplorando l'estetica del non-finito: certe idee ha smesso di svilupparle, preferisce lasciarle a un livello embrionale, e magari al limite montarle assieme in composizioni patchwork: un trucco che quando funziona può contribuire al miracolo di A Day in the Life, ma quando non funziona (e Paul è il primo ad ammettere che non sempre funziona) può portare all'incisione di strani scarti, oggetti enigmatici come Wild Honey Pie o Why Don't We Do It in the Road. Canzoni bonsai, le chiama Alan W. Pollack: minuscole, autosufficienti e (aggiungo io) abbastanza inspiegabili: a cosa serve una canzone che dura meno di un minuto? (È buffo perché io faccio parte dell'unica generazione che avrebbe in effetti saputo dare una risposta a questa abbastanza assurda domanda: l'unica a trovare un senso pratico e circoscritto alle canzoni minuscole: erano quelle che si mettevano alla fine di un nastro per non sprecare nemmeno un minuto di vuoto. Esistevano dei veri e propri repertori, alcuni sono finiti anche on line). Ma bisogna ammettere che rispetto agli antecedenti del Disco Bianco, Her Majesty è davvero autocompiuta: probabilmente se avesse deciso di lavorarci Paul avrebbe potuto trasformarlo in un altro bozzetto in costume, ma la verità è che siamo abbastanza felici che non ne abbia avuto voglia, anzi, viene il sospetto che avrebbe fatto meglio a lasciare allo stadio larvale anche cose come Obladì o Silver Hammer. Come una foto rubata a una ragazza, uno sguardo che per puro caso funziona meglio di centinaia pose provate prima o dopo.
Dopo aver risalito ormai un centinaio di canzoni del repertorio beatle, credo che si tratti della prima volta in cui ci capita di parlare del Famoso Medley di Abbey Road, che è del resto il trionfo di questa tecnica compositiva "per incastro" che McCartney avrebbe conservato anche dopo la fine del suo sodalizio con Lennon. Ne parliamo per la prima volta incontrando l'unico pezzo che Paul decise di scartare – non abbastanza da eliminarlo dal disco, anzi: sappiamo che un tecnico del suono non sapendo dove buttarlo lo appiccicò al termine della bobina. Sappiamo che riascoltandola Paul rimase stupito dall'effetto straniante di questa sua canzoncina in solitario, che riemergeva all'improvviso dal silenzio ancora echeggiante dell'ultimo accordo di The End, e decise che avrebbe condiviso questa sorpresa con tutti noi, lasciando lo scarto alla fine del vinile e facendo di Her Majesty la prima ghost track della Storia. In un momento in cui lo scioglimento era ormai una prospettiva concreta, qualcosa che The End poteva in qualche modo rendere ufficiale, mentre Her Majesty sembra voler avere una funzione sdrammatizzante: niente paura, nulla finisce mai davvero, e io sono qui ancora con la mia chitarra e le mie canzoncine (dice Paul) (sì, ma è da solo mentre lo dice) (e poi all'improvviso anche lui scompare, un istante prima che la canzone finisca davvero, un silenzio ora davvero completo e spaventoso come quello che subentrava al fruscio, al termine di una cassetta).
150. I'll Be Back (Lennon-McCartney, A Hard Day's Night, 1964)
 |
| Try to realize it's all within yourself, no-one else can make you change |
"[Il bambino,] tenendo il filo a cui era attaccato, gettava invece con grande abilità il rocchetto oltre la cortina del suo lettino in modo da farlo sparire, pronunciando al tempo stesso il suo espressivo “o-o-o”; poi tirava nuovamente il rocchetto fuori dal letto, e salutava la sua ricomparsa con un allegro “da” [“qui”]. Questo era dunque il giuoco completo – sparizione e riapparizione – del quale era dato assistere di norma solo al primo atto, ripetuto instancabilmente come giuoco a sé stante,
anche se il piacere maggiore era legato indubbiamente al secondo atto..." (S. FREUD, Al di là del principio di piacere, 1920.
A proposito di finali inattesi: I'll Be Back non doveva essere l'ultimo solco di A Hard Day's Night. Lo spazio per un brano in più (il quattordicesimo) c'era, e considerati i dischi precedenti sappiamo più o meno che brano avrebbe dovuto essere: il classico finale col botto, quel tipo di cover breve ma travolgente che era anche il modo con cui i Quattro si congedavano nei set dal vivo. Nel primo disco era Twist and Shout, nel secondo Money: nel terzo il più probabile candidato sarebbe stato Long Tall Sally – sennonché a un certo punto si decise di farne a meno e non è neanche così importante capire chi davvero fece la proposta e chi l'accettò, insomma chi stava dirigendo i lavori nel 1964 (George Martin? Brian Epstein? John e Paul?): quel che importa è che si trattò di una ragione più estetica che commerciale. A Hard Day's Night avrebbe contenuto solo materiale originale, 100% Lennon-McCartney: una prova di forza che però richiedeva un prezzo. Long Tall Sally fu destinata a un Extended Play, insieme ad altre pregevoli cover, e l'album più compatto e travolgente dei Beatles fino a quel momento uscì senza il botto finale, perché malgrado la loro provata versatilità, brani del genere non avevano ancora provato a scriverli (succederà pochi mesi dopo con I'm Down). Al termine di una cavalcata gloriosa, con poche e memorabili soste, i Quattro si congedano all'improvviso con un brano vagamente sinistro, dalla costruzione coraggiosa, per non dire già sperimentale (cinque strofe e tre bridge, di cui uno diverso dagli altri due, in posizione centrale: un riff ancora semplicissimo e persino più ipnotico di And I Love Her.
Da un punto di vista musicale I'll Be Back è una riflessione ingenua e potente su uno dei misteri più universali della musica: la differenza tra accordo in minore e accordo in maggiore. Il modo in cui basta spostare un dito di pochi millimetri sulla tastiera, o sul manico di uno strumento a corda, per cambiare un intervallo di terza e portare la tristezza dove c'era l'allegria, o viceversa. Quel miracolo che succede tutti i giorni miliardi di volte senza che nessuno abbia più tempo o coraggio per esplorarlo, se non i bambini nella primissima fase di apprendistato, o i Beatles che anche dopo qualche milione di dischi venduti continuavano a giocare con gli strumenti come i bambini con l'interruttore: accendi la luce (accordo in maggiore): serenità, spegni la luce (accordo in minore), tristezza. A questo punto Freud comincerebbe a sospettare qualcosa (il bambino sta mettendo in scena una scomparsa? ha paura che un genitore non torni più? a proposito, ha ancora entrambi i genitori?) Neanche a farlo apposta, il brano comincia proprio mettendo in scena una sparizione e una ricomparsa, come il nipotino del Dottore: "if you break my heart I'll go", minore – "but I'll be back again", maggiore. Il seguito ovviamente annacqua la suggestione iniziale: non è più il bambino orfano a parlare, ma un giovane adulto restio a usare l'unica arma deterrente che gli è rimasta in quella schermaglia che è il rapporto di coppia: l'allontanamento volontario. Se continui a spezzarmi il cuore me ne vado (accordo in minore); sì vabbe' tanto poi torno (accordo in maggiore). Non si fatica a immaginare la perplessità dell'interlocutrice: questo ragazzo non ha neanche bisogno di me per litigare, sta facendo tutto da solo. I want to go, but I hate to leave you...
149. Please Mister Postman (Dobbin/Garrett/Gorman/Holland/Bateman, incisa in With the Beatles, 1963).
Per favore signor postino, controlli meglio, se c'è una lettera nel suo sacco per me. Certe canzoni hanno un picco, non saprei come definirlo meglio, un singolo momento che vale la pena di aspettare per tutta la canzone: in questo caso il momento in cui John non riesce più a tenersi e strattona il povero postino con una richiesta ridicola e struggente: "Deliver the letter! The sooner the better!" I Beatles del '63 stanno alla posta cartacea come gli artisti trap del '19 stanno a Instagram. È semplicemente il loro mondo, l'universo che si è creato spontaneamente tra loro e i fan, quelle ragazzine che sulle buste lasciavano messaggi anche ai postini, inviti a sbrigarsi a consegnare i loro messaggi ai Beatles (che ricambiavano scrivendo canzoni in forma epistolare). Magari basta questo a spiegare il perché una canzone allegra e tutto sommato abbastanza sciocchina della filiera Motown (Please Mr Postman ha quattro accordi e cinque autori ufficiali), ripresa dall'altra parte dell'oceano sembra diventata non dico una canzone seria, ma in un qualche modo credibile. Malgrado quel martellante e garrulo giro di Do che nessuno tranne Lennon avrebbe mai cercato di usare per comunicare un genuino senso di ansia, malgrado i coristi sembrano più divertiti che preoccupati – ma comunque simpatetici (la vera svolta di queste cover è la minore distanza tra voce solista e coro, quel nuovo senso di complicità che può trasformare un brano commerciale in un inno generazionale). Malgrado tutto perdere una lettera, all'inizio degli anni Sessanta, tra Liverpool e Amburgo, non è affatto uno scherzo: non c'è poi così tanto da riderci sopra. E insomma fermati postino, guardaci meglio, posso sembrarti un teenager piagnone ma ho diritto all'espressione delle mie emozioni – nonché a un servizio puntuale.
148. Flying (Lennon-McCartney-Harrison-Starkey, Magical Mystery Tour, 1967)
"Se ora guardate a sinistra, signori e signora, il panorama non è molto suggestivo. Ma se guardate a destra..."
Magical Mistery Tour è l'oggetto più sfuggente di tutta la discografia dei Quattro. Del resto dipende tutto da cosa vuoi e non vuoi vedere: da che parte ti volti. Se decidi di considerarlo un album (di solito la versione LP uscita negli USA per la Capital), non fatichi a considerarlo un capolavoro, non di molto inferiore al tanto decantato Sgt Pepper uscito pochi mesi prima. Se invece lo consideri un film, o almeno un prodotto audiovisivo, hai davanti l'unico vero fallimento artistico della loro carriera. Già. Ma d'altro canto i Beatles erano soprattutto musicisti, no? E anzi da questo punto di vista Magical Mystery Tour rappresenta il definitivo rigetto della cultura cinematografica, il loro modo (abbastanza involuto) di dire al pubblico e all'industria: grazie tante, ma questa cosa tutto sommato non ci interessa. La sbrighiamo per obbligo contrattuale, non ci perdiamo più tempo di tanto, se il risultato sembra il super8 di una gita aziendale tanto peggio, ci scusiamo coi telespettatori e andiamo avanti (McCartney davvero si scusò, evento rarissimo ai tempi). L'importante è la musica, e la musica non è buona? Sì, in molti casi è eccezionale, ma non è esattamente il caso di Flying, che è poco più di una jam session e ha il grosso torto di ricordare all'ascoltatore proprio l'origine cinematografica dell'operazione – davvero: puoi ascoltare The Fool On the Hill o persino Blue Jay Way senza mai farti venire in mente quel brutto tentativo di film, ma Flying ti riporta a terra (che ironia): cioè davvero questi credevano di poter improvvisare una cosa come una colonna sonora? Davvero pensavano che fosse il momento giusto per pubblicare una jam session e di attribuirla a tutti e quattro i componenti del quartetto? Più che un gesto generoso, sembra uno scarico di responsabilità. Un sintomo della stessa incoscienza che li aveva portati in giro per la campagna in pullman a girare un film senza una riga di sceneggiatura.
Anche nell'economia del film Flying rappresenta uno dei momenti più critici: nell'idea iniziale doveva rappresentare l'irruzione del sogno, del meraviglioso, sul "fianco destro" del pullman. Poteva essere il momento cruciale, il passaggio dall'estetica crepuscolare della campagna inglese a quella psichedelica che avrebbe cambiato il mondo in quell'ormai imminente anno 1968. Dai Kinks di Village Green ai Pink Floyd di The Piper at the Gates of Dawn in un battito di ciglia: chi se non i Beatles avrebbero potuto riuscirci? E invece i Beatles, che fino a quel momento si erano accreditati come artigiani del meraviglioso, decidono in questo caso di sprecarsi il meno possibile e usare per l'occasione un po' di materiale di scarto di 2001 Odissea nello Spazio. Oddio: chi, avendone l'occasione, non impreziosirebbe i propri filmini delle vacanze con un po' di fotogrammi inediti di Stanley Kubrick, peraltro coloratissimi? Il film però andò in onda sul primo canale della BBC, che in quel 26 dicembre 1967 trasmetteva in bianco e nero. Quello che videro davvero i telespettatori erano poco più che riprese fosche e inquietanti di una piana desertica. Nulla di così "inspiring", e anche la musica non sembrava quella delle grandi occasioni. Flying dovrebbe esprimere la gioia del volo, ma per un altro caso di ironia involontaria, sceglie di affidarsi a una scala discendente, suonata sì sullo strumento più sofisticato in circolazione (il maledetto mellotron) ma montata sulla struttura meno fantasiosa a disposizione dei Quattro: il blues in dodici battute. Questo non rende Flying un brano così orribile dopotutto: alla fine nel suo piccolo fa davvero tutto quel che dovrebbe fare un breve brano all'interno di una colonna sonora: accarezza l'orecchio senza farsi troppo sentire, senza rubare l'attenzione all'occhio. Andrebbe tutto bene se il film in questione non fosse Magical Mystery Tour, e se l'occhio non stesse implorando pietà.
147. Why Don't We Do It In the Road? (Lennon-McCartney, The Beatles, 1967).
"Perché non lo facciamo per strada? Nessuno ci starebbe a guardare". Ok, Paul, che stai dicendo, aspetta. È chiaro che tutti si metterebbero a guardare, se lo facessimo per strada. Si fermerebbero a guardare anche se tu non fossi il grande McCartney, garantisco, dalle nostre parti in effetti per una serie di questioni sociologiche la gente a volte lo fa davvero per strada, blindandosi comunque dentro compatte autovetture, scegliendo non a caso le provinciali meno asfaltate e malgrado questo, malgrado questo, una volta su tre incappando in ciclisti guardoni: è più forte di loro. Ok Paul, sei stato in India, e un giorno sul tetto di un ashram hai visto due macachi copulare, rapidi e spudorati, chissà che epifania, bisogna dire che scene come in tv ai tempi il National Geographic non le trasmetteva. Va bene, ma ci sarà anche un motivo se i macachi sono rimasti sugli alberi mentre gli homo sapiens sapiens hanno inventato la fotografia e più tardi il cinema e ancora più tardi internet – sembra proprio che gli piaccia guardare. Ancor più che copulare, che ammettiamolo: dopo una certa età è uno sbattimento imbarazzante.
 |
| oi in realtà ci stiamo spulciando, cioè non dovete necessariamente pensare subito a quella cosa. D'altronde, siete umani. |
Vabbe', divago perché sono indietro con la scaletta, ma quello che all'inizio volevo dire è che Why Don't We Do It In the Road è il brano più hippy che i Beatles abbiano mai scritto – posto che abbia ancora senso la parola "scrivere" per un un riff che è il grado zero del blues, e per un testo che consiste nell'invito a farlo per strada "tanto nessuno ci guarda": due righe, una sciocchezza che poteva suonare meno ridicola giusto fino a quella metà del 1968, il tempo di tornare dall'India ancora un po' intontiti, buttarsi nell'imprenditoria e arrivare a un passo dal fallimento. Quel senso di utopia a buon mercato che è la cosa che è invecchiata più in fretta degli anni Sessanta – cominciava a puzzare di muffa e ridicolo già verso dicembre, e si è tramandata ai giorni nostri soltanto attraverso le caricature che circolavano sin da allora (Frank Zappa aveva iniziato a prendere in giro Why Don't We Do It prima ancora di ascoltarla). Per capire Why Don't We Do It dobbiamo invece accettare che non è una caricatura: che Paul in quel minuto ci sta credendo davvero. Viviamo nell'attesa degli ultimi tempi, tra un po' si farà sesso per strada senza che nessuno si fermi a guardare, e anche le canzoni non ci sarà più bisogno di arrangiarle così tanto, diventeranno raga semplicissimi e universali: da questo punto di vista Why Don't We Do It è un altra di quelle canzoni che parlano di sé stesse, è una session breve di due musicisti (Paul e Ringo) che sanno cosa devono fare e lo fanno grezzo e rapido, senza vergogna, un coito tra macachi mentre George e John finivano di registrare qualcos'altro. Questo forse ci consente di capire la reazione di Lennon quando li scoprì, e invece di scrollare le spalle rimase offeso: ma come, combinate una sveltina del genere e non mi chiamate?
Tra tante promesse dei Beatles che il mondo ha deluso Why Don't We Do It è una delle più involute e difficili da comprendere oggi – viviamo davvero in tempi diversi, oggi l'idea che nessuno si fermi a guardarti se decidi di fare sesso per strada è praticamente offensiva, ma come? neanche un like, una condivisione, un cuoricino? noi qui a sbatterci e voi neanche vi voltate? L'unico motivo per cui si ascolta ancora volentieri non ha niente a che vedere con la liberazione sessuale, ma con un tema assai più fondamentale per il destino dell'umanità: il funky. Ovvero, proprio quel giorno, mentre jammava a tempo perso con Paul sul fondamentale argomento del sesso dei macachi, Ringo se ne salta fuori con due o tre rullate che sono francamente funky (ascoltatele ad esempio da 1:25). Sicuramente più funky di quanto avesse mai suonato fino a quel momento. E va be', direte voi, in fondo il funky col sesso ci sta abbastanza bene, no? Indubbiamente, ma il punto è che nella primavera del '68 le rullate funky, quelle classiche che avete sentito campionate ovunque, ancora non esistevano. L'Amen break, per dirne una, è del 1969 (cos'è l'Amen break? È il ritmo che aveva il vostro cuore se andavate a ballare negli anni '90). Quanto a Funky Drummer, e direi che siamo tutti d'accordo che il calendario astrale dell'Hip Hop si calcola a partire dal quinto minuto di Funky Drummer, addirittura è del 1970! Insomma, l'Hip Hop stava quasi per cominciare nel 1968, (anno 2 avanti James Brown) agli Abbey Road Studios, se solo qualcuno avesse fatto un po' più di attenzione alle rullate di Ringo. Davvero, se per un attimo Paul avesse smesso di calpestare il pianoforte e urlare eufemismi sconci, i Beatles avrebbero potuto produrre il primo break campionabile al mondo. Ma non era, come dire, la priorità. La priorità era inneggiare al libero amore dei primati. Buon 1968.
146. It's Only Love (Lennon-McCartney, Help!, 1965)
È vero che io e te dobbiamo combattere? Ogni notte? It's Only Love ha il curioso primato di essere la canzone di John Lennon più detestata dallo stesso John Lennon. O meglio: diciamo che John Lennon – che nelle interviste degli anni '70 amava sparare a zero sulle canzoni di Paul, sulle sue, sui Beatles in generale, e su chiunque si azzardasse a parlare male dei Beatles tranne lui – ha espresso più volte il suo odio per It's Only Love che per qualsiasi altra canzone. Perché? Cos'ha di davvero odioso questo pezzo riempitivo ma tutt'altro che fastidioso, ricamato con una certa eleganza su una progressione armonica anche abbastanza originale (che tra l'altro è una specie di esperimento preparatorio di Being For the Benefit of Mr Kite)?
 |
| Sono il premio Nobel Eugenio Montale e non ho la minima idea del motivo per cui illustro questo pezzo, a me i Beatles probabilmente non piacevano |
Gli esegeti hanno notato che di solito l'odio di John si concentrava sui contenuti: un altro brano del 1965 che non sopportava è Run For Your Life, uno schizzo di maschilismo che comprensibilmente doveva imbarazzarlo. Anche le parole di It's Only Love accennano vagamente a una crisi di coppia, ma quello che le rende più facilmente fastidiose è la loro banalità. Sono sempre le solite parole che stavano bene in ogni testo e che ormai a furia di rimontare hanno perso anche quel poco del loro significato originale. Insomma la mia ipotesi è che l'insofferenza di Lennon per It's Only Love non scaturisca, per una volta, da una questione esistenziale, ma sia il segno di un'insoddisfazione estetica: John non ce la fa più a scrivere i soliti riempitivi dei dischi dei Beatles, i costumi di scena cominciano a stargli stretti. Non riesce più a prendersi sul serio mentre canta le solite rime: è un passo dall'autoparodia quando infila negli stessi versi tutte le vocali più aperte che riesce a trovare (I get HIGH when I see you go BY, MY oh MY! When you SIGH MY-MY inSIDE just FLIES, butterFLIES), quando pronunciando un "bright" si lascia scappare una R squillante, quasi italiana.
Le rime, spiegava il vecchio Montale, "sono più noiose delle Dame di San Vincenzo: battono alla porta e insistono. Respingerle è impossibile". Il "poeta decente" ci prova a tenerle fuori, ma niente da fare: "le pinzochere ardono di zelo e prima o poi (rime e vecchiarde) bussano ancora: e sono sempre quelle". Dopo tre anni di dischi, Lennon una canzone come It's Only Love poteva scriverla ad occhi chiusi e forse a questo punto la cosa cominciava a diventare un problema: non riuscire a chiudere gli occhi senza essere disturbato dal bussare di una vecchia rima, un vecchio riff, un vecchio giro di accordi. Poi dice che uno si droga. Bob Dylan, quando ascoltò il primo verso "I get high when I see you go by", ritenne di aver captato un verso in codice: "I get high", finalmente i Beatles avevano cominciato a farsi seriamente. Ma probabilmente It's Only Love parla di droga così come parla di rapporti di coppia, come di qualsiasi altra cosa: è solo un mucchio di frasi e Lennon cominciava a essere stanco di stare alla catena a montarle in base al suono. Non è che fosse in crisi di ispirazione, o meglio: era in quel tipo di crisi che ti porta a scrivere Ticket to Ride o Norwegian Wood. C'era ancora della musica fantastica da scoprire e riportare alla luce – ma quella vecchia non se ne andava: continuava a farsi viva coi suoi ritornelli chiocci, con le sue frasi fatte.
Le canzoni dei Beatles (#165-156)
28-11-2019, 21:15beatles, Il Post, musica, vita e mortePermalinkPuntate precedenti: Le 250 migliori canzoni dei Beatles (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#214-201), (#200-181), (#180-165).
La playlist su Spotify.
165. Free as a Bird (Attribuito a Lennon-McCartney-Harrison-Starkey, Anthology I, 1995)
"Can we really live without each other?
Where did we lose the touch
That seemed to mean so much?
It always made me feel so..."
"Free as a bird".
I Beatles, tra le altre cose, sono un Mito della Caduta. A questa idea nel 1995 Paul McCartney doveva essersi rassegnato; aveva avuto tutto il tempo per farlo. C'è stata un'età dell'oro, benedetta dagli dei, in cui qualsiasi accordo infilato a casaccio in una canzone per teen-ager era un capolavoro. Era favoloso, era assurdo, forse un insieme pazzesco di coincidenze, ma insomma a un certo punto è finito, e mezzo secolo dopo non smettiamo di chiederci: di chi è stata la colpa? Sono stati i soldi, le mogli, l'invidia, la droga, insomma cosa? Se solo si potesse dare tutta la colpa a Mark Chapman: se solo fosse così facile. Ma neanche puoi tenertela, questa immensa colpa, o dividerla con altri tre compagni che non avevano nemmeno trent'anni. E ora che faremo? Siamo condannati a vivere del frutto del nostro sudore? Scrivere dischi per tutta la vita anche se la gente vuole ascoltare solo quelli che buttavamo fuori allegramente a vent'anni? Come abbiamo potuto rassegnarci a vivere l'uno senza l'altro? Quand'è che abbiamo perso quel Tocco che ci rendeva così, così...
(Dillo tu, John)
"...così liberi", dice John. "Liberi come uccelli".
(Salvo che non è John, è solo un vecchio nastro registrato).
I morti non invecchiano, l'avrete notato. In qualsiasi momento torniate a trovarli vi mostreranno lo stesso sorriso, che a seconda della luce o della stagione vi saluta o vi compatisce o vi sbeffeggia. Ma è sempre lo stesso e col tempo può persino risultare irritante, questa cosa di rimanere sempre sulle stesse posizioni, tornare sempre sugli stessi ricordi. I morti non ne hanno altri, non cambiano più idea, e John Lennon per esempio aveva idee molto nette sui Beatles e sulla libertà.
La libertà, per Lennon, era anche e soprattutto libertà dai Beatles. Lo aveva scritto abbastanza chiaro in God, ma non è che McCartney avesse avuto idee molto diverse quando in You Never Give Me Your Money sognava di fuggire su una limousine lontano da quella gabbia di matti. Paul però ha avuto tutto il tempo per cambiare idea, per assistere alla progressiva costruzione del Mito (della Caduta) e sopravviverne, accettando di esserne il protagonista. E così rieccoli assieme, il vivo e il morto, in un fotomontaggio irrimediabilmente sbagliato e comunque struggente. John, che odiava i Beatles, aveva scritto un ritornello sulla gioia di essere liberi; Paul scrive un bridge sulla pena di non poter più essere liberi, perché i Beatles non esistono più. È impossibile capirlo dal nastro registrato, ma quando riprende a cantare, è come se John stesse sorridendo di lui.
(Ora che sono passati 25 anni da quando Yoko Ono concesse a Paul McCartney l'uso del demo di Free As a Bird, possiamo dirlo: non è una canzone dei Beatles. Ormai è remota da noi quanto erano lontani i veri Beatles dai superstiti che tornarono a incidere Free As A Bird nel 1995. In quel decennio un paio novità tecnologiche resero per qualche stagione meno macabro il concetto di "duetto col defunto", che diventò anzi una specie di format: aveva cominciato Natalia Cole duettando col papà e nel giro di dieci anni si arrivò a remixare Elvis. Anche in questo contesto Free non poteva che lasciare perplessi, malgrado l'amore e il rispetto con cui era stata rilavorata dai tre superstiti con Jeff Lynne. Ma non c'era ancora modo di sapere come avrebbe retto al tempo: se gli anni, accumulandosi, l'avrebbero fatta suonare più simile ai veri brani dei Quattro. 25 anni dopo viviamo in un mondo digitale, ossessionati dal concetto di fake, e Free As a Bird ci urta proprio in quanto falso storico. Ma tra altri 25 anni chissà).
164. Wait (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965).
It's been a long time. Come forse intuite, questa non è la prima classifica di tutti i brani dei Beatles dal migliore al peggiore. Quando sarà finita sarà ovviamente la più lunga (e faconda), ma nel frattempo il primato spetta ancora al magazine on line Ultimate Classic Rock, che qualche anno fa pubblicò una lista di più di 220 canzoni, comunque 27 in meno della nostra, ah ah, pivelli. UCR ignorò la più parte degli inediti di Anthology, certe outtakes del Disco Bianco che non erano ancora state pubblicate e... Wait. No, aspetta, perché saltarono Wait?
Wait è tutt'altro che un brano inedito, e si trova anzi in uno degli album più importanti. Però ha un titolo molto breve, uno di quelli che si cancellano con un clic, e questo potrebbe aver tratto in inganno i compilatori. Per dire quanto è facile dimenticarsi di Wait. Persino i Beatles se ne dimenticarono, in un certo senso, escludendola da Help!, per poi recuperarla qualche mese dopo, mentre la scadenza natalizia incedeva inesorabile sulle sessioni entusiasmanti ma meno fruttuose di Rubber Soul. Non significa necessariamente che la considerassero uno scarto: magari era un'idea sulla quale avrebbero preferito lavorare un po' di più (ma ebbero solo il tempo per aggiungere tamburello e maracas, un assolo di George e un coro di Paul). Wait è un classico esempio di riempitivo beatle dell'età di mezzo: non è un avanzo registrato in fretta e alla bell'e meglio come Little Child, né un bizzarro esperimento di laboratorio come Good Morning. È un brano tutt'altro che banale e anzi discretamente sperimentale per l'uso delle percussioni 'in crescendo', la strofa in sestine alternate ABCABC, la presenza sia di un ritornello sia di un bridge, cantato da Paul, che dà alla canzone una dimensione ulteriore. Però è quel tipo di brano che scivola rapido senza restare in testa, mettiamola così. Io comunque me lo sono ricordato, nella classifica del Post Wait c'è. (Ne avrò senz'altro dimenticato un altro. Con un po' di fortuna non se ne accorgerà nessuno).
163. I Don't Want to Spoil the Party (Lennon-McCartney, Beatles For Sale, 1964)
John Lennon nel numero "a questa festa mi si nota di più se me ne vado". I Don't Want to Spoil the Party rompe un tabù: per la prima volta qualcuno nel beatleverso ammette di avere preso "un drink o due". Quindi, insomma, si beve. Chissà se si fuma addirittura... Il secondo lato di Beatles For Sale è il momento in assoluto più country nella discografia dei Beatles, e a questo punto ormai abbiamo capito che il country era un genere che i Beatles non disprezzavano, ma a cui si rivolgevano per disperazione: la ragazza simpatica a cui ti riduci a fare il filo per cercare di dare senso a una serata che non doveva finire così. E malgrado in questo caso il country sia in sostanza una mascheratura, sotto la quale I Don't Want conserva una struttura schiettamente pop, c'è in questa scelta qualcosa di assolutamente appropriato.
Il country mette in scena stereotipi rigorosi: la società è una sala da ballo, stare al mondo è apparentemente facile (è sufficiente chiacchierare, bersi un bicchiere, rispettare le figure della danza), salvo che il cantante proprio non ci riesce. Decide quindi – virilmente – di allontanarsi da solo, perché la Festa non dev'essere rovinata. Tutto abbastanza giusto e inoltre a chi di noi non è successo, di scoprire che eravamo in un posto solo perché speravamo che ci fosse qualcuno, qualcuno senza il quale la società si svela un meccanismo vano e insensato. Ovviamente era previsto che la cantasse Ringo (o magari George, avrebbe avuto un senso anche per George). Ma anche stavolta la scadenza natalizia si avvicinava minacciosa, non restava che mettersi a flirtare con tutti le vecchie canzoni che non erano ancora state incise in quei due anni, alcune delle quali erano brani country ancora più adatti a Ringo (Honey Don't) o a George (Everybody's Trying to Be My Baby). Così alla fine I Don't Want rimase a John – oppure fu John a capire che in una canzoncina del genere c'era qualcosa di sommessamente tragico che meritava il suo prezioso intervento vocale? Non lo sappiamo. Non siamo neanche sicuri di chi siano i cori: chi ci sente George, chi John, chi Paul (soprattutto nel bridge). Quest'ultimo nella sua biografia fa i complimenti a... Ringo: si vede che è da un po' che non la riascolta. Ma insomma si vede che è facile dimenticarsi anche di I Don't Want to Spoil the Party. Come di tante feste di cui non ti restava che la puzza di fumo sui vestiti il giorno dopo, e un vago senso di vuoto.
162. For You Blue (Harrison, Let It Be, 1970)
I've loved you from the moment I saw you. Qual è l'ultima canzone dei Beatles? Scelta ardua. Candidati papabili: Let It Be, in quanto ultimo singolo, e ovviamente The End. Ma dopo The End c'è pur sempre Her Majesty. Oppure I Me Mine, che fu l'ultima canzone che registrarono nel 1970. Ma a quel punto Lennon era già fuori, e quindi perché non aggiungere Free As a Bird, incisa appena 25 anni dopo? Però dopo Free c'è Real Love... Insomma, è complicato.
Il Disco Blu finiva con The Long and Winding Road, una scelta suggestiva perché davvero quell'orchestra non te l'aspetti, è una specie di sigla a sipario già sceso. Quanto all'ultimo album, Let It Be, finisce con un brano che era uscito come singolo addirittura l'anno prima, Get Back!: più che un finale sembra un bis. Prima di Get Back! Phil Spector volle inserire For You Blue, che quindi è uno dei meno credibili candidati alla posizione di "ultima canzone dei Beatles". E tuttavia nella sconcertante banalità di questo blues in 12 battute, uno dei rari casi di riempitivi senza vergogna in tutta la loro discografia, c'è qualcosa che ci dice che davvero la storia è già finita.
John si diverte a suonare la chitarra con un bossolo di metallo, George lo incita invocando il dio della slide guitar ("Elmore Jones got nothing on this, baby!"). È quel tipo di jam rilassata che segue una tempesta. Come se non ci fossero più scadenze, non più battaglie da combattere, territori da marcare: solo vecchi amici che perdono tempo suonando un blues, purché sia il blues meno triste possibile. Più che l'ultima, For You Blue sembra la prima canzone che i Beatles hanno inciso dopo essersi sciolti.
161. Octopus's Garden (Starkey, 1969, Abbey Road)
"Restai sul ponte col capitano e parlammo delle piovre. Mi raccontò che vanno in giro sul fondo del mare cercando pietruzze luccicanti, lattine di metallo e bottiglie per collocarli davanti alle loro tane, come se fossero un giardino. Pensai che fosse fantastico, dato che anch'io all'epoca avrei voluto vivere sotto il mare".
Con la sua seconda prova autoriale, Ringo torna in quei fondali marini che ci aveva fatto scoprire cantando Yellow Submarine. Ma persino gli abissi non sono più quelli di una volta: se nel 1966 erano l'ambiente ideale per avventurose scorribande di un gruppo di amici, ora quel che importa davvero è che laggiù si è al sicuro ("safe"). La Piovra, ci spiega Ringo, ci farebbe entrare, perché la Piovra sa attraverso cosa siamo passati: e laggiù urleremmo e nuoteremmo e canteremmo e riposeremmo, nell'ombra, e nessuno saprebbe più trovarci.
Se è finalmente una buona canzone per bambini (quella che non erano riusciti a incidere sulla colonna sonora di Yellow Submarine), è stata scritta da un padre moderatamente apprensivo e stanco dei tumulti del successo. Ma in un certo senso è ancora la vecchia fantasia di Brian Epstein, di quando si era messo a cercare un'isola greca dove rifugiarsi coi suoi quattro ragazzi e non invecchiare mai. Ringo la concepì al largo della Sardegna, sullo yacht che gli aveva prestato Peter Sellers, in quello scorcio d'agosto in cui era scappato dalle session del Disco Bianco. Octopus's Garden trova la sua strada per Abbey Road soprattutto grazie al piccolo aiuto di George Harrison, che trasforma l'abbozzo dell'amico in una canzone completa e ne approfitta per aggiungere il riff di chitarra più spensierato del disco. Si riverbera sul brano la luce smagliante di Here Comes the Sun, segno dell'intesa particolare maturata tra i due Beatles di seconda fila – la stessa squadra che due anni dopo avrebbe mandato in classifica It Don't Come Easy. Chissà che avrebbero combinato ancora assieme se i Beatles non si fossero sciolti (chissà perché continuiamo a farci questa domanda. Si sono sciolti. Non poteva andare diversamente. Sul serio, dai).
160. Slow Down (Larry Williams, singolo americano del 1964, poi nell'EP Long Tall Sally).
Un altro brano di cui è facile scordarsi. Persino i fan di Larry Williams – e non ne aveva troppi – gli preferivano il lato B, Dizzy Miss Lizzy. Gli stessi Beatles avrebbero onorato Dizzy usandola come chiusura del loro ultimo disco vagamente yeah-yeah, una specie di ultimo bis prima di salutare e cominciare a progettare il futuro. Slow Down invece l'avevano già incisa sul lato A di un singolo americano, in quel tumultuoso 1964 in cui avrebbero potuto anche incidere una gara di peti con le ascelle e il disco sarebbe comunque finito in top100. Ristampata nel Regno Unito nell'EP Long Tall Sally, Slow Down è un altro tassello di un'operazione più sentimentale che economica: un revival del rock'n'roll più sanguigno che gli inglesi avevano potuto ascoltare soltanto sulle onde incerte delle radio pirata, e che per qualche coetaneo dei Beatles poteva funzionare da madeleine. Un ritorno ai suoni di una preadolescenza breve e irripetibile: il suono a cui di lì a poco Animals e Rolling Stones avrebbero dato una solenne spolverata. Negli USA invece Slow Down doveva suonare come una mossa precisa di appropriazione culturale: conosciamo il rock'n'roll meglio di voi, siamo qui per riscattare i suoi eroi meno compresi in patria. Ma se qualcuno nel loro entourage si aspettava di ottenere più successo così che con i pezzi smielati e yeah-yeah, si sbagliava. Meglio così, credo. Agli americani interessavano più i Beatles che il rock'n'roll: i Beatles se ne accorsero presto e si regolarono di conseguenza.
159 I'll Get You (Lennon-McCartney, 1963; lato B del singolo She Loves You).
Immagina che io sia innamorato di te... è facile, perché è vero. Un mese fa sul giornale della Society of Neuroscience statunitense è stata pubblicata una ricerca sul piacere della musica, Prevedibilità e incertezza nel piacere della musica: una ricompensa per l'apprendimento? Per i ricercatori della McGill University (Canada) e della Queen Mary University (Canada) la produzione di dopamina legata all'ascolto di brani musicali dipende anche dai passaggi tra gli accordi, che non devono essere troppo prevedibili, ma sorprendere di tanto in tanto l'ascoltatore. Una conferma a questa ipotesi è arrivata da un gruppo di studiosi tedeschi e norvegesi che ha esaminato 745 brani presi dalle classifiche americane tra il 1958 e il 1991, ed è giunto alla conclusione che il segreto sia la combinazione tra incertezza e sorpresa.
Tutto questo come poteva saperlo il ventenne Paul McCartney mentre componeva I'll Get You con John Lennon a casa di zia Mimi, sul letto di John, cercando di evitare il manico della chitarra di John col manico della sua? I'll Get You è quasi un manuale di composizione beatle, un compendio dello stile "yeah yeah": si comincia con i tre accordi classici, il primo il quarto e il quinto (do, fa e sol), tutti maggiori. Ci puoi cantare Twist and Shout e centinaia di altre canzoni, ma stavolta ci canti "Immagina che io sia innamorato di te". E a quel punto un altro gruppo sarebbe abbastanza soddisfatto, ma i Beatles no. Il secondo verso aggiunge un accordo ed è un la minore: ed ecco che Twist and Shout si ammolla in un languido giro di Do, talmente legato al doo-wop e ai gruppi vocali degli anni '50 che in inglese lo chiamano proprio "50s progression". Anche al microfono Paul e John cominciano ad atteggiarsi a crooner, raddoppiano gli aggettivi "many many many times before". E la canzone a questo punto potrebbe ritenersi abbastanza originale, per come alterna due progressioni armoniche che rimandano a due stili diversi. Ma Paul vuole qualcosa di più, Paul ha sentito in un brano di Joan Baez un accordo nuovo (un Sol Minore Settima) e ha deciso di usarlo alla prima occasione.
Non importa che la Baez stesse cantando un brano folk delle Bahamas, mentre Paul sta scrivendo una canzone di facile ascolto per le ragazze inglesi: Paul ha voglia di Sol Minore Settima, e Sol Minore Settima sia. Lo sentite nel momento in cui cantano "pretend", ed è appena un istante, davvero. Non rende la canzone minimamente simile a All My Trials, però... è un accordo insolito, e la dopamina pare che si produca così. Per una pura coincidenza, il Sol Minore Settima cade proprio sulla parola "pretend": è come un esitazione, un voltarsi indietro, ai segreti della propria coscienza, prima di prendere coraggio e affermare i propri diritti virili: "but I'll get you, I'll get you in the end. Yes I will, oh yeah, oh yeah, oh yeah". Siamo in effetti all'apice della fase "yeah": I'll Get You doveva essere il singolo successivo a From Me to You, ma alla fine uscì come lato B di She Loves You, in una versione un po' tirata via perché tutti gli sforzi si sono concentrati sul lato A. Non c'è nemmeno una chitarra solista udibile (George, dove sei?); in compenso l'armonica di John segue, per quanto può, la progressione armonica, dando al brano quella particolare coloritura che a quel punto sulle frequenze inglesi era immediatamente riconoscibile: il suono dei Beatles (in effetti chi altri sarebbe stato così barbaro da usare l'armonica in quel modo?)
I'll Get You comincia con la parola "Imagine", mentre il secondo verso recita "it's easy". È facile immaginare un amore, spiegano John e Paul. Qualche anno dopo John avrebbe usato le stesse parole in un'altra canzone – se ci pensate un attimo, l'avete sentita sicuramente.
158. The Continuing Story of Bungalow Bill (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).
"Uscì a cacciare con gli elefanti e la pistola. In caso di incidente portava sempre con sé la mamma. È il classico americano bianco, l'orgoglio di sua madre, testa di pallottola..."
Richard A. Cooke III è il co-fondatore di Hui Ho’olana, un centro artistico ed educativo a Kualapu’u nelle Hawaii. È stato a lungo fotografo freelance, collaborando soprattutto col National Geographic e con lo Smithsonian Institute, e pubblicando due libri: America's Ancient Cities e The Blue Ridge Range. Ma non è il motivo per cui è famoso in tutto il mondo, vero?
Il motivo per cui il mondo lo conosce è che quando era un ragazzo – un ragazzo bianco e ricco, figlio di una potente figura della moda USA, Nancy Cooke de Herrera – andò in India e sparò a una tigre. Una cosa che un sacco di ragazzi bianchi fa ancora oggi senza che nessuno si scandalizzi più di tanto. In certe zone sono proprio gli indiani a chiedere ai cacciatori di abbattere le tigri che creano prevedibili disagi. Richard però dopo aver ucciso una meravigliosa tigre ed essersi fotografato sopra la sua preda (con la mamma fiera al fianco), sentì un turbamento simile a un senso di colpa e andò a parlarne al guru che da qualche anno sua madre seguiva professionalmente – sì, a un certo punto Nancy Cooke era passata da ambasciatrice ufficiale della moda USA ad addetta PR di Maharishi Mahesh Yogi. Il guru fu meno conciliante del solito, e mise in chiaro che "distruggere la vita è distruggere la vita": come dargli torto. Da quel giorno Richard non sparò più e sostituì la fotocamera al fucile.
Anche tutta questa storia non avrebbe fatto il giro del mondo se all'udienza di Richard non avesse assistito John Lennon. Lennon che in mezzo a tutta quella pace e quella meditazione non riusciva a calmarsi, continuava a pensare a quella ragazza giapponese e non riusciva a impedirsi di trovare buffe le cose, in particolare le cose dei ricchi. Per esempio questo bellimbusto che si prendeva una pausa dalla meditazione trascendentale per andare a fare caccia grossa con gli elefanti e i fucili e la mamma, e poi tornava piangente a corte del Maharishi a sfoggiare un senso di colpa come un trofeo, non si meritava di diventare protagonista di una canzone di John Lennon? E magari Richard avrebbe smesso di fare il cacciatore anche se Lennon non lo avesse messo alla berlina davanti a tutto il mondo. Tra l'altro non lo chiamò nemmeno per nome, nulla di paragonabile anche lontanamente agli autodafé che oggi si innescano quotidianamente sui social network.
The Continuing Story è l'idea lennoniana di farsa, ormai nettamente divergente da quella concepita da McCartney in altri numeri di Sgt Pepper's e del Disco Bianco. McCartney concepisce la farsa come un mascheramento e lo vorrebbe sempre più preciso, sempre più sofisticato: in Honey Pie vorrebbe ridurre la voce a un graffio sul grammofono. Per Lennon la farsa è libertà: il carnevale non è l'occasione per lavorare a maschere elaborate, ma per andarsene per strada in pigiama o quasi nudi. Malgrado questo, o proprio per questo, è uno dei brani più politici dei Beatles, se non forse l'unico brano politico che abbiano mai realizzato, una satira del consumismo armato meno allucinata di Happines is a Warm Gun. Anche lo strumento più costoso e all'avanguardia (il maledetto mellotron!) viene impiegato come un giocattolo: è davvero come se Lennon giocasse a premere tasti a caso – se ne premi uno esce fuori un assolo di flamenco, bello! Mettiamolo nella canzone. Alla fine fischiettiamo tutti in coro, mi raccomando, un po' stonati. Ah, e Yoko vuole cantare almeno un verso, perché no? Facciamo che Yoko è la mamma di Bill. (Sigmund Freud scuote la testa in segno di assenso). La mamma di Bill, a detta dei testimoni, era una abbastanza antipatica (Mia Farrow: "una signora di mezza età che si dava un sacco di importanza"). Per entrare a giocare coi maschi, Yoko deve rassegnarsi al ruolo di vecchia bianca ricca e supponente. Che pazienza ci voleva con quei quattro.
157. Act Naturally (Morrison-Russell; incisa dai Beatles in Help!, 1965).
"Spero che mi verrai a vedere al cinema, così saprò che hai potuto vedere il più grande buffone che abbia mai avuto successo; e tutto quello che devo fare... è essere me stesso". Certo, If You Got Trouble sarebbe stata una scelta più coraggiosa e di rottura. Ma come avrebbero potuto evitare di incidere Act Naturally i Beatles, nel 1965? Come avrebbero potuto impedire a Ringo di cantare una canzone che sembra scritta apposta per lui? Con il film A Hard Day's Night Ringo aveva dimostrato di avere la faccia adatta per il grande schermo. Tutto quello che doveva fare era comportarsi in modo naturale, appunto. La canzone parla di questo e ci mette esattamente la malinconia e l'autoironia che ci aspettiamo dal personaggio-Ringo. Il country, coi suoi arrangiamenti rigidi e impassibili, funziona qui da corrispettivo musicale al deadpan humour, l'arte di far ridere senza ridere. Non è così facile essere sé stessi – specie se tutti intorno a te stanno impazzendo, cantando suonando e facendo milioni e perdendoli. Ringo ci è quasi sempre riuscito, diamogliene atto.
156. Boys (Dixon-Farrell; registrata dai Beatles in Please Please Me, 1963).
"Shod shu bop, shu bop shod shu bop". Sto parlando di RAGAZZI, adesso. Se Boys a Liverpool era diventata "il numero del batterista", la canzone affidata all'ugola dello sfigato nascosto dietro il set dei tamburi, era probabilmente perché veniva incontro alle loro difficoltà: la maggior parte delle parole le canti prima di iniziare a darci dentro con le bacchette; dopodiché il grosso del lavoro lo fanno i cori ("Shod shu bop, shu bop shod shu bop" e tu devi solo lanciare un "hey hey" ogni tanto: si può fare. Quindi per esempio nei Beatles la cantava Pete Best, e negli Hurricanes di Rory Storm era già il pezzo di Ringo. E sia Best sia Ringo urlavano "boys", come se fosse la cosa più naturale del mondo – salvo che la hit di Luther Dixon e Wes Farrell era stata composta per le Shirelles, le quali cantandola non lasciavano dubbi sul fatto che i RAGAZZI del ritornello fossero un oggetto del desiderio: sì sì va bene i lollilop e i chewingum e tutto quanto, ma noi adesso vogliamo parlare di RAGAZZI (sì, sì, RAGAZZI).
Vale la pena di domandarselo: per quale motivo non una sola band, ma almeno due gruppi di mancati scaricatori del porto di Liverpool non trovavano per nulla imbarazzante che il loro batterista cantasse a squarciagola la gioia che si prova a parlare di RAGAZZI? Gli stessi protagonisti, anni dopo, ammettevano che la cosa avrebbe dovuto sembrare un po' strana, ma alla fine era come se venisse naturale. Ci sono tre ipotesi.
(1) Ipotesi puristica: Hurricanes e Beatles preferivano il rischio di essere derisi a quello di allontanarsi anche solo di una sillaba dai testi originali. Succedeva nello stesso periodo anche nella scena folk: per Joan Baez era normale cantare testi che facessero riferimento in prima persona a un protagonista maschile.
(2) Ipotesi cacofonica: Il rock'n'roll prosperava in una specie di bolla culturale e linguistica, in cui le parole (cantate con accento americano anche nei sobborghi di Liverpool) mantenevano un legame labilissimo coi loro significati. Quel che contava erano i suoni, e "boys" aveva il suono giusto (eppure anche "girls" è un monosillabo).
(3) Ipotesi bullistica: al batterista veniva imposto di cantare una canzone sui RAGAZZI perché anche nei suoi due minuti di gloria non doveva mai dimenticarsi di essere lo sfigato del gruppo. Sì, beh, potrebbe essere il caso di Ringo. Ma Pete Best non sembrava altrettanto sfigato dopotutto. Anche nel terzo caso, Boys funziona da Dio e da perfetto anello di congiunzione tra il rock'n'roll del '57 e il pop dei complessi vocali femminili del '60. Il rock delle origini non era morto: si era solo messo una gonna e lasciato crescere i capelli. Ma sotto quei coretti e quei caschetti continuava a pulsare più sboccato e irriverente che mai. Voglio dire, qui si parla di RAGAZZI. (Sì, sì, RAGAZZI).
Le canzoni dei Beatles (#180-165)
15-11-2019, 21:21beatles, Il Post, musicaPermalinkPuntate precedenti: Le 250 migliori canzoni dei Beatles (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#214-201), (#200-181).
La playlist su Spotify.
180. Matchbox (Carl Perkins, incisa nell'EP Long Tall Sally, 1964).
"I'm sitting here watching matchbox holes in my clothes". Quanto devono essere frusti gli abiti di un uomo perché comincino a comparirvi "buchi a forma di scatola di fiammiferi"? Ecco, questo è il blues. La musica della miseria, che nel 1964 in alcuni locali di Londra cominciava a diventare di tendenza, per un pubblico borghese che evidentemente non dava troppo peso alle parole. Ringo però veniva dal quartiere più misero di Liverpool, Ringo quei buchi negli abiti non li trovava esotici o divertenti. Matchbox non è la solita cover beatlesiana di Carl Perkins. I Beatles la incidono nel 1964 e ne fanno il primo singolo americano con Ringo solista, il che ormai corrispondeva a una concreta esigenza di mercato perché nel 1964 non solo infuriava la beatlemania, ma cominciavano anche a delinearsi nicchie commercialmente interessanti come la Ringomania: c'erano specifiche fan di Ringo, che urlavano ancora più forte quando ai concerti John cominciava a sistemare il microfono per il numero di Ringo, compravano più merchandising con Ringo, mandavano in classifica Ringo I Love You o I Want to Kiss Ringo Goodbye, e avrebbero apprezzato in particolare un singolo cantato da lui: tanto meglio se era un brano del suo artista preferito, Carl Perkins appunto. Salvo che Matchbox non è il solito rockabilly screanzato alla Perkins; è qualcosa che conserva più venature di blues, e Ringo lo canta con un tono più accigliato e virile del solito, in un primo e forse unico tentativo di scrollarsi di dosso la maschera di Harpo Marx del gruppo (If You Got Trouble sarebbe stato il secondo, ma non se ne sentì l'esigenza).
A quest'altezza i Beatles non avevano bisogno di continuare a imbottire i dischi di cover: se sceglievano ancora di registrarne, è perché volevano davvero usarle per dire qualcosa. Nel Regno Unito Matchbox uscì su un supporto particolare, un extended play di quattro brani, di cui tre erano cover di vecchi pezzi r'n'r. Sembrava quasi un messaggio al pubblico più esigente e maschile, che in quei mesi cominciava ad affezionarsi a gruppi più 'duri', apparentemente più fedeli alla matrice blues (tra cui i Rolling Stones): guardate che noi saremmo sempre i migliori a fare questa roba. Se solo volessimo. La suoniamo anche a occhi chiusi. La facciamo cantare a Ringo, e Ringo comunque è più credibile di voi.
179. Mr. Moonlight (Roy Lee Johnson, incisa in Beatles for Sale, 1964).
Mister Moonlight, come again please... Quando dicono che Mr Moonlight era una delle canzoni preferite di John, mi domando sempre: preferite in che senso? E mi rispondo che magari era la sua canzone preferita mentre faceva la doccia; magari amava cantarla a squarciagola nei cessi di Amburgo, aiutandosi col riverbero delle ceramiche. È un'ipotesi come un'altra per una delle cover meno spiegabili tra quelle incise dai Beatles, una ballata vagamente latineggiante di William Lee Perryman, detto anche Willie per gli amici, Piano Red per i clienti dei bordelli(*), Dr Feelgod per i collezionisti di 45 giri esotici. Probabilmente erano stati gli stessi Beatles a portarla in Europa, inserendola nel loro repertorio nel 1962 (c'è in giro persino una registrazione allo Star-Club di Amburgo). Nel 1963 comunque l'avevano già tolta dalla scaletta dei concerti, il che aveva consentito ad altri gruppi della scena nord-inglese di appropriarsene: i Merseybeats ne avevano inciso una versione più intima e rilassata, mentre gli Hollies di Graham Nash ci sperimentarono folli cambi di tempo che anticipano il prog-rock. Proprio a quel punto John Lennon decide di tornare sul luogo del delitto, offrendo al mondo la sua Mr Moonlight, molto più vicina all'originale, abbassata appena di un semitono: quanto basta per cantarla senza lacerarsi le corde vocali. Cosa voleva fare davvero? Mostrare che la sapeva cantare meglio di tutti? Prendere in giro le tendenze eclettiche di Paul? Forse semplicemente si divertiva a intonarla a squarciagola, come quando si entra in doccia urlando la canzone più cretina che si ha in mente. Perché t'amo, Signor Chiaro di Luna.
(*) scherzo.
178. What Goes On (Lennon-McCartney-Starkey: Rubber Soul, 1965).
Cosa succede in What Goes On? Se lo ascolti in stereo capisci subito che qualcosa non va. Magari non è sempre stato così, magari la versione in mono non era così disorientante. Ogni tanto vale la pena di ricordarlo: i Beatles che ascoltiamo nel 2019 non suonano esattamente come quelli originali. Sono rimasterizzati, ripuliti, riequalizzati, Paul probabilmente ha alzato un po' le frequenze basse, mentre George potrebbe aver stornato l'attenzione da qualche magagna chitarristica; quello che meno ha potuto intervenire è stato ovviamente John (il quale fece in tempo a trovare orribili le prime riedizioni in stereo). Ma insomma di tempo per far sparire sotto il tappeto qualche errore di percorso ce n'è stato, e nonostante ciò è chiaro che in What Goes On è successo qualcosa di strano. Quelle chitarre troppo alte sul lato destro, sembrano suonate proprio da qualcuno che si sente troppo alto in spia e ha paura di sovrastare il cantato. What Goes On è una delle incursioni della ditta Lennon-McCartney nel country, giustificate dalla necessità di procurare a Ringo un brano adatto: il ritornello era già nel loro repertorio del 1962 e ha il sapore tipicamente acerbo dei primi brani McCartney-Lennon; le strofe vengono completate nel 1965 con un contributo simbolico di Ringo stesso (cinque parole, dice lui). Appena in tempo per completare la scaletta di Rubber Soul, anche se qualcosa davvero non va. Dopo un minuto e mezzo Ringo smette all'improvviso di cantare il ritornello e... non succede niente: sembra quasi che abbia perso il foglietto con le parole, le chitarre imbarazzate sul lato destro continuano a fraseggiare, una se ascolti bene sta suonando una specie di assolo ma non è molto più alta dell'altra, è come se avesse pudore a farsi avanti. Qualcosa evidentemente non ha funzionato e il fatto che dopo 50 anni di indagine ancora non si sia capito cosa è quasi consolante. Magari tra vent'anni un ragazzino si domanderà "ma cosa succede in What Goes On" e un Supermotore-di-ricerca lo porterà su questa pagina – ciao ragazzino del futuro, sono così felice che ti piacciano ancora i Bea – no, non ho la minima idea di cosa sia andato storto in What Goes On, ma resta qui, magari ti sarai anche chiesto perché hanno inciso Maggie Mae...
177. Maggie Mae (tradizionale; suonata per scherzo durante le session del gennaio 1969; incisa in Let It Be, 1970).
"'Tis the part of Liverpool / they returned me to / two pound ten a week, that was my pay". Alla fine della pazzesca storia erano passati appena dieci anni da quando cantavano canzonacce da pub alle fiere, con tre chitarre e a volte un contrabbasso. Dieci velocissimi anni, salvo che erano quelli che separavano il 1959 dal 1969, la miseria del dopoguerra dalla vertigine dell'era spaziale. Nel gennaio del 1969, nei freddi studi di Saville Row, i Beatles per la prima volta decidono di voltarsi indietro e dare un'occhiata a tutta la strada percorsa fino a quel momento. Un'idea più che legittima, salvo che sarà l'inizio della fine. Evidentemente non era consentito ai Beatles di fermarsi, guardarsi indietro e non trasformarsi in colonne di sale. Maggie Mae, quando la intona John quel mattino (e Ringo arriva subito a doppiarlo), può sembrare uno scherzo, o un semplice automatismo: lo studio non è abbastanza riscaldato, fa freddo, e quando i Quarrymen nel '59 dovevano scaldarsi prima di un'esibizione dal vivo magari intonavano una canzonaccia come Maggie Mae. Un ricordo spontaneo che un anno dopo Phil Spector trasforma in uno sberleffo, ritagliando una strofa di Maggie Mae e piazzandola proprio al termine dell'inno sacro di Paul, Let It Be; così che quella sporca Maggie "che non valeva niente neanche come ladra" diventa una specie di anti-Mother Mary. Due sterline e 10 scellini a settimana.
Cambiando apparentemente argomento: sapete che in tutta la Divina Commedia nessuno mai chiama il protagonista per nome, tranne Beatrice in Purgatorio XXX, quando si rivolge a lui per la prima volta da che è morta? Lei lo chiama "Dante" e Dante a quel punto trascrive il suo stesso nome "di necessitate". Ecco, nel canone beatlesiano Maggie Mae è l'unica ad avere il diritto di pronunciare il sacro nome: Liverpool.
176. I Call Your Name (Lennon-McCartney: già incisa da Billy J. Kramer and the Dakotas nel 1963; ripresa dai Beatles nell'EP Long Tall Sally, 1964).
"Ti chiamo e non ci sei; è colpa mia, mi sono comportato male? Non riesco a dormire la notte da quando sei andata". Anni dopo, riascoltando un vecchio pezzo che Lennon aveva cominciato a scrivere "quando ancora non c'erano i Beatles" a Paul venne il dubbio: ma forse stava pensando a sua madre?
Non è implausibile. In effetti I Call Your Name contiene una negazione da manuale freudiano, quando al settimo verso spiega "non piango mai di notte, non posso andare avanti così", laddove tutto il senso della strofa lascia intendere che quel "never" davanti a "weep at night" va inteso al contrario: altroché se piango, tu non ci sei più, non riesco a dormire, è stata colpa mia? È veramente quel che può credere un bambino durante l'elaborazione di un lutto: se non ci sei più non sarà perché mi sono comportato male?
"Non capisci che non posso farcela? Non so chi ne sia capace. Non ce la farò, non sono quel tipo di uomo". Anche se fosse soltanto una canzoncina d'amore, è comunque una protesta di impotenza abbastanza desolante (un'altra mattonata al monumento di John-Lennon-maschilista di You Can't Do That e simili). Ma è lecito il sospetto che sotto covi qualcosa di più irrisolto. L'approccio di John e Paul alla composizione dei testi non è molto diverso dal modo in cui cominciano a comporre canzoni: riutilizzando intere frasi che hanno già sentito sui dischi, rimontandole in modi diversi e aggiungendo qua e là cose mai sentite, inventate lì per lì, pescate dall'inconscio. In seguito Lennon avrebbe negato di aver mai voluto parlare di sé stesso nelle canzoni precedenti al 1965: fino ad allora si sarebbe limitato a montare le parole più funzionali a ogni musica che gli venisse in mente. E però l'inconscio è un bastardo, l'inconscio s'apposta proprio lì dove non te l'aspetti, tu stai semplicemente pensando a come finire la strofa di una canzoncina che farà ballare le ragazze e boom! riveli al mondo che la notte sei un orfano che piange. Forse a posteriori Lennon se n'era reso conto, e la decisione di regalare il pezzo a un altro gruppo (i Dakotas di Billy J. Kramer) corrispondeva a una necessità di allontanare la canzone da sé.
L'anno dopo però i Beatles decidono di tornare sul delitto (che brutta bestia l'inconscio), forse perché la versione di Kramer a John non piaceva, forse perché nel 1964 non c'erano mai abbastanza canzoni da incidere. Il pianto lennoniano viene nascosto in una confezione ancora più dinamica e roccheggiante di quella dei Dakotas. Ringo addirittura accenna un due quarti vagamente ska durante l'assolo, primo caso in assoluto di cambio di tempo in una canzone dei Beatles: non abbastanza per impressionare il regista Richard Lester che la trovava troppo simile a You Can't Do That e così scelse di non includerla nel film A Hard Day's Night. Così il brano finisce un po' defilato nell'EP Long Tall Sally, insieme a tre cover. Negli USA avrebbe ottenuto più attenzioni, uscendo nel Second Album della Capital al culmine della Beatlemania, giusto in tempo per essere ripreso dai Mamas and Papas che aggiungendo coretti e cambi di tempo ne faranno una hit e un cavallo da battaglia dal vivo. E a questo punto il freudometro s'impenna: i "Mamma e Papà" che cantano una canzone di John che piange perché la mamma non c'è più. Cassie dei Mamma e Papà che durante la canzone sussurra: "Oh John" come una Giocasta disperata, e così via. Che brutta bestia l'inconscio, davvero.
175. You Know My Name (Look Up the Number) (registrata nel 1967 ma incisa nel 1970 sul retro del singolo Let It Be).
Magari non avete ancora sentito You Know My Name (vi invidio); magari avete sentito dire che è uno dei brani più divisivi: o lo ami o lo odi. Non è vero, per esempio io amo solo il primo minuto e mi stanco prima dell'ultimo. Almeno una volta McCartney disse che era la sua canzone dei Beatles preferita, perché "è così folle" [insane]. Per alcuni è il capolavoro sconosciuto (per quanto possa essere 'sconosciuto' un lato B dei Beatles); per altri una stronzata senza senso. Hanno tutti ragione.
You Know My Name è quel che succede a un brano di Lennon-McCartney quando Lennon e McCartney si accorgono di crederci poco ma non riescono a smettere di cantarlo, giocandoci fino a trasformarlo nella parodia di sé stesso. La lunghissima storia del brano comincia nell'estate del 1967: John sta aspettando Paul a casa di quest'ultimo, quando sul pianoforte vede l'elenco telefonico di Londra con lo slogan "You know the name, look up the number". Il telefono fisso esercitava un fascino particolare su Lennon, che aveva iniziato a inserirlo nelle canzoni (All I've Got to Do, No Reply) molto prima che arrivasse nelle case della maggior parte degli inglesi. All'inizio You Know My Name è solo una frase musicale nella sua testa, un "mantra", dice lui. L'idea è di farne una cosa "alla Four Tops", ma nessuno dei due compositori sente la necessità di aggiungere una strofa a quello che continua a sembrare un jingle pubblicitario. Anzi già nel primo minuto è chiara la volontà di insistere sul suono delle parole fino a svuotarle di significato: "you, you know, you know my name". Nel primo minuto lo ascoltiamo cantato all'unisono da John e Paul, anzi, dalla versione "soul" di John e Paul: entrambi la urlano con foga e sentimento degni di concetti più profondi. È il momento in cui forse ci rendiamo conto che da qualche parte qua dentro potrebbe davvero esserci una buona canzone. Ma è restata lì. La ripetizione della stessa frase a velocità diverse è un espediente abbastanza raro che torna in un altro dei 'capolavori nascosti' del periodo, Hey Bulldog.
Anni dopo Paul arriverà a ipotizzare che lo scopo di John fosse inviare un messaggio disperato a Yoko Ono, che aveva già incontrato e non sapeva come rivedere: "sai come mi chiamo, cerca il mio numero!" Di lì a poco la situazione sentimentale dei due si sarebbe comunque sbloccata senza bisogno di You Know My Name: e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui fu accantonata. Un altro motivo potrebbe essere che a una session fu invitato Brian Jones... che si portò un sassofono: uno strumento che i Beatles non avevano mai usato e di cui lo stesso Jones non era un virtuoso. Nel '67 presentarsi in uno studio con uno strumento insolito era diventata una disperata tattica di sopravvivenza per Jones, che forse sentiva di non poter più competere come chitarrista coi colleghi di pari rango. Il brano a quel punto prese una piega surreale (o forse l'aveva già presa) non dissimile da quello che stava succedendo negli studi dove i Rolling Stones, abbandonati a sé stessi da Andrew Loog Oldham, conducevano gli esperimenti confusi che avrebbero portato a Their Satanic Majesties Request.
Il mantra del primo minuto viene declinato in stili diversi, forse alla ricerca di quello adatto a ospitare una guest star col sassofono: prima abbiamo la versione ska, forse il primo ska suonato in Inghilterra da musicisti bianchi, anche se lo avremmo sentito soltanto su Anthology 2. Poi abbiamo la versione bossanova, attribuita da un Lennon-presentatore agli "Slaggers, featuring Dennis O'Bell". Dennis O'Bell altri non è che Paul McCartney all'apice della sua gigioneria, e lasciatemi dire una cosa. È facile odiare Paul quando fa il gigione, quando ride di sé stesso e pretende che anche tu lo trovi divertente, ma in questo caso la situazione è così manifestamente una buffonata, e lui così contento di fingersi un crooner baffuto col microfono in mano, che quel minuto e mezzo di vocalizzi ammiccanti è davvero esilarante. Sappiamo che la bossanova è sempre stato un desiderio frustrato di Paul, e che trasformare una canzone dei Beatles in una bossanova era una cosa che gli capitava spesso di fare in studio tra una take e l'altra (durante le session di Get Back! improvvisa lì per lì una Long and Winding Road samba che non è davvero male). Segue una sezione detta 'vaudeville' con Mal Evans che 'suona' una vanga in un secchio di ghiaia mentre Paul e John fanno le vocine con lo stesso senso infantile del divertimento già visto all'opera in Los Paranoias, e finalmente la sezione swing con l'intervento sassofonico di Brian Jones.
Una volta registrata, nessuno sapeva esattamente cosa fare di You Know My Name. Rimase inedita anche quando i Beatles si ritrovarono a corto di materiale e per la colonna sonora di Yellow Submarine ripresero vecchi scarti di Sgt Pepper come Only a Northern Song. Ma più che uno scarto da riciclare You Know appariva forse come una possibilità da esplorare meglio. Viene rispolverata il 30 aprile del '69, quando John e Paul, in una fase complessa del loro rapporto, decidono di riaprire lo scrigno e giocarci ancora un po', mandando appunto Mal Evans a procurarsi una vanga e un bidone di ghiaia. In luglio Brian Jones, ormai estromesso dagli Stones, affoga nella sua piscina. In novembre Lennon decide che You Know My Name sarà il lato B del terzo singolo della Plastic Ono Band (sul lato A un altro buffo esperimento di studio, What's the New Mary Jane). Qualcuno – non sappiamo chi – si oppone formalmente, e alla fine You Know My Name uscirà sul lato B dell'ultimo singolo dei Beatles prima dello scioglimento, Let It Be. Il che rende You Know My Name una delle possibili "ultime canzoni dei Beatles". Non sarebbe neanche il finale peggiore: non con un bang, ma con una risata. Ok, forse una risata tirata un po' troppo a lungo. Ma davvero, è bello ricordare ogni tanto che John e Paul si divertivano. Che non si sono sempre detestati come ai tempi di...
174. Maxwell's Silver Hammer (Lennon-McCartney, Abbey Road, 1969).
"Questa è di Paul – la odio. Mi ricordo solo che ce la fece fare un centinaio di milioni di volte. Fece di tutto per farne un singolo, e non lo è mai stato, e non avrebbe mai potuto esserlo, ma ci mise i suoi inserti di chitarra e fece sbattere a qualcuno dei pezzi di metallo [Ringo picchia con un martello su una vera incudine] e così spendemmo più soldi in quella canzone che in tutto il resto dell'album, penso".
Maxwell's Silver Hammer è la canzone che ha rotto i Beatles. Magari sarebbero morti ugualmente da lì a pochi mesi – non li tieni assieme quattro ventenni superstar quando cominciano a sposarsi – però in questo universo non è stata Yoko e non è stata Linda e i suoi genitori che non si fidavano di Allen Klein, né George che sentiva di avere canzoni migliori: è stato il martello d'Argento di Maxwell (clang clang!), e Paul McCartney che credeva sinceramente di avere scritto una hit. Non era una hit, Lennon l'aveva capito al volo. Non la sarebbe mai diventata ma Paul continuava a farla provare e riprovare, a imporre la sua canzoncina macabra al più grande gruppo della storia del rock. Là fuori intanto stavano succedendo cose. I Cream si scioglievano tra indelebili fuochi artificiali, gli Stones gettavano nel piatto Sympathy for the Devil e Honky Tonk Women, gli Who alzavano la posta con Tommy, insomma ormai quel genere che oggi chiamiamo Rock si era emancipato dai languori adolescenti, la gara tra i gruppi inglesi per suonarlo più forte e meglio era apertissima e nel frattempo Paul si ostinava con le sue canzoni da ospizio/asilo. When I'm 64 era simpatica, Your Mother Should Know un po' ripetitiva, Honey Pie lasciava perplessi, Maxwell's Silver Hammer è il momento in cui persino l'ammiratore di Paul si domanda se ci fa e ci è. Cioè non sei ironico, Paul. Non è quel tipo di rivisitazione del passato che può attirare un pubblico distratto e non particolarmente preso dal rock'n'roll. Non c'è nemmeno più un sapore rétro in Maxwell; non si può nemmeno più giustificare come un numero in costume. Maxwell è semplicemente una melodia che ti frulla in testa e che non ti lascerà in pace finché non te ne libererai – del resto anche Yesterday è nata così, e anche Yesterday all'inizio sembrava qualcosa di assurdo e rischioso.
Maxwell è l'inevitabile errore di percorso di uno straordinario talento naturale che non ha più punti di riferimento – tanto è solitario il percorso in cui si è avviato. Mentre fuori infuria la battaglia tra blues-rock e folk-rock, McCartney insiste ad attingere al vaudeville, a Tin Pan Alley, magari pure alle operette di Gilbert e Sullivan, e a tutto quello che gli suona in testa un grammofono personale. Per quanto riguarda il testo, Paul forse si rende conto di aver esagerato col bozzettismo di Obladì-Obladà e Honey Pie: ma nel tentativo di proporre qualcosa di meno stucchevole, sbanda sul lato opposto raccontando con sorridente serenità la storia insolitamente trucida di un laureando in medicina che col suo Martello d'Argento rompe la testa a una compagna di studi, all'insegnante e al giudice che lo condanna. Non fa ridere, non fa riflettere, lascia perplessi come quella assurda copertina in costume da macellai che tre anni prima Paul aveva insistito per stampare per un disco americano: viene il sospetto che il senso dell'umorismo di Paul sia tarato su una frequenza diversa da quella dei comuni mortali.
Alla morte di Brian Epstein, McCartney aveva preso le redini del gruppo perché dei quattro appariva il più pragmatico, il più responsabile, insomma il più maturo. Non tutto era filato per il verso giusto, ma anche quando perdeva un colpo (il film di Magical Mystery Tour) aveva dimostrato di essere in grado di rialzarsi e ribattere. E finché era in grado di garantire lati A come Hey Jude o Lady Madonna, gli altri tre sarebbero stati folli a non seguirlo. Ma appunto, per continuare a mantenere la sua posizione Paul era costretto a dover sfornare capolavori a getto continuo. Maxwell è un moto di ribellione, forse inconscio: puntando su Maxwell, Paul dimostra ai colleghi di non essere infallibile, firma le sue dimissioni da boss dei Beatles e a quel punto tutto precipiterà abbastanza rapidamente. Bang Bang, Maxwell's Silver Hammer made sure that they were dead.
(Maxwell è anche la canzone dei Beatles in cui irrompe all'improvviso l'inconfondibile suono di un moog, il padre di tutti i sintetizzatori. Non dà fastidio, è in una certa misura un passaggio simbolico: sorge la musica elettronica, i Beatles tramontano).
173. The Inner Light (Harrison, lato B di Lady Madonna, 1968).
"Senza uscire dalla mia porta posso conoscere tutte le cose della terra". Ho sempre trovato abbastanza ironico che l'unico brano dei Beatles non realizzato (del tutto) in uno studio europeo sia una canzone che parla di quanto sia inutile viaggiare, composta peraltro dal Beatle più giramondo e meno eurocentrico: eppure "più uno viaggia, meno uno conosce". The Inner Light, che poteva essere l'inizio di una nuova fase, ne segnò il termine: è l'ultimo pezzo 'indiano' scritto da Harrison per i Beatles. Si ritrovò inciso quasi per caso sul Lato B di Lady Madonna, e poi per molti anni non più ristampato, al punto da godere della reputazione di pezzo meno conosciuto dei Quattro. Eppure quando un anno prima qualcuno aveva chiesto a Lennon se avrebbero ancora inciso canzoni col sitar, Lennon aveva risposto "sarebbe come chiederci quando la smetteremo di suonare canzoni con la chitarra", dando sfoggio di una correttezza politica molto in là da venire. E però il problema c'era: il sitar nei dischi dei Beatles fino a quel momento aveva funzionato da spezia esotica per movimentare pietanze quasi completamente occidentali. Molto presto la spezia avrebbe stancato: cosa sarebbe successo a quel punto: l'avrebbero accantonata o avrebbero deciso di fare sul serio e cucinare pietanze realmente diverse? Già Within You Without You era un evidente tentativo di fare sul serio, anche se confinato in un album di travestimenti.
Nel gennaio del 1968 George è in India, alla ricerca di stimoli per una colonna sonora che gli avevano commissionato e che sarebbe stato il suo primo disco solista. A Mumbai (si chiamava ancora Bombay) incide con musicisti indiani professionisti un raga vero, non un'imitazione alla Beatles; a Londra in febbraio aggiungerà il cantato, ispirato al Tao Te Ching, con qualche coro di John e di Paul nel tentativo di dare una parvenza più beatlesiana a qualcosa che ha davvero più l'aria di un progetto solista. Con questa canzone George arriva a un limite: ora deve scegliere se tornare indietro od oltrepassarlo (e uscire dai Beatles?) Tornerà indietro, con risultati spettacolari e un'ombra di rimpianto: cosa sarebbero diventati i Beatles se nel 1968 avessero deciso di fare sul serio world music? Forse fu proprio l'esperienza indiana a suggerire a George un'inversione di rotta – forse ebbe la sua importanza anche la delusione al termine dell'esperienza nell'ashram del Maharishi. Meno uno viaggia, meno resta deluso.
172. I'm Happy Just to Dance With You (Lennon-McCartney, A Hard Day's Night, 1964).
Before this dance is through I think I'll love you. Può un buon bridge salvare qualsiasi canzone? Ma se compare prima della strofa, è tecnicamente ancora un bridge?
A proposito: tecnicamente cos'è un bridge? Eh, non facile da spiegare. Più facile definire cosa non è: il bridge non è la strofa. Ma non è nemmeno il ritornello, quell'elemento che nel pop moderno diamo per scontato di ritrovare alla fine di ogni strofa, secondo una convenzione che proviene dalla musica popolare (e che invece i primi Beatles usavano molto parcamente, preferendo strutture compositive più classiche, tipiche della musica radiofonica scritta e prodotta a Tin Pan Alley). Se il ritornello è il momento in cui la canzone trionfa, il bridge è un elemento più umile: non vuole trionfare sulla strofa, vuole soltanto distrarci un attimo da essa affinché non ce ne annoiamo, giusto il tempo minimo per farcela di nuovo desiderare. All'inizio compariva una volta sola, ma quando i Beatles cominciano a comporre è già consolidata l'abitudine di ripeterlo almeno due volte, secondo lo schema strofa-strofa-bridge-strofa-bridge. A volte si sviluppa intorno a un accordo in minore, solo per la gioia di rifarci trovare alla fine il tono maggiore (e a volte i Beatles fanno l'esatto contrario).
Può un bridge rubare la scena alla strofa? È appunto quel che succede in I'm Happy. Il bridge è talmente più interessante della strofa che alla fine decisero di farcelo sentire per primo, in quei primi dieci secondi in cui secondo George Martin i Beatles tra il 1963 e il 1964 si giocavano tutto: o ti piace subito o cambi frequenza della radio. Fate pure la prova, provate a saltare quei dieci secondi e ascoltare I'm Happy a partire dalla strofa. Non diventa subito più detestabile? Per Paul era una di quelle canzoni scritte "per assecondare i gusti dei fan", ambientate in quell'universo-balera in cui il massimo del consesso carnale consisteva nel ballare vicini e tenersi la mano. Scritta facile facile per venire incontro alla timidezza di George, I'm Happy è quasi completamente riscattata dal tiro del bridge, che sviluppa le banali premesse della strofa in modo inatteso ma coerente
171. Old Brown Shoe (Harrison; lato B di The Ballad of John and Yoko, 1969).
"Se cresco voglio fare il cantante, indossare anelli in ogni dita". Sepolto (assai ingiustamente) alla centosettantaduesima posizione, Old Brown Shoe è il primo brano che risalendo incontriamo del Blue Album. E allora è il caso di spiegare cos'è il Blue Album (e il suo gemello Red Album), perché a distanza di 40 anni la discografia dei Beatles si è ormai cristallizzata e chi li ascolta oggi su Spotify o altrove non ha difficoltà a identificare i dodici album canonici, mentre il Red e il Blue Album non li trova, magari nemmeno sa cosa siano, il che in fondo è anche giusto, trattandosi di compilation postume: e però sono i due dischi che i Beatles hanno venduto di più negli anni Settanta (un decennio in cui a quanto pare i Beatles, senza esistere, hanno venduto più dei Rolling Stones che facevano quasi un disco all'anno); sono i dischi che hanno formato un'intera generazione di beatlemaniaci, compreso il sottoscritto che ancora prima di farseli prestare da una zia e di rovinarli con puntine scadenti, aveva già buone nozioni di Storia dei Beatles grazie agli autisti delle autocorriere che tenevano il Red Album sul mangiacassette. Il Red Album (disco doppio antologico del periodo '62-66) e il Blue Album ('67-70) con le loro copertine speculari sono stati fondamentali nel trasformare nell'inconscio collettivo di una generazione un catalogo di canzoni in una vera e propria saga: di traccia in traccia senti i Quattro crescere, trionfare, sperimentare, litigare, lasciarsi. In un certo senso il Rosso e il Blu sono il più grande e struggente concept album mai realizzato.
Quando poi sento dire che Old Brown Shoe è sottovalutata, è uno dei 'tesori nascosti' della discografia beatle, resto perplesso: sottovalutato in che senso, un pezzo che si trova nella più storica raccolta dei Beatles? Solo 54 brani su duecentotrenta ebbero questo onore, il che significa che tra Settanta e Ottanta Old Brown Shoe è stata suonata da centinaia di milioni di giradischi in tutto il mondo, assai più spesso di tanti riempitivi dei dischi ufficiali. Se questo non l'ha resa ugualmente una canzone 'famosa', forse davvero Old Brown Shoe non se la meritava e aveva ragione Lennon quando la scelse come lato B del singolo The Ballad of John and Yoko: è un brano che le caratteristiche impalpabili di un lato B, quel tipo di canzone che non troverai mai per caso all'autoradio o mentre fai la spesa al supermercato, quel tipo di canzone che devi andarti a cercare nel tuo scaffale privato. Old Brown Shoe è l'ennesima sottovalutata produzione di George Sottovalutato Harrison in quell'anno di grazia che fu il suo 1969. È una specie di tentativo di rileggere in chiave più rock alcuni stilemi beatlesiani: il gioco tra strofa in minore e ritornello in maggiore, il pianoforte in levare suonato barbaramente da George come una percussione, il gusto per i giochi di parole tra il nonsense e l'alta filosofia. Tutte queste cose che vi piacciono dei Beatles (ci dice George il Sottovalutato), i Beatles potrebbero suonarle anche un po' più dure, come i gruppi che andavano sempre più forte in quegli anni. Il che spiega anche la bizzarra la linea di basso, che negli anni è stata oggetto di un lungo dibattito tra beatlemani: l'ha suonata George o Paul? La cosa buffa è che entrambi almeno una volta l'hanno attribuita al compagno! In realtà non c'è nessun mistero, almeno stavolta: la linea è stata composta da George su quello strano ibrido chitarra-basso che è la Fender VI, e Paul l'ha rieseguita fedelmente, ottenendo il plauso del collega. E in effetti riflettendoci, oltre a non avere le caratteristiche più classiche dello stile bassistico 'squillante' di Paul, è quel tipo di linea di basso che può venire in mente a un chitarrista: notevole ma ingombrante, più efficace nel farsi notare che nel creare un accompagnamento ritmico: è vero che in quegli anni anche Paul ogni tanto ci teneva a dimostrarsi un virtuoso del suo strumento, ma non al punto di rubare la scena, e il basso di Old Brown Shoe fa esattamente questo: si mette in primo piano come un bassista non dovrebbe fare mai. Poi chissà, forse è solo un effetto delle pessime puntine con cui l'ascoltavo a sedici anni, o del missaggio. Lennon odiava il missaggio del Rosso e del Blu (Lennon odiava un po' tutto, negli anni Settanta).
170. Think for Yourself (Harrison, Rubber Soul, 1965).
Think For Yourself non sarà il capolavoro di George Harrison – dopotutto era la sua quarta o quinta canzone – ma è una delle più divertenti da ascoltare, grazie alle trovate strumentali (basso fuzz, organo hammond, Ringo che terzina a tutt'andare) e malgrado il testo saccente e rancoroso. (Più tardi George ammise di non ricordare a chi aveva destinato i suoi moniti severi, "probabilmente al governo"). È uno dei brani su cui si riverbera con maggior lucidità la gioia di vivere e di suonare che pervade Rubber Soul anche e soprattutto quando i testi vorrebbero essere più profondi – a volte più che profondi sembrano imbronciati, ed è spesso il problema di George. Qualcuno avrà già notato che i suoi titoli, messi assieme, sembrano rivelare un atteggiamento piuttosto bipolare nei confronti dell'interlocutore/partner: "lasciami stare", "ho bisogno di te", "ti piaccio troppo", "se avessi bisogno di qualcuno [penserei a te]"... "pensa per te". Non c'è un solo caso in cui la canzone non sia rivolta a una seconda persona dalla quale George sente quasi sempre la necessità di distanziarsi. È un atteggiamento che finisce proprio con Think For Yourself, che in effetti sembra studiata come canzone di commiato: "Fai quel che vuoi fare, vai dove devi andare, pensa per te perché io non ti accompagnerò". Da qui in poi George si preoccuperà principalmente di sé stesso e della condizione spirituale (e del fisco, anche, sì).
Think è significativa anche per quello che succede ai cori. L'idea originale era di registrare le armonie vocali di George, Paul e John intorno al microfono: una soluzione a cui George era particolarmente affezionato. Qualcosa però non funzionava e così decisero di registrare tre tracce separate: anche stavolta un brano di George offriva spazio per sperimentare qualcosa di nuovo. Il risultato è interessante persino dal punto di vista psicanalitico: nel ritornello abbiamo il giovane e inesperto George doppiato in sottofondo da un Paul baritonale che canta le stesse parole sulla stessa melodia come un padre che dice, vedi, la dovresti cantare così, quando sarai grande vedrai che riuscirai a cantarla bene come me. Mentre nella strofa irrompe a sorpresa e a tutto volume un John-soprano, la prefigurazione del John-mamma coi capelli lunghi ancora un bel po' di là da venire. Con genitori adottivi del genere, quanto spazio aveva a disposizione il giovane George per diventare sé stesso?
169. P.S. I Love You (Lennon-McCartney; lato B di Please Please Me, poi nell'album omonimo, 1963).
"As I write this letter, send my love to you". C'è parecchia corrispondenza epistolare nei primi testi dei Beatles: è uno degli aspetti che li rende più datati. Chi sarebbero questi teenager che per dirsi Ti Amo si scrivono lettere? "Tienimi la mano" oggi fa un po' ridere, "stringimi forte" non tramonta mai, ma "post scriptum ti amo" ai miei tempi era quasi surreale, ai miei tempi non si scriveva più nessuno. Lennon era in qualche modo consapevole del problema, quando cercava di infilare in All I've Got to Do o No Reply almeno un telefono. Ma era un'americanata: i fidanzatini inglesi dell'epoca non potevano ancora telefonarsi, in casa un apparecchio con la cornetta ancora non l'avevano, e così... si scrivevano lettere. Lettere anche abbastanza banali, come banalissimo è questo testo che insieme a Love Me Do lascia pochissime speranze sulla futura carriera letteraria del duo Lennon-McCartney: qui davvero ogni verso che ascolti è il verso più banale che ti potrebbe venire in mente per far rima con quello che hai appena ascoltato. "Together", indovinate, anticipa "forever", ed è la rima più difficile della canzone: nelle strofe Paul si limita a rimare "love" con "love", "you" con "you", e quando non sa che altro cantare continua a riempire il bridge di "you you you". Come gli abbiano permesso di continuare a scriversi i testi da soli dopo una simile prova di inanità resta un mistero. Sospetto che a Lucio Battisti, in Italia, abbiano affiancato Mogol per molto meno. E invece bastava dargli un po' di tempo a Paul, e prima poi dalla fontana capricciosa della sua ispirazione sarebbe scaturita... Obladì-obladà. Sì, vabbe'. Magari anche Battisti, a insistere. Chi lo sa.
I testi non sono mai stati la specialità di Paul, mettiamola così. Hanno sempre un che di irrisolto, e certe espressioni che siamo abituati a trovare normali perché le abbiamo appunto ascoltate da lui, ma se ti fermi un attimo a pensarci... Cosa vuol dire "Io credo in Ieri"? Cosa vuol dire "Il movimento di cui hai bisogno è sulla tua spalla"? Cosa vuol dire Maxwell's Silver Hammer, dalla prima all'ultima parola? E allo stesso tempo Paul ha una sensibilità precisa e immediatamente riconoscibile, che si avverte dal primo momento e forse il primo momento è proprio PS I Love You: l'attenzione sincera e priva di snobismo per i piccoli fatti della vita quotidiana, un gusto che in Italia definiremmo crepuscolare. A 21 anni Paul ha già deciso che vuole cantare le buone cose di pessimo gusto, come quelle lettere banali che si scrivono gli innamorati proletari: poche parole e stentate parole, formule artefatte dietro le quali è necessario immaginare un trasporto sincero. PS I Love You non sembra davvero molto diversa dalla lettera stereotipata di un soldato dal fronte, e nel 1963 di lettere del genere erano ancora pieni molti cassetti inglesi. Le armonie vocali del bridge sembrano proprio voler virare la canzone al seppia delle vecchie foto coi contorni irregolari – il titolo PS I Love You lo aveva già usato Bing Crosby, Paul non lo copia ma si atteggia comunque a crooner, con lo stesso mimetismo istintivo con cui i soldati innamorati al fronte componevano frammenti lirici con le poche espressioni letterarie che avevano memorizzato alle elementari.
168. Dig a Pony (Lennon-McCartney, 1969 ma incisa in Let It Be, 1970).
Una delle tante sue canzoni che presto o tardi Lennon avrebbe definito "spazzatura" ("a piece of garbage"): un ritornello che è una professione di amore per Yoko ("Everything has got to be just like you want it to"), una strofa nonsense dove il nonsense ormai ha esaurito la spinta propulsiva di Strawberry Fields e di Walrus, ed è rimasta solo una pigra abitudine a riempire i versi di sillabe a caso, non senza inserire almeno una frecciatina ai Rolling Stones ("I roll a stoney. Well, you can imitate everyone you know"). Tutto qui, davvero? Dig a Pony ha tutta l'aria di non essere mai uscita da una condizione embrionale: è un brano che Lennon non riuscì a completare prima del concerto sul tetto della Apple, e che successivamente non riprese in mano perché non avrebbe avuto più senso. Come I've Got a Feeling, si tratta di un brano pensato e scritto per essere suonato dal vivo: un pezzo di bravura, a modo suo. Lo svela il riff, una fittissima scala pentatonica suonata da John e Paul all'unisono. Malgrado fosse il musicista tecnicamente meno preciso dei quattro (o forse proprio per questo), John era il più incline ai riff sovrabbondanti: vedi I Feel Fine, And Your Bird Can Sing, Everybody's got Something to Hide. Questo rende un po' meno gratuito il riferimento agli Stones: Dig a Pony è l'ennesimo avvertimento. Guardate che ci saremmo ancora, e saremmo ancora i più forti. Anche dal vivo, con le chitarre in mano. Se solo volessimo (ma forse ci è passata la voglia).
167. All I've Got to Do (Lennon-McCartney, With the Beatles, 1963).
Ecco un altro record: su duecento canzoni, credo che sia stata l'unico caso in cui quando sono andato a controllare perché non ricordavo chi l'avesse scritta, ho scoperto che erano stati Lennon e McCartney. Ero convinto che si trattasse di una cover, e in effetti i debiti di Lennon nei confronti di Smokey Robinson sono più evidenti qui che altrove: la melodia è smaccatamente pentatonica e somiglia più davvero allo stile delle cover beatlesiane che a quello delle loro composizioni originali. E siccome sia Lennon che McCartney cominciarono a scrivere canzoni riempiendo, per così dire, i buchi, ovvero ingegnandosi a scrivere una canzone per quelle situazioni in cui non ne trovavano una già scritta, è interessante cercare di capire di che canzone sentisse la necessità John Lennon mentre scriveva All I've Got to Do. Nessuna particolare necessità, si direbbe dalla prima strofa, se non quella di visualizzare una partner completamente succube delle necessità o dei capricci del cantante: se ho bisogno di te, ti chiamo (al telefono!) e tu ci sei. Se ho bisogno di un bacio, ti chiamo ed eccoti qui, la fidanzata come accessorio portatile erogatore di gratificazioni immediate (Mick Jagger ci scriverà decine di canzoni negli anni successivi). Dopodiché però arriva il bridge – e col bridge una sorpresa: "and the same goes for me", canta John con foga genuina. The same goes for me: la stessa cosa vale per me. Se hai bisogno, mi chiami, io arrivo. Ti serve un bacio, eccolo. Perfetta simmetria del rapporto, completa parità dei sessi concepite e cantate nel 1963, su una musichetta pop, da un tizio che quasi per caso non è diventato uno scaricatore nei docks di Liverpool. Quando si dice che i Beatles sembrano un miracolo, ecco.
166. Don't Bother Me (Harrison, With the Beatles, 1963).
Don't Bother Me è la "falsa partenza" di George Harrison, il primo pezzo scritto da lui che poi non ne avrebbe più firmati fino al 1965. La carriera autoriale di George Harrison è uno dei grandi enigmi della storia della musica popolare. Sintetizzando: all'inizio George non è un compositore. Dopo questo primo tentativo (abbastanza promettente) non riuscirà più per parecchio a proporre materiale confrontabile a quello dei due colleghi. Questi ultimi fino a un certo punto mostrano nei suoi confronti una relativa pazienza, rivelatrice del fatto che non lo considerino un vero rivale. Lo assecondano allegramente nella sua 'fase indiana', costruendogli di fatto una specie di ghetto in Sgt Pepper. Nel 1968 la situazione cambia all'improvviso: di ritorno dall'India, Harrison comincia a sfornare canzoni di buon livello, una manciata delle quali sono considerate tra le migliori mai incise dai Beatles. I colleghi, pur non potendo negare il potenziale di While My Guitar o Here Comes the Sun, restano increduli, e anche noi a 50 anni di distanza lo siamo: era già incredibile che due compositori e interpreti di eccezionale talento come John Lennon e Paul McCartney si fossero incontrati in un sobborgo di Liverpool: quante possibilità c'erano che anche il loro chitarrista fosse l'autore di alcune delle più belle canzoni mai scritte nel '900?
La traiettoria di George Harrison diventa da questo punto di vista uno dei grandi argomenti dell'ambiente contro la genetica: Harrison non è nato genio, evidentemente non lo era quando scriveva Don't Bother; lo è diventato a causa delle sollecitazioni dell'ambiente, stimolato dalla prossimità e dalla competitività di Lennon e McCartney. Lo dimostra anche il fatto che il suo apice creativo sia stato raggiunto proprio durante la crisi e lo scioglimento dei Beatles, come documentato da quel monumentale disco solista, All Things Must Pass, che prometteva cose incredibili di là da venire. E invece, una volta allontanatosi dai colleghi, Harrison ha smesso abbastanza rapidamente di scrivere canzoni interessanti, seguendo una parabola non troppo scostante da quella di Lennon, e ritrovandosi verso la fine dei '70 a far uscire dischi per evitare inadempienze contrattuali. Come se il vero motore della creatività di George fosse stato dimostrare di non essere il meno interessante dei Beatles: una volta cessati i Beatles, il problema non si poneva più. Don't Bother Me non è una brutta canzone. Confrontatela con le canzoni che scrivevate voi a 21 anni. Magari se a quel punto vi avessero preso a bordo John e Paul, a 27 avreste potuto scrivere Something. Ma non è andata così, sospetto.
Le canzoni dei Beatles (#200-181)
30-10-2019, 22:36beatles, Il Post, musicaPermalinkLe 250 migliori canzoni dei Beatles (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#214-201)
La playlist su Spotify.
200. Baby It's You (Bacharach-David-Williams, incisa dai Beatles in Please Please Me).
Sha la la la la. Quando glielo chiesero, Burt Bacharach rispose che era un onore, aver scritto un brano ripreso dai Beatles. "È un grande complimento per me, considerate le canzoni che hanno scritto loro". Li incontrò proprio in quel 1963, alla Royal Command Performance, il concerto in onore della famiglia Windsor passato alla storia perché Lennon prima di Twist and Shout chiese alla platea di applaudire e ai palchi di tintinnare la gioielleria. Loro erano ormai i famosi Beatles, lui non era ancora esattamente il famoso Burt Bacharach. Già da qualche anno dirigeva l'orchestra di Marlene Dietrich, che stravedeva per lui. Aveva scritto un paio di successi, ma non era ancora il re Mida dell'easy listening. "C'era qualcosa in loro che è difficile da spiegare. Non l'ho mai dimenticata. Quei quattro ragazzi stavano andando verso una direzione che nemmeno loro conoscevano". Sulla strada per arrivarci si erano imbattuti in questo pezzo delle Shirelles che in Inghilterra aveva appena inciso la loro amica e compagna di tour Helen Shapiro.
Pur pagando il pegno alle convenzioni del pop femminile del tempo, è già una canzone bacharachiana, anche se a questa altezza nessuno forse può rendersene conto, Bacharach incluso. I Beatles se ne impadroniscono senza timore reverenziale – è pur sempre un brano per orchestra, solista e coro! – e senza darsi la minima pena del fatto che sia concepita per un'interprete-personaggio femminile. Ne risulta una versione 'da camera' molto più intima e sincera, una lezione su come in certi casi il Meno possa diventare il Più: niente archi, niente cori riverberanti in lontananza, soltanto chitarre basso batteria e tre voci un po' doppiate. Riducendo la distanza tra voce solista e coro invidioso ("Cheat, cheat") il brano guadagna in intimità: il prodotto pensato a tavolino per un target di ragazzine assume improvvisamente credibilità, diventa qualcosa che i ragazzini potrebbero davvero cantare. Nel 1963 quei ventenni stavano già salendo in cattedra, e i trentenni intelligenti erano già in grado di prendere appunti (molti anni dopo Bacharach e McCartney avrebbero collaborato a un disco di Elvis Costello).
199. Devil in Her Heart (Richard B. Drapkin; in With the Beatles, 1963).
"She's got the devil in her heart", "No, she's an angel sent to me". Di tutti i brani americani ripescati dai Beatles nei dischi fino al '65, Devil in Her Heart è il più sfigato. Quel tipo di canzone che le etichette americane nei primi anni '60 stampavano un tanto al chilo, affidandole a gruppi vocali femminili esordienti. Uno su cento ce l'avrebbe fatta: gli altri 99 sarebbero state inghiottite dal dimenticatoio. Le Donays erano state già completamente digerite dal dimenticatoio quando Janice e Armie Guinn, due delle coriste del quartetto, guardando su ABC l'orrido cartone animato dei Beatles, si accorgono che i Quattro stanno cantando la loro canzone! La stessa melodia, abbastanza banale, sulla più tipica progressione doo-wop; le stesse melense parole, tranne che ora il coro non consiste più in tre ragazze che cercano di convincere la solista a mollare un ragazzo diabolico, ma in tre teddy boy che suggeriscono al solista di svegliarsi, quella tizia ti farà il cuore a pezzi! Gender-swap, ne abbiamo già parlato. Forse non è il caso di enfatizzarlo, ma nemmeno si può sottovalutare il fatto che nei mesi in cui preparavano l'invasione americana, i Beatles setacciassero l'archivio discografico del negozio di Brian Epstein, alla ricerca di brani sconosciuti che rappresentassero la quintessenza dello stile dei girl-group afroamericani. In quelle canzoncine per adolescenti, disprezzate da tutti, c'era qualcosa che li interessava. Qualcosa che col tempo avrebbero imparato a fare meglio, ma intanto non c'era niente di male nel prendere lezioni anche dalle sconosciute Donays. Nel 1963 i Beatles erano un gruppo di giovani inglesi che a volte cantavano come i neri, a volte cantavano come le donne, e a volte – l'abisso! – cantavano come donne nere.
198. Long Tall Sally (Johnson-Penniman-Blackwell; incisa dai Beatles in un omonimo EP nel 1964)
We gonna have some fun tonight. Se dovessimo condensare tutto il rock and roll in una frase, toccherebbe cantarla a Little Richard (scusa Elvis). Però "cantarla" non è la parola. "Stasera ci divertiremo un po'" non è soltanto un atto performativo (il divertimento si compie nel cantarlo): è una formula magica che dev'essere buttata fuori dal corpo con brandelli d'anima e di corda vocale. Questo Paul McCartney lo aveva capito : Long Tall Sally è la sua Twist and Shout, Little Richard il suo spirito guida negli abissi del r'n'r.
La Long Tall Sally originale nacque da una sfida: Richard si sentiva minacciato dal successo che aveva avuto Pat Boone con la cover della sua Tutti Frutti, e voleva un testo che Boone non riuscisse a cantare. Qualcosa di impossibile da urlare a tutta velocità, un nastro di parole da mitragliare sul pubblico ("They saw Aunt Mary comin', so they ducked back in the alley"). Long Tall Sally è una sfida, e McCartney ne riemerge vincitore. "Se non li avessi visti coi miei occhi", disse Richard che li aveva già visti ad Amburgo, "non mi sarei mai immaginato che fossero bianchi". Eppure la leggenda narra che fu lui stesso a insegnare a Paul il segreto del suo urlo (ma Richard usa il falsetto, Paul non ne ha abbastanza). Cantare Long Tall Sally significa alzare a dieci la rotella del tuo volume interiore, lasciare che tutto il sangue del tuo corpo corra tra l'ugola e il seno nasale, e trasformarsi per due minuti nel Dio del rock and roll, che non è bianco (scusa Elvis). Non è cosa che si conceda ai mortali molto a lungo, ma se sopravvivi alla prova tutto ti può succedere, ad esempio il giovane John Lennon può decidere che sei degno di entrare nei Beatles (Paul lo impressionò proprio cantando Little Richard).
È un dono della natura, ma la natura ne è gelosa: di lì a pochi mesi Paul scoprirà di non esserne più in grado. Ancora nel 1969 i compagni lo vedono arrivare ad Abbey Road presto alla mattina per incidere Oh! Darling con appena un'ombra di quel rantolo littlerichardiano. Eppure gli era stato detto: We gonna have some fun tonight. Ci si può divertire "un po'", "stasera", non "per sempre". Non si può invecchiare nel rock'n'roll, nessuno c'è riuscito (Little Richard ci ha provato).
197. A Taste of Honey (Scott-Marlow; Please Please Me, 1963).
I'll come back for the honey and you... A proposito di segni precoci della fine. Please Please Me è un disco inciso in fretta e furia, e in mezzo a tutta questa fretta e furia John non capisce per quale motivo bisogna perdere tempo a registrare una ballata di Broadway. "A waste of money", la chiama, e sembra di sentirlo mentre intona il ritornello storpiato. Se fosse un film sarebbe il primo indizio del dramma che scoppierà a metà secondo tempo: nelle prime sedute del 1963 abbiamo già una prova di forza di Paul, che spalleggiato da George Martin cerca di allargare il più possibile lo spettro delle possibilità musicali, e dall'altra l'aggressività passiva di John, spesso mascherata da pragmatismo economico. Quando sei anni dopo Paul sprecherà chilometri di nastro per incidere Maxwell's Silver Hammer, la censura di John sarà sullo stesso tono: "deve averci perso un sacco di soldi". A Taste of Honey sembra escogitata dall'autore del film per evocare l'aggettivo "melenso". In fin dei conti non è più mielosa di altri brani del disco invecchiati anche peggio (Ask Me Why!), ma lo è in un modo diverso: più professionale? più impersonale? meno giovanile? Dura due minuti secchi, non certo i due minuti peggiori del disco (Ask Me Why!), ma sono quelli che passano più lentamente. Tradisce già un'idea dei Beatles molto più eclettica di quella che si stava concretizzando: non (solo) rocker scatenati, ma interpreti a tutto tondo, in grado di intercettare pubblici imprevedibili: ecco, forse era il brano più continentale. Uscì infatti come singolo in Germania, e stimolò una cover italiana dei Giganti che è forse la cover italiana più interessante dei Beatles (prima di fare quella faccia, pensate ad altre cover italiane dei Beatles interessanti) (ho detto interessanti, non imbarazzanti). La versione strumentale di Herb Alpert si sarebbe poi legata indissolubilmente a Tutto il calcio minuto per minuto, ma solo negli anni '80 e forse sarebbe successo anche senza Beatles.
196. Roll Over Beethoven (Chuck Berry; inciso in With the Beatles, 1963).
Lennon aveva Twist and Shout, McCartney Long Tall Sally; qual è il rock'n'roll 'panico' di George Harrison? È una domanda malposta: George non perde mai il suo aplomb. Comunque la risposta dovrebbe essere Roll Over Beethoven. Una cover il cui aspetto più interessante è proprio l'approccio di George alla musica dei Maestri, molto diversa da quella dei suoi due compagni. John accelera, Paul aumenta il volume: George si rilassa, canta in una chiave più confortevole, scandisce tranquillo le parole dandone un'interpretazione vagamente ironica – sembra di vederlo sorridere. Certo lo aiuta la scelta di Chuck Berry, un rocker molto più tecnico e meno viscerale di Little Richard: più interessato agli incastri di parole che agli urli primordiali, già citazionista nel 1956! Mentre Paul e John sembrano disposti a sputare l'anima per il rock'n'roll, George sembra già deciso a trovare una via per salvarsela. La fascinazione per le culture orientali potrebbe anche partire da qui: malgrado tutto il professato amore per l'Occidente, George non sente il richiamo dell'afroamerica. Il r'n'r gli piace, ma non così tanto. Non urla, non scuote la testa capelluta con la stessa foga autoipnotica. Sta in seconda fila attento a non sbagliare le entrate con la chitarra solista: si preoccupa dei dettagli, e anche quando canta sceglie brani più tecnici, più freddi. Per scoprire l'estasi gli serve qualcosa di diverso, lo troverà.
195. Your Mother Should Know (Lennon-McCartney; Magical Mystery Tour, 1967).
"Anche se è nata tanto tanto tempo fa, tua madre la sa". Pare che McCartney andasse in giro per il set di Magical Mistery Tour con uno "scrupt" che consisteva più o meno in un foglio da riempire con quello che gli sarebbe passato per la testa. Your Mother è forse l'esempio migliore della leggerezza del progetto: un'idea magari interessante, (i Beatles in completo bianco che scendendo da una scala accennando una coreografia da musical), abbastanza adatta alla situazione (uno special televisivo per grandi e piccini), che però... rimane un'idea. Due righe su un foglio: il testo di Your Mother consiste appunto in due righe sul foglio. Perfette per far scendere i Quattro dalla famosa scala, e poi? E poi boh, qualcosa ci inventeremo (durante l'inciso strumentale, nel film, passa l'Esercito della Salvezza) (due volte) (non fanno nulla, passano solo davanti ai Beatles). (Poi ripartono ma nel frattempo sono tornati un po' indietro, così possono rifare lo stesso percorso davanti alle telecamere due o tre volte) (E poi ripassa l'esercito della Salvezza) (e così sono passati tre minuti, ma insomma persino tua madre quel capodanno davanti alla tv meritava qualcosa di più). Non era ancora successo che i Beatles restassero a corto di idee a metà di una canzone.
194. When I Get Home (Lennon-McCartney, A Hard Day's Night, 1964)
Whoa-oh-ah! Il film avrebbe potuto chiamarsi Beatlemania; il disco la cattura al suo apice. When I Get Home è il penultimo brano, e a quanto pare il più debole: ma a più di venti minuti dall'esplosione iniziale, è ancora una perentoria affermazione di vitalità. John non è ancora tornato a casa, ma ormai non sta più nella pelle: guaisce (Whoa-oh-ah!), sfodera un lessico insolitamente ricercato ("I have no time for trivialities"), ha un sacco di cose da dire e da fare, non può stare fermo. Mi piace considerare questo brano, con quello che dà il titolo ad A Hard Day's Night, i primi due suoi testi autobiografici: non più ambientati nel beatleverso dei teenager che si stringono le mani, ma scritti e cantati da un giovane adulto in trasferta di lavoro che non vede l'ora di tornare dalla moglie, di tornare a casa. È un John senza schermi, in una fase in cui si può ancora permettere di abbassarli.
193. Good Night (Lennon-McCartney: ultimo pezzo di The Beatles (il disco bianco), 1968).
A un certo punto della vita ti accorgi che Good Night è un brano di Lennon. Può essere uno choc, ma appena l'orecchio si rassegna alla cosa, di colpo tutto comincia ad avere senso. Anche l'orchestrazione di George Martin, che non è mai sembrato tanto barocco ma anche tanto pericolosamente proiettato verso il muro del suono di Phil Spector. Da ragazzo le cose ti sembrano semplici: se un pezzo è rock, è di John, se un pezzo è roba da nonni, è di Paul. Ma Paul avrebbe mai accettato di addobbare un suo brano come John si fece orchestrare Good Night? Tutto il male che si può dire dell'arrangiamento di The Long and Winding Road, non si poteva già dire due anni prima per Good Night? Una volta McCartney spiegò che una delle cose che non poteva sopportare della Winding Road prodotta da Spector era il coro femminile, e che lui non avrebbe mai messo un coro femminile in un brano dei Beatles. È un dettaglio interessante, sul quale magari torneremo: per quale motivo McCartney non avrebbe accettato un coro femminile su un disco dei Beatles? Ma soprattutto: se le coriste erano un problema, perché ce ne sono in Good Night? A ben vedere si tratta di un precedente che Spector non poteva non avere presente: senza Good Night magari non si sarebbe sentito autorizzato a scritturare cori e violinisti per The Long and Winding Road. Ma forse Paul non si era preoccupato più di tanto dei violini e dei cori di Good Night perché non era roba sua.
Quando accetti che Good Night è di Lennon, che suona proprio come una tipica cantilena di Lennon, cominci a cambiare opinione su Good Night. L'hai sempre trovata una cosa abbastanza terribile, l'ennesima manifestazione gerontofiliaca di Paul McCartney, già spudoratamente espressa pochi minuti prima con Honey Pie. Ma se l'ha scritta John, significa che il Disco Bianco termina con tre brani di John in fila, tre variazioni sul tema della ninna nanna: quella che fa piangere (Cry Baby Cry), quella che fa sbadigliare (Revolution 9), quella che ti chiude gli occhi sul serio: Good Night. Un finale interessante per un lato che era esordito con "Dici che vuoi la rivoluzione": sì, sì, la faremo la rivoluzione, contaci, contami, però adesso a nanna. Paul dorme già da un po', o forse è stato portato a casa.
Viene il sospetto che più di un brano autonomo si tratti di un movimento di quella sinfonia ready-made che è Revolution 9: come se all'improvviso John e Yoko mentre giocano a estrarre rumori da una radio ruotando la manopola della frequenza si imbattano in una stazione misteriosa che trasmette il vecchio pezzo di un crooner dei tempi della loro infanzia. Ma non è più semplice nostalgia dei beati tempi in cui i genitori ci mandavano a nanna: se l'avesse scritta Paul, sì, sarebbe l'ennesima regressione. Invece l'ha scritta John al vertice della sua fase sperimentale, e quindi è qualcosa di più meta, non è proprio nostalgia, è... lo spettacolo della nostalgia, ecco. La scomposizione concettuale della nostalgia, o whatever. Ringo non sta veramente cantando: sta recitando la parte di un crooner che canta (Ringo in quegli anni sembrava avere più un futuro da attore che da cantante).
Quando capisci che Good Night è di Lennon, ti rendi conto che non avrebbe potuto scriverla nessun altro, e che avrebbe potuto essere una canzone meravigliosa. Se invece di trasformarla in una meta-ninna-nanna concettuale l'avesse cantata da solo con la chitarra, o anche senza, da solo, a luci spente, con Julian in braccio. Chi l'ha ascoltata in quelle condizioni (Paul) giura che era incantevole e non è difficile crederci. Ma Lennon non voleva farcela ascoltare così (anche in quei pochi secondi del Wedding Album, sembra imitare Ringo): e tutte le orchestrazioni e i metadiscorsi forse servivano semplicemente a proteggerlo.
192. Words of Love (Buddy Holly; incisa in Beatles for Sale, 1964).
Devo chiedere scusa per avere scritto più sopra che i Beatles non hanno mai inciso una versione davvero memorabile di Buddy Holly: mi ero colpevolmente dimenticato di questa Words of Love, che è nientemeno che l'anello mancante tra Buddy Holly e i Byrds. Con Words of Love Holly aveva per la prima volta raddoppiato la sua voce, armonizzando con sé stesso: una tecnica di cui i Beatles si erano impossessati appena entrati negli studi della EMI. Words of Love era un brano fisso del loro repertorio live: qualcosa che si poteva registrare in fretta in un momento in cui la scadenza del nuovo disco cominciava a farsi vicina. Ne approfittano invece per inventarsi un suono diverso che da mezzo secolo lascia disorientati i beatleologi – anche a causa di un errore di Derek Taylor, che nelle note di copertina sostiene che Ringo stesse suonando una cassa da imballaggio. Secondo MacDonald invece era una custodia di chitarra aperta. Più probabilmente sono le cosce di Ringo schiaffeggiate ritmicamente dalle anellute manone di Ringo. In ogni caso è un espediente che doveva suonare low fi perfino nel 1965, uno dei primi tentativi di far entrare dentro un disco ufficiale l'estetica del non finito, del demo: un'intuizione che tornerà col Disco Bianco e col progetto Get Back. Poi c'è una chitarra che secondo alcuni è una 12 corde e secondo altri no, e io capisco entrambi ma credo che si tratti di una suggestione: le vere corde che suonano parallele sono quelle vocali di... John e George, probabilmente, ma MacDonald ci sente anche Paul e chi siamo noi per contraddire MacDonald? Fatto sta che anche se cantano un tipico contrappunto alla Beatles, non suonano come i soliti Beatles. Un po' perché diversamente dal solito John canta alto e George (o Paul?) basso, un po' perché affettano l'accento texano di Holly ("tell me love is reeaalah"), un po' perché si mantengono sempre rigorosamente a cinque toni di distanza, come due corde parallele. Ne scaturisce un suono che punta già verso la California, anche se partiva dal Texas.
191. Honey Don't (Carl Perkins; incisa in Beatles for Sale, 1964).
Miele, no. Malgrado tutti gli sforzi che tra poco faremo per rivalutarlo – perché davvero, è un disco più interessante di quel che sembra – Beatles for Sale rimane un episodio abbastanza trascurabile nella storia dei Quattro, e Honey Don't è uno dei momenti più trascurabili dell'episodio trascurabile. Insomma è uno dei brani che avremmo dovuto trovare in fondo, molto più in fondo. Un pezzo facile, inciso alla svelta per non complicarsi la vita. Anzi uno dei segni della fretta dannata che avevano era il ridursi a incidere non le solite esotiche cover di un lato B sconosciuto, ma uno dei rockabilly più famosi (comunque un lato B, ma il lato A era nientemeno che Blue Suede Shoes!), un brano che a Liverpool conoscevano già tutti, anzi cantavano già tutti. Lo cantava forse Ringo quando suonava negli Hurricanes; nei Beatles lo cantava Pete Best, e quando fu estromesso passò a Lennon, probabilmente il più adatto a interpretare il cantato istrionico di Perkins; ma in quel momento serviva un pezzo che potesse cantare Ringo, cioè un pezzo facile che si potesse cantare anche suonando la batteria, e niente era più facile di Honey Don't. Non c'era neanche bisogno di scomodare gli avvocati per chiedere i diritti, Perkins lo avevano conosciuto mesi prima e sapevano che era felicissimo di farsi interpretare dai Beatles (deve anche averci guadagnato qualcosa). E così vai con Honey Don't. Canzoni dei Beatles in cui compare la parola miele: A Taste of Honey, Honey Don't, Wild Honey Pie, Honey Pie. Troppo miele per i miei gusti.
190. What You're Doing (Lennon-McCartney; Beatles for Sale, 1964)
Look! What you're doing? Parte Ringo da solo, e se fossimo nel 1994 diremmo che sta campionando Be My Baby delle amiche Ronettes: tum, tu-tum. Ma siamo nel 1964, e quindi Ringo si limita a citarle, infiorettandole anche un po': tum (tatatà), tu-tum (tatatà). Poi arriva George, con quello che è ormai definibile un riff di chitarra: i Beatles stanno iniziando a dare evidenza ai riff. Sono passati pochi secondi e What You're Doing potrebbe essere il capolavoro che manca in Beatles for Sale. Ma poi partono le voci, e fanno qualcosa di ancora diverso, e non del tutto riuscito: "Look!"
Siamo abituati a sentire le voci dei Beatles armonizzare. Sappiamo anche che non armonizzano in modo ortodosso: a volte si scostano anche solo di un semitono, qualcosa che la musica occidentale non autorizza e che li rende unici sin dai tempi di Love Me Do. Ma in What You're Doing si spingono un passo più in là: non armonizzano più, o forse tentano un'impossibile armonia tra il suono e il rumore. Insomma, Paul canta e John no, John sbraita la prima parola di ogni verso, cosa stai facendo John? Sarebbe troppo chiedertelo? Non è che non abbia un senso, soprattutto se uno fa caso alle parole (ormai dobbiamo anche iniziare a far caso alle parole): Paul ha dei problemi con una partner, le cose non vanno come si aspettava che andassero. In seguito diventerà un luogo comune (e produrrà, tra le altre cose, Yesterday e For No One). Ma nel '64 è ancora una relativa novità, e richiede una musica diversa, meno conciliante.
Alla trovata rumorista di John, Paul risponde con un'innovazione complementare, una piccola raffinatezza che però comunica la stessa sensazione di disarmonia: la rima interna. I versi rimano, ma il secondo è un po' più lungo e prosegue dopo la rima! "You got me runnin' / and there's no fun in it"; il tutto asseconda il pessimo umore espresso da John nei primi tre brani dello stesso disco, e contribuisce a fare di Beatles for Sale un oggetto più interessante di quanto il titolo e l'apparente trascuratezza della confezione ci lascia immaginare.
What You're Doing non è un capolavoro, ma è un esperimento utilissimo, forse il gradino necessario per arrivare a cose come Ticket to Ride. Quando ci arriveremo, sentiremo di nuovo la batteria di Ringo in evidenza (ma un po' più originale); di nuovo un riff di chitarra solista, di nuovo qualcosa di dissonante e memorabile. Ah, ecco cosa stavi facendo, John. C'è voluto un po' per capirlo.
189. Every Little Thing (Lennon-McCartney; Beatles for Sale, 1964).
"Sapete qual era un buon pezzo?" Anni dopo, mentre annaspavano nel tentativo di mettere insieme materiale per l'ultima esibizione dal vivo, i Beatles sarebbero tornati con nostalgia ai tempi in cui potevano permettersi di nascondere in dischi raccogliticci gemme come Every Little Thing. (Il momento in cui George e Paul intonano per scherzo Every Little Thing è documentato nei contenuti speciali di Let It Be... Naked).
Tra gli artisti e le loro canzoni c'è un rapporto strano. Ci sono canzoni che ti chiedono quasi tutti i giorni, canzoni che ricordi senza sforzo ma devi fare comunque un grosso sforzo per cantarle ancora senza farti venire la nausea. E viceversa ci sono canzoni che non ti ricordi più; che hai inciso tra le altre ma non hai mai suonato dal vivo. Nessuno te l'ha più chiesta, nessuno te l'ha fatta risentire; non ci fosse il disco, dubiteresti che esistano. Every Little Thing è uno dei brani che è più difficile attribuire a un Lennon o a un McCartney: quest'ultimo nelle interviste tende a rivendicarla (ma ammette di ricordarsene poco), mentre Lennon prendeva le distanze (ma era il suo tipico atteggiamento, negli anni '70: quando difficilmente avrebbe ammesso di aver scritto una bella canzone per l'ex moglie). Gli storici tendono a dare retta a Paul, che lo considera un "singolo mancato" ma Alan W. Pollack, uno dei beatleologi dall'orecchio più fine, riconosce alcune caratteristiche formali tipiche di John (nonché uno dei primi versi liricamente memorabili: "I remember the first time I was lonely without her": l'idea che l'innamoramento nasca in una condizione di assenza della persona amata è lennonianissima). Inoltre la canta John, e questo dovrebbe chiudere il discorso: e se davvero come raccontano le cronache c'era anche Paul con lui intorno al microfono, non c'è dubbio che John la canti con più convinzione.
La strofa ha un incedere inconsueto e trascinante: comincia con la più tipica delle progressioni (La-Re-Mi), e proprio quando pensiamo di aver capito, fa un passo indietro: (La-Sol-Re) per poi passare in Si minore, ed è uno dei passaggi più emozionanti di tutto Beatles for Sale: "Yes I know I'm a lucky guy". C'è un che di inaspettatamente barocco che gli Yes coglieranno. Il ritornello a questo punto delude un po' le attese, ma contiene a metà il punctum di tutto il brano: il doppio colpo di Ringo sui timpani: Pum Pum! (Ringo in Beatles for Sale suona di tutto, dai timpani alle proprie cosce). Every Little Thing infine è quel tipo di canzone che il beatlemaniaco finisce per ascoltare più spesso di Hey Jude o Yesterday, perché... perché di quelle ha paura di stancarsi, e poi le conoscono anche i profani. Invece Every Little Thing è tutta sua. E ogni piccola cosa che fa (pum pum) la fa per me, yeah!
188. Thank You Girl (Lennon-McCartney: lato B del singolo From Me To You, 1963).
"Oh, oh, you". Appena arrivati ad Abbey Road, i Beatles erano già in cerca di un posticino dove fumare. Trovarono una stanza in fondo al corridoio che sembrava un ripostiglio, si accomodarono e poi vennero investiti dal riverbero. Erano entrati nella stanza dell'eco, l'arma segreta degli studi EMI. Thank You Girl è un esempio precoce di come i Beatles amino giocare con gli effetti. Basta sentire nel finale come il coretto "oh oh" cominci a sfuocarsi, come se volesse dilatarsi nella nostra memoria a breve termine e in effetti quell'"oh, oh" è davvero il punctum della canzone, quello che la rende unica e immediatamente riconoscibile. Si sente per pochi istanti all'inizio e alla fine, ed è tutto quello che ti serve sentire per essere sicuro che è Thank You Girl dei Beatles. Preciso ed efficace come un jingle pubblicitario – e la cosa più incredibile è che lo sapevano. Erano ancora quattro ragazzi di provincia che scrivevano canzoni in corriera e avevano già capito come si scrivono i jingle. Stavano deliberatamente costruendo le canzoni intorno ai jingle: Oh Oh sta a Thank You Girl come Come on Come on sta a Please Please Me, come Da da da da da dumb dumb da sta a From Me To You. Sono tutti tentativi sempre più vicini al risultato ottimale, che ovviamente sarà Yeah Yeah Yeah. Anche il resto della canzone è programmaticamente, gioiosamente paraculo: grazie ragazza per aver comprato Please Please Please Me, ti amerò eternamente, e intanto comprati anche questa. John e Paul partono all'unisono; nel secondo verso John mantiene la rotta mentre Paul prende il volo stracciando ancora una volta ogni convenzione armonica. Nel finale, mentre il riverbero si imprime nella nostra memoria, Ringo si concede qualche rullata in libertà, viva Ringo.
187. Hold Me Tight (Lennon-McCartney; With the Beatles, 1963).
It feels so right now! Una volta messe in fila tutte le canzoni dei Beatles dalla numero Uno alla numero Duecentocinquantaquattro, ovviamente mi sono chiesto: qual è l'album dei Beatles migliore? Ovvero quello che sommando la posizione in classifica di tutti i brani ha la media più alta? E ho scoperto addirittura che... non ve lo posso ancora dire. Invece è tempo di svelare qual è il disco più pesante, ossia quello che ha la media più bassa. Si tratta di With the Beatles, il secondo. Ve lo sareste immaginato? In effetti, se ci pensate, è un disco abbastanza opaco. In quella fase i Quattro erano concentrati sui singoli; With the Beatles contiene solo una hit, All My Loving, più alcune cover inessenziali, alcuni brani abbastanza involuti, alcune gemme che sono rimaste un po' nascoste, e il primo caso di avanzo riciclato nella discografia dei Beatles, ovvero Hold Me Tight.
La canzone era l'unica avanzata da Please Please Me, un disco registrato in fretta e furia con tutto quello che si poteva trovare di registrabile nel repertorio – ma Hold Me Tight non era stata accettata, il che ci autorizza a pensare che la selezione per il secondo LP sia stata un po' più lasca rispetto a quella del primo. Le cose non stanno necessariamente così: magari Hold Me Tight era ancora incompiuta ai tempi di Please Please Me (i nastri della prima versione non ci sono arrivati). Magari era troppo estrema, in una fase in cui gli innamorati delle canzoni beatlesiane potevano al massimo tenersi per mano e scambiarsi gli anelli: qui Paul chiede un'effusione un po' più esplicita, vuole essere "stretto forte", propone addirittura di "fare l'amore solo a te". E comunque Please Please Me cominciava già con gli immortali versi "She was just seventeen / You know what I mean", insomma non sono mai state educande questi Beatles, e Paul meno di altri. Hold Me Tight è una delle sue classiche idee che partono in quinta e poi si ammosciano un po' nel ritornello ("You you you you", sembra la classica cosa che canti per fermare la melodia in attesa che ti vengano parole migliori).
C'è comunque un colpo di genio nell'idea di cominciare la canzone con quello squillo di gioia, una richiesta di affetto che non tollera respingimenti: "It feels so right now!" È come se la canzone fosse già cominciata da qualche parte e ci capitasse davanti in medias res. Più tardi ne avremo la conferma: quel "feels so right now" è davvero una passerella che collega bridge e strofa. Un espediente più tipico di John ma che Paul potrebbe avere usato per primo (e comunque la mania di cominciare subito con la frase più potente è un pallino di George Martin).
186. Kansas City / Hey-Hey-Hey-Hey! (Leiber-Stoller-Penniman; Beatles for Sale, 1964).
Charles O. Finley aveva appena rilevato gli Athletics, una squadra di baseball. Non riesco a non immaginarmelo con un cappello alla texana anche se in quel periodo gli Athletics giocavano a Kansas City, Missouri. È per come si comportò coi Beatles durante il secondo tour del 1964: alla fine di ogni concerto si avvicinava a Brian Epstein e alzava l'offerta per un concerto nel suo stadio, finché l'offerta fu così alta che Epstein non poté rifiutare. 150.000 dollari del 1964, l'ingaggio più alto mai offerto a un artista: 1785$ al minuto. E nei primi minuti i Beatles rispolverarono un classico che non suonavano da un pezzo: Kansas City. L'idea di farne un medley live con la Hey Hey Hey Hey di Little Richard era già venuta allo stesso Little Richard, che i Beatles avevano conosciuto durante una sua trasferta a Liverpool e poi reincontrato allo Star Club di Amburgo. È un brano perfetto per le esibizioni live, con quel call-and-response che avrebbe potuto far cantare le ragazze, se soltanto le ragazze avessero smesso per un attimo di strillare; nella versione in studio non contiene un decimo della furia panica espressa da Paul nell'altro classico littlerichardiano, Long Tall Sally. È un brano che alla fine del 1964 si ritrova nella scaletta di Beatles for Sale in mancanza di qualcosa di più fresco. E va bene anche così, anzi, sarebbe stato un finale più interessante di Everyboy's Trying. Dal vivo avrebbe funzionato ancora meglio, se dal vivo ci fosse già stato un sistema per registrare decentemente i Beatles.
185. Don't Pass Me By (Starkey, The Beatles, 1968).
Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue... Uno dei casi più tristi di autoboicottaggio. Ringo la proponeva ai colleghi da cinque anni e finì per registrarla praticamente da solo, con un pianoforte volutamente distorto, un violinista country costretto a non suonare country (una nota sola invece che due), e la collaborazione perplessa di George Martin, la cui introduzione pseudosinfonica (tagliata in sede di missaggio) somigliava a una preziosa cornice di mogano messa intorno allo scarabocchio di un bambino. Il brano meritava di più, Ringo meritava di più, ma i colleghi erano troppo concentrati a marcare i propri territori per dargli un altro piccolo aiuto nel momento in cui ne avrebbe avuto più bisogno.
Nel 1968 i Beatles sono tre compositori maturi più un debuttante, ma Don't Pass Me By non doveva necessariamente diventare il pasticcio fracassone che è diventato. La melodia non è il massimo dell'originalità ma è orecchiabile, il ritornello è trascinante anche se rimane curiosamente incompleto. Digressione personale: la prima volta che l'ho sentita mi è sembrato naturale ripetere "don't pass me bay" nel passaggio tra ritornello e strofa. Mi ero sempre chiesto perché non fosse venuto in mente anche a Ringo – è talmente ovvio. Quando ho ascoltato la prova su Anthology ne ho avuto la conferma: Ringo faceva la stessa cosa che facevo io, anche se lui cantava "Don't make me blue". Lo fa anche in una sua versione molto più tarda (e più professionale). Perché non lo fa nella versione del Disco Bianco? È come sbagliare un goal davanti a una porta vuota, quanto devi essere insicuro per castrarti così? Ipotesi: qualcuno gli deve aver detto che il ritornello in questo modo diventava troppo simile a un'altra canzone (glielo dicevano ogni volta che proponeva una sua melodia). Sì, ma a quale canzone? Non si è mai capito.
Ringo aveva un buon pezzo in canna, ma era il primo a non crederci: e se in teoria le session del Disco Bianco erano il momento ideale per provare un po' tutto, nella pratica i colleghi non avevano nulla da guadagnare dall'eventuale riuscita di Don't Pass Me By. C'era già poco posto per i brani di George: un quarto compositore avrebbe tolto ulteriore spazio e compromesso i fragili equilibri. Ne sembra consapevole lo stesso Ringo, che invece di chiedere un arrangiamento country professionale, si accontenta di un siparietto fracassone, per l'ultimo sketch in cui gioca il ruolo di zimbello del gruppo (Ringo è l'unico autore dei Beatles che dopo una classica scenata di gelosia è costretto a scusarsi: "I'm sorry that I've doubted you, I was so unfair"). E malgrado tutto il pezzo non è inascoltabile. Certo, il violino è frastornante ma la batteria ha quell'allegria fracassona e imperturbabile che è la cosa che amiamo più in Ringo, noi che amiamo Ringo. Non mi ignorate. Non mi fate piangere. Non mi fate blue.
184. Real Love (Lennon; incisa da Harrison, McCartney e Starkey nel 1995 in Anthology 2).
È Real Love una canzone dei Beatles? Vessata questione. Quando uscì, 25 anni fa (ed erano già 25 anni che i Beatles non esistevano più) sembrò a molti un'operazione macabra: un vecchio nastro di Lennon riconfezionato dai tre ex compagni che quell'anno dovevano piazzare un confanetto. La canzone non era male (riascoltandola, è un piccolo miracolo), ma trovare nell'heavy rotation di MTV, tra i Green Day e Alanis Morissette un brano inedito titolato "The Beatles" ti dava la sensazione di trovarti a qualcosa di profondamente sbagliato. I Beatles non esistevano più, nel 1995. Non era giusto che esistessero. Lennon non l'avrebbe voluto. Lennon quella canzone non aveva nemmeno voluto inciderla in un disco suo.
C'è anche da dire che mentre mi sembra impossibile ascoltare Free As a Bird senza essere distratti dal concetto di Free As a Bird (McCartney che scrive un bridge per la strofa del compagno morto), Real Love è una canzone che in qualche modo si riscatta e riesce a prendere il volo da sola. Tutto sommato era già completa nei demo di Lennon; anche l'introduzione-bridge in minore che era facile immaginare come un barocco tentativo di Paul di aggiungere qualcosa di suo, a ben vedere è farina del sacco di John (e non è neanche così barocca infatti, è più romantica, no? Vabbe' non me ne intendo tanto, ma neanche John). Paul in questo caso aggiunge poco e lascia viceversa spazio a George, quello spazio che raramente gli concedeva. La chitarra solista dialoga col cantato di Lennon esattamente come Paul non voleva che George dialogasse col suo cantato ai tempi di Hey Jude. Lo aiuta il fatto che in cabina di regia ci sia Jeff Lynne, fondatore degli Electric Light Orchestra, produttore di George Harrison da un decennio e suo collega d'avventura nei Traveling Wilburys. Lennon anni prima aveva autorizzato per gli Electric Light Orchestra la definizione di "figli dei Beatles", il che rendeva Lynn una scelta quasi obbligata – ancor più nel momento in cui l'operazione non è più riempire i buchi di una composizione monca di John, ma creare per tre minuti un mondo alternativo in cui John non è morto e i Beatles non si sono mai sciolti. Che tipo di musica avrebbero fatto? Se la vedi in questo modo Real Love diventa una scelta sensata: un dignitoso brano che John per qualche motivo non si decideva a incidere da solo (forse era indeciso sul testo o assomigliava troppo ad altri brani di Double Fantasy). Se invece lo avesse portato ad Abbey Road a fine anni '70, gli altri tre cosa ne avrebbero tirato fuori?
Mentre non c'è dubbio che Real Love suoni come una canzone dei Beatles, si fa una bella fatica a immaginare un disco dei Beatles che potrebbe contenerla. Eppure Ringo suona come il solito Ringo, George alla chitarra è proprio George. Ma il punto è esattamente questo: Real Love non è un brano dei Beatles storici, ma dei Beatles di un mondo alternativo in cui avessero continuato a collaborare almeno fino al 1980. La chitarra di George è più harrisoniana che beatlesiana; il cantato di Lennon più rilassato e simile ai suoi classici da solista. Ma anche Lynn non rinuncia a trattarlo come lo trattava George Martin, come lo trattava Paul, come lo trattavano i marinai di Amburgo: più veloce, John, più veloce! il nastro originale di Real Love è accelerato del 12%.
183. All Together Now (Lennon/McCartney, Yellow Submarine, 1968).
A, B, C: can I bring my friends to tea? Fino al 1966 i bambini per i Beatles non esistono, anche quando tra i versi scappa un "little child" è comunque riferito a una teenager nell'età del consenso. Persino Yellow Submarine (la canzone) all'inizio tradiva più un'atmosfera da spogliatoio maschile che da scuola dell'infanzia. L'idea di trasformarla in un cartone animato per bambini non è accolta con particolare entusiasmo da Lennon e McCartney – quest'ultimo sembra più a suo agio con gli anziani, tra When I Am 64 e Honey Pie. È strano, perché c'è qualcosa di intrinsecamente infantile nell'approccio dei Beatles alla musica, qualcosa di barbaro e disarmante. I Beatles giocano coi loro strumenti, con le loro canzoni: li smontano, li rimontano, cambiano le regole del gioco appena cominciano ad annoiarsi. In pubblico sono quattro teenager, in privato quattro giovani adulti con tutti i problemi degli adulti (soldi, famiglie, droghe); ma in sala di incisione sono quattro bambini curiosi e pasticcioni. Forse il motivo per cui non hanno mai davvero provato a scrivere per i bambini è che erano bambini, e i bambini non concepiscono sé stessi come una categoria a parte: i bambini, se scrivono una canzone, la scrivono per tutti (un disegno di una bambina all'asilo per John può diventare un inno all'acido lisergico; Bungalow Bill non è una canzone per bambini, è una canzone di bambini).
Fatta questa premessa, c'è almeno un'occasione in cui i Beatles si sono detti: ok, qui ci vuole una canzone per bambini, scriviamola. Non sorprende che sia di Paul: è il suo tipico approccio, il procedere per pastiche, scimmiottando i generi (senza mai impararli davvero, che è poi quell'approssimazione che lo salva un attimo prima che si trasformi in un compositore professionista, in un adulto insomma). C'era da scrivere la colonna sonora di un cartone animato, e quindi serviva qualcosa del genere. Gli altri non si pongono nemmeno il problema: per Lennon il disco è una scadenza da onorare con la prima canzone che gli viene in mente (e gli venne in mente Hey Bulldog!), per George una valvola di sfogo, o un ripostiglio dove accantonare qualche esperimento sonoro scartato dai dischi più importanti. Paul è l'unico a porsi il problema: come funzionano le canzoni per bambini? Può una canzone essere beatle e per bambini? La risposta a queste domande è abbastanza deludente: per Paul si tratta di accumulare un po' di filastrocche e trascurare gli arrangiamenti. Anche se alla fine quello che rende più godibile All Together è proprio la sua sciatteria fracassona. George Martin in quella sessione non c'era e si sente: quando il gatto non c'è...
182. Anna (Go to Him) (Arthur Alexander; incisa dai Beatles in Please Please Me, 1963).
"Per tutta la mia vita ho cercato una ragazza che mi ami come io amo te. Ma tutte quelle che ho avuto mi lasciano solo e triste, cosa dovrei fare?" La notte che registrarono il loro primo album (perché davvero, lo registrarono più o meno in una notte), Lennon non stava bene. Non stava facendo apposta; non metteva la sveglia presto al mattino per cercare di arrivare negli studi il più roco possibile, come avrebbe fatto Paul verso la fine della storia. Era realmente raffreddato e assolutamente convincente. Please Please Me è un "instant album", una cosa fatta in fretta e imbottita di canzoni che erano passate in classifica pochi mesi prima. Ma al contrario di Chains o Baby It's You, questa è una canzone maschile. Lamentevole, ma maschile. Assistiamo così al primo calarsi di John Lennon nel personaggio del maschio fallito, e la raucedine rende tutto ancora più plausibile. "Lo sai che ti amo ancora, ma se dici che lui ti ama più di me, va' da lui". Anna è il prudente ritirarsi del toro scornato da un toro più grosso; è il vecchio capobranco che abbassa la testa perché sa che non può competere col nuovo pretendente; è il canto antichissimo e sempre lancinante del Maschio Beta che cerca di ritirarsi dignitosamente (e non ci riesce: senti il lieve imbarazzo che ci coglie in quella strofa finale "Just one more thing, girl: give back your ring to me", il rantolo passivo-aggressivo del maschio sconfitto che credeva di avere comprato la fedeltà con un anellino, su quel riff cromatico che sembra davvero mimare l'indecisione, la goffaggine di un tizio che dovrebbe già essersi levato di torno da un pezzo e invece è ancora in pista a ripetere "vai da lui").
Il ricorso massiccio a brani pop di interpreti femminili o comunque ben poco machisti come Arthur Alexander, è qualcosa di più di una mossa paraculo da parte di una r'n'r band in lotta per la visibilità: i Quattro sentono davvero l'inconscia necessità di stemperare un machismo in cui non si riconoscono più. Questo tipo di canzoni se le vanno a cercare, e smetteranno di cercarle quando John sarà in grado di scriverle: I'm a Loser, I'll Cry Instead. Arthur Alexander non riuscirà ad approfittare della visibilità ottenuta, e dopo una lenta traiettoria discendente si metterà a fare l'autista di bus. Neanche scrivere una canzone dei Beatles ti salva da quella sfiga che è la vita.
181. Only a Northern Song (George Harrison; scritta per Sgt. Pepper's, 1967, ma incisa in Yellow Submarine, 1969).
"Se ascolti questa canzone potresti pensare che ora gli accordi sono sbagliati: e invece no, l'abbiamo scritta così". Cosa sarebbe successo se invece di scrivere l'ennesimo atteso e inevitabile capolavoro, i Beatles nel 1967 avessero inciso una canzone brutta? Se ne sarebbe accorto qualcuno? Nel momento in cui erano i cocchi di tutta la stampa, non solo musicale, quanto brutta avrebbe dovuto essere questa canzone perché qualcuno rifiutasse di considerarla l'ennesima manifestazione del Genio? Durante la lavorazione di Sgt Pepper, George Harrison si pose il problema. E se in mezzo a tante canzoni ne infilassimo una deliberatamente brutta, qualcuno se ne accorgerebbe? Non si precipiterebbero a gridare al miracolo, al capolavoro? Proviamoci. (Per quel che ci guadagno di diritti). (La Northern Songs era la società che riscuoteva i diritti d'autore dei Beatles, versandone davvero pochissimi ai Beatles, tra cui George era stato il primo a rendersi conto della fregatura). Nacque così It's Only a Northern Song, che in un primo momento doveva essere il suo contributo a Sgt Pepper, di cui avrebbe reso ancora più evidente il carattere di esperimento sociale: cosa succede se i Beatles per un disco smettono di essere i Beatles? La gente li comprerà lo stesso, li apprezzerà lo stesso, griderà al capolavoro anche se non sono più canzoni dei Beatles?
I maligni potrebbero rispondere che la scelta di scrivere canzoni brutte da parte di George era quasi obbligata: quelle belle non gli venivano. È più o meno quello che pensavano Lennon-McCartney (e George Martin), e in un certo senso non è sbagliato: da I Need You in poi George è quello che cerca di sperimentare di più, nel tentativo di farsi sentire almeno quando stecca. Ma anche le stecche si sarebbero perse in tutto quel caos deliberato che stava diventando Sgt. Pepper, e così Harrison preferì inserirci il suo saggio di filosofia orientale.
Only a Northern Song a quel punto avrebbe potuto finire in Magical Mystery Tour, di cui in effetti interpreta al massimo livello la filosofia: ok siamo i fottuti Beatles, ormai abbiamo capito che vi farete piacere qualsiasi cosa, e quindi noi facciamo qualsiasi cosa senza davvero sbattercene più di tanto. Ma anche in quel caso restò sullo scaffale, perché? Non c'è un perché, davvero, a quel punto nessuno capiva esattamente dove si stava andando. Così alla fine Only a Northern Song si ritrovò nella colonna sonora di Yellow Submarine, di cui senz'altro ribadisce il clima giocoso: ma è comunque un grosso peccato, perché finisce per impattare con l'altra più ambiziosa composizione di Harrison, It's All Too Much, di cui è quasi la parodia. Col risultato che questi due brani (entrambi recuperati da una fase sperimentale che nel 1969 George si era lasciato alle spalle) finiscono per creare una suite cacofonica che allontana l'ascoltatore. Delle due, Only a Northern Song è la più programmaticamente sperimentale, e nel canone harrisoniano andrebbe ascoltata prima della parentesi indiana. È la canzone in cui il piccolo Beatle tranquillo evade dalla musica occidentale per tentativi: cosa succede se sposto una nota, se sbaglio un accordo, se cambio una progressione? Ops, ho rotto il rock'n'roll, beh, vediamo cosa c'è qui fuori.
C'era roba fantastica (continua...)
Renzi 1 – Salvini 1 – giornalisti 0
16-10-2019, 20:05come diventare leghisti, giornalisti, Il Post, Renzi, tvPermalinkAnche se può essere ugualmente teso ed emozionante, un "duello" televisivo non è un vero duello; non è un match, non è una partita. La differenza sostanziale sta nel risultato: un duello è definito dal fatto che non possa che esserci un vincitore. Quando il vincitore non c'è, come in quel film di Ridley Scott, il duello non è davvero finito. Anche nello sport è quasi sempre così (il calcio è un'eccezione). I dibattiti televisivi non sono così, anche quando cercano di vendersi come "duelli", come quello di ieri sera da Vespa. A proposito: secondo voi ha vinto Matteo Renzi o Matteo Salvini? È una domanda retorica, scusate, in realtà non m'importa così tanto del vostro parere. Suppongo che dipenda molto da quanto vi risulta simpatico uno dei due, o a quanto vi stiano antipatici entrambi. Ma il solo fatto che il giorno dopo se ne possa discutere ("chi ha vinto"?) dimostra che non stiamo parlando di un duello – che viceversa è la negazione di un dibattito. Fino a qualche decennio fa spesso serviva a terminarlo una volta per tutte: io dico che tu sei un farabutto, tu neghi l'affermazione, per decidere chi ha ragione ci si vede domattina dietro al convento dei carmelitani scalzi.
(Fermatevi per un attimo, gustatevi l'immagine dei due Mattei in manica di camicia, che si allontanano nella bruma con una pistola in mano, mentre su un lato Bruno Vespa conta i passi. Quello sarebbe stato un duello).
Invece in un dibattito televisivo possono vincere entrambi, anzi; il motivo per cui a volte due politici acconsentono a un "duello" è proprio che entrambi ritengono di poter ottenere qualcosa senza rimetterci molto (non sono mica politici per caso). È più o meno il caso del dibattito di ieri sera: entrambi avevano un'occasione per mettersi in mostra al loro pubblico di riferimento, ed entrambi hanno cercato di impiegarla al meglio. Entrambi ora possono pubblicare sui loro profili social qualche spezzone che dimostri in modo equivocabile ai loro fan che hanno 'asfaltato' l'avversario. Quanto a noi, possiamo anche assegnarci il ruolo di esperti di comunicazione (su internet è gratis), inforcare un monocolo immaginario e cercare di capire/spiegare chi dei due abbia fornito la prestazione migliore. Boh. Quasi quasi direi Renzi: ha rischiato di più, anche perché aveva meno da perdere. Ma a questo punto è chiaro che non stiamo più parlando di una competizione tra i due, quanto di una gara che ognuno stava ingaggiando con sé stesso, e con le aspettative che ormai il pubblico ha nei suoi confronti. Salvini da questo punto di vista ha giocato in difesa, recitando senza sbavature il ruolo di Matteo Salvini: ma non è quello che i suoi elettori pretendono da lui?
E quindi ci troveremmo di fronte a un esempio lampante di gioco win/win: entrambi vincono, entrambi ci guadagnano. E allora perché io spettatore mi sento defraudato? Mi aspettavo davvero che almeno uno stramazzasse al suolo? No, onestamente non ci speravo: queste cose non succedono, da Vespa poi. Però devo ammettere che per quanto basse fossero le mie aspettative, sono rimasto deluso, in alcuni momenti persino disgustato. Non tanto da Renzi e Salvini, che stavano facendo il loro mestiere. Forse nemmeno da Vespa, che si limitava a contare i minuti e a prevenire quei corpo-a-corpo che sul ring diventano anti-spettacolari. Quelli che mi hanno messo davvero in imbarazzo sono i "giornalisti".
Lo scrivo tra virgolette perché la considero una citazione: a un certo punto Vespa ha annunciato che nella seconda parte del dibattito ci sarebbero stati i "giornalisti". Voi li avete sentiti? Uno in effetti a un certo punto ha osato fare una domanda, ma è stata un'eccezione. Gli altri si sono fatti un'ora e mezza di diretta tv per niente e umanamente mi spiace per loro; immagino che sia faticoso rimanere per tanto tempo sotto i riflettori cercando di mantenere un'aria concentrata, contenere gli sbadigli eccetera. Poi spero che abbiano protestato, perché, insomma, che ci sono andati a fare? Già.
E allo stesso tempo, che ci aspettavamo da loro? Cosa avrebbero dovuto fare? Le domande. Quelle scomode, quelle che avrebbero dovuto mettere in difficoltà i due duellanti. Ma come Vespa ha prontamente capito, non ce n'è stato bisogno: i due le domande se le stavano già facendo tra loro e sembravano già abbastanza 'scomode'. Un intervento terzo sarebbe stato ridondante. Renzi e Salvini non solo hanno vinto, ma hanno sconfitto i giornalisti, li hanno ammutoliti. Alla fine anche la loro tacita presenza ha avuto un senso: hanno rappresentato per un'ora e mezza la sconfitta del "giornalismo" da talk-show. Nessuno ha dato loro la parola perché nessuno ne sentiva il bisogno; i politici le domande se le sanno fare da soli.
Ora immagino un'obiezione: forse i giornalisti non dovrebbero semplicemente fare le domande, forse da loro ci aspettiamo qualcosa di più. Il fact-checking? Ho letto qualcuno proporre un fact-checking, magari approfittando dei break pubblicitari per appurare se quanto dicevano i due fosse vero o falso. Sono un po' scettico. Il fact-checking è una cosa delicata: se lo fai in diretta rischi di commettere ulteriori errori davanti a due contendenti che non vedono l'ora di strumentalizzarli. Ma non credo nemmeno che avrebbero accettato un rischio del genere: un tizio super partes che a un certo punto del duello si mette tra i due e si mette a contare per filo e per segno tutte le affermazioni false? Non è così che funziona in tv, perlomeno da noi. Il fact checking si può fare sui giornali del giorno dopo: ecco una delle tante cose a cui i giornali possono ancora servire. Giusto.
E tuttavia.
E tuttavia, davvero possiamo permettere che i politici in televisione affermino tutto quello che vogliono senza che nessuno mai si alzi a chiedere, semplicemente: ma cosa sta dicendo costui? Anche questa è una domanda retorica: Porta a Porta funziona così, e funziona da così tanto tempo che ormai in Italia un'intera generazione, se cambiando canale inciampa in Via col vento, si domanda cosa sia questo film che ha rubato la sigla a Bruno Vespa. Ma in generale i talk italiani sono così. Se vuoi un politico, lo devi ascoltare e al massimo ogni tanto annuire. Se vuoi più azione puoi mandargli contro un altro politico, e a quel punto le domande se le faranno da soli, e anche al fact-checking dovranno pensarci loro. Non è un'iperbole, ieri a un certo punto Renzi ha deciso di interpretare il ruolo di fact-checker di Salvini, con risultati non sempre soddisfacenti: per più di una volta gli ha permesso di affermare serenamente che grazie a lui i morti annegati nel Mediterraneo sarebbero diminuiti. Ecco, quando parlavo di disgusto mi riferivo a cose del genere: possibile che nessuno in quel momento abbia osato chiedergli in che modo li stava contando, i morti annegati nel Mediterraneo? Ormai sappiamo che il famoso "pull factor" non esiste; sappiamo che non basta chiudere i porti (o dichiarare i porti "chiusi") per evitare che la gente in Libia si imbarchi. Quindi Salvini è davvero convinto che basta mandare meno navi a contare meno morti annegati per risolvere il problema? Ovvio che no, ovvio che sta semplicemente prendendo in giro i suoi interlocutori. Davvero nessuno poteva farglielo presente, in quel momento, se Renzi in quel momento pensava ad altro o non voleva insistere? Davvero l'unico limite alle sparate di uno dei due contendenti dev'essere l'attenzione dell'altro? E se a entrambi conviene dichiarare il falso su un argomento?
La cosa più disgustosa è successa alla fine, e almeno su questo livello io posso dichiarare un vincitore: a disgustarmi di più è stato Matteo Salvini che ha chiuso il dibattito facendo con le mani il segno delle forbici, a indicare il trattamento che gli piacerebbe riservare nei confronti dei molestatori dei bambini. Dove il linguaggio verbale non poteva arrivare, il gesto è arrivato forte e chiaro e a quel punto non c'era comunque il tempo, né lo spazio, né l'opportunità di alzarsi e domandare: onorevole Salvini, ma a chi la vuole dare a bere? Lei non castra nessuno. Non ne ha il potere, non ne avrebbe la forza, le mancherebbe il coraggio. Tutto quello che ha osato fare è proporre in parlamento una cosa che dietro un nome minaccioso ("castrazione chimica") nasconde una banale cura ormonale: una terapia che in teoria, solo in teoria, dovrebbe inibire gli atteggiamenti violenti dei maniaci sessuali. Niente forbici, onorevole Salvini, non siamo all'asilo e non ci vanno nemmeno i suoi elettori. Ecco, qualcuno avrebbe dovuto rispondergli così. Non poteva essere il suo avversario, che doveva coprirsi e non poteva rischiare di passare davanti ai telespettatori assonnati come un difensore dei maledetti pedofili. Non poteva essere l'arbitro-presentatore. Avrebbero potuto essere i giornalisti, ma a quel punto forse si erano addormentati anche loro: e li capisco.
Le canzoni dei Beatles (#214-201)
13-10-2019, 20:01beatles, Il Post, musicaPermalinkLa playlist su Spotify!
Lo sapete che fin qui abbiamo scherzato? Sì, abbiamo già messo in fila una quarantina tra le meno apprezzate canzoni dei Beatles, ma a ben vedere erano tutti scarti di produzione, curiosità per gli acquirenti dei cofanetti. Ora si entra nel vivo, ora cominciano i pezzi veri, quelli che i Beatles hanno realmente inciso durante la loro carriera. Sono più o meno 214: qual è il più brutto? Secondo l'opinione abbastanza unanime dei critici la maglia nera va a...
214. Ask Me Why (Lennon-McCartney, lato B del singolo Please Please Me (1963; poi nell'album omonimo).
 I love you, you-you-you-you... La più brutta dei Beatles è una canzone straordinaria. Faceva parte del loro repertorio sin dal 1962; la incisero sul retro del loro primo singolo di successo, Please Please Me, a cui apparentemente non somiglia (è il lento mieloso da suonare per abbracciare la ragazza che ballando Please Please Me ha saltellato fino all'affanno). Ma a ben vedere Ask Me Why esprime la stessa indisciplinata esuberanza, una voglia di strafare persino a livello compositivo (c'è una strofa con due varianti, più il bridge!), un utilizzo particolarmente sagace dei cori, che a volte sostengono il cantato di Lennon e a volte lo lasciano solo, esaltando ad esempio la drammaticità di quel "misery" che torna come un sinistro refrain in questi primi tentativi confidenziali. Sul lato B di Please Please Me doveva servire a dimostrare la versatilità dei Quattro (oltre che a fornire ai giovani ascoltatori un'occasione per stringersi teneramente dopo aver saltellato fino all'affanno col lato A); rimontata nella scaletta del primo LP finisce per risultare il pezzo più molesto e appiccicoso, come un bubblegum finito per sbaglio in una pietanza. Ask Me Why in effetti è uno dei motivi per cui quando hai voglia di ascoltare i Beatles, quasi sempre non scegli il disco di esordio: che pure è straordinario, però... ti lascia quel senso di appiccicaticcio che ci mette un poco a venir via dalla memoria a breve termine. Eppure Ask è un brano tutt'altro che banale, in cui i due apprendisti compositori muovono passi da giganti senza chiedere il permesso a nessun maestro di musica che non si sarebbero ancora potuti permettere.
I love you, you-you-you-you... La più brutta dei Beatles è una canzone straordinaria. Faceva parte del loro repertorio sin dal 1962; la incisero sul retro del loro primo singolo di successo, Please Please Me, a cui apparentemente non somiglia (è il lento mieloso da suonare per abbracciare la ragazza che ballando Please Please Me ha saltellato fino all'affanno). Ma a ben vedere Ask Me Why esprime la stessa indisciplinata esuberanza, una voglia di strafare persino a livello compositivo (c'è una strofa con due varianti, più il bridge!), un utilizzo particolarmente sagace dei cori, che a volte sostengono il cantato di Lennon e a volte lo lasciano solo, esaltando ad esempio la drammaticità di quel "misery" che torna come un sinistro refrain in questi primi tentativi confidenziali. Sul lato B di Please Please Me doveva servire a dimostrare la versatilità dei Quattro (oltre che a fornire ai giovani ascoltatori un'occasione per stringersi teneramente dopo aver saltellato fino all'affanno col lato A); rimontata nella scaletta del primo LP finisce per risultare il pezzo più molesto e appiccicoso, come un bubblegum finito per sbaglio in una pietanza. Ask Me Why in effetti è uno dei motivi per cui quando hai voglia di ascoltare i Beatles, quasi sempre non scegli il disco di esordio: che pure è straordinario, però... ti lascia quel senso di appiccicaticcio che ci mette un poco a venir via dalla memoria a breve termine. Eppure Ask è un brano tutt'altro che banale, in cui i due apprendisti compositori muovono passi da giganti senza chiedere il permesso a nessun maestro di musica che non si sarebbero ancora potuti permettere.213. Misery (Lennon-McCartney, Please Please Me, 1963).
 |
| La tag cloud delle parole di Please Please Me (Ma "Misery" dov'è?) |
 |
| Helen Shapiro nel 1963. |
La inciderà Kenny Linch, un altro ospite dello stesso pullman (era una specie di cantagiro, con una decina di artisti in cartellone). Anche Linch aveva assistito ai tentativi di Paul e John di scrivere canzoni sui seggiolini del pullman, e aveva rapidamente concluso che si trattava di due idioti incompetenti. Stavano scrivendo From Me To You, un'altra numero 1 di lì a pochi mesi. La Misery di Linch invece non arrivò in classifica. I Beatles riprendono il brano durante le eroiche sessioni del loro primo disco, accentuando ancora di più il contrasto tra testo lamentoso e musica trascinante. Perché se come compositori non disdegnano affatto i luoghi comuni del pop più radiofonico, come interpreti vorrebbero mantenere una credibilità rock: il risultato è un fraseggio tipicamente rock'n'roll applicato a una progressione anni Cinquanta (il giro di Do, anzi di Sol). Quasi come mettere l'ananas sulla pizza: non tutti apprezzano, ma in un qualche modo funzionerà.
212. Not Guilty (Harrison, Escher Demo, 1968, ora in Anthology 3)
"I'm not guilty / For looking like a freak, / Making friends with every Sikh..." Not Guilty è il caso più limpido di messaggio privato in forma di canzone in tutto il repertorio dei Beatles, anzi forse era troppo limpida per entrarci davvero, nel repertorio dei Beatles. Nello stesso periodo in cui i colleghi suggestionano i fan con testi enigmatici e deliberati tentativi di confondere le acque ("The walrus was Paul"), George propone una canzone in cui dice chiaro e tondo non si sente colpevole. Di cosa? Di averli portati in India, per esempio; di esserci restato mentre Paul e John trasformavano l'Apple Music in una corte dei miracoli; di essersi scelto una posizione defilata davanti all'imminente disastro. Come dicevano i latini? excusatio non petita... Un analista freudiano avrebbe invece fatto notare che "non colpevole" non è proprio la stessa cosa di "innocente", e che quel "not" è già una mezza ammissione. Not Guilty è una canzone sull'emancipazione: George è entrato nei Beatles a sedici anni, è rimasto per molto tempo il ragazzino del gruppo, ma ora sente di poter parlare da adulto ad adulti.
 |
| George con Ravi Shankar |
Non sappiamo se gli altri abbiano reagito da adulti (Lennon a quanto pare la apprezzava), ma probabilmente fu proprio la sua natura di messaggio privato a condannare la canzone. Il Disco Bianco poteva ospitare pezzi vaudeville e ska e western e heavy metal, ma non tutta questa franchezza. George la riscopre in soffitta soltanto nel '78, mentre sta lavorando alla sua biografia, e la incide in una versione più rilassata, senza più balzani cambi di tempo e nastri rovesciati. È ancora una buona canzone, ma non morde più. Si capisce che ora George non si sente davvero più colpevole.
211. Everybody's Trying to Be My Baby (Carl Prerkins, Beatles For Sale, 1964).
 |
| Irresistibòl |
210. Chains (Gerry Goffin – Carole King; incisa in Please Please Me, 1963).
Ti prego di credermi, le tue labbra sono dolci e mi piacerebbe baciarle, ma sono prigioniero di queste catene. Certe canzoni non soffrono il tempo: sono state scritte più di mezzo secolo fa ma potrebbero essere uscite ieri... non è il caso di Chains, che al contrario sembra una delle più datate del repertorio (e invece era una hit relativamente fresca, scritta l'anno prima dalla premiata coppia Goffin-King che spesso facevano incidere successi alle loro baby sitter, in questo caso un trio chiamato Cookies). Chains non è difficile da ascoltare, ma appartiene irrimediabilmente a un paesaggio sonoro che non è più il nostro. Quel che davvero sfugge alle nostre orecchie contemporanee è la carica eversiva che contenevano i Quattro teppistelli mentre si appropriavano di una canzone come Chains, concepita negli USA per essere cantata da un gruppo femminile. Quel che oggi viene chiamato gender-swap, ed è oggetto di severe recriminazioni, nel 1964 diventerà l'arma segreta dell'invasione americana.
La seconda grande breccia: dopo che Elvis Presley aveva reso possibile il r'n'r bianco, ora i Beatles avrebbero reso bisex la musica dei gruppi vocali femminili. Senza nemmeno cambiare i testi, e operando così una rivoluzione inconsapevole: le "catene" che impediscono alle brave ragazze di baciare chi vogliono ora sembrano funzionare in entrambi i sensi, ora sono i maschietti a cantare che la loro fidanzata li inchioda in catene e tutto sembra stranamente credibile. In fondo sono inglesi, magari in Inghilterra funziona così. In Inghilterra non funzionava affatto così, in Inghilterra John poteva alzare le mani su Cynthia per uno sguardo di troppo, e poi salire sul palco a intonare un coretto delle Cookies: la parità dei sessi è una fantasia che prende forma rimbalzando per equivoco tra le due sponde dell'Atlantico. È la promessa di un nuovo modello di mascolinità che nel 1964 i Beatles non sapevano nemmeno di interpretare. Loro volevano semplicemente cantare tutto quello che volevano, senza barriere etniche o sessuali. Senza vergogna, ecco, oggi si fa fatica a capire ma quei ragazzi che stanno cantando Chains non conoscono più la vergogna. Di non essere abbastanza maschi, di amare le canzoni sdolcinate, di cantare in gruppo, di spettinarsi in pubblico. È una rivoluzione.
209. Dig It (Lennon-McCartney-Harrison-Starkey; improvvisazione del 1969 ritagliata da Phil Spector e incisa in Let It Be, 1970).
"...and the CIA. And the BBC. B.B.King! And Doris Day!" Vi è mai capitato di mettervi a cantare insieme a qualcuno che ha una chitarra e magari conosce solo tre accordi? Ma se sono i tre giusti ci potete cantare Twist and Shout, ci potete cantare La Bamba, Like a Rolling Stone, e tante altre, è un giochino che facevano tutti. Lo facevano pure i Beatles, in studio, quando dovevano suonare qualcosa perché c'erano le cineprese che giravano tutt'intorno, ma non avevano realmente voglia di trovare qualcosa di interessante od originale – a rischio di mettersi a litigare sugli arrangiamenti. Questa in sostanza sarebbe Dig It: una lunga improvvisazione su Twist and Shout che a un certo punto diventa proprio il ritornello di Like a Rolling Stone, suonata il 29 gennaio del 1969 più o meno verso la fine delle inconcludenti sessioni del progetto Get Back. Il senso dell'operazione non era tanto incidere, quanto esibire una certa allegria davanti alla macchina da presa, per un film che a questo punto comunque si sarebbe fatto. La musica non importava, la musica si sarebbe aggiunta poi, come era successo quella volta che avevano messo Lady Madonna sulle immagini delle prove di Hey Bulldog.
Così poco era importante la musica, che al microfono per parecchi minuti fu lasciata indisturbata Heather, la figlia adottiva (e non proprio melodiosa) di Paul. Un anno dopo il film era montato e i Beatles si erano già praticamente sciolti quando Phil Spector, incaricato di setacciare le registrazioni per ricavarne un disco postumo, decide di ritagliare mezzo minuto di Dig It e piazzarlo immediatamente prima del brano che al disco darà li nome, Let It Be. Così ridotta, Dig It non è neanche più una canzone, ma un semplice rimando al film, come quando in una colonna sonora capita di sentire qualche brandello di dialogo. E allo stesso tempo l'operazione di Spector è particolarmente sottile. Il brano scelto ci mostra un Lennon felice di fare quello che ci aspettiamo che faccia (buffi giochi di parole, libere associazioni di nomi e sigle). Spector ha scelto uno dei rari momenti in cui non stanno cantando né Heather né Paul, come un regista che voglia 'stringere' su John un attimo prima di lasciare al collega la ribalta, con quella Let It Be che sarà l'ultimo grande successo del gruppo. In mezzo Spector sovrappone un altro lacerto di registrazione, un annuncio in falsetto di John: "E ora ci piacerebbe fare Hark the Angels Come", un tipico brano natalizio. Let It Be comincia subito dopo, senza un mezzo secondo di pausa.
È nota l'avversione di McCartney per il lavoro di Spector su Let It Be. In tutte le occasioni, Paul ha sempre spiegato che il problema erano le tipiche orchestrazioni barocche di Spector, il muro del suono e i coretti sovrapposti a The Long and Winding Road. Ma anche la decisione di Spector di introdurre Let It Be con questa Dig It, un sarcastico preludio in cui John sembra voler cantare tutt'altro e poi si mette a bamboleggiare, rappresenta un'esplicita scelta di campo: l'impressione è che John si stia divertendo a suonare con gli amici, mentre Paul incide un altro disco zuccheroso per grandi e piccini. McCartney diffiderà Phil Spector: Lennon inciderà con lui altri quattro dischi.
208. Little Child (Lennon/McCartney, With the Beatles, 1963).
I'm so sad and lonely... baby take a chance with me. Le canzoni dei primi due dischi sono ambientate in un universo dai contorni confusi, ma in sostanza coincidenti con quelli di una grande sala da ballo dove potenziali partner si incontrano, si piacciono, ballano assieme. Il massimo dell'emozione è tenersi la mano. Non si beve, non si fuma, insomma corteggiarsi è l'unica opzione e porta abbastanza presto allo scambio di un anello. Un microcosmo francamente non credibile se non sei una teenager, e i Beatles nel 1963 non lo erano più (John aveva già messo su famiglia). È comunque notevole la dedizione con cui riescono a renderlo plausibile, senza mai concedersi sfumature ironiche, senza mai svelare l'ipocrisia, tranne in qualche raro momento di stanchezza, come per esempio... Little Child.
Con Please Please Me i Beatles avevano azzeccato la formula, il giusto dosaggio di ingredienti: rock'n roll del '57 e bubblegum pop del '60. Ma la miscela è comunque instabile, e Little Child è quel che succede quando esageri col bubblegum o ti scappa appena una goccia di Elvis di troppo. E improvvisamente è come se il Lupo Cattivo irrompesse nella discoteca delle pecorelle, ma tutto impestato di farina per sembrare un montone a modo: "I'm so sad and lonely", canta, in falsetto: e le agnelline potrebbero anche cascarci, ma subito dopo gli scappa quel "baby take a chance with me" un'ottava più in basso che puzza di brillantina, di alcool, di sesso. "Little Child" dimostra quanto complicato fosse l'equilibrio che Lennon e McCartney avevano trovato fino a quel momento: bastava un nulla per farlo incrinare. L'avevano scritta semplice e un po' piagnona ("I'm so sad and lonely") perché pensavano di farla cantare a Ringo, ma non convinceva nemmeno Ringo. Così alla fine la cantarono John e Paul, e ti immagini proprio la ragazzina che li guarda perplessa mentre scoppia un bubblegum: sad and lonely, voi due? Le vostre mogli sanno dove passate la domenica pomeriggio?
207. Till There Was You (Meredith Willson, incisa in With the Beatles, 1963)
C'erano uccelli in cielo, ma non li avevo mai sentiti. I Beatles sono eclettici. Lo sono sempre stati, non è vero che fino a un certo punto facevano rock con quattro strumenti e poi hanno scoperto tutto il resto. I Beatles hanno sempre cercato di suonare tutto quello che ascoltavano: l'unico vero limite era l'accessibilità dei dischi, degli strumenti e delle tecniche di registrazione. I Beatles sono sempre stati eclettici perché, banalmente, ad Amburgo e al Cavern dovevano suonare per ore e ore e la gente non si aspettava soltanto i rock'n'roll: la gente voleva i lenti. I lenti erano fondamentali, e se non li sapevi suonare non ti avrebbero pagato nemmeno i rock'n'roll. I Beatles avevano imparato a suonarli. Till There Was You era un disco del 1957 di Peggy Lee che Paul si era fatto prestare da una cugina. Non era un rock, non ci assomigliava nemmeno vagamente; non sembrava nemmeno uno di quei pezzi lenti ballabili che anche i rocker riuscivano a inserire in scaletta senza perdere la loro credibilità. Till There Was You veniva da un musical, un'altra dimensione rispetto a tutte le altre canzoni del loro repertorio, al punto da richiedere per la prima volta una strumentazione diversa: chitarre acustiche e bonghi. Ed improvvisamente è come se da With the Beatles si aprisse un varco verso un nuovo mondo. Till There Was You è la prima canzone che suona davvero diversa dalle altre. Di lì a qualche anno, i dischi dei Beatles diventeranno caleidoscopi di canzoni completamente diverse l'una dall'altra. Till There Was You è stata la prima canzone a prendere un colore diverso.
206. Tell Me What You See (Lennon-McCartney, Help!, 1964)
Apri gli occhi, cosa vedi? Non è una sorpresa, sono io. Tell Me What You See è appena un bozzetto, un'idea anche interessante che Paul non aveva il tempo di sviluppare meglio, in un periodo in cui perdere troppo tempo a sviluppare le idee era controproducente: bisognava uscire con due album all'anno, a volte era meglio piazzarci un bridge qualsiasi e scriverne subito un'altra. Questa in particolare era stata immaginata per la colonna sonora di Help!, ma Richard Lester (il regista) non ne apprezzò l'arrangiamento vagamente caraibico o la strofa armonizzata a due, o semplicemente non seppe dove infilarla; il brano uscì comunque nell'album omonimo, di cui è ritenuta generalmente il più debole. Sì ma "generalmente" in che senso? Come si fa a dire davvero che una canzone è meglio/peggio di un'altra, esiste un metodo di misurazione, uno strumento, un punto di vista oggettivo? E inoltre: come faccio a inserire con così sicurezza Tell Me davanti a Till There Was You e dietro a Bad Boy? Più in generale: come ho fatto a mettere in fila 250 canzoni dei Beatles? Chi mi credo di essere?
Un maniaco, evidentemente.
Ma non così maniaco. Cioè senz'altro mi interessava capire quali fossero le canzoni più o meno apprezzate (dalla critica più che dal pubblico), ma non volevo perderci nemmeno una nottata. Ok, forse una nottata l'ho persa, comunque ho preso tutte le classifiche già pubblicate dai siti specializzati e ho estratto la media (col copia-incolla e Google Fogli è una cosa sorprendentemente facile da fare, eh, soprattutto non voglio passare per quel tipo di maniaco che si scrive tutte le posizioni a penna). Rimaneva fuori la trentina scarsa di pezzi che non erano stati inclusi nemmeno nella classifica più esaustiva. Erano quasi tutti brani di Anthology, per cui li ho messi in fondo alla lista dal più ascoltato su Spotify (In Spite of All Danger) al meno ascoltato (Moonlight Bay). Ed eccoci qui. Tell Me What You See è al duecentoseiesimo posto perché, ad esempio, Ultimate Classic Rock la piazza al numero numero 221, mentre per USA Today è al 146. Interessante, vero? No, per ora non molto. Ma in seguito lo diventa, fidatevi.
205. Bad Boy (Larry Williams, incisa in Beatles VI, 1965).
Now Junior, Behave Yourself! E questa da dove salta fuori? Bad Boy è una cover di Larry Williams incisa dai Beatles per il mercato USA. Come forse già sapete se invece di avere una vita sociale passate le serate a cercare su internet informazioni su musicisti che erano già vecchiotti al tempo dei vostri genitori, la discografia americana dei Beatles fino al 1965 è un caos pazzesco, un altro effetto dello choc culturale causato da un gruppo inglese che invade il mercato americano. Anche se credevano di capirsi, inglesi e americani associavano alle stesse parole concetti diversi; ad esempio il "Long Playing" (LP) inglese, il disco che girava a 33giri e 1/3 al minuto sul piatto, durava perlopiù mezz'ora e conteneva in genere 14 pezzi originali. Non i grandi successi: quelli uscivano come singoli a 45 giri, e si cercava di evitare di riciclarli negli LP.
Negli USA invece gli LP di musica pop duravano un po' meno, erano tarati sui 10-12 pezzi e contenevano anche le hit che uscivano contemporaneamente sui singoli. La necessità di produrre dischi più brevi, e l'opportunità di arricchirli con le hit dei 45 giri, aveva permesso ai discografici americani di gettare in un mercato mai sazio più almeno tre LP beatlesiani all'anno. A metà del 1965 comunque il gioco cominciava a mostrare la corda: in giugno era atteso il sesto disco ufficiale della Capital (Beatles VI), e a disposizione c'era solo qualche primizia dal disco che sarebbe diventato Help!, il lato B di un singolo e gli avanzi di Beatles For Sale scartati dal precedente LP americano. Anche così non si arrivava a dieci tracce, insomma, bisognava aggiungerci qualcosa.
Ai Quattro fu richiesto per la prima volta (e ultima) di incidere qualcosa appositamente per il mercato americano, e la risposta alla richiesta furono due cover di Larry Williams: Dizzy Miss Lizzy e Bad Boy. Vendere vecchi r'n'r agli americani non sembra concettualmente molto diverso da offrire agli eschimesi i frigoriferi – e in effetti ai tempi del disco d'esordio la Capital aveva scartato le cover – ma due anni dopo ormai era chiaro che i Beatles potevano vendere qualunque cosa, e quindi, insomma, rock'n'roll. Dizzy sarebbe poi diventata l'ultimo brano di Help!, motivo per cui in generale la consideriamo l'ultima cover incisa dai Beatles in un LP: il canto del cigno. Ma Bad Boy fu registrata lo stesso 10/5/1965; in Europa si sarebbe sentita solo un anno più tardi, nella compilation natalizia del '66 (Oldies... But Goldies). Quindi sì, potremmo considerarla l'ultimo vero grido d'addio ai Grandi Padri del R'n'R.
Più che appropriato che si tratti di una canzone che parla proprio di sé stessa, di quanto sia losca questa cultura giovanile, questi demoniaci juke-box, questi capelli lunghi (il testo dice, letteralmente va' dal barbiere, sembra il mio nonno). In ogni caso il bad boy sembra più boy che bad: prima ancora che un ragazzaccio è un consumatore perfettamente targettizzato (compra addirittura i "rock'n'roll books" che escono in edicola). Insomma l'originale del 1959 tradiva più di un indizio di autoironia che a Lennon non interessa. Si è sgolato cantando Dizzy e adesso ne approfitta per incendiare la canzone di una foga pre-punk, infondendo alle parole di Williams una sincerità che non aveva ancora messo in quelle scritte da lui: è chiaro che il ragazzaccio è sé stesso ai tempi del liceo artistico (o magari una versione di sé stesso meno miope e insicura), quando non aveva un soldo in tasca ma poteva aggirarsi indisturbato per i sobborghi di Liverpool cercando rogne e sgraffignando armoniche.
204. You Like Me Too Much (Harrison, 1965, Help!).
 |
| Ma sì dai diciamo che non mi dispiaci, ecco. |
203. Not A Second Time (Lennon-McCartney, 1963, With the Beatles).
You know you made me cry, I see no use in wond'ring why. Che pezzo strano. Verso la fine del 1963 il critico musicale William Mann avvertì i lettori del Times che nel finale di Not A Second Time risuonava la stessa "cadenza eolia" che concludeva Il Canto della Terra di Gustav Mahler, in un articolo che in generale riconosceva nei Beatles due o tre compositori intuitivi e originali (ma non li paragonava a Schubert, come si trova scritto un po' dappertutto). Lennon avrebbe ricambiato a modo suo, sette anni dopo, definendo il professor Mann un cazzaro ("bullshitter"), ma riconoscendo che era grazie alle sue astruse parole che il ceto medio riflessivo aveva deciso di farsi piacere i Beatles.
Per capirci: fino al dicembre del 1963 i Beatles in Inghilterra erano una simpatica boyband; dopo l'articolo di William Mann... continuarono a essere una boyband, ma con lo stesso appeal intellettuale che riusciva a conservare Stefano Allevi quando andava da Fazio una volta all'anno. Tanto meglio per i Beatles, ma John non ci cascava e nelle interviste continuava a giurare che sul finale di Not A Second Time stava solo scimmiottando Smokey Robinson, e di non aver mai avuto la minima idea di cosa fosse questa "cadenza eolia". Senza rendersi conto di essere in ottima compagnia: 50 anni dopo si discute ancora di cosa stesse cercando di dire il professor Mann, e se per caso non di fosse confuso con qualche altra canzone dei Beatles.
Per quel che ne ho capito io, "cadenza eolia" potrebbe essere un sinonimo di "scala minore naturale", ma talmente forbito da indurre in soggezione anche i cultori di musica classica: un modo molto complicato di dire una cosa alla fine abbastanza ordinaria, che è quello che spesso fanno gli accademici per far notale la propria competenza ('Lennon e McCartney saranno anche due ignoranti, ma io che li apprezzo so cos'è una cadenza eolia'). Erano peraltro i primi anni '60, il successo di Kind of Blue di Miles Davis aveva riportato in auge la nozione di musica modale. Mann non voleva fare di Lennon e McCartney due intellettuali, ma mostrare che il loro modo intuitivo di fare musica si ricollegava a una tradizione popolare che in epoca moderna l'avvento della musica 'colta', tonale, aveva occultato agli occhi dei critici, ma non alle orecchie della gente. Certo, avrebbe potuto dirlo con parole più facili: ma l'avrebbero preso altrettanto sul serio?
Lascia in ogni caso perplessi che, tra tutte le composizioni originali incise in quell'eroico '63, un critico di musica classica si sia soffermato su quel bozzetto apparentemente incompiuto che è Not A Second Time, dove, più che copiare Smokey Robinson, Lennon sembra volerlo smontare come un giocattolo, salvo poi non riuscire più a riassemblarlo. Anche la sua voce sale e scende su una scala (eolia?) senza trovare pace, passando dal basso all'alto con una libertà che fin qui non si era mai preso. L'intermezzo strumentale è affidato a un pianoforte (George Martin?) che sembra trovare le note con un certo sforzo. È un pezzo veramente molto strano. Abbastanza strano per far chiedere a un critico: ma cosa sto ascoltando? A volte le persone nelle canzoni cercano enigmi da risolvere. I Beatles ci avrebbero messo ancora qualche anno a capirlo: dopodiché, avrebbero iniziato ad accumulare enigmi a non finire.
202. Wild Honey Pie (Lennon-McCartney, 1968, White Album).
I'm lonely, honey pie. A proposito di enigmi: cosa ca**o è Wild Honey Pie? Cosa rappresenta, a parte una prova di forza di Paul, una delimitazione di territorio, una pisciatina di cane? Sì, la conosco la storia, Paul che si mette a giocare in sala di registrazione, Pattie Boyd Harrison che passando di lì dice qualcosa del tipo "Wow, carina", e il risultato è che nel Disco Bianco non c'è Child of Nature, non c'è Junk, non c'è Not Guilty, ma c'è questa roba qui. La conosco la storia, e non ci credo. Sembra una parodia del sodalizio John-Yoko: lui che registra cose a caso, lei che dice "Wow" ed ecco che un accrocchio di note senza senso finisce in un disco dei Beatles. Certo, rispetto a Revolution 9, questa Torta di Miele Selvatico ha un non trascurabile pregio: è breve, meno di un minuto, non vale neanche la pena di premere Skip. E non tenta come Revolution 9 di impressionarti da un punto di vista artistico-concettuale: non è musica concreta, è Paul che gioca con tre strumenti e otto piste. Allo stesso tempo c'è qualcosa di sempre più inquietante nei giochi di Paul, nella sua ostinazione a raddoppiare in scaletta un numero già controverso come Honey Pie; il suo umorismo comincia a diventare incomprensibile, ci stiamo avvicinando a quell'imbarazzante enigma che è Maxwell's Silver Hammer. Ho sempre pensato che quell'improvviso "I'm lonely" tradisse un'inconscia preoccupazione: seduto in cima al mondo, Paul è sempre più solo.
201. Dizzy Miss Lizzy (Larry Williams, 1958; Help!, 1965).

John: "Che c'era di sbagliato in questa?"
George Martin: "Ehm, non era abbastanza emozionante, John".
John: "All'inferno, vieni a cantarla tu allora".
I Want to Marry You. Dizzy Miss Lizzy è l'ultimo pezzo di Help!, è l'ultima cover incisa dai Beatles nella loro carriera (con Bad Boy), è l'ultimo rock'n'roll "d'autore" (benché l'autore nella fattispecie sia il misconosciuto Larry Williams): per riascoltare i Beatles alle prese con un r'n'r bisognerà aspettare tre anni (Back in the USSR) e avremo comunque il dubbio di non trovarci più con un prodotto genuino, ma una parodia, un esercizio di stile, un pastiche.
Dizzy Miss Lizzy invece non ha nulla di parodico: è l'ultimo superstite degli anni Cinquanta, l'ultima manifestazione di quella euforia orgasmica che i Beatles non si erano vergognati di manifestare sui vinile a partire da Twist and Shout e che continua a scoppiare a intervalli sempre più lunghi nei primi cinque dischi, come succede agli orgasmi di una coppia affiatata. La segreta melanconia di Dizzy Miss Lizzy sta appunto in quell'aria di rimpatriata, nell'essere l'ultimo tentativo di far funzionare una cosa che una volta andava fortissimo – e che va ancora fortissimo, con un po' di impegno però, e sempre col pudore di dover fare il ragazzino quando ormai è chiaro anche a te stesso che non lo sei più. La magica sera in cui incise Twist and Shout, John era febbricitante e aveva già la voce a brandelli. Fu buona la prima. Tre anni dopo, per cavargli fuori una prestazione abbastanza emozionante, George Martin deve fargliela riprovare almeno sette volte.
Il risultato è più che buono: la riuscita di Dizzy è di nuovo tutta nella voce trascinante di John. Ma non è ottimo come Twist and Shout, e sarebbe stato ingiusto pretenderlo. Non si può vivere nell'ombra di Twist and Shout e i Beatles non lo fecero. Forse non avrebbero inciso nemmeno Dizzy se la Capitol non avesse voluto un brano in fretta e furia per chiudere l'ennesimo LP per il mercato americano. Quattro anni più tardi sarà Paul a tormentarsi la voce in un ultimo disperato tentativo di riportare indietro le lancette (Oh! Darling).
Le canzoni dei Beatles (#224-215)
03-10-2019, 16:01beatles, Il Post, musicaPermalinkLe 250 migliori canzoni dei Beatles (#254-235)
Le 250 migliori canzoni dei Beatles (#234-225)
La playlist su Spotify!
224. Like Dreamers Do (Lennon-McCartney, provino Decca, 1/1/1962, ora in Anthology 1).
You, you came just one dream ago... Produttore della Decca, chiunque tu sia, fammi un favore, fatti un favore. Questo ragazzino che canta ancora con un vocione alla Elvis, guardalo bene. Ti sembra un po' nervoso? Due notti fa suonava a Liverpool, poi si è fatto dieci ore di pullman per fare questo provino. Hai notato che mentre canta solista suona il... basso? E canta bene, e suona abbastanza a tempo, conosci molti altri che alla sua età ne sarebbero capaci? La canzone magari non ti sembra molto originale, in effetti è il tipico sottoprodotto che poteva realizzare un professionista di Tin Pan Alley negli anni '30-'40, salvo che l'ha scritta proprio questo ragazzo a quindici anni in un sobborgo di Liverpool, senza saper leggere una nota sullo spartito. Poi si è intruppato in una rock'n'roll band, eppure, lo vedi? Riesce lo stesso a imporre il suo materiale fuori dal tempo; in qualche modo riesce a rendere credibile una canzone del genere. Produttore della Decca, andiamo. Se non riconosci un talento in Paul McCartney, in chi?
Ok, è facile col senno del poi. Bisognerebbe trovarcisi, alla Decca, il primo gennaio del 1962, coi postumi della sbornia di capodanno e un certo pregiudizio verso la teppa di Liverpool che si ostina a suonare musica americana con le chitarre – lo sanno tutti che le chitarre hanno fatto il loro tempo. Eppure. L'hai sentita quell'intro? È probabilmente la prima cosa che hanno suonato quel mattino, ancora intontiti e terrorizzati dalla luce rossa che segnala in sala che il registratore sta incidendo. Riavvolgi il nastro. Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan... che accordi sono? Hai mai sentito una canzone cominciare così? Lo capisci quanto coraggio hanno questi ragazzi che tra qualche ora ripartiranno sul loro pullman scassato e non li rivedrai più? (Due anni dopo, quando ormai qualsiasi cosa firmata Lennon/McCartney spariva dai negozi di dischi in poche ore, la Decca fece incidere Like Dreamers Do a un gruppo di ex scout di un sobborgo di Birmingham, gli Applejacks. Per sicurezza tolsero l'intro fulminante e aggiunsero un ottuso riff di piano, e così furono gli unici a non entrare in top10 con un brano dei Beatles).
223. Mailman Bring Me No More Blues (Buddy Holly; incisa dai Beatles nel gennaio 1969, ora in Anthology 3).
Di quanti personaggi si dice "senza di lui non sarebbero esistiti i Beatles", beh, Buddy Holly è uno di pochi per cui possiamo esserne sicuri. La sua influenza su Lennon e McCartney non sta tanto nelle sue intuizioni musicali (che tendevano comunque verso la stessa sintesi di rock e pop che avrebbe fatto la loro fortuna), quanto nella sua immagine pubblica. Il primo nerd del rock'n'roll, con occhiali dalla montatura spessa, un'aria da bravo ragazzo bianco del sud e un approccio sperimentale agli arrangiamenti. Buddy Holly dimostrava che si poteva produrre un rock credibile senza scimmiottare gli afroamericani e senza assumere pose machiste. E soprattutto, Buddy Holly si scriveva le canzoni da solo: nessun altro lo faceva, Lennon e McCartney cominciarono a provarci.
Premesso questo, è un peccato che i Beatles non abbiano prodotto un'interpretazione davvero memorabile di un pezzo di Holly. Quando suonano Mailman durante le sedute del progetto Get Back!, nel gennaio del '69, non ci stanno nemmeno provando. Forse devono semplicemente scaldarsi le dita, gli studi sono freddi e un blues è sempre la prima cosa che viene loro in mente. L'originale di Holly è una canzone più spensierata e radiofonica, ma i Beatles a inizio 1969 hanno questo problema, tipico di chiunque si metta a frugare nel solaio in caccia di vecchi reperti del passato: vogliono i ricordi, ma non sono pronti ad accettarne gli aspetti più sdolcinati e puerili. Rivogliono l'infanzia, ma senza lo zucchero.
 222. Rip It Up / Shake Rattle and Roll / Blue Suede Shoes (medley di brani suonati dai Beatles agli Apples Studio il 26/1/1969, ora in Anthology 3).
222. Rip It Up / Shake Rattle and Roll / Blue Suede Shoes (medley di brani suonati dai Beatles agli Apples Studio il 26/1/1969, ora in Anthology 3).Qui per esempio ci sono tre istantanee prese da un giorno di prove agli Apple Studios, montate assieme trent'anni dopo in un unica foto ricordo. Sappiamo che quel giorno in particolare stavano frugando nel loro repertorio delle origini, forse nel tentativo di ritrovare il bandolo del progetto Get Back. Oppure lo stavano sabotando e questi vecchi r'n'r erano l'unica cosa che riuscivano a suonare senza litigare, in favore della cinepresa. Queste canzoni per John e Paul sono familiari come le preghiere del mattino e della sera: magari all'inizio le prime parole stentano a saltar fuori, ma basta attaccare e tutto viene da sé.
221. If You've Got Trouble (Lennon-McCartney, febbraio 1965, sessioni di Help!, ora in Anthology 2).
"Se hai dei problemi, tu hai meno problemi dei miei". Solo Ringo poteva dire una cosa del genere. E magari non l'ha mai detta, ma avrebbe potuto cantarla. Ma in realtà non aveva nemmeno una gran voglia di farlo. Eppure If You've Got Trouble non è lo scarto orribile che tutti dicono che sia, secondo me. Mi rendo conto di non essere in buona compagnia, anzi in totale solitudine: If You've Got Trouble non è gradita nemmeno dai più pazienti degustatori tra i beatologi. Non piace a Mark Lewisohn. Non piace a Ian MacDonald ("l'unico disastro senza mezzi termini in tutto il catalogo Lennon/McCartney"). Non piaceva a George Harrison, che la trovava assurda e pacchiana. Non piaceva a Ringo, che la canta con scarsa convinzione ("rock on anybody!"), e dire che la canzone era concepita come un veicolo per il suo personaggio: un testo tipicamente lagnoso, affidato a poche note e facili. Non piaceva né a Lennon né a McCartney, che alla fine la accantonarono permettendo a Ringo di incidere su Help! l'ennesimo numero di Carl Perkins, Act Naturally. Invece a me If You've Got Trouble un po' piace. Sincero. La canticchio ogni tanto, del resto ognuno ha i suoi problemi (e i tuoi sono meno dei miei).
Sono convinto che sarebbe diventata una buona canzone, se qualcuno ci avesse creduto un po'. O forse no, forse è una buona canzone proprio perché nessuno riusciva a crederci, e così hanno iniziato a giocarci, a rovinarla montandoci sopra un riff di chitarra così spigoloso e insistito che nel 1965 doveva risultare oltre il limite dell'ascoltabile, e invece oggi suona quasi new wave. Per tacere di quel minuscolo coretto, appena un cenno di assenso, "ah-ah", che parte da una quarta e scivola di un semitono, qualcosa che forse non si era ancora sentito in un pezzo rock. Il testo è uno dei primi a collocarsi fuori dal limitatissimo beatleverso delle canzoni pre-Rubber Soul, popolato esclusivamente da teenager innamorati. Stavolta Ringo è tartassato da una ragazza di buona famiglia che pretende regali, "money and things", ma i milioni non hanno tolto a Ringo il buon senso e quel briciolo di coscienza di classe: tu ci provi gusto a comportarti male, dice, con tutti i privilegi che hai avuto su di me. Probabilmente non avrebbe reso Help! un disco molto migliore, ma è una canzone che getta un lampo di luce sulle frustrazioni di quattro proletari-milionari immersi in un bel mondo di ricchi veri che fingono di avere più problemi di loro. Probabilmente è di John, che non l'ha mai reclamata.
220. How Do You Do It? (Mitch Murray, incisa a Abbey Road nel settembre 1962; ora in Anthology 1).
Ma come fai a fare le cose che mi fai? Se sapessi come fai te le farei. ReSettima! Una volta messi a contratto i Beatles, George Martin si era messo a cercare un brano adatto a loro, che li mandasse più in alto possibile in classifica. Tutto quel che aveva trovato era How Do You Do It? di tale Mitch Murray, un compositore abbastanza conosciuto nell'ambiente. Il brano che era già stato scartato per esempio dai Tremeloes (il gruppo che la Decca aveva preferito ai Beatles, probabilmente per una considerazione logistica: vivevano più vicino a Londra). Per Martin How Do You Do It avrebbe fatto il botto, i Beatles la odiavano. Il nonsense lievemente malizioso del testo non li intrigava. Come facciamo a tornare a Liverpool dopo aver inciso un brano così, pensava Paul. Avevano suonato pezzi anche più mielosi al provino della Decca, e altri ne avrebbero suonati di lì a poco, ma in quel preciso momento How Do You Do It sembrava davvero troppo teenpop per loro.
Alla fine, com'è noto, George Martin si lasciò convincere dai Beatles a incidere il loro materiale, e in particolare Please Please Me; una decisione che permise a Lennon e McCartney di diventare i compositori di sé stessi, cambiando la storia della musica leggera. Quel che è meno noto, è che prima di abbandonare How Do You Do It i Beatles fecero di tutto per farsela piacere. Non la rispedirono al mittente come bambini capricciosi; tentarono di trasformarla in qualcosa che potevano suonare senza perdere la dignità, aggiungendo le armonie vocali che Murray non aveva previsto, e soprattutto quell'accordo, spiazzante e riconoscibilissimo, che tutte le fonti definiscono un Re7 ma potrebbe già essere qualcosa di più dissonante, a interrompere la placida e banale progressione anni '50 della strofa ("I'd do it to you. Re7!"). Lo senti già nell'introduzione ed è davvero il punctum di tutto il brano, quello che te lo fa riconoscere al primo colpo e che lo distingue da centinaia di altri brani quasi uguali. Murray quell'accordo nel demo non l'aveva previsto: ha tutta l'aria di una trovata di John, una virgoletta aperta a mezz'aria che trasforma tutta la canzone in una presa in giro di sé stessa. George Martin aveva visto giusto: How Do You Do It, scartata dai Beatles e affidata a Gerry and the Pacemakers sarebbe arrivata in cima alla classifica inglese dei singoli. Ma anche la versione dei Pacemakers riprende l'arrangiamento escogitato dai Beatles, con quel Re7 un po' meno evidente ma ancora fondamentale. Solo i Beatles sapevano come fare le cose che sapevano fare.
Le canzoni dei Beatles (#234-225)
20-09-2019, 22:00beatles, Il Post, musicaPermalinkLe 250 migliori canzoni dei Beatles (#254-235).
(La playlist #234-225 su Spotify).
234. That'll Be the Day
 You say you're gonna leave, you know it's a lie / 'Cause that'll be the day when I die. Secondo la leggenda (avvalorata dal film Nowhere Boy), That'll Be The Day sarebbe stata registrata il 15 luglio 1958, pochi giorni dopo la morte di Julia, la madre di Lennon, in un incidente stradale. I 15 scellini necessari per stampare il disco di lacca sarebbero stati l'ultimo regalo di Julia al figlio. Come facciamo a sapere che è una leggenda? Colin Hanton, il batterista, ricorda una giornata gelida, tanto che era entrato nella piccola sala di registrazione con una sciarpa e l'aveva usata per attutire il rullante quando il proprietario della sala si era lamentato per il rumore.
You say you're gonna leave, you know it's a lie / 'Cause that'll be the day when I die. Secondo la leggenda (avvalorata dal film Nowhere Boy), That'll Be The Day sarebbe stata registrata il 15 luglio 1958, pochi giorni dopo la morte di Julia, la madre di Lennon, in un incidente stradale. I 15 scellini necessari per stampare il disco di lacca sarebbero stati l'ultimo regalo di Julia al figlio. Come facciamo a sapere che è una leggenda? Colin Hanton, il batterista, ricorda una giornata gelida, tanto che era entrato nella piccola sala di registrazione con una sciarpa e l'aveva usata per attutire il rullante quando il proprietario della sala si era lamentato per il rumore.Hanton potrebbe anche ricordarsi male, così come voi magari non ricordate bene quando avete inciso questo o quel nastro con la vostra band di trent'anni fa (che però non è diventata la più famosa al mondo). Il vero motivo per dubitare dell'aneddoto è che combacia quasi perfettamente col testo della canzone: mi hai dato tutti i tuoi abbracci e i baci e anche i soldi. Il giorno che mi lascerai sarà il giorno in cui piangerò, sarà il giorno in cui muoio. Cose che succedono al cinema, più che nella realtà.
That'll Be the Day è uno dei due pezzi incisi dai Quarrymen presso il piccolissimo studio del signor Phillips, il retrobottega del suo negozio di dischi e giradischi. Gli acetati avevano il grosso difetto di deteriorarsi dopo pochi ascolti: i professionisti li usavano per incidere demo da sottoporre ad altri artisti, i dilettanti per creare un bel ricordo da conservare, più che riascoltare. I cinque Quarrymen si mettono d'accordo per conservarlo una settimana a testa: John lo tiene la prima settimana, poi lo passa a Paul che dopo una settimana lo passa a George che dopo una settimana lo passa a Colin che dopo una settimana lo passa a John "Duff" Lowe, che lo infila da qualche parte e se lo dimentica vent'anni... per poi cederlo al milionario Paul McCartney in cambio di una cifra che non è mai stata resa nota. Ora lo possiamo ascoltare tutti gratis su Internet. In mezzo a un baccano abbastanza ordinario, la voce di John è già inconfondibile.
233. Bésame Mucho (Velázquez; incisa nel 1962 durante il provino della Decca)
Cha-cha-boom! Se ora fate partire la Bésame dei Beatles su Spotify, e subito dopo cominciate a cercare tutte le Bésame Mucho su Spotify, finirà la canzone prima che riusciate a visualizzarle tutte, volete provare? Sennò fidatevi. La leggenda più diffusa su Bésame Mucho è che l'autrice, quando la compose (a 24 anni) non era ancora stata baciata, né mucho né poquito: nada de nada, povera Consuelo Velázquez. Paul mentre canta non suggerisce la stessa inesperienza, anzi si atteggia a crooner consumato e in effetti un dettaglio comune di molte cover di quel provino (alcune abbastanza improbabili) è che presuppongono nell'interprete un carisma da latin lover. The Sheik, Bésame, la stessa Ain't She Sweet che era pur repertorio di Sinatra. E siccome a scegliere i pezzi fu Brian Epstein, viene spontaneo domandarsi: l'ha fatto apposta? Sul serio stava cercando di lanciare quattro teddy boy di Liverpool calcando sul loro sex appeal? O semplicemente si fidava del suo gusto, e il suo gusto lo portava in una direzione un po' più camp di quella che poi i Beatles avrebbero preso?
Bésame i Beatles avevano iniziato a suonarla ad Amburgo, in una fase in cui erano juke-box viventi e l'eclettismo, durante concerti che duravano due o tre ore, più che una scelta estetica era una necessità. Il brano arriva alla Decca perfettamente rodato, e se ci sembra assurdo è appunto perché i Beatles lo lasciarono a quel bivio; ma se alla Decca fossero piaciuti, chissà.
232. In Spite of All the Danger (McCartney-Harrison; registrato su acetato dai Quarrymen nel 1958; ora in Anthology 1).
Malgrado tutto il pericolo, malgrado tutto quello che potrebbe succedere, farò qualsiasi cosa per te. In Spite of All the Danger è incisa sull'altro lato del disco 78giri in acetato prodotto nello studio del signor Phillips in un giorno imprecisato del 1958. Se vi sembra assurdo che questa istantanea sfuocata di 60 anni fa sia di gran lunga il pezzo più ascoltato su Spotify tra tutti quelli che abbiamo passato in rivista fin qui, considerate che è inciso sul disco più raro e quotato mai esistito. Ed è in assoluto la prima canzone originale dei Beatles... che non si chiamavano ancora così: diciamo che è la prima canzone originale di Paul McCartney, anche se una scritta a pennarello sulla label dell'acetato reca la dicitura "McCartney-Harrison", in quanto quest'ultimo era l'autore dell'assolo di chitarra. Lo stesso Paul poi sta smaccatamente ricalcando un pezzo di Elvis Presley che ha ascoltato a un campo scout, Tryin' to Get to You: la melodia è praticamente identica, anche il testo è simile. Nel 1958 Paul non ha ben chiaro il concetto di proprietà intellettuale: crede che le canzoni siano di tutti, e se decide di cambiare le parole probabilmente è perché non si ricorda il testo di Elvis né è riuscito a procurarsi il disco o lo spartito. Non ha nessuna velleità autoriale, per ora: non sta cercando neanche di sembrare originale. Ci riesce lo stesso.
Quel che rende In Spite una canzone diversa, non già beatlesiana ma nemmeno così presleyana, è l'intreccio vocale. Lasciando perdere il batterista, che suona troppo lontano dal microfono, i Quarrymen consistono di tre voci e tre chitarre che suonano gli accordi praticamente all'unisono, salvo il momento del non esaltante assolo. Magari il "muro di chitarre" era l'unico sistema per farsi ascoltare alle feste senza amplificatori, ma nello studio del signor Phillips di tanto baccano non c'è bisogno, è ridondante. Per contro, le tre voci sono già alla ricerca di armonizzazioni sofisticate (il che non significa che le trovino).
L'altro motivo per cui In Spite negli ultimi anni è diventata così popolare potrebbe essere la versione filologicamente correttissima contenuta nel film Nowhere Boy, un esempio clamoroso di potere del cinema, anche mediocre. Nowhere Boy non è un capolavoro, e il modo in cui utilizza In Spite per farci piangere non ha nulla di originale: è un banale montaggio di immagini di Julia Lennon, di John che balla con lei, che si ricorda di lei, che canta questa canzone evidentemente a lei. Funziona benissimo anche se non è vero niente: la canzone è di Paul, non ha nulla di strappalacrime in sé, John la canta con partecipazione ma non fa ancora spettacolo dei suoi sentimenti.
231. You Know What To Do (Harrison; outtake del 1964; ora in Anthology 1).
So if you want me just like I need you... You Know What to Do è la canzone che per poco non ha stroncato la carriera compositiva di George Harrison. Forse. Quel che è sicuro è che George era già stato accettato come terzo compositore dei Beatles nel loro secondo LP, che ospitava Don't Bother Me, incisa nel settembre del 1963. Per ascoltare una sua nuova creazione (I Need You) i fan avrebbero dovuto aspettare il febbraio del 1965: nel frattempo altri due album erano usciti senza brani firmati da George. Cosa lo aveva bloccato?
Secondo George Martin, Harrison si era scoraggiato quando "nessuno di noi aveva apprezzato una cosa che aveva scritto". Ora, l'unica "cosa" di Harrison che conosciamo tra il 1963 e l'inizio del 1965, è appunto You Know What to Do, registrata in fretta un giorno prima di partire per un tour, con Paul al basso e forse John al cembalo (Ringo era malato); non sembra onestamente questo orrore di canzone. Se la strofa è abbastanza banale, nel bridge incontriamo forse il primo accenno di descending bass line, un trucchetto che Paul saprà sfruttare meglio in Michelle, intorno al quale John costruirà Cry Baby Cry e lo stesso George farà risplendere in While My Guitar. Insomma, bastava insistere: e invece George si bloccò. Non doveva essere sempre facile lavorare con la ditta Lennon/McCartney. Questi ultimi a dire il vero stavano entrando in una breve fase di stallo creativo che li avrebbe portati, pochi mesi dopo, a consegnare alle stampe il loro disco più involuto: Beatles For Sale, con una sola hit, qualche esperimento e diverse cover poco interessanti. You Know What To Do non avrebbe abbassato la media più di tanto, ma George si era bloccato. Just call my name if you're lonely...
230. That Means A Lot (Lennon-McCartney; outtake del 1965-66, ora in Anthology 2).
C'è un cartoon divertente in giro per internet (oddio forse è divertente soltanto per i beatlemaniaci), comunque in questo cartoon ci sono Paul e John intorno a un microfono che fanno un duello di composizione mentre in cabina siedono George, Ringo e George Martin. Sulla stessa base Paul canta That Means A Lot e John Ticket To Ride: alla fine tutti votano per John, e Paul si mette a piangere. Ok. In effetti la progressione di That Means A Lot assomiglia un po' a quella di Ticket To Ride, soprattutto nelle prime versioni. Ma non c'è mai stata una gara del genere: quando Paul propose That Means A Lot, il brano di John era già stato completato. That Means A Lot, scrive Ian MacDonald, è un raro esempio di Lennon e McCartney che brancolano nel buio: cercano un motivo, si accorgono che è troppo simile a qualcosa che hanno appena registrato, provano a modificarlo, ma non funziona niente, proprio come succede ai comuni mortali. That Means A Lot non solo somiglia troppo a Ticket, ma ne tradisce tutti gli aspetti rivoluzionari: è un passo indietro dopo un grande salto, un incidente. Ascoltarla è farsi un'idea su cosa sarebbero diventati i Beatles se invece di spingere continuamente sull'acceleratore avessero deciso di calmarsi un po' e presidiare i territori già esplorati. Probabilmente non era un'opzione praticabile: l'unico modo per restare in piedi era continuare a correre.
229. Junk (McCartney, Esher Demo, 1968; completato poi nel primo disco di Paul McCartney, McCartney; la prima versione si trova in Anthology 3).
 Cianfrusaglie. Ci sono brani dei Beatles che parlano di sé stessi; Junk parla dei tesori che lasciamo marcire in solaio o in cortile e a risentirla su Anthology sembra esattamente questo: ciò che rimane di un tesoro abbandonato. Il brano è già praticamente completo durante la prima session informale del 1968, quella in casa Harrison in cui i Quattro portano tutto quello che hanno composto prima e durante l'esperienza indiana, si rendono conto di avere già materiale per più di un LP e decidono che 'pubblicheranno tutto', ovvero che il prossimo album sarà doppio. Ma non è vero che pubblicheranno tutto, per esempio accantoneranno Junk come cianfrusaglia, e non è semplice capire il perché.
Cianfrusaglie. Ci sono brani dei Beatles che parlano di sé stessi; Junk parla dei tesori che lasciamo marcire in solaio o in cortile e a risentirla su Anthology sembra esattamente questo: ciò che rimane di un tesoro abbandonato. Il brano è già praticamente completo durante la prima session informale del 1968, quella in casa Harrison in cui i Quattro portano tutto quello che hanno composto prima e durante l'esperienza indiana, si rendono conto di avere già materiale per più di un LP e decidono che 'pubblicheranno tutto', ovvero che il prossimo album sarà doppio. Ma non è vero che pubblicheranno tutto, per esempio accantoneranno Junk come cianfrusaglia, e non è semplice capire il perché.Junk contiene anche la prima riflessione di Paul sul consumismo, se non sugli eccessi della sua esperienza di giovane rockstar affetta da shopping compulsivo. In pochi minuti avrebbe aggiunto al Disco Bianco una dimensione in più, tra tante che ne ha già. Certo, non è che sia stata buttata via: se mi va di ascoltarlo posso sempre andarmi a cercare McCartney, il disco in cui Paul la incise due anni dopo. Ma è uno di quei dischi che anche se li apprezzi preferisci lasciarti indietro - quel tipo di dischi che dopo un po' i ragazzi trovano in soffitta, appunto. E forse è perfetto così, quell'amarognolo che senti in fondo è esattamente quello che Paul voleva farti sentire. Maledetto Paul.
228. Step Inside Love (Lennon-McCartney; incisa da Cilla Black nel 1968; suonata per scherzo durante la lavorazione a The Beatles il 16/9/1968, ora in Anthology 3).
You look tired, love; let me turn off the lights... Secondo una voce giornalistica probabilmente inverificabile, le due canzoni più eseguite della storia della musica sono Yesterday e (subito dopo) Garota de Ipanema. Questo cosa significa? Anche niente, ma immaginate per un attimo che i Beatles si fossero dedicati a scrivere pezzi di bossanova. Davvero, perché no? Nel '68 spaziavano dell'heavy metal allo ska, perché non ci hanno nemmeno provato? Perché la bossanova è più difficile, ovvio. Ma fino a un certo punto: in fondo se c'è qualcosa che hanno in comune con Gilberto è proprio la passione per gli accordi strani che all'inizio suonano dissonanti e poi ti ci affezioni. Invece una colore che alla loro tavolozza sembrava mancare è quel timbro rilassato, languido, senza il quale non si dà bossanova – proprio quel timbro che stava cercando Paul quella sera di settembre, mentre registrava I Will. Si capisce che Paul una bossanova avrebbe voluto cantarla, in un disco dei Beatles. Ci aveva già provato prestissimo, con la cover di Till There Was You ('64), ma comporne una era un altro paio di maniche. Step Inside Love era una mezza bossanova che aveva scritto per lo show televisivo di Cilla Black, ex compagna di Cavern scoperta, come i Beatles, da Brian Epstein. Spogliata da tutta la fanfara orchestrale, sussurrata in un microfono, accompagnata da quegli accordi sempre un po' imprevedibili, è la più esplicita preghiera che Paul poteva rivolgere ai compagni: ragazzi, dai, proviamoci. Potremmo farcela, potremmo sbarcare sulla spiaggia di Ipanema anche stasera. I compagni non lo prendono sul serio. Quella sera sono solo due (manca George) ma di buon umore, forse troppo. Ringo è alle maracas, John si diverte con legnetti e altre percussioni. Lo stesso Paul non insiste più di tanto, e alla fine si dissocia dal risultato attribuendolo a un tale "Joe Prairies" (una storpiatura di Pereira?) e ai suoi "Prairie Wallflowers". Niente Ipanema nel Disco Bianco, abbiamo scherzato. Peccato però.
Step Inside Love fu un discreto successo, anche perché si sentiva in tv una volta alla settimana e c'era tutto il tempo per affezionarcisi; per metà stagione Cilla dovette accontentarsi di cantarne la prima strofa, perché era l'unica che Paul aveva scritto; quando finalmente riuscì a incontrarlo e convincerlo a completarla, Paul notò che Cilla sembrava stanca, forse provata da quel ruolo di soubrette, e lo scrisse: "You look tired, love". Insomma Paul scriveva le prime cose che gli venivano in mente e fa un po' effetto pensare che sono proprio le parole che Cilla si è fatta incidere sulla tomba.
227. Los Paranoias (Lennon-McCartney; improvvisazione estemporanea durante la lavorazione a The Beatles, 16/9/1968, ora in Anthology 3).
Sing à la latina! Inventare buffi pseudonimi d'artisti era uno scherzo ricorrente tra i Beatles in sede di registrazione (in fondo anche Sgt Pepper è nato così). Quando Paul abbozza i "Prairie Wallflowers", John ribatte con "Los Paranoias", un termine che a detta di Paul faceva parte dello slang portuale di Liverpool. Paul ridacchia e ci inventa lì per lì un riff: "Come on enjoy us / Los Paranoias". John in falsetto protesta: "I can't make it", e intanto qualcuno, lui o Ringo, fa un gran casino tribale coi legnetti. Ogni tentativo di impostare una bossanova va a farsi benedire. Però è sempre un piacere sentire che si divertivano. Ci sono alcuni brani dei Beatles (You Know My Name, Hey Bulldog) che sembrano avere principalmente questa funzione: ricordare agli ascoltatori che i Beatles non hanno sempre litigato, anzi. Certe sere potevano andare avanti tutta la notte a suonare cretinate coi registratori accesi, così, per ridere. Tutto questo può spezzarti il cuore come quei filmini super8 in cui ti ritrovi più giovane a giocare con amici che non ci sono più o che non sono più tuoi amici. Come on, enjoy us! (I can't make it).
226. Teddy Boy (McCartney; outtake del 1969 ora in Anthology 3; McCartney la incise nel suo primo disco omonimo).
Ma poi ci sono canzoni che sono coltellate alle spalle, e Teddy Boy è la peggiore. Ci sono canzoni inutili e canzoni dannose, ma Teddy Boy è in un cassetto tutto suo, quello delle canzoni catastrofiche. Se non è quella che ha spaccato i Beatles, è per il semplice motivo che le crepe erano già abbastanza profonde e non sarebbero sopravvissuti comunque. Per come la imbastisce al microfono durante le difficili sessioni del gennaio '69, è la storia di un "teddy boy" che sotto la patina da duro è dolce e mammone come un orsacchiotto, appunto: e se avete più o meno presente la situazione psicologica di John in quel periodo, ve lo immaginate già stringere i pugni. Ma nella terza strofa la mamma di Teddy incontra un "another man", Paul canta proprio così e lo canta di fianco a John, e pretende che John gli dia pure una mano coi cori.
L'anno successivo John avrebbe iniziato un faticoso percorso di terapia allo scopo di superare il trauma dell'abbandono materno. Proprio come la mamma di Teddy, quella di John aveva incontrato un altro uomo, e John a cinque anni era andato a vivere da zia Mimi. Julia non aveva smesso di vedere il figlio; gli aveva insegnato a suonare Fats Domino al banjo, e poi era morta in un incidente stradale. John a quel punto si era già evoluto nel teddy boy del quartiere, ma "Teddy don't worry, now mummy's here taking good care of you", canta Paul, e magari c'è Yoko nei paraggi e John si innervosisce anche solo se la fissi per più di un secondo.
Che Yoko fosse una figura materna lo aveva ammesso John già nel '68, quando tra i versi di Julia si era lasciato sfuggire un "Ocean's Child", figlia dell'oceano, che è il significato degli ideogrammi che compongono il nome Yoko. Che questa nuova madre, dietro a una naturale possessività, nascondesse ambizioni manageriali era un'osservazione che Paul evidentemente non riusciva più a tenere per sé. Sceglie dunque di affidarla a una melodia che è poco più di una filastrocca irrisolta, sbilenca, che induce l'ascoltatore a domandarsi per un paio di minuti: ma ci è o ci fa? Si è accorto che sta mettendo a nudo il lato più fragile e rimosso del suo amico e socio in affari, o è l'inconscio che sta giocando un brutto scherzo anche a lui? Si tratta di un maldestrissimo tentativo di trasformare la musica in terapia (quel che poi John farà nel suo primo disco da solo), o di un'orribile gaffe? E se te lo domandi tu che hai avuto una vita famigliare standard, figurati un tizio devastato da dipendenze e nevrosi come John in quel momento. Tanto più notevole il fatto che invece di mandare Paul a quel paese, John si limiti a sabotarlo intervenendo nel ritornello nei panni di un maestro di ballo "Take your partners, dosi-do, hold them tight and don't let go". Un modo abbastanza garbato di dire: Paul, questa fa schifo.
Perché oltre a poter essere interpretato come un atto ostile nei confronti del partner, Teddy fa proprio schifo come pezzo e getta una luce sulle difficoltà impreviste che McCartney si troverà davanti, come compositore, dopo il divorzio. Nel biennio '69-'70 Paul comincia a sbandare: proprio nel momento in cui vorrebbe imporre un suo controllo creativo soffre il fatto che nessuno sta più controllando lui; alterna trovate geniali (Let It Be) ad altre che mal si conciliano con il gusto dei compagni (Obladì) se non lo sfidano apertamente (Maxwell's Silver Hammer). Era un momento psicologicamente molto teso, e ognuno reagisce alla tensione a modo suo. George e John approfittarono della situazione per scrivere alcune delle loro cose migliori, Paul si intestardì su Maxwell e Teddy Boy.
225. 12 Bar Blues Original (Lennon-McCartney-Harrison-Starkey, incisa nel 1965 durante la lavorazione di Rubber Soul, poi inclusa in Anthology 2).
Quando chiesero a Lennon se esisteva del materiale beatle non registrato, lui rispose che ricordava soltanto "qualche schifoso 12 bar". Il 12 bar blues, blues in 12 misure, è l'abc delle rock'n'roll band. Non devi neanche metterti d'accordo prima: qualcuno conta fino a quattro e alè, si comincia. Non c'è nulla da inventare, nulla da dimostrare, magari si stanno soltanto scaldando, o rilassando. Quando due anni più tardi capiterà loro di accennare il tema di una colonna sonora, finiranno di nuovo per montarla sull'ossatura di un blues (Flying), come se il 12 bar fosse il destino di qualsiasi tentativo di comporre in quattro, dal vivo, con gli strumenti in mano. Nel frattempo il blues stava tornando di moda proprio all'Inghilterra, una specie di radicalizzazione del rock praticata da gruppi come i Fleetwood Mac prima maniera. Ma il blues a cui tornerà soprattutto Lennon, dal Disco Bianco in poi, non è più la struttura fissa e rassicurante: è la musica del dolore (Yer Blues) o dell'ossessione (I Want You).
Per i Beatles del 1965 invece il blues è come il pane o l'acqua, qualcosa che di necessario, di scontato, che comunque fin qui non si è mai pensato di servire come pietanza centrale. Per questo è intrigante l'ipotesi che 12 Bar, invece di essere un semplice riscaldamento, fosse stata concepita all'inizio come la title-track di Rubber Soul, un vero e proprio manifesto: eccoci, siamo i Beatles, facciamo soul di gomma ("plastic soul" era la definizione con cui qualche critico americano aveva liquidato i Rolling Stones). Forse a un certo punto voleva essere una rivendicazione orgogliosa: davvero credete che non sappiamo suonare il blues? Sentite qua. Magari poi si portarono a casa l'acetato, lo riascoltarono con comodo, e si resero conto che... era davvero un blues di gomma. La versione di Anthology mette assieme i momenti meglio riusciti di un'esecuzione più lunga, che sfora i sei minuti. Anche così rimane comunque una jam qualsiasi, non così "schifosa", ma più divertente da suonare che da riascoltare.
Le canzoni dei Beatles (#254-235)
09-09-2019, 22:17beatles, Il Post, musicaPermalink254. Moonlight Bay (Wenrich-Madden, "eseguita" dal vivo al Morecambe & Wise Show nel 1963, poi in Anthology I).
I Beatles dovevano scegliere tra rompere con la vecchia generazione o compiacerla: scelsero l'opzione più paraculo, ne trassero benefici immediati su stampa e quotidiani, ma l'equilibrio tra credibilità e paraculaggine era fragilissimo e destinato a spezzarsi entro il decennio. Morecambe e Wise invece continuarono a fare apprezzatissima e rassicurante televisione fino agli anni Ottanta. Paul considerava questo sketch la migliore apparizione televisiva dei Beatles, motivo per cui è stata inclusa nel primo volume di Anthology entrando in un qualche modo nel corpus delle canzoni dei Beatles. Su Spotify è attualmente il loro brano meno ascoltato, e quindi si piazza al numero 254. Giusto così: non è nemmeno una canzone, è uno scherzo di pochi secondi. Ma sappiamo tutti che sapevano fare di peggio, se si impegnavano.
253: (You're So Square) Baby I Don't Care (Leiber-Stoller, incisa durante una session di The Beatles, 1968).
You don't like crazy music, you don't like rocking bands... Anche nella fase in cui farcivano i loro dischi di buoni vecchi standard rock'n'roll, i Beatles si sono sempre tenuti a religiosa distanza dal repertorio di Elvis Presley. Non era solo il rispetto che si tributa a una divinità, ma una scelta estetica e commerciale: i Beatles cercavano brani poco noti in Inghilterra, cercando di personalizzarli per quanto possibile. Elvis non si presta a essere personalizzato: chiunque ci si avvicini si trasforma inesorabilmente in un imitatore. È quel che succede a Paul il 9 settembre del 1968, la mitica session in cui Ringo suonando 18 volte Helter Skelter si farà venire le vesciche alle dita. È il giorno in cui insomma nasce l'heavy metal, ma prima del parto, per scaldarsi le mani e testare il riverbero, i Beatles avevano suonato una versione selvaggia di un brano della colonna sonora di Jailhouse Rock.
Nella versione deluxe del Disco Bianco se ne possono ascoltare soltanto 40 secondi, più che sufficienti per farci cascare dalla sedia: è un Elvis rabbioso e primordiale, sequestrato a tutta la melassa hollywoodiana dei suoi tristi anni Sessanta e riportato gloriosamente sul rock-trono spettantegli per diritto divino. È un Elvis ibernato durante il servizio militare, un Capitan America che aspetta che vengano a scongelarlo gli Avengers, o meglio ancora i Led Zeppelin. Un Elvis che non ha mai dovuto riciclarsi come star del cinema di serie B, un Elvis mai rassegnato a proporre versioni di sé sempre più rassicuranti per tutte le ex-ragazzine del Midwest ormai sposate e con figli.
Un Elvis che in realtà è l'ennesimo travestimento di Paul, galvanizzato dal riverbero rockabilly che intendeva usare per far esplodere Helter Skelter. Tre anni prima i Beatles avevano ottenuto un'udienza presso il Re, nel suo esilio californiano. Cosa accadde nell'occasione non è chiaro: erano tutti un po' fatti un po' imbarazzati, i resoconti divergono. Lennon era il solo a sostenere che avessero suonato assieme; Ringo ricorda di averci giocato a pallone. Paul se lo ricorda seduto sul divano con in braccio un basso elettrico. You're So Square è uno dei rari pezzi in cui Elvis suona il basso (e che basso).
252: Can You Take Me Back? (improvvisazione di McCartney durante una session di The Beatles, 1968).
Can you take me back where I came from? Quarto, drammatico lato del Disco Bianco: pochi secondi prima che tutto sprofondi nel caos di Revolution 9, dalla dissolvenza di Cry Baby Cry spunta fuori Paul con la chitarra. Non ha un'altra canzone da proporre: vuole solo che lo portino a casa. È un breve brandello di musica che si intona in modo incantevole con l'atmosfera fiabesca del precedente, e col senso generale di malinconia che si insinua nell'ascolto verso la fine del Disco Bianco. È stata una lunga festa, piena di errori e cose memorabili, ma comunque sta per finire, anzi è già finita. John sta ancora armeggiando con manopole a caso, Ringo è salito nelle camere dei bambini che reclamano la ninna nanna, Paul vi saluta: negli ultimi (lunghissimi) dieci minuti non sentiremo più la sua voce.
Can You Take Me Back è stata inserita nella scaletta del Disco Bianco soltanto nell'edizione del 50esimo anniversario. Fino a quel momento era rimasta ufficialmente una coda di Cry Baby Cry. Per quanto brevissima, era comunque più interessante ed efficace di molti brani in scaletta; uno degli esempi più felici di quel "non finito" così caratteristico del Disco Bianco, un kolossal incompiuto in cui numeri provati e riprovati si alternano a schizzi estemporanei. In certi momenti il Disco Bianco sembra voler suonare come un bootleg, in un periodo in cui il concetto di bootleg è appena nato. Il fascino di Can You Take Me Back stava nel suo emergere dall'ombra e ricadervi subito, dando all'ascoltatore la sensazione di perdersi chissà cosa. Più tardi coi cofanetti abbiamo scoperto che Can You Take Me Back era il terzo stadio di una lunga improvvisazione incisa da Paul il 16 settembre 1968, durante la lavorazione di I Will. E abbiamo scoperto per l'ennesima volta che la canzone completa era più bella da immaginare che da ascoltare davvero. Can you take me back?
251. Lend Me Your Comb (Twomey-Wise-Weisman; eseguita dai Beatles nel luglio del 1963 negli studi della BBC).
Prestami il pettine, i miei capelli sono un disastro. Baciarti è stato divertente, tesoro, e grazie dell'appuntamento: ma adesso dobbiamo tornare a casa. Scegliendo di eseguire per il pubblico televisivo della BBC questo oscuro lato B di Carl Perkins, i Beatles si concedono due minuti di fuga nell'immaginario americano, ricostruito grazie al cinema e comunque più realistico di quello tratteggiato nelle loro canzoni del tempo: qui non ci si limita a tenersi per mano, il bacio non è più l'estatico punto d'arrivo del corteggiamento, ma una prassi "divertente" quantunque non priva di inconvenienti, ad esempio ci si rovina l'acconciatura. Inoltre ci sono i genitori, a casa, che ci aspettano (e i vostri, di genitori, non lo tenevano un pettinino nel cassetto del cruscotto?)
250. St. Louis Blues (W.C. Handy; incisa durante la lavorazione di Hey Jude, 1968)
Insomma, qui ci sono trenta secondi di St. Louis Blues cantati da Paul al pianoforte tra una prova e l'altra di Hey Jude, con un accento non definibile e un tentativo di falsetto che forse preannuncia quello di Get Back (c'è anche John alla chitarra) – ma che senso ha tutto questo? Ho chiesto al Post di pubblicare la più lunga e completa classifica dei brani dei Beatles mai comparsa on line, e affinché sia davvero la più lunga e la più completa devo anche mettermi a parlare di un brano del genere come se fosse qualcosa di più di un "brano" nel senso etimologico, un brandello, uno strappo, un lacerto? Nel frattempo sono già passati 40 secondi da quando ho iniziato a scrivere questa cosa, il che significa che ci ho perso più tempo io che i Beatles. In seguito diventa più interessante, giuro.
249. Ain't She Sweet (Milton Ager – Jack Yellen; incisa da John, Paul, George e Pete Best ad Amburgo nel 1961, e in una versione più tranquilla, a Londra nel 1969).
...ma i tedeschi dicevano, "più dura, più dura" – la volevano tutti un po' come una marcia – così finimmo per farne una versione più dura.
Adesso, in confidenza: non è fantastica questa versione di uno standard swing che dagli anni Venti avevano suonato tutti, veramente tutti, senza che a nessuno mai venisse in mente di poterla fare così veloce, così ringhiosa, sgusciante come brillantina? Ascoltatela un'altra volta. Non meriterebbe di essere più su in classifica, molto più su di Revolution 9 o Wild Honey Pie? E dire che, se fosse stato per John, la sua Ain't She Sweet non sarebbe suonata molto diversa da quella rockabilly di Gene Williams, melliflua e ancora molto swingante. Ma quei tedeschi insistevano: "schwerer, schwerer!" e insomma se abbiamo il rock forse dobbiamo davvero ringraziare la clientela dei nightclub di Amburgo.
Eppure, quando gli ricapiterà otto anni di re-intonarla per scherzo coi colleghi milionari, John la rifarà proprio come l'aveva sentita da Gene Williams. Quel che era successo con Ain't She Sweet nel frattempo si era ripetuto con Please Please Me, con Help!, con Revolution: in tutti questi casi qualcuno aveva chiesto a John "faccela più dura", o "più veloce", e in tutti questi casi John aveva accettato. La gente ha sempre chiesto a John di fare il duro, e i Beatles sono durati più o meno finché John ha imparato a dire di no.
248. You'll Be Mine (Lennon-McCartney, incisione casalinga del 1960)
247. Cayenne (McCartney)
Ancora una registrazione domestica del 1960. La band più importante d'Inghilterra si chiama The Shadows: quando non accompagnano Cliff Richard suonano un surf rock strumentale squillante come una fanfara. Paul alla chitarra solista ha in mente di prendere il volo con qualcosa del genere, ma il basso goffo di Sutcliffe e la chitarra (poco) ritmica di John lo bloccano a terra. Un altro chitarrista di buone speranze, riascoltando la bobina, avrebbe tratto le sue conseguenze e mollato i due incapaci. Paul si comportò diversamente. A un certo punto accettò che se voleva una sezione ritmica decente, doveva preoccuparsene lui. Un passo indietro enorme per il suo ego, decisivo per la band. Il basso sarebbe diventato il suo migliore travestimento.
246. Searchin' (Leiber-Stoller, incisa dai Beatles nel 1962 durante il provino presso la Decca, ora in Anthology I).
Per il provino alla Decca, quello che andò inspiegabilmente male, Paul aveva scelto tra le altre una delle sue canzoni preferite (anni dopo la includerà tra i dischi da portare su un'isola deserta). Anche stavolta la sua capacità di interpretare in modo credibile un pezzo rhythm and blues è notevole, ma forse alla Decca cercavano qualcosa di più originale: non è che il r'n'b andasse così di moda a Londra nei primi anni '60, e che farlo cantare a un bianco di Liverpool fosse una mossa commercialmente scontata. Questa Searchin' resta comunque il brano del provino che richiama più l'atmosfera caotica e fumosa del Cavern Club. In mezzo a un pubblico già adorante ("Sing Searchin'!"), Paul sta già recitando una parte.

Siamo ancora nei profondi bassifondi della classifica, dove compaiono pezzi che non sono mai stati inclusi in nessun'altra. L'unico motivo per inserire Searchin' al 246esimo posto, sopra Cayenne e sotto Hallelujah, è il numero di ascolti su Spotify, appena sopra i 330.000. Il pezzo dei Beatles più riprodotto attualmente è... non vi dico ancora qual è, ma comunque risulta riprodotto appena dieci volte tanto. E comunque non è il brano di Spotify più riprodotto, tra quelli in cui suona e canta Paul McCartney. Il brano di Paul più ascoltato su Spotify è una collaborazione con Kanye West e Rihanna, FourFive Seconds. Lui ci scherza su, dice che su c'è gente che pensa che Kanye West lo abbia scoperto. Non è una battuta, dice. Lo sappiamo che non è una battuta.
245. Hallelujah, I Love Her So (Ray Charles; incisione domestica del 1960, in Anthology 1)
Let me tell you about a girl I know... C'è chi dice che la chitarra è quella di George, perché nella parte tagliata su Anthology (a volta la si trova su Youtube) c'è un tentativo di assolo. Per Mark Lewisohn, il beatlesologo più autorevole, George quel giorno davanti al registratore a bobina non c'era, magari aveva un impegno. Invece John c'era, quindi l'assolo sarebbe suo. Io in realtà ci sento una chitarra sola, quindi per me è Paul. Chiunque sia, è un disastro. Hallelujah colpisce per lo scarto tra voce e strumento: non c'è dubbio che chi canta abbia talento – magari un talento mimetico, si capisce che è uno che ha imparato Hallelujah suonando la cover di Eddie Cochran fino a impararla a memoria. Invece il chitarrista non può farcela. In un certo senso non ce l'ha mai fatta.
Gli strumenti dei Beatles non suoneranno mai lisci come le voci dei Beatles: ci sarà sempre un gap sensibile tra la musica che passa dalla voce e quella che arriva nelle mani. Non è una coincidenza, credo, che due su quattro fossero mancini in un mondo dove ancora gli strumenti per mancini non esistevano – e lo stesso John, che mancino non era, sapeva di avere un senso del ritmo tutto suo. È stata questa difficoltà ad avere reso i Beatles qualcosa di diverso dall'ennesimo gruppo che suona Cochran che suona Ray Charles. Non ce l'avrebbero mai fatta, e così si sono inventati qualcosa di diverso. Qualcosa che è ancora parte del nostro paesaggio musicale, sessanta anni dopo, qualcosa che diamo per scontato, oggi. Ma nel 1960 non esisteva.
Uno, nessuno, centomila Calogero
18-06-2019, 12:02Il Post, invecchiare, repliche, santiPermalink"San Calogero di Girgenti, miracoli non ne fa nienti;
San Calogero di Canicattì, miracoli non ne fa tri;
San Calogero di Naro, miracoli ne fa un migliaro".
 |
| Calogero di Agrigento |
Di tutte le leggende, quella della cerva avvalora l'ipotesi. Racconta che giunto intorno ai novant'anni, Calogero non riuscisse più a mandar giù nessun tipo di cibo. Il digiuno, che di solito nelle storie dei santi è una pratica autoindotta e consapevole, qui è semplicemente il segno dell'invecchiamento. Calogero dunque si nutre unicamente del latte ad altissima digeribilità prodotto da una cerva che Dio gli invia tutte le mattine. Finché un cacciatore, Siero, non gliela ferisce a morte. La cerva fa giusto in tempo a tornare nella grotta di Calogero e morirgli tra le braccia; il cacciatore che la stava braccando arriva anche lui nella grotta, vede il monaco che l'ha battezzato bambino chiudere teneramente gli occhi alla preda che ha ucciso: minchia, pensa, l'ho fatta grossa. Ma il santo lo perdona immediatamente, e già che c'è gli mostra la grotta vaporosa e gli illustra tutte le virtù delle acque che sgorgano in quelle falde, un vero tour guidato al termine del quale Siero diventa un suo discepolo, appena in tempo perché Calogero non sopravviverà alla cerva che per quaranta giorni.
Calogero è un buon vecchio che conosce le virtù nascoste all'interno della terra; lo si venera a Sciacca, il cui monte era dedicato al dio Crono; sul monte di Termini Imerese dove avrebbe scacciato i demoni e lasciato l'impronta della mano; mentre a Vicari avrebbe lasciato quella del piede. Calogero è insomma una figura dell'inculturazione, il nome dietro al quale uno dieci o centomila chierici, forse davvero provenienti dalla Grecia bizantina, scacciarono le antiche divinità ctonie dalle grotte della Sicilia; che poi uno o dieci avessero davvero la pelle scura, non è implausibile; ma il momento in cui San Calogero diventò davvero nero fu quando cominciarono a circolare le sue statue, più spesso in bronzo o in rame. Il bronzo dei Calogeri di Agrigento e di Naro ha anche l'indubbio vantaggio di scintillare al sole, il che deve suggerire durante la processione del pomeriggio di giugno l'idea che anche il santo stia sudando; che il suo sudore sia qualcosa di fisico, che si può trattenere nelle pezzuole e poi usare per curare i malati. Il sudore di Naro pare che funzioni di più di quello di Agrigento (ma che sia anche più costoso).
 |
| La madonna nera di Czestochowa è talmente nera che a Haiti è diventata una divinità Vudù, storia lunga, un’altra volta la raccontiamo. |
La negritudine di Calogero nei secoli è stata spiegata con tante ipotesi diverse, nessuna del tutto soddisfacente. Fino a un certo punto deve essere sembrata una cosa naturale, così come era naturale in ambito bizantino dipingere icone della Madonna con un certo pigmento; poi a un certo punto (nel basso Medioevo?) i colori hanno preso un significato diverso, un’icona qualsiasi della Madonna è diventata una “Madonna nera” e gli agiografi hanno cominciato a domandarsi il perché fosse stata dipinta con una tinta così scura (che magari in quel secolo era l’unica a disposizione): o non si era annerita col tempo, e il fumo degli incensi e dei ceri? O il colore scuro indicava la sofferenza? Più difficilmente si sarebbe potuta trattare di un’insolita concessione al realismo, visto che Maria di Nazareth in fin dei conti era un’ebrea della Palestina.
Anche nel caso di Calogero, il colore scuro forse dipende unicamente dai materiali a disposizione degli artisti. Però si lasciava facilmente interpretare anche come un segno della lotta dell’eremita contro i demoni del sottosuolo, quelle forze della terra che aveva domato, ottenendone in dono le acque della salute. Solo al termine del medioevo il colore assume un significato etnico o geografico; è il momento in cui davvero qualcuno potrebbe aver sostituito in un manoscritto l’appellativo Chalkhidonos, (“di Calcedonia”, la città bizantina sulla sponda asiatica del Bosforo), con “Karchidonos“, “Cartaginese”. A Cartagine poi non è che la gente abbia mediamente la pelle molto più scura che sul Bosforo, o a Sciacca. Ma lo scambio segna il momento in cui “nero” comincia a significare “africano”, ovvero “alieno”. Con la complicazione che in Sicilia, a differenza che nelle altre regioni dell’Europa cattolica, qualche alieno ci viveva: persino a quei tempi il Mediterraneo non aveva la chiusura ermetica che piacerebbe a Salvini e ai suoi seguaci. Il fatto che il nero fosse il colore di San Calogero portò a un curioso corto circuito: ai frati neri veniva chiesto più spesso di fare miracoli; e a furia di chiederli evidentemente i miracoli si realizzavano, sicché dopo Calogero in Sicilia nacque e visse più di un santo nero: Benedetto il Moro di San Frau, che oltre a essere nero come un etiope parlava pure un dialetto lumbard, in Sicilia nel XVI secolo, c’è da perderci la testa, e almeno tre Antonii: uno ad Avola (chiamato anche Catagerò, morto verso il 1550), uno a Caltagirone e uno a Camerano; tutti e tre portano il nome di quell’Antonio di Padova che in molti santini viene raffigurato con la pelle olivastra, benché sia nato a Lisbona.
 |
| Cercando “Calogero” sulla libreria di immagini del Post ho trovato la foto di Sacko Soumali, che è stato ucciso a 29 anni a San Calogero. |
Epifanio di Salamina e la castrazione semantica
12-05-2019, 09:53campagna elettorale (permanente), come diventare leghisti, Il Post, santi, sessoPermalinkEpifanio un po’ lo invidio. Erano tempi un po’ più semplici, almeno per gli intellettuali: esistevano le Scritture, un po’ di patristica, qualche classico pagano ancora universalmente rispettato, e il resto erano fake news, sciocchezze, teorie del complotto da liquidare senza pietà. Non ci mettevi neanche molto: un versetto biblico assestato al momento giusto ti buttava giù tutto l’impianto gnostico, ammesso che gli gnostici avessero un impianto. Epifanio scrisse moltissimo (anche per questo lo invidio) e la sua opera che conosciamo meglio, diciamo pure la sua opera che conosciamo un po’, ha un titolo fantastico: Panarion. Lo trovate a volte tradotto come “Contravveleno”, e i latini preferivano chiamarlo col titolo generico “Adversus omnes haereses”, già appioppato a un Ireneo e a uno pseudotertulliano. Ma Panarion è molto più incisivo e pratico, Panarion era la cassetta del pronto soccorso, con le ampolline degli antidoti e le pinze, le tenaglie, i seghetti, tutto quello che poteva servire ai medici di quei tempi.
 |
| In libreria è disponibile solo a puntate (piuttosto costose). |
 |
| Origene |
In realtà è un pezzo che ho già scritto e mi piacerebbe migliorare, ma non ho tutto il tempo del mondo, come Epifanio, né posseggo la concentrazione di Origene. Inoltre, non so se avete notato come funziona il grande dibattito delle idee su internet: uno ha una serie di argomenti che amerebbe studiare, su cui amerebbe scrivere, ma chi se li leggerà? Chi è che una mattina qualsiasi potrebbe decidere di passare la pausa caffè a leggersi due cartelle sulla castrazione chimica? Nessuno. E così bisogna aspettare. Cosa? Che un politico tiri fuori l’argomento: di solito in campagna elettorale. In sostanza il politico è l’accattone con la fisarmonica, io l’orso che balla. Anche il dibattito politico del resto funziona così ormai, è una specie di contest tra dj che ci fanno ballare, non con le canzoni ma con gli argomenti. Uno tira fuori, che ne so, l’abolizione della povertà, e per due o tre giorni balliamo tutti ah ah ah, abbiamo davvero abolito la povertà? Poi ne arriva un altro con la flat tax (ma a tre aliquote), e ci mettiamo a ballare su quella. Vince il dj con la playlist di argomenti più ballabili, quello che li riesce a mixare eliminando i tempi vuoti – e va da sé che in questo periodo Salvini non ha rivali, è teso come una molla, non ti concede un secondo. Qualsiasi cosa succeda lui ha una soluzione pronta, una parolina magica che risolve: No euro! Flat tax! Educazione Civica e Grembiulini! Case chiuse! Chiudiamo i porti! Qualche giorno fa aveva anche Castrazione chimica, ed è appunto il momento in cui sono andato a riprendermi le mie due cartelle sull’argomento dal mio panarion personale.
Quel che mi affascina delle formulette salviniane è che sono davvero promesse elettorali a costo zero: i porti sono già chiusi ai migranti, e Salvini non li ha veramente resi meno accessibili. L’educazione civica si fa già; i grembiulini alle primarie si indossano ancora; la flat tax a più aliquote esiste già; la prostituzione è già legale. E la castrazione chimica? Beh, in Italia la castrazione chimica sarebbe una relativa novità. Con un piccolo dettaglio: che non è una vera castrazione. Non condivide con la castrazione i dettagli che rendono la parola più vivida, più memorabile, più spendibile per un politico che voglia fare la voce grossa e restare in mente all’elettore: non è una mutilazione, non è irreversibile, non è sanguinosa, non è nemmeno una punizione. È una cura ormonale. Che probabilmente non funziona (non basta intervenire sugli ormoni per prevenire i comportamenti violenti), ma notate il paradosso: il tizio che si gonfia il torace proponendo di castrare i maniaci sessuali, in realtà sta dicendo che sono malati e che andrebbero curati (e non imprigionati). E noi che subito scattiamo sdegnati per dimostrare il nostro progressismo, ecco, forse ci facciamo fregare anche stavolta. Davvero saremmo contrari a una cura ormonale come alternativa alla detenzione?
 |
| Orwell |
La castrazione chimica è una cosa che non esiste. È un nome feroce, che evoca lame arrugginite e barbare mutilazioni, appioppato a una banale cura ormonale senza effetti definitivi. Come andare dal barbiere a “decapitarsi” barba e capelli. O dal dentista affinché ci “amputi” un dente cariato. Allo stesso modo, da qualche anno in alcuni Paesi il condannato per reati sessuali può chiedere di essere “castrato” chimicamente per usufruire di uno sconto di pena. È chiaro? In cambio di un po’ di pilloline tornano fuori prima. E una volta fuori, chi di voi madri e padri premurosi sarà in grado di accertare che il maniaco continui ad assumere la pillolina?
Aveva ragione Orwell: chi controlla il significato delle parole, controlla il Potere. Allo stesso tempo aveva torto: lui pensava che il Potere avrebbe chiamato “libertà” la dittatura, “amore” le torture; per ora le cose vanno in modo diverso. C’è in circolazione una cura (per la verità ancora non molto sicura), per i maniaci sessuali, e il Potere decide di chiamarla “castrazione”, per darsi un tono. Salvini non è un boia che si atteggia a damerino, ma l’esatto contrario. Per rimanere popolare deve fare il gradasso. Certo, se proponesse la libertà anticipata ai pedofili in cambio di una cura ormonale senza effetti definitivi, sarebbe sommerso di fischi. Ma è proprio quello che sta facendo: salvo che la cura ormonale ha questo nome formidabile, “castrazione chimica”. Senti che suono che fa, senti come ti riempie la bocca. E tanto meglio se nel frattempo ti svuota anche le galere, con quel che costa un carcerato.
E funziona? Dipende dai punti di vista. Probabilmente non salva nessuno dalle insidie degli stupratori. Ma come arma mediatica è fenomenale: vuoi mettere quant’è liberatorio e popolare poter affacciarsi al balcone e gridare “castrazione chimica”, ogni volta che una donna o un bambino ci va di mezzo? Tanto più che se si trovasse qualcosa di realmente efficace contro la violenza sessuale, il mondo si svuoterebbe di donne e bambini abusati e genitori impauriti, e a quel punto gridare al balcone non servirebbe più, bisognerebbe inventarsi qualcos’altro. Ma finché c’è un problema vero, e uno slogan efficace, non c’è nessuna necessità di risolvere il problema. No, neanche quello dei vostri bambini, mi spiace.
Forse allora aveva ragione Pasolini, in una sequenza di quel film orribile. Perché mai il Potere dovrebbe mutilare realmente le sue vittime, quando può mettere in scena la mutilazione all’infinito? “Imbecille, non lo sai che vorremmo ucciderti mille volte fino all’infinità possibile prima di ucciderti per davvero?”
Il Cristo come non l'avevano mai visto
04-05-2019, 09:01arti figurative, fotografia, Il Post, santiPermalink4 maggio – Santa Sindone.
Sempre lei. Il telo più studiato del mondo, a quanto dicono. Qualche mese fa l’ennesima ricerca sulla Sindone approdò sulle prime pagine, il che di solito è un buon segno: quando si tira fuori la Sindone di solito è perché non sta succedendo niente di troppo drammatico nel mondo. Scoprimmo che “metà delle macchie di sangue sono false“, un titolo che è capolavoro nel creare dibattito senza scontentare nessuno e suggerire che metà del sangue potrebbe anche essere vero. Non credo che i responsabili dello studio in questione abbiano sollecitato un titolo del genere, eppure in un qualche modo un titolo del genere è il compendio di tutta la sindonologia: anche chi vuole dimostrare che la Sindone non è acheropita, ovvero è stata dipinta da mani umane, dà la sensazione di non desiderare mai dimostrarlo del tutto. Perché da un punto di vista epistemologico forse è impossibile dimostrare una cosa senza ragionevole dubbio? Certo, ma soprattutto perché a quel punto il mistero finirebbe, e non si potrebbero più finanziare ulteriori ricerche. Per fortuna dall’altra parte ci sono e ci saranno sempre sindonologi convinti che quel tessuto è acheropita, è miracoloso, è una proiezione tridimensionale di un cadavere palestinese del primo secolo. I sindonologi scettici lottano contro i sindonologi credenti, ma solo gli uni danno in fondo agli altri la ragione d’essere, e viceversa. A volte viene il sospetto che ormai si siano messi d’accordo, che una volta al mese vadano in trattoria insieme e alla dodicesima bottiglia di rosso ci scappino anche gli scherzi da prete, professoressa, stia più attenta guardi che macchia ha fatto, sembra il costato di Nostro Signore. Monsignore, ha ragione! e la sua chiazza di sugo sembra la stimmate sul piede. Forse dovremmo testare il tessuto per il ragù, è mai stata fatta una prova col ragù? Attenzione attenzione adesso io con la delizia al lampone provo a fare la stimmate della mano destra, se viene credibile il conto lo pagate voi. Eccetera.
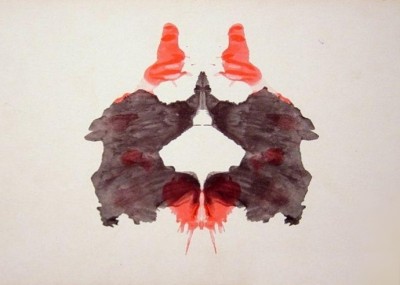
La Sindone, tra le altre cose, è un insieme di macchie, e le macchie sono pericolose, anche lasciando stare Rorschach. Nelle macchie ognuno trova sempre quello che vuole trovare. La pareidolia ha origine dalla nostra stessa necessità di riconoscere al volo i volti, e decifrare rapidamente le loro espressioni. Nel corso di milioni di anni siamo diventati piuttosto bravi; il prezzo da pagare è che ogni macchia sul muro ci sembra una faccia, e ogni faccia ci vuol dire qualcosa, c’è chi ci perde la testa. Prima di affrontare la Sindone avevo studiacchiato un po’ un’immagine acheropita persino più famosa, la vergine della Guadalupe: anch’essa, come il Mandylion di Edessa, non fu immediatamente considerata acheropita: all’inizio i fedeli sapevano che era stata dipinta da un pittore (l'”indio Marcos”) ma forse all’inizio anche la pittura era una dote così rara e pregiata che si confondeva col miracolo; come nel secolo iconoclasta a Bisanzio, la sola capacità di disegnare qualcosa di simile al vero faceva di te un medium tra il divino e l’umano; poi il tempo passa, un sacco di gente impara a disegnare anche meglio di te, addirittura qualcuno inventa la fotografia e a quel punto un’immagine eccezionale deve distinguersi in qualche altro modo: nasce la leggenda dell’indios José che avrebbe ricevuto la tilma miracolosa dalla madonna sul sacro monte (sacro alla dea azteca Tonantzin, ma quella è un’altra storia). La vergine della Guadalupe diventa dunque una foto, salvo che dopo un po’ siamo talmente abituati alle foto vere che non riusciamo più a credere che la vergine della Guadalupe lo sia. Servono altre prove, e così qualcuno comincia a ingrandire le foto alla ricerca di cosa? Di macchie, si trovano soltanto macchie, ma le macchie dicono tutto quello che vuoi. La vergine ha praticamente gli occhi chiusi, ma se ingrandisci quella piccola fessura di occhio aperto ci trovi… niente, probabilmente non ci trovi niente, i buchi del tessuto, ma se ingrandisci le foto in bianco e nero trovi macchie d’inchiostro e la pareidolia fa il resto: in quelle macchie d’inchiostro vengono identificati i testimoni del miracolo, le persone che stavano guardando la tilma nel momento in cui s’impressionò con l’immagine della vergine. Che storia affascinante, che puttanata incredibile, a che livello ci si abbassa quando si cercano motivi per credere in qualcosa. Ci sono studiosi che sfidano il ridicolo, e a volte lo vincono.
Nel 2009 Barbara Frale è una stimata medievalista. I suoi studi sui Templari – studi rigorosi, basati sulla lettura degli atti del processo francese del XII secolo, finalmente resi disponibili dal Vaticano – sono stati apprezzati tra gli altri da Umberto Eco. La Frale in realtà ha anche altri interessi, non vorrebbe fossilizzarsi sull’argomento della sua tesi di laurea, ma (spiega in un’intervista), ogni volta che propone agli editori un argomento, quelli le rispondono: non hai mica invece qualche cosa sui Templari? Barbara Frale qualcosa in effetti ce l’ha. È un’idea spericolata, che potrebbe appannarne la reputazione. Le si è presentata alla mente durante lo studio dei verbali del processo, in uno di quei momenti in cui all’improvviso unisci due puntini e ti capita di urlare Eureka, sì, succede anche agli storici. È un’intuizione folle, bisognerebbe essere prudenti. Ma gli editori insistono, e l’idea rimane lì, un chiodo fisso.

Quel che succede in seguito sembra un capitolo di un romanzo di Eco: la storia appassionante di una studiosa sedotta dal demone più insidioso (per uno storico): lo spettro della Somiglianza. Cosa altro può spingere la Frale a pubblicare per il Mulino un libro in cui cerca di dimostrare che la Sindone non è, come dicono gli esami al carbonio, un panno trecentesco, ma lo stesso Mandylion custodito prima a Edessa e poi fatto portare a Costantinopoli dal basileo Romano I? È una tesi temeraria, che finisce per posarsi su una premessa ancora più ardita: la Sindone sarebbe un tessuto medio-orientale del primo secolo, le lesioni dovute alla piegatura sono compatibili con i contenitori in cui nel deserto gli Esseni tenevano i lenzuoli; sul panno oltre alla sagoma del morto si vedono delle scritte, in greco, degli sgorbi che potrebbero essere ebraico, e sia il greco che l’ebraico sono del primo secolo, nel tredicesimo sarebbero risultati incomprensibili; ciò dimostrerebbe che la Sindone non è un documento del XIV secolo ma del primo dopo Cristo; insomma la Sindone è vera, la Frale non arriva a dirlo, ma afferma che prima era custodita in un recipiente dagli Esseni, poi è passata a Edessa, poi a Costantinopoli, poi durante l’imbarazzante saccheggio del 1204 i templari l’hanno presa, l’hanno trovata un documento incredibile che provava che Gesù Cristo oltre a Dio era stato un uomo ed era morto come un uomo (seppure temporaneamente): una testimonianza che avrebbe messo a tacere ogni rigurgito monofisita, ogni tentativo degli eretici di sostenere che Gesù fosse solo Dio e non uomo, che il suo corpo fosse un fantasma, un mero involucro, eccetera eccetera.
Di eretici del genere ce n’erano molti al tempo: in particolare nella Francia meridionale, dove avevano prosperato i Catari (Albigesi) fino ai massacri del 1222-1229; qui anche i Templari avevano molte basi, il che forniva ai loro detrattori un argomento irresistibile: siete catari mascherati, vi siete fatti templari per sfuggire alle persecuzioni. Contro queste dicerie, i Templari decidono di ricorrere alla Sindone, simbolo ma anche dimostrazione della corporeità del Cristo; la usano per le cerimonie di iniziazione ma non raccontano a nessuno di esserne giunti in possesso, forse perché poi avrebbero dovuto ammettere di averla rubata ai bizantini. La Frale scrive tutto questo, il Mulino glielo pubblica, il libro viene recensito con tutti gli onori (un paginone centrale su Repubblica), molti colleghi restano perplessi. Roba da Indiana Jones, anzi peggio, da Dan Brown. La Frale non demorde, risponde alle critiche più cattive, scrive altri due libri sull’argomento, ormai tra le due squadre di sindonologi ha scelto da che parte stare; e indietro non si torna.

La pareidolia è probabilmente un vantaggio evolutivo: ci consente di riconoscere i volti e decifrare le emozioni. E allo stesso tempo ci condanna a riconoscere anche quello che non c’è, a trovare il senso anche a macchie che non lo hanno. Da uno storico rigoroso ci aspettiamo che resista alle seduzioni della pareidolia; non di quella che ci fa identificare occhi e naso in una macchia di umidità sul muro, ma quella che ci istiga a riconoscere cause ed effetti nelle macchie casuali della storia. La pagina più bella del libro della Frale è quella in cui Costantino Porfirogenito scopre le forme del Cristo sul Mandylion, appena recuperato dagli arabi di Edessa. Ricordiamo la scena: i figli dell’imperatore sono davanti alla tela e non vedono niente. Costantino invece (che dell’imperatore è soltanto il genero, ma poi ne diventerà il successore) vede l’immagine e ne resta profondamente turbato. Questo per la Frale significa due cose: primo, l’immagine si vede solo da lontano. Proprio come la Sindone. Secondo: è un’immagine incredibile, scandalosa per i bizantini del tempo, abituati a icone ieratiche e stilizzate. Il mandylion non è ieratico, non è stilizzato, è un’immagine di realismo insopportabile, pare dipinto col sangue e col sudore. Il mandylion è la sindone (per la Frale). Da qualche parte era stato pur scritto che il mandylion era “piegato in otto”: ecco spiegato perché veniva rappresentato solo come un piccolo panno col volto di Gesù; il resto del corpo restava nascosto sotto, difeso da quelle pieghe che col tempo lo avrebbero consumato. È una scena affascinante, ed è a quel fascino a mio parere che la Frale non ha saputo resistere. Il resto sono dettagli: le scritte greche con gli errori di grammatica, gli sgorbi che forse sono alfabeto ebraico ma si vedono così male che potrebbero essere rune di Tolkien, addirittura le tracce di monete sugli occhi (monete con scritte in latino!) e una traccia di terriccio sul naso – dunque il modello doveva essere caduto, sulla via del supplizio, almeno una volta. Tutte macchioline, che la Frale ha voluto leggere così perché ormai si era convinta che la Sindone è autentica: pareidolia. Uno storico deve diffidarne, ma a quel punto forse si troverebbe senza più piste da seguire, senza più storie da raccontare. Io che storico non sono, potrei contribuire semplicemente mostrando come le macchie possono assomigliare anche a tutt’altro. Per esempio:
Torniamo al ritrovamento del Mandylion. Ricordiamo i dettagli. Nel 943 l’imperatore Romano I aveva mandato un suo plenipotenziario a trattare coi musulmani di Edessa, una città che se davvero aveva avuto il Mandalyon, ormai lo aveva perso da più di un secolo. Il plenipotenziario fa un’offerta davvero irrifiutabile: libertà per i prigionieri, immunità eterna, eccetera. I musulmani decidono che se il prezzo da pagare per un accordo del genere è un’immagine del Cristo, si può anche provare a farne una. Dev’essere però un falso credibile. Bisogna trovare un pittore. Ahi, non ce n’è. Siamo in terra d’Islam, l’iconoclastia ha vinto, i pittori non dipingono Dio e per sicurezza ormai non dipingono più nessuna figura umana, nessuna figura vivente, nessuna figura tout court. Solo figure geometriche e calligrafia. Ormai non c’è più nessuno che sappia mettere assieme due occhi e un naso sulla tela, e alle porte della città c’è un nemico che offre un sacco di soldi e la liberazione dei personaggi in cambio di una faccia su una tela. Se solo ci fosse un modo di fissare una faccia su una tela.
E se qualcuno avesse trovato il modo?
Abbiamo già visto che un primo Mandylion viene rifiutato dal plenipotenziario in quanto falso. Nell’occasione però il plenipotenziario ha avrà avuto la possibilità di chiarire alcuni dubbi sull’immagine, insomma di spiegare che immagine si aspettava di trovare a Edessa: dai, siete saraceni, veniamoci incontro, io devo riportare al mio boss un’immagine così e così, trovatemene una e siamo a posto. È una proposta ragionevole; salvo che a Edessa non c’è nessuno che la sa realizzare. Che si fa?
Va bene, si sarà detto qualche notabile di Edessa, se non sappiamo disegnare i volti, ci sarà pure qualche modo per ottenerli senza disegnare. Abbiamo tintori, abbiamo tessitori, abbiamo un sacco di artigiani: ingegniamoci. Qualcuno magari ricordava d’aver letto da qualche parte di un antico sistema per proiettare immagini su tela; qualcuno in sostanza potrebbe aver ricostruito la camera oscura, come l’aveva descritta secoli prima Aristotele e come la descriverà cinquant’anni più tardi il grande scienziato egiziano Alhazen (Ibn al-Ḥasan). E qualche altro artigiano potrebbe anche aver trovato qualcosa in più, qualcosa che in Occidente ci abbiamo messo altri secoli a scoprire o forse non abbiamo nemmeno scoperto: un processo chimico, un reagente strano, insomma, qualcosa che lascia impronte di luce sulla tela. Fantastico.
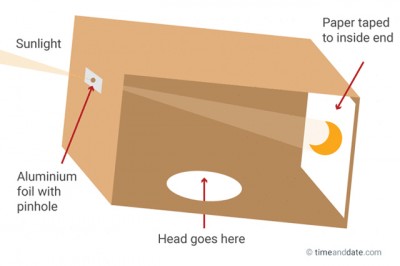
Però a questo punto serve un modello. Che assomigli al Cristo, ma che ne sanno i musulmani di Edessa del cristo? È un profeta del Corano, morto malissimo, in seguito a una di quelle barbare torture occidentali. Sanguinava qui, qui, e qui. Hmmm. Ci vorrebbe un modello. Andate al suk a prendermi un mendicante che abbia libera una mezza giornata. Uno abbastanza giovane, con la barba e coi baffi e i capelli lunghi. Se non vanno di moda procurate parrucca e barba finta. Ah, eccolo qua. Dunque, dobbiamo immaginarcelo che sanguina. Come si sanguina quando ti fustigano e poi ti crocefiggono? Qualcuno ha un’idea? Le frustate anche anche, ma la crocefissione è proprio un mistero. E quei maledetti cristiani vorrebbero un ritratto dal vero, ma come si fa? (I cristiani in realtà non pretendono tutto questo realismo; non sono nemmeno pronti per accettarlo, ma i musulmani di Edessa non se ne rendono conto. Per loro qualsiasi disegno di un corpo umano è qualcosa di estremo: quando si trovano costretti a realizzarne uno, ottengono il più estremo di tutti).
Ma insomma stiamo parlando di una ricompensa di 12.000 corone d’oro, oltre alla libertà per duecento prigionieri di guerra. Non possono correre il rischio di sbagliare, così qualcuno prima o poi lo propone: crucifiggiamo il modello, vediamo come reagisce, dove si raggruma il sangue ecc. Il tizio magari non è entusiasta, ma lo confortano: non ti faremo male davvero, beh, magari un po’ sì, ma sarai adeguatamente ricompensato, inoltre diventerai famoso, presso quei cani idolatri. E poi magari quando si calma lo ammazzano davvero, non si può escludere, e la Sindone oltre a essere la prima foto dell’umanità sarebbe il primo snuff. Il trucco riesce: gli artigiani di Edessa riescono a produrre un sudario con la figura intera e sanguinante, avanti e dietro. Questa è roba forte, questo farà impazzire quei pagani adoratori del corpo e del sangue. Lo impacchettano, lo consegnano al plenipotenziario, e appena quello è partito a cavallo scoppiano a ridere e a tirarsi manate sulle spalle: c’è cascato, chi l’avrebbe detto. Il plenipotenziario in realtà ci crede fino a un certo punto, è anche lui uomo di mondo, ma magari intasca una percentuale, e in ogni caso è sempre meglio che tornare a Bisanzio a mani vuote.
 |
| La Veronica vaticana |
Oppure potremmo strabuzzare un po’ gli occhi e cedere alla tentazione delle macchie. Le macchie raccontano la storia che vorremmo sentirci raccontare, che nel mio caso magari è questa: il realismo occidentale nasce un po’ per caso in una città musulmana del decimo secolo, dove un gruppo di artigiani, costretti a produrre il ritratto di un cadavere senza avere nessuna competenza pittorica, inventa per caso un procedimento fotografico. Dopo averlo inventato lo dimentica subito, perché le raffigurazioni sono comunque devianze occidentali di cui diffidare. Quanto agli occidentali, per quattro secoli nemmeno si rendono conto nemmeno di cos’hanno per le mani, finché dopo essere passato di mano più volte, il primo negativo fotografico della Storia arriva a Torino e comincia a ispirare qualche pittore che passa di lì. È una storia che non si può dimostrare. Soltanto raccontare. Ecco fatto, spero che nessuno se la prenda.
Santa Zita che rubi per noi
27-04-2019, 01:30Il Post, santiPermalinkCerti santi sono semplicemente persone diventate famose all'improvviso, a volte non si sa nemmeno il perché. Quando muore, 741 anni fa, Zita è ancora un'anziana domestica della famiglia Fatinelli. Trent'anni dopo i diavoli delle Malbolge di Dante definiscono già "anzian di Santa Zita" un magistrato lucchese appena precipitato nel girone dei barattieri. Diventata nel giro di una generazione uno dei simboli della sua città, Zita sarà proclamata santa soltanto quattro secoli dopo, quando in molte nazioni toccate dalla riforma protestante l'eco del suo successo si era ormai spento, rapidamente come si era acceso. Quanti miracoli abbia compiuto Santa Zita dal Trecento in poi non è chiaro; per molto tempo non si sentì la necessità di documentarli. Si trattava in ogni caso di quel tipo di miracoli domestici, poco eclatanti, che singolarmente non ti fanno vincere nessuna causa di canonizzazione, ma messi tutti assieme ti rendono una delle sante più invocate e apprezzate – per farla breve: Zita è la santa che s'invoca quando perdi le chiavi di casa. Pensateci: c'è qualcosa di più angoscioso del momento in cui perdi le chiavi di casa? C'è un sollievo più subitaneo e appagante di quello che provi quando le ritrovi? E nove volte su dieci le ritrovi. Poi corri ad accendere un cero a Santa Zita. Altri santi ti guariscono dalle malattie, forse, o ti mostrano la via, certamente. Ma una santa che ti trova le chiavi nella borsa o in un tombino non è affatto da snobbare, ammettiamolo. E come mai il patronato dei mazzi di chiavi è capitato a una domestica lucchese? Non bastava San Pietro, che ha in mano le chiavi del cielo in centinaia di quadri dal Rinascimento in poi? Eh, ma Pietro è il primo papa: vi verrebbe mai in mente di disturbare un papa perché al mattino prima di uscire non trovate il telecomando del cancello? Zita invece, neanche a farlo apposta, era una serva (oggi è la patrona delle serve). Che tipo di serva? Il tipo un po' ladruncolo.
Ci sono santi pirati, santi ubriaconi, sante puttane, santi esattori. Ufficialmente li veneriamo perché a un certo punto hanno corretto i loro errori, si sono purificati e sono diventati graditi a dio; ma il momento in cui ci rivolgiamo davvero a loro è quando ci sentiamo pirati, ubriachi, puttane, esattori. La speranza è che anche immersi nella gloria di Dio, conservino una scheggia di memoria della loro vita peccaminosa, tanto simile alla nostra. Zita, per esempio, era una ladruncola. Non rubava per arricchirsi, forse per cleptomania o per il gusto di farlo o in polemica con la ricca famiglia presso cui viveva e lavorava; non lo faceva nemmeno così spesso, visto che il padre di famiglia si fidava abbastanza da averle affidato le chiavi di casa; ovviamente le cronache ci dicono che rubacchiava per i poveri e a maggior gloria di Dio, al punto che Dio in molti casi la copriva. C'è carestia, Zita si mette a regalare le fave che trova in un cassone di casa Fatinelli. Dopo un po' il cassone è vuoto e il signor Fatinelli chiede a Zita di consegnarlo a un cliente che le ha acquistate e pagate. Zita è disperata, ma quando apre il cassone le fave sono tutte al loro posto. Oppure: la notte di Natale Zita esce di chiesa infreddolita perché non c'è mantello che non abbia già regalato a un povero. La signora Fatinelli impietosita le presta una pelliccia; ovviamente nel tragitto per arrivare a casa Zita riesce a trovare un povero a cui la pelliccia serve più che a lei. Ma il giorno dopo la pelliccia viene miracolosamente ritrovata. Oppure: invece di impastare il pane com'è sua specifica mansione, Zita è in giro a soccorrere questo o quel povero. I domestici borbottano, stavolta quella esagera, irrompono in cucina: gli angeli stanno cucinando al posto suo. O ancora: il signor Fatinelli la incrocia per le scale con un sacco pieno di pane (pane avanzato, puntualizzano gli agiografi). Zita, cos'hai nel sacco? "Mah, niente, rose e fiori". Apre il grembiule: sono davvero rose e fiori, il pane non c'è più. È un miracolo talmente tipico che lo troviamo smontato e rimontato nella vita di tante altre sante.
 |
| Te la sei cavata anche stavolta |
Certi santi ci mostrano la via per lasciarsi da parte le debolezze umane e ascendere al divino; altri funzionano proprio al contrario, sono umanissimi ma in un qualche modo li abbiamo fatti ascendere al cielo, in modo più o meno regolare, e adesso ci aspettiamo che ci diano una mano. Il culto dei santi, è già stato osservato, è un compromesso millenario tra il politeismo di matrice greco-romana e il rigoroso monoteismo che picchiava da est: l'unico sistema per accettare un Dio unico e giudice era circondarlo immediatamente da una folla di burocrati, lacchè e intermediari con cui sembrava più ragionevole poter interagire. Ufficialmente i santi "intercedono", ci aiutano a portare avanti le pratiche. In realtà sappiamo tutti che molte pratiche all'Assoluto non arrivano, e anche ai piani alti ci imbarazzerebbe che salissero certe nostre richieste molto terra-terra, ad es., dove ho messo il mio mazzo di chiavi? I santi ci schermano, svolazzando ci proteggono dalla luce implacabile di quell'occhio nel triangolo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa; ma di' solo una parola, o fa' finta di niente mentre la tua serva mi passa un boccone. Se poi il Giorno del Giudizio San Pietro si tastasse la tunica nervoso, ma dove ho messo le chiavi? le avevo appoggiate un attimo qui e non ci sono più e tra un quarto d'ora si va in scena, le trombe già squillano, ma i cancelli del cielo sono aperti e nessuno sa come chiuderli, dov'è Zita quando serve? Zita? Qualcuno ha visto Zita? Che colpo sarebbe, Santa Zita, fallo per noi.
La Salle vuole te
07-04-2019, 02:01dialoghi, Il Post, racconti, santi, scuolaPermalink |
| Se non sai le cose, SALLE |
"Lo scrittore! Che bella idea!"
"È più che un'idea, praticamente è tutta la mia vita. Sa io ho già pubblicato una raccolta di racconti per Busillis e inoltre..."
"Quindi le piace leggere".
"Leggere, beh, sì, senz'altro, ma soprattutto..."
"Farsi leggere dagli altri".
"In che senso, scusi".
"Ma niente riflettevo a voce alta... secondo lei ogni quanti lettori dovrebbe fiorire uno scrittore interessante?"
"Non sono sicuro di aver capito".
"Cercherò di spiegarmi meglio. Lei è uno scrittore, quindi le serviranno dei lettori. A ogni scrittore servono lettori. Secondo lei qual è il rapporto ottimale tra scrittori e lettori? Uno su cento?"
"Non saprei".
"Spari un numero".
"Teniamo conto che i lettori possono leggere migliaia di libri, e quindi... cioè il rapporto potrebbe anche essere uno a uno: tutti scrivono, tutti leggono".
"È vero, potrebbe anche essere così".
"Ma non è così, vero?"
"No, neanche un po'".
"Uno su cinquanta?"
"Eh, è ottimista lei".
"Ma si sa il numero preciso?"
"Abbiamo stime abbastanza precise ormai, sa, abbiamo avuto moltissimo tempo a disposizione per elaborarle".
"Ed è?"
"Premesso che negli ultimi secoli è sceso di molto, ma per ora sta intorno a millesettecentotrentanove virgola sei periodico".
"Ah".
"Quindi lei, insomma, capisce il problema".
"No, ancora no".
"Ha ragione, le manca un altro dato importante. Quest'anno mi sono arrivati quassù già centocinquantamila scrittori, gente brava eh? E non sto dicendo che non sia bravo anche lei, ma per dare un posto a tutti ci servirebbero..."
"150.000x1739,6=..."
"Ottocentosessantanove milioni di lettori".
"E non li avete?"
"Per adesso no".
"Ma forse in seguito aumenteranno".
"Ma certo, è quel che speriamo tutti, ma potrebbero anche aumentare gli aspiranti scrittori, mi capisce?"
"Mi sta dicendo che non potrò fare quel che ho sempre desiderato di fare?"
"Ma no, no, perché. Siamo nel migliore dei mondi possibili, prima o poi una soluzione la troviamo. E comunque noi abbiamo un grande bisogno di gente come lei".
"Ma se mi ha appena fatto capire che sono inutile".
"No, no, non volevo, mi perdoni se le ho suggerito questa idea, mi creda. Non è affatto inutile".
"E che tutte le mie aspirazioni erano malriposte".
"Niente di più sbagliato. Le sue aspirazioni erano preziose. Lei è prezioso. Abbiamo tutto il posto che vuole per le persone come lei".
"In che senso?"
"E non c'è nemmeno da fare anticamera. Se accetta questo incarico può cominciare anche domattina, è una scuola molto simpatica vicina alla rosticceria di San Lorenzo..."
"Una scuola? Dovrei lavorare nella scuola?"
"È una zona molto verde, si troverà bene".
"Mi dispiace io non... non credo di essere adatto. A me piace scrivere".
"Meraviglioso, quindi insegnerà agli altri".
"Io non... non credo di essere capace".
"Ha paura di crescere allievi più bravi di lei? In effetti è un rischio. Ma non si preoccupi, non deve insegnare a scrivere. È sufficiente che insegni a leggere".
"Non è davvero quello che mi aspettavo".
"Rifletta. Se ogni 1739 lettori fiorisce uno scrittore, lei non ha che da insegnare a leggere a 1739 anime e..."
"Posso essere sincero?"
"Deve".
"Non credo che sarei un bravo insegnante. Mi sentirei frustrato, incompleto, e sfogherei la mia frustrazione sugli studenti. Non solo non sarebbe paradiso per me, ma per loro sarebbe un inferno".
"Un inferno, ehi, ehi, che parole. Guardi che a scuola ci si diverte anche. È chiaro, a volte è faticoso. Dovrebbe leggere i temi".
"No i temi no".
"Mentre a lei piace scriverli".
"Non c'è davvero niente'altro che io possa fare?"
"Per adesso no, al massimo la posso mettere in lista per il reddito di beatitudine. Sono due spicci però, è sicuro di non volerci ripensare?"
"I temi no".
"Io comunque sono qui, se cambia idea..."

A metà mattina passa san Fiacrio a curare le siepi di rose, che hanno le spine anche nel Paradiso perché, perché, misteriosi disegni di Dio. San Cristoforo sta portando a pisciare San Guinefort. Qualcuno in un ufficio di fianco ha portato il caffè e Gianbattista ne assapora il profumo denso, anche se sta cercando di smettere, mentre risponde a un signore che ha le idee molto chiare.
"Insomma, teatro".
"Sono nato per farlo".
"Meraviglioso".
"E se non lo faccio muoio. Ora lei mi troverà ridicolo, ma..."
"Ridicolo, e perché?"
"Chissà quanti le hanno già detto la stessa cosa".
"Tre milioni e qualcosa, ma che vuol dire?"
"Sul serio?"
"Non lo so, dopo i tre milioni ho smesso di contare, è stato qualche anno fa, comunque il trend è costante dall'Ottocento".
"Quindi sta per dirmi che non c'è pubblico per tutti quelli che vogliono fare teatro".
"E perché? Siamo in paradiso, c'è pubblico per tutti".
"Davvero?"
"Certo, bisognerà modificare un poco il repertorio".
"Il repertorio non è un problema".
"Allora posti ce n'è finché ne vuole".
"Sul serio?"
"Però la devo avvertire: può essere un lavoro molto faticoso, sfibrante".
"Oh lo so".
"Magari non lo sa ancora del tutto".
"Quando posso cominciare?"
"Domattina, presso l'Istituto Don Bosco in via..."
"Ma... ma è una scuola".
"Ha anche un giardino meraviglioso".
"È uno scherzo? Io ho chiesto di fare teatro".
"Le garantisco che ne farà tutti i giorni".
"No".
"Quattro o cinque ore al giorno, per il pubblico più esigente".
"Non è quello che mi aspettavo".
"Potrà improvvisare e declamare a memoria. Piangerà, farà piangere. Riderà, farà ridere. Tutto quello che succede a teatro, tranne forse..."
"Gli applausi?"
"Eh, applausi in effetti pochissimi. Ma sono così importanti? È quello che veramente cercava nel teatro?"
"La prego, niente prediche, io..."
"Il teatro è dedizione, è sacrificio, è disciplina, gli applausi sono un contentino per i filodrammatici. Il vero attore agonizza nel silenzio, o peggio ancora, nel frastuono che segue la campanella".
"Io li odio gli studenti. Sono il pubblico peggiore".
"Sono solo i più esigenti".
"Non riuscirei nemmeno a farli tacere".
"Allora forse non è un grande attore".
"Davvero?"
"Mi perdoni, mi è sfuggita".
"È quello che pensa di me?"
"È quel che penso in generale. Insegna chi ha le palle, firmato de la Salle".
"Non fa ridere".
"No, in effetti no".
"Sta cercando di provocarmi?"
"Io?"
"Lei vorrebbe che io le rispondessi vaffanculo, le faccio vedere io chi ha le palle qui, lei vorrebbe che io firmassi per finire domattina a declamare Shakespeare in un inferno di bambini ridacchianti finché non si arrendono loro a Shakespeare o io alla mia mediocrità".
"Non deve sottovalutare Shakespeare".
"Senta ma quella cosa che diceva il tizio che è uscito prima... il reddito di santità..."
"Di beatitudine".
"È una cosa seria?"
"No, non tanto".
"Insomma non c'è alternativa".
"Un'alternativa a passare l'eternità a far conoscere Shakespeare ai ragazzi? Pensando che ogni volta sarà la prima volta? Un'eternità di Giuliette al balcone? Davvero ha bisogno di un'alternativa a questo?"
"Mi ci faccia pensare".
"Ma certo. Io comunque resto qui".

A pranzo gli piacerebbe sedersi sulla panchina sotto agli aceri ad ammirare il foliage, ma è da milletrecento anni che ci siede San Simeone Stilita, e non si schioda. Anche per questo ha chiesto di fare orario continuato, e il primo pomeriggio mentre digerisce un sandwich del distributore automatico di solito passano quelli più strani, quelli che per esempio vogliono combattere il Male.
"Il Male? Ma ha studiato medicina per caso?"
"No no, io intendo un Male più nel senso morale del termine".
"Ma certo, mi scusi, che sciocco. E in che modo lo vorrebbe combattere?"
"L'ideale sarebbe sparare, ma mi rendo conto che..."
"Sparare! Ma siamo in paradiso".
"Lo so, ma..."
"Non ha mai pensato che si potrebbe far male qualcuno?"
"È... è un po' il senso della cosa".
"Far soffrire i malvagi".
"Detta così suona molto stupida, ma io..."
"Lei sente che è questa la sua missione".
"Io senso che se non mi si darà qualcosa di nobile per cui lottare, o anche solo qualcosa di spregevole da combattere, finirò comunque per combattere, ma per delle sciocchezze. Perché sono fatto così e non credo di poter farci niente".
"Dovrebbe combattere contro sé stesso".
"E perderei".
"La ringrazio per la franchezza".
"Non dovrei nemmeno essere qui, vero?"
"E perché mai? Lei è una persona onesta, con un forte senso morale, che chiede di poter lottare..."
"A volte mi domando se la morale non sia solo un pretesto. La verità è che mi piace combattere, e ovviamente vorrei sentirmi dalla parte dei buoni. Sulla Terra era molto facile fregare quelli come noi. Ci davano in mano un'arma, ci additavano i malvagi e..."
"Buffo, le stavo per proporre la stessa cosa".
"In che senso?"
"Nel senso che si dà il caso che io abbia un sacco di malvagi da sconfiggere e sarei molto lieto di additarglieli. Ho anche qualche arma da fornire... certo non esplosivi, ma..."
"Sul serio?"
"Sì, anche in paradiso esistono le guerre sante. Ciò la stupisce?"
"Di solito c'è sempre la fregatura".
"Qui no. Mi basta una firma qui e domattina può andare a combattere l'analfabetismo e la superstizione presso l'istituto Sant'Ignazio che dà sui giardini del..."
"No no no. Lei sta proponendo una scuola anche a me".
"La trovo adattissima all'incarico".
"Io sono una persona semplice, per me esiste il bianco e il nero, non capisco le sfumature".
"C'è bisogno anche di quelli come lei".
"Senta, piuttosto mi dia anche solo uno scudo, un bastone, mi dica di difendere una città fortificata da ventimila infedeli, ma in una classe preferirei non entrarci più".
"Ha già esperienze di insegnamento?"
"Ho fatto una supplenza, una volta".
"Ha fatto una supplenza, e poi la guerra".
"Già".
"E preferirebbe tornare in guerra".
"La trovo più semplice. Si vince, si perde".
"Anche a scuola, no?"
"No, a scuola si perde soltanto. Tutti i giorni".
"A volte si vince pure".
"Non mi ricordo che sia mai successo".
"Eh, in effetti si scopre molto tempo dopo, e il più delle volte non ti mandano nemmeno un telegramma".
"Ma nel frattempo dovrei ritrovarmi in trincea tutti i giorni, davanti alla sconfitta tutti i giorni, non ce la posso fare".
"Ma in guerra non è la stessa cosa? Mi scusi: qual è la vera differenza? Perché l'unica che mi viene in mente... è che la guerra dopo un po' finisce".
"Già".
"Mentre la scuola riapre tutti i giorni".
"Mi dia un bastone piuttosto, davvero".
"Quindi insomma lei è pronto a combattere il Male... purché la lotta sia breve".
"Se vuole metterla così".
"Potrei metterla in un altro modo: dove ha messo le palle?"
"Eh".
"Mi ha capito bene. Lei viene da me poco dopo mezzogiorno, con tutti i suoi propositi eroici, il suo alto senso della moralità, e io ho qui pronta per lei l'unica guerra che valga la pena di essere combattuta, giorno per giorno, metro per metro, e lei si sgonfia così? Sul serio: dove le ha messe?"
"Lei... lei non dovrebbe parlare così".
"Io parlo come voglio e posso, soldato! Sull'attenti!"
"Sissignore".
"Ha letto qua fuori: ufficio smidollati?"
"Nossignore".
"Crede che io abbia da perdere il mio prezioso tempo con gli smidollati?"
"Nossignore".
"Tutte le mattine alle sette e mezza il Sant'Ignazio apre i cancelli. È in un brutto quartiere, gli studenti puzzano e non sanno stare seduti e c'è una cattedra vacante. Hanno bisogno di un docente con le palle, purtroppo oggi non ne ho ancora visto uno. Può sempre andare lei, se entro domattina le ritrova. Nel frattempo si tolga dalle mie".
"Grazie, signore. Mi scusi signore. Arrivederci, signore".
Verso le cinque del pomeriggio l'idea limpida di una birra cruda si insinua dietro la fronte di Giovanni Battista della Salle. Gli piacerebbe berla sotto il pergolato, prima di cena, qualche volta ha anche ceduto alla tentazione. Ma stasera ha ancora un colloquio, con uno che non ha sbocchi, dice lui, perché è un... un filosofo? Addirittura?
"Indirizzo sociologico. Mi sta già disprezzando, vero?"
"E perché mai? Di tutti c'è bisogno. Mi faccia controllare..."
"Non c'è bisogno di fingere con me".
"Non sto fingendo. Sto davvero controllando una lista, vede? Dunque..."
"Ma sappiamo benissimo entrambi come va a finire".
"C'è posto anche qui dietro, alle figlie dell'Immacolata".
"È una scuola".
"Con un magnifico giardino".
"Me lo avevano pur detto. Lei ci fa parlare ma alla fine, qualsiasi cosa diciamo, lei ci manda tutti a scuola".
"No, non tutti".
"Non tutti?"
"Capitasse un idraulico, ne abbiamo una necessità disperata. Ma ne arrivano pochi".
"Come sulla Terra".
"No, no, molti meno, ah ah".
"E mi avevano anche detto questo, che le sue battute erano terribili".
"Sì, beh, servono più a rompere il ghiaccio... lei è sociologo, capirà benissimo..."
"Fin troppo. Dunque lei è San Giovanni de la Salle, l'inventore della scuola dei poveri".
"Dicono questo di me? Pazzesco".
"Cosa c'è di pazzesco? Ha ispirato i regolamenti di dodici congregazioni, ha lottato per la scuola gratuita, ha praticamente inventato le classi elementari..."
"Ma scusi, la scuola esisteva già, i poveri pure, bastava fare entrare i secondi nella prima, non è che ci volesse un genio".
"E secoli dopo è ancora qui. Tutti quelli che capitano nel suo ufficio, lei li fa parlare un po' e poi li manda a scuola".
"Che ci posso fare se lì c'è un sacco di posto?"
"Ma ci sono davvero tutte queste scuole in paradiso?"
"Perché non dovrebbero esserci? ci sono molti bambini. E sa quanti buoni maestri servono a crescere un uomo?"
"Abbiamo il numero?"
"Mediamente una dozzina. Si rende conto? E qui arriva sempre più gente. Il lavoro non mancherà mai, nelle scuole".
"Ma non è il lavoro che uno si aspetta di fare, quando arriva qui".
"Lo so, e questo mi tormenta. Ma insomma l'umanità è così. Vorrebbero tutti fare gli scrittori, e nessuno vuole insegnare a leggere la gente. Tutti attori, tutti condottieri, tutti vorrebbero un pubblico, ma Dio non ci ha creati così".
"Ci ha destinati al dolore, a quanto pare".
"Non saprei. Ognuno vede il proprio dolore, ma Dio non ci ha creati uno alla volta. Ci ha creato tutti assieme, in un solo grande giardino. Un po' di sofferenza forse è necessaria, come le spine alla rosa".
"E insomma questo suo Dio ci avrebbe creato comparse, ma con manie di protagonismo".
"Immagino che queste manie, come le chiama, siano necessarie a farci combinare qualcosa di interessante".
"Ma non è onnipotente? Non avrebbe potuto creare un mondo senza dolore, senza comparse, senza frustrazioni?"
"Magari lo ha fatto, poi lo ha trovato noioso e ne ha creato un altro. Lo sa che è inutile farsi queste domande, vero?"
"Senta, io non sono molto d'accordo con questa cosa. Se potessi, non so... fare domanda per il Nirvana..."
"Il Nirvana, buon dio, ma lo sa che non c'è proprio niente laggiù?"
"Lo preferisco a tutto questo. Il giardino a cui invidia i profumi e i colori, io lo guardo più da vicino e lo scopro popolato da insetti che si divorano, organismi animati dalla paura e dalla fame. Siamo uno spettacolo doloroso, congegnato da un Dio indifferente o crudele. Vorrei alienarmi da tutto questo. Posso?"
"Non lo so, ma se lo lasci dire, lei parla davvero bene".
"E adesso crede di raggirarmi coi complimenti".
"Ha mai pensato di diffondere il suo pensiero? Credo che potrebbe fare molti, come si dice, seguaci. Potrebbe perfino creare una, una..."
"Sta cercando un sinonimo per scuola?"
"Ops, sì".
"Ma lo capisce che non sono tutti come lei? Non sono tutti pervasi dal sacro fuoco dell'insegnamento?"
"Ma io non sono pervaso da nessun sacro fuoco, io anzi avrei voglia di bermi una birra guardi, io..."
"Lo sa perché sono venuto qui? Potevo anche rifiutarmi, ma alla fine la curiosità mi ha vinto".
"Era curioso di me?"
"Di una sola cosa che non riesco a capire. Lei passa l'eternità qui, in questo ufficio, a convincere povere anime ad andare a scuola. Ma perché non c'è andato lei?"
"Ah, buona domanda, davvero buona".
"Se è davvero il lavoro più interessante, il più nobile, il più eroico, perché non l'hanno voluta?"
"Onestamente non lo so".
"Non lo sa?"
"La cosa mi imbarazza anche un po', ma dunque, è andata così. Mi hanno mandato proprio in questo ufficio, ovviamente c'era un altro seduto al mio posto, e ho cominciato a spiegare, dunque mi chiamo Giovanni Battista de la Salle, ho fondato alcuni istituti scolastici, blablablà, insomma il tizio mi ha offerto di prendere il suo posto, e mi è sembrato inelegante dir di no".
"E non gli ha offerto una cattedra?"
"Buffo, no".
"Ma poteva pur chiedere un trasferimento".
"Ah sì, l'ho chiesto quasi subito. Non che mi dispiaccia il posto, si sta bene, però..."
"E perché non l'ha ottenuto? Lo dice anche lei che c'è sempre posto, a scuola".
"Ecco, io non ho chiesto di andare a scuola".
"No?"
"No. Per carità se mi ci mandassero, ok, ma se devo essere sincero non è che abbia tutta questa voglia di tornare laggiù. È un mestiere faticoso, sfibrante".
"E quindi... dove ha chiesto di essere trasferito?"
"Ah, proprio qui di fianco".
"Qui di fianco?"
"Questo bel giardino, vede? Ma è complicato, c'è una lunga fila, è una posizione molto ambita..."
"Non vedo niente, ormai si è fatta sera".
"Già. Io direi che per oggi basta così, magari continuiamo un'altra volta. O per caso ha voglia di bersi una birra?"
"Una birra?"
"A quest'ora Brigida ha appena aperto, i fusti sono freddissimi, ci mettiamo nel pergolato, non dovrebbe ancora esserci molta gente".
"Non pensavo che bevesse".
"Ufficialmente no".
"Lei è un personaggio simpatico, alla fine".
"Grazie, confesso che fa piacere un complimento ogni tanto".
"E gli applausi?"
"Quelli sono adatti ai ragazzini, alla mia età li trovo quasi sconci. Lei no?"
"Sono convinto che sarebbe un ottimo insegnante".
"Ah ah ah, me lo dicono tutti, ma non esistono gli ottimi insegnanti".
"No?"
"Forse il martedì. Qualcuno anche al mercoledì. Ma se cerchi di essere un ottimo insegnante al giovedì, al venerdì sei in burnout. Io ho bisogno di insegnanti mediocri, che mi arrivino al sabato ancora in piedi".
"E pensa che io potrei essere un insegnante abbastanza mediocre?"
"Ma certo. C'è un mediocre in ciascuno di noi, se siamo abbastanza umili da cercarlo".
"Beviamoci questa birra, offro io".
"Allora dovrò offrire la seconda".
"E poi ci sarà una terza, una quarta..."
"...ma no".
"Finché non mi sveglierò nella toilette di Brigida con un cerchio alla testa e un contratto firmato per cent'anni di cattedra al Sant'Ignazio".
"Ahah, non farei mai una cosa del genere".
"No?"
"Non sono mica un reclutatore dell'esercito".
"No?"
Giovanni Battista de La Salle è il patrono degli insegnanti, che ne hanno bisogno, così come la scuola ha bisogno di insegnanti, e il mondo di scuole: perlomeno questo mondo è andato così, il prossimo vedremo.
Chi è la Samaritana?
21-03-2019, 02:36cristianesimo, Cristo, Il Post, santiPermalink |
| Samaritani celebrano la fine della festività Pasquale sulla cima del Monte Garizim. Nablus, Israele (Jaafar ASHTIYEH / AFP / GettyImages) |
Un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui…


Dei quattro evangelisti, Luca è il più vicino alla nostra moderna sensibilità progressista: quello che più offre la ribalta a donne, poveri e altri emarginati. È il vangelo di Maria di Nazareth, quello della natività coi pastori (Matteo ci mette i re Magi, tutt’un’altra idea di presepe): il vangelo che corregge la parabola dei talenti dividendo il budget in parti uguali tra i servi. Luca collaborava con Saul/Paolo, e ne condivideva evidentemente le idee ecumeniche, il progetto di evangelizzare anche i non circoncisi. Bisogna ammettere però che persino lui, per definire il concetto di “prossimo” non andò a pescare un personaggio così straniero per lingua, cultura e religione. Avrebbe potuto farlo, senza forzare più di tanto la verosimiglianza. La Palestina del primo secolo era già un crogiuolo, dove Gesù incontra senza andarseli a cercare centurioni romani, donne siro-fenicie e re idumei. Ma il prossimo della parabola è un samaritano, e i samaritani sono ebrei, a modo loro. Non riconoscono il tempio di Gerusalemme, ma offrono sacrifici sul monte Garizim. Sono ebrei scismatici? Dal loro punto di vista, ovviamente, gli scismatici sono tutti gli altri. L’ipotesi tradizionale è che discendano dagli abitanti del regno di Israele che non furono deportati dagli Assiri nel 722 aC, mescolati con altre popolazioni pagane che gli Assiri avevano deportato lì. Anche ai tempi però le sostituzioni etniche funzionavano fino a un certo punto: dai documenti assiri sappiamo che gli emigrati coatti furono poco più di ventimila. Gran parte della popolazione era rimasta lì, conservando leggi e tradizioni di matrice mosaica, anche se sensibilmente diverse da quelle rielaborate dai giudei che vivevano un po’ più a sud, deportati a Babilonia intorno al 600. Eppure quando settant’anni dopo i discendenti di questi ultimi ritornano nella Terra Promessa, lo scontro di culture in principio non sembra inevitabile. La Torah samaritana non differisce moltissimo da quella ebraica (anche se è scritta in un alfabeto più simile al fenicio), il che oggi fa pensare agli storici che in un primo momento la situazione tra le due comunità e le due narrative fosse più fluida. A un certo punto però avviene un irrigidimento, ed è forse l’evento raccontato nel Libro di Esdra: i matrimoni misti vengono annullati, le mura di Gerusalemme ricostruite imponendo una gerarchia precisa tra capitale e contado, che gli autoctoni samaritani rifiutano.

Cinque secoli più tardi, samaritani ed ebrei sono sudditi della stessa provincia romana, ma danno ancora l’impressione di non parlarsi volentieri. Il samaritano di Luca, più che uno straniero in terra straniera, è davvero il vicino di casa che suscita diffidenza: perché lo conosciamo poco o perché temiamo che ci conosca fin troppo bene? In un altro versetto di Luca, però (17,18), è Gesù stesso a chiamare “straniero” un samaritano, l’unico di dieci lebbrosi da lui miracolosamente guariti che si fermi a ringraziarlo:
Ma Gesù osservò: «Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Alzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».La fede salva anche gli stranieri. Quando mette in bocca a Gesù questa battuta, Luca forse ha in mente l’episodio dei vangeli di Marco (7,24-30) e Matteo (15,21-28) in cui Gesù risponde all’insistenza della Cananea che gli supplica di guarirne la figlia: “Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri”. La Cananea è una straniera, molto più di quanto non lo sia un samaritano. Marco, l’evangelista più stringato e meno a suo agio coi riferimenti geografici, la definisce “greca di origine siro-fenicia”, ovvero un’abitante della regione di Tiro e Sidone (oggi Libano). In un primo momento Gesù nemmeno le risponde: per ottenere una reazione, la donna deve tallonarlo per un buon pezzo, esasperando gli apostoli che alla fine intercedono: “Mandala via, perché ci grida dietro”. Gesù allora obietta di non avere giurisdizione su di lei: “non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa d’Israele”. Aggiunge poi una metafora dal sapore quasi razzista, che non stona del tutto in bocca al Gesù del vangelo di Marco, regale e un po’ sprezzante, ma che Luca non avrebbe mai messo in bocca al suo: “Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini”.

Un samaritano sotto una sukkah (un tipo di capanna che ricorda il transito degli ebrei nel deserto del Sinai durante l’esodo) fatta di frutta, vicino alla città di Nablus
Lo stesso Marco però registra la risposta straordinaria della straniera, che riesce addirittura a modificare l’atteggiamento di Gesù. “Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni”. In entrambi i vangeli l’episodio arriva dopo un duro confronto coi farisei sul tema delle impurità rituali. Ma è soprattutto in Matteo che esso suona come la riproposizione di un leitmotiv: Gesù era venuto per il suo popolo, il suo popolo non l’ha riconosciuto, non resta che rivolgersi agli stranieri. È il senso della Parabola del banchetto di nozze (22,1-14): visto che gli invitati rifiutano di venire, anzi uccidono i servi che portano le partecipazioni, il padrone ne manda altri ai crocicchi di strada, affinché invitino chiunque passa, “buono o cattivo”. (Luca, con quel gusto un po’ radical chic per gli emarginati, si diverte ad aggiungere “poveri, storpi, ciechi e zoppi”).
Gli stranieri dei vangeli di Matteo e di Luca rispecchiano un dibattito che deve avere animato i cristiani della prima generazione. Matteo non condivide l’entusiasmo ecumenico di Luca. Il suo Gesù, almeno in un primo momento, aveva chiesto ai suoi discepoli di “non andare fra i pagani e non entrare nelle città dei Samaritani”, ma di “rivolgersi piuttosto alle pecore perdute della casa d’Israele” (10,5-6). Più che l’apertura agli outsider, cagnolini avidi di briciole, imbucati a una festa, lo anima la vergogna per i correligionari che non hanno riconosciuto il Messia.
Il vangelo di Giovanni arriva un po’ più tardi (verso il 100) e rispecchia una situazione già molto cambiata. Il rapporto con gli altri tre testi è abbastanza complesso: Giovanni sembra volerli quasi ignorare, e allo stesso tempo se ne nutre. Matteo e Luca avevano attinto a Marco come a una fonte (o viceversa): Giovanni, negli altri vangeli, cerca qualcosa di meno definito, una specie di sfondo, di background. Ad esempio riutilizza i nomi: Marta di Betania in Luca serviva a un rapido scambio di battute: in Giovanni diventa un vero e proprio personaggio. Suo fratello, Lazzaro, in Luca era un poveraccio protagonista di una parabola: in Giovanni diventa amico fraterno di Gesù. Qualcosa di simile accade anche alla figura del Samaritano: quello che in Luca era l’evanescente protagonista di una parabola, Giovanni lo trasforma in un personaggio a tutto tondo, che dialoga con Gesù. Non solo, ma Giovanni lo contamina con la Cananea di Matteo, così che le due figure evangeliche dello straniero diventano una sola: la Samaritana.

«Chiunque beve di quest’acqua avrà sete di nuovo; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete; anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d’acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest’acqua, affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere».La reazione della Samaritana somiglia a quella del Pietro giovanneo, che non capisce perché Gesù gli vuole lavare i piedi, ma quando il Maestro gli risponde che sono funzionali alla vita eterna, chiede che gli si lavino anche viso e mani. La Samaritana, come Pietro, non capisce di cosa si stia parlando: non può capire, la salvezza le è preclusa, finché Gesù non ricorre alla sua arma segreta: il Segno. I miracoli del vangelo di Giovanni si chiamano così, “segni”, e non funzionano come quelli degli altri vangeli. In Matteo, Marco e Luca sono una specie di accessorio della divinità a cui Gesù è quasi costretto a ricorrere, spesso di malavoglia, inseguito da folle adoranti ma anche esigenti. In Giovanni i “segni” sono il principale strumento con cui Gesù manifesta la propria divinità: li usa deliberatamente, talvolta in modo teatrale. Per esempio quando alla Samaritana dice di andare a prendere suo marito, e lei obietta maliziosa “non ho marito”, Gesù risponde:
Hai detto bene: “Non ho marito”; perché hai avuto cinque mariti; e quello che hai ora, non è tuo marito; in questo hai detto la verità».Non è un miracolo così strabiliante, per i suoi standard: ma alla Samaritana tanto basta per riconoscere in Gesù “un profeta”. Molti commentatori traggono dal versetto la conclusione che la Samaritana, oltre a essere straniera, sia anche peccatrice: ma su sei uomini, almeno cinque la Samaritana li avrebbe pure sposati legalmente, magari in ottemperanza alla legge mosaica che costringeva la vedova senza eredi a risposare il cognato più giovane. Nel dettaglio immaginoso dei “cinque mariti” Giovanni infatti rielabora un altro spunto trovato in Luca: l’antiparabola della donna dai sette mariti (20,27-38). Nel vangelo di Luca la storiella era narrata dai Sadducei a Gesù nel deliberato tentativo di mettere in crisi il concetto di resurrezione: se una donna ha (legalmente) sposato sette mariti, di quale marito dovrebbe essere moglie nel Regno dei Cieli? (Nell’occasione la risposta di Gesù non è delle sue più convincenti, bisogna dire). Anche in questo caso, quello che in Luca era il protagonista di un breve racconto-nel-racconto, in Giovanni ottiene la dignità di personaggio reale, che interagisce con Gesù: e questo a prezzo della verosimiglianza, perché anche ai tempi una vedova di cinque o sette mariti doveva essere un caso eccezionale. È come se Giovanni leggendo Luca non voglia o non riesca a percepire la differenza tra i personaggi storici (Gesù, i Sadducei) e quelli fittizi delle parabole e degli apologhi (il povero Lazzaro, la sposa di sette fratelli), e questo è un argomento abbastanza pesante a favore di una datazione più tarda. I primi tre vangeli sono rielaborazioni sommarie di persone che magari non avevano assistito ai fatti, ma avevano conosciuto personalmente i testimoni: il quarto somiglia più a una rielaborazione fantastica. Una volta convintasi che Gesù è il Messia (è stato sufficiente che quest’ultimo le indovinasse lo stato civile), la Samaritana arriva in paese e si mette a fare apostolato, convertendo in breve diversi correligionari. Gesù si ferma per due giorni e poi riparte. Siccome è diretto in Galilea, ma il suo destino lo attende in Giudea, dalla Samaria (che è in mezzo) dovrebbe essere ripassato almeno una volta: ma Giovanni non ne parla più. Tradizioni molto più tarde le assegnano un nome greco, Fotina, e un martirio romano, probabilmente ottenuto quando qualcuno la confuse con una cristiana omonima martirizzata nell’Urbe il 20 marzo di un anno imprecisato, insieme con “Giuseppe e Vittore suoi figli, e così pure Sebastiano capitano, Anatolio, Fozio, Fotide, Parasceva e Ciriaca”.
I samaritani invece esistono ancora: vivono in due comunità, una proprio a Nablus nei pressi del loro monte sacro, un’altra a Holon, ormai periferia di Tel Aviv. Secondo i censimenti israeliani sono poco più di 700 persone, discendenti di un popolo talmente sventurato che persino gli ebrei, almeno ai tempi di Gesù, li guardavano con sufficienza. Tra rivolte e persecuzioni avrebbero avuto almeno 2000 anni di tempo per disperdersi o essere assorbiti da qualche altra religione o popolazione più grande. In un qualche modo, non è ancora successo.
La felicità di Felicita (e Perpetua)
07-03-2019, 19:26essere donna oggi, Il Post, santiPermalinkQuando l’arrestarono insieme con la sua padrona Perpetua e altri cristiani (Saturo e Saturno), Felicita era triste, perché aspettava un bambino. Era all’ottavo mese. Quando la padrona, nell’afa e nel buio della prigione cartaginese, cominciò ad avere visioni in cui saliva una scala di bronzo ignorando le armi di tortura appese a ogni piolo, Felicita si intristì ancora di più, perché capì che avrebbero ucciso tutti i suoi compagni in quanto cristiani, ma lei no: l’avrebbero risparmiata, perché la legge impediva di mettere a morte una donna gravida. I padroni se ne sarebbero andati in cielo, e la serva sarebbe rimasta giù a badare ai figli. Ma poi, due giorni prima di finire nell’arena tra le bestie, i suoi fedeli compagni si misero a pregare per la sua salvezza, e così intensamente pregarono che Felicita ebbe le doglie, e non senza soffrire partorì. Immaginatevi allora la felicità di Felicita, quando capì che non l’avrebbero lasciata sola, che avrebbero martirizzato anche lei (il figlio lo allevò una sua parente).
La Passione di Perpetua e Felicita non è la solita leggenda di santi. Come ha già scritto qualcuno (qualcuno che stasera ovviamente non riesco a ritrovare), la Passione assomiglia alle leggende come un manufatto originale ricorda le copie industriali. Ovvero: nel giro di qualche centinaio di anni il bacino del Mediterraneo si sarebbe riempito di storie di santi divorati dalle belve, santi sgozzati bruciati squartati e cotti alla brace; storie abbastanza ripetitive elaborate da copisti mediocri, costretti ad abusare di effettacci di scena per attirare l’attenzione; ma è abbastanza chiaro che al tempo in cui fu scritta la Passione tutto questo grandguignol immaginario ancora non esisteva. Chi scrive la Passione ci mette la freschezza, la sorpresa, di chi queste cose le scrive per la prima volta, per un pubblico che non deve controllare gli sbadigli a metà di una funzione religiosa; un pubblico che potrebbe ancora sgranare gli occhi e stupirsi per queste novità atroci e incredibili, questa giovane donna che sogna di combattere il demonio come un gladiatore in un anfiteatro gremito di spettatori: e che in quello stesso anfiteatro qualche giorno dopo muore davvero, non senza essersi raccolti i capelli dopo l’assalto di una vacca feroce; non prima di aver guidato il coltello nella mano del carnefice che alla fine tremava più di lei.
La Passione dovrebbe essere scritta all’inizio del terzo secolo, quando i cristiani erano ancora una minoranza soggetta a persecuzioni. I suoi protagonisti non sono supereroi inflessibili e senza paura: hanno caldo, soffrono la solitudine, si preoccupano per i genitori e i figli, temono i denti delle belve; sono esseri umani. La loro storia non serve a dimostrare la superiorità del cristianesimo sulla barbarie antica, ma a infondere coraggio a persone normali a cui sarebbe potuta toccare davvero una sorte come quella di Perpetua e di Felicita. Perpetua che descrive la sua prigione è stata anche accostata ad Anne Frank, con la sensibile differenza che nessuno leggendo il diario di Anne ha probabilmente concepito il desiderio di recludersi in una soffitta, mentre migliaia di lettori della Passio potrebbero davvero aver sognato di emulare l’eroismo suicida di Perpetua.
Perché la Passione è un piccolo capolavoro. Se poi le pagine centrali le avesse scritte davvero, in prigione, la nobildonna Vibia Perpetua, si tratterebbe di un documento ancora più eccezionale: l’unico brano di letteratura latina femminile. No, in effetti abbiamo anche qualche distico elegiaco di una sodale di Tibullo; certe iscrizioni di Pompei che per quanto ne sappiamo potrebbero anche essere i testi di canzonacce da spogliatoio; e questo è tutto. Straordinariamente poco. Non esiste una Saffo latina di cui imparare a memoria i versi; nemmeno un’Ipazia di cui immaginare i manoscritti perduti; niente. Come se le donne non avessero mai scritto, per mille e più anni. Perpetua però qualche pagina l’avrebbe composta: c’è fior di studiosi che onestamente lo pensa. Certo, per crederci dobbiamo ipotizzare che abbia scritto la sua memoria nel carcere di cui pure si lamenta per via dell’afa, del buio e dell’affollamento: probabilmente in quel “meliorem locum carceris” in cui i suoi protettori avevano ottenuto che potesse passare qualche ora al giorno, magari corrompendo i carcerieri. Bisogna immaginare che in una situazione del genere Perpetua si metta a scribacchiare su un rotolo, o su una tavoletta di cera, concludendo con “Hoc usque in pridie muneris egi; ipsius autem muneris actum, si quis voluerit, scribat“: “Questo mi è successo fino alla vigilia del martirio: quel che succederà dopo lo racconti qualcun altro, se vuole”. E infatti le pagine scritte in prima persona da Perpetua sono integrate da un anonimo narratore che la tradizione identificava col grande teologo Tertulliano, vivo e attivo a Cartagine proprio nello stesso periodo. Tertulliano però è un avvocato di formazione, e la sua foga oratoria non ricorda molto lo stile dimesso ma a suo modo orgoglioso della Passio. Allo stesso tempo chi, se non lui, avrebbe potuto tentare un’operazione letteraria così complessa e sottile, dando la voce a una o più vittime di una persecuzione?
Il punto è che la Passio è un testo talmente sui generis da autorizzare qualsiasi speculazione. Sta tra la leggenda eroica e l’agiografia, senza assomigliare troppo a nessuna delle due: racconta una storia agghiacciante con gli accenti inconfondibili del realismo, e come certe superfici troppo lucidate dal tempo, ci restituisce più la nostra immagine che quella dei personaggi di cui vorremmo interessarci. Chi coltiva la psicanalisi non può che desiderare che Perpetua abbia davvero vissuto un rapporto complesso col padre e un martirio, e soprattutto che abbia sognato quelle immagini intriganti di cui ci restituisce una trascrizione tanto vivida: quella scala adorna di simboli fallici, quel gladiatore egiziano che simboleggia il maligno, davanti al quale Perpetua afferma di essere diventata all’improvviso un “masculum”, (sì, l’unica donna della letteratura latina sogna di trasformarsi in masculum e sconfiggere un gladiatore). Chi studia il cristianesimo come fenomeno sociale ha un bel da obiettare che i sogni di Perpetua sembrano elaborati da un ideologo religioso con idee molto chiare da veicolare: in particolare quella in cui Perpetua ricorda il fratellino morto per un tumore al volto, anche lui recluso in un luogo oscuro e afoso, incapace di attingere acqua da una fontana troppo alta. Perpetua prega per lui giorno e notte, finché non lo sogna di nuovo: dell’orribile ferita è rimasta solo una cicatrice, la fontana gli arriva all’ombelico; sul bordo c’è una coppa d’acqua che non si esaurisce mai. Qui non c’è dubbio che i due sogni siano un racconto a tema, composto da un teologo che sta mettendo a punto il concetto di purgatorio. Così alla fine la mia opinione (se vi interessa) è che la Passione sia l’opera di un presbitero che aveva assistito ai fatti: che aveva pianto per Perpetua, magari invidiandone il coraggio; e che aveva deciso di riscattarla dall’oblio cedendo a lei la parola – qualcosa di forse mai provato prima da uno scrittore di lingua latina. Senza riuscire a levare del tutto dal racconto una certa proiezione virile (il sogno del combattimento), e aggiungendo al racconto dei sogni e delle privazioni quei significati teologici che gli premeva veicolare. Missione compiuta: due secoli più tardi Agostino sentiva ancora la necessità di ricordare ai fedeli di Ippona che la Passio, per quanto importante, non era da considerare sullo stesso piano delle Sacre Scritture.
Questa è la mia ipotesi; ma in fondo che ne so. Dopotutto domani è l’otto marzo, forse avrei più successo presentando Perpetua e Felicita come campionesse dell’empowerment femminile: due giovani donne che scelgono in perfetta autonomia il loro destino, rifiutando il ruolo di figlie devote e di madri sollecite; no, loro preferivano morire, e sono morte. Ok. Probabilmente qualcuno prima o poi lo farà, (senz’altro qualcuno lo ha già fatto secoli fa). Io, scusate, per stavolta non me la sento. Buona giornata della donna e felicità perpetua a tutti.
I santi hikikomori
01-03-2019, 00:11Il Post, santi, StoriaPermalink |
| Non è Donnina, ma Rosa da Lima |
Il fatto che sia probabilmente una santa inventata non la rende meno interessante, anche perché a volte un santo immaginario è solo il preannuncio di un santo vero; forse il mendicante Alessio non è mai esistito, ma mille anni più tardi i popolani romani si affezionarono al mendicante San Benoit Labre perché un po’ gli assomigliava; San Pelagio non è mai stato fatto uccidere da un monarca vizioso, ma a San Kizito è successo davvero, poco più di un secolo fa; e se anche non c’è mai stata davvero una Santa Domnina, tante altre ragazze avrebbero in seguito scelto di autorecludersi in una dépendance della casa dei genitori. La più famosa è probabilmente Santa Rosa da Lima, che oltre a pregare e digiunare strimpellava la chitarra, e questo le bastava (a 15 anni, ve lo dico, sarebbe bastato anche a me). Per ottenere questo stato di grazia, aveva dovuto lottare non poco contro i famigliari, che avrebbero preferito vederla ammogliata, o almeno titolare di una cella di riguardo in un convento: ma niente da fare, Rosa preferiva restarsene chiusa in casa, come Domnina. Come gli hikikomori.
 Avete mai sentito parlare degli hikikomori? Ultimamente hanno scoperto il fenomeno anche i Fratelli d’Italia – nel senso del partito di Giorgia Meloni. “HIKIKOMORI“, spiega fratel Massimo Ruspandini, “è un termine giapponese che significa “stare in disparte”. Hanno tra i 14 e i 25 anni e non studiano né lavorano. Non hanno amici e trascorrono gran parte della giornata nella loro camera. A stento parlano con genitori e parenti. Dormono durante il giorno e vivono di notte per evitare qualsiasi confronto con il mondo esterno. Si rifugiano tra i meandri della Rete e dei social network con profili fittizi, unico contatto con la società che hanno abbandonato. È QUESTO IL MONDO VERSO IL QUALE STIAMO ANDANDO?”
Avete mai sentito parlare degli hikikomori? Ultimamente hanno scoperto il fenomeno anche i Fratelli d’Italia – nel senso del partito di Giorgia Meloni. “HIKIKOMORI“, spiega fratel Massimo Ruspandini, “è un termine giapponese che significa “stare in disparte”. Hanno tra i 14 e i 25 anni e non studiano né lavorano. Non hanno amici e trascorrono gran parte della giornata nella loro camera. A stento parlano con genitori e parenti. Dormono durante il giorno e vivono di notte per evitare qualsiasi confronto con il mondo esterno. Si rifugiano tra i meandri della Rete e dei social network con profili fittizi, unico contatto con la società che hanno abbandonato. È QUESTO IL MONDO VERSO IL QUALE STIAMO ANDANDO?”Può anche darsi. Ma è anche il mondo dal quale provenivamo: un mondo in cui la scelta di appartarsi o autorecludersi è sempre stata un’opzione praticata da una minoranza non irrilevante di giovani, adulti e anziani. Abbiamo avuto l’ascetismo tardoantico, il monachesimo medievale; monache e suore di clausura; e poi certo, Diderot ci ha fatto scoprire che molte di queste persone venivano costrette dai genitori; Manzoni ci ha spiegato che questa costrizione prendeva molto spesso le forme di una coercizione psicologica così pressante da togliere alle vittime anche la consapevolezza di essere tali, convincendole di aver preso liberamente i voti di castità, obbedienza e clausura. Ma le testimonianze del passato ci dicono che nelle celle contigue c’è sempre stato chi ci entrava liberamente e volentieri: chi per entrarci doveva addirittura sfidare i genitori o scappare di casa. E c’era chi – come Rosa, come Domnina – dalla casa dei genitori non voleva semplicemente uscire.
 | ||
|
Pier Damiani e l'annoso problema della sodomia
21-02-2019, 08:41cristianesimo, Il Post, omofobie, pedofilie, preti parlanti, santiPermalinkCosa fareste per recuperare quel documento?
| Ma cos'è che avevo scritto quella volta |
Avete messo sottosopra gli scaffali, rivoltato i cassetti come calzini. Tutti i dischi rigidi, tutte le chiavette, avete portato dai cinesi quel laptop che si è spento per sempre cinque anni fa. E più cercavate, più quel documento diventava interessante, necessario, fondamentale, unico. Perché è l’unico che non si trova più. Il che non è possibile; voi non buttate mai nulla. Probabilmente è nel posto sbagliato, archiviato col nome sbagliato, dove lo ritroverete quando sarà troppo tardi. Oppure lo avete prestato a qualcuno, sì: qualcuno sembrava curioso e vi siete fidati senza tenervi una copia, pazzi! A nessuno bisogna prestare i propri documenti, di nessuno ci si può fidare. Neanche di un papa. Non è un modo di dire, per esempio San Pier Damiani si fidò di un papa, e lo sapete come andò a finire, no? In effetti forse no.
Pier Damiani il dottore della Chiesa, Pier Damiani l’inflessibile, l’incorruttibile, l’uomo che in teoria riusciva a vivere soltanto in un eremo appartato, circondato dall’algido affetto dei suoi confratelli, Pier Damiani che invece per un motivo o per un altro era sempre in giro per Sinodi o a Roma a lobbizzare con questo e quel pontefice; Pier Damiani un giorno scrisse una lettera stranissima a due cardinali, una lettera matta in cui si prendeva gioco del papa in carica, proprio lui! Pier Damiani, il riformatore: ce l’aveva con Alessandro II. Stia attento, scriveva: che un papa di nome Alessandro c’è già stato e fu frustato a sangue. Ma che aveva fatto il secondo Alessandro per meritare anche solo un vago riferimento al supplizio inflitto ai ladri? Cosa poteva aver mai fatto un pontefice per meritare un’accusa infamante e neanche tanto velata da parte di Pier Damiani? Indovinate: non gli restituiva un manoscritto.
Glielo aveva chiesto per farsene una copia: e doveva averglielo chiesto in termini piuttosto perentori, se Pier confessa che altrimenti non glielo avrebbe dato. Quando era tornato a riprenderlo, niente: il documento non c’era più. Ma che c’era mai scritto, in quell’unico fascicolo autografo tra mille che Pier non poteva più andarsi a rileggere? Magari niente d’importante. Lui stesso protesta che era poca roba, nulla per cui valesse la pena litigare o perdere il favore di un pontefice. E invece era proprio quello che stava facendo: aveva aperto un contenzioso col vicario di Pietro. Non riusciva a contenersi, Pier Damiani il continente. Ma perché Alessandro non rendeva il malloppo? L’ipotesi banale resta la più verosimile: magari aveva perso tutto. Basta appoggiare il quinterno sull’angolo sbagliato della tua Cattedra; magari qualcuno viene a mettere a posto, con le migliori intenzioni del mondo lo infila nello scaffale sbagliato delle biblioteche vaticane, e bye bye Inedito del Dottore della Chiesa, vallo a ritrovare se ci riesci. Possono passare anni. Secoli.
| Mi era venuto così bene quella volta maledizione |
Beh, è una specie di pietra miliare. Mettiamola così: sapete che la Chiesa ha questo problema dei preti pedofili, no? Ogni tanto se ne parla. Ecco: da quand’è esattamente che se ne parla? Quando è cominciato lo scandalo, o almeno quando la Chiesa ha iniziato a percepirlo come scandalo? Sono stime difficili da fare per uno storico. Di solito. Ma in questo caso no, in questo caso si può mettere una data quasi precisa: il primo a denunciare il fenomeno, in un latino ecclesiastico semplice ed elegante, fu Pier Damiani, nel Liber Gomorrhianus, indirizzato a papa Leone IX più o meno nel 1051. Quando si dice che il tal problema è annoso, pensate che questo specifico problema sta per compiere mille anni.
E prima non esisteva? Pier ne parla già come di una malattia morale ben nidificata. Più che i peccatori gli preme denunciare chi li copre: tutta una spaventosa rete di complicità sulla quale intende fare luce. In effetti chi voglia affrontare il Liber come se si tratti davvero del primo trattato di sessualità del medioevo rischia di restare deluso. Pier parla pochissimo dei peccati che denuncia; si capisce che ne prova un ribrezzo genuino. La sua casistica è limitata all’essenziale: secondo Pier ci sono quattro tipi di atti esplicitamente denunciati dalla Bibbia come contro natura. In ordine crescente di gravità: masturbazione solitaria, masturbazione reciproca, coito interfemorale e rapporto anale. Sono comunque tutti peccati mortali: chi li commette, secondo Pier, deve essere sollevato dall’incarico ecclesiastico. E la pedofilia? Pier ci arriva per gradi, esprimendo una riprovazione particolare per i presuli che iniziano al peccato i giovani che sono loro affidati. Oltre alla sodomia, in questo caso Pier intravede l’incesto, dal momento che il maestro è un padre spirituale, e il vincolo spirituale è più importante di quello carnale. In ogni caso, la soluzione è la stessa: chi pecca contro la natura e contro il vincolo famigliare deve perdere il suo incarico; gli deve essere impedito di confessarsi e ricevere l’assoluzione da un complice nel peccato (Pier aveva la sensazione che la cosa succedesse spesso). Ne va della salute morale della Chiesa, il papa deve assolutamente recepire la gravità del fenomeno e intervenire con severità. Il papa ringraziò, recepì, e qualche anno dopo fece sparire il manoscritto del Liber. Il primo caso di dossier sugli abusi del clero insabbiato dal clero. Notevole. Fin troppo.
| Ma dove l’ho scritto accidenti, qui non c’è |
 |
| Il cast di Spotlight, un film del 2016 sul problema denunciato nel 1051 da Pier Damiani. |
Un giorno – più facilmente una notte – avete perso un documento. All’inizio non vi sembrava una grande perdita, ma ora che non lo trovate più vi rendete conto che era perfetto. A dire il vero queste cose ormai succedono sempre meno, ora che tutto è sulla nuvola. Per dire, a me capita di ritrovare cose che credevo perdute e bellissime, articoli che avevo scritto per magazine on line che un giorno sono andati offline senza preavviso e figurati se l’Internet Archive si è fatta una copia: poi un bel giorno mi viene in mente una data o una stringa e bingo! Li trovo proprio sull’Internet Archive.
E fanno schifo.
Non riesco nemmeno a leggerli, buon dio, bisognerebbe chiedere all’Internet Archive di cancellarli. Chissà che schifezza aveva scritto Pier Damiani, che papa Alessandro non gli voleva restituire, e che gli sembrava un capolavoro soltanto perché non poteva più rileggerla. Io per dire qualche ora fa ho cancellato senza volere le dieci righe che servivano a finire questo pezzo e ora mi dispero, sono convinto che non troverò mai più un finale altrettanto bello e necessario, e intanto prendo tempo raccontando inezie al lettore. Era tutta una digressione finale sulla Chiesa Cattolica come prodigiosa macchina celibe, ma proprio per questo condannata ad avanzare nei secoli guidata da un’esplosiva miscela di uomini (selezionati e svezzati nei collegi): omosessuali e asessuali (ancora oggi secondo il New York Times i sacerdoti USA di inclinazione omosessuale potrebbero essere il 40% – qualche ecclesiastico col gay radar particolarmente sensibile parla del 70%). Con questa fondamentale controindicazione, che gli asessuali proprio non capiscono gli omo, e quindi questi ultimi devono in tutti i modi nascondersi ai primi attraverso tutta una serie di ipocrisie e codici di comportamento e regole che ti spiegano perché devi metterti le scarpine porpora anche se a te francamente basterebbero due sandali e via che si va. E che comunque la macchina, con qualche strappo e qualche panne ogni tanto sarebbe potuta andare avanti ancora per molto, non avessimo chiuso quasi tutti i collegi. Ecco, il pezzo diceva più o meno questo, ma lo diceva molto meglio di così. Magari se facessi control+Z per mezz’ora ritroverei quelle righe, ma quante altre ne perderei che immediatamente dopo troverei più necessarie. Quindi niente, stanotte il pezzo finisce così, chiedo scusa.
(Per scrivere un pezzo su Pier Damiani ho letto diverse cose, non tutte capendole e molte dimenticandone; in particolare lo spunto del manoscritto sottratto da papa Alessandro l'ho trovato in un articolo di Irene Zavattero, "Il Liber Gomorrhianus di Pier Damiani").
La libertà di Onesimo
15-02-2019, 00:27cristianesimo, Il Post, santi, StoriaPermalink |
| Il frammento conosciuto più antico del testo della Lettera a Filemone risale circa al 200. |
D’altro canto, perché inventarsi una lettera così breve, così limitata? Se qualche falsario avesse avuto in mente di affibbiare all’apostolo qualche idea rivoluzionaria o almeno progressista sulla questione degli schiavi, avrebbe dovuto scrivere ben altro. Ma Paolo, ogni volta che si tratta di parlare di schiavi, ribadisce che si devono comportare bene e rispettare i loro padroni. Naturalmente anche i padroni devono essere gentili con gli schiavi, come Filemone sarà gentile con Onesimo. Tutto qui: fine della dottrina sociale di Paolo.
 |
| Paolo detta una lettera a Onesimo |
 |
| "Prega il tuo Dio, Anassameno!" |
Non proprio le parole di un liberatore: né aveva senso aspettarsi qualcosa di più estremo da lui. Paolo non aveva nessuna intenzione di liberare il mondo dalla schiavitù: senz’altro gli interessava liberare una risorsa umana, Onesimo, che gli sarebbe stata molto utile come collegamento con tutta una serie di comunità di lingua greca e fede cristiana. Questo gli premeva, in vista del Giorno del Giudizio: quanto a ribaltare la società, senz’altro no; non ci pensava, non c’era tempo. Tutte le sue lettere, anche le più teologiche e sistematiche, sono sempre testi occasionali, studiati per determinate comunità in determinati momenti. Il vero fondatore della Chiesa non ha mai scritto un trattato per spiegare in generale come la vedeva, questa Chiesa. Niente libri: solo lettere, messaggi, comunicati, circolari. Forse non ha fatto in tempo; eppure la fine quando arrivò non fu esattamente imprevista. Forse non se ne riteneva capace, forse per lui i libri importanti erano quelli scritti dai colleghi, che portava con sé e magari stava ispirando, i Vangeli e gli Atti. E forse semplicemente Paolo di Tarso non pensava che ci fosse tutto questo tempo per dare ai suoi insegnamenti un impianto sistematico. Non era solo Paolo ad avere poco tempo: era il mondo a essere agli sgoccioli.
Per capire Paolo dobbiamo capire questa cosa: lui era realmente convinto di vivere nell’imminenza della fine, in un istante protratto in cui è senz’altro segno di saggezza continuare a comportarsi compostamente, rimanendo ai propri posti nella società (guai a chi smetteva di lavorare o lasciava la famiglia), ma senza darsi troppa pena di indagare sul perché quella società fosse fatta proprio così: dopotutto stava per finire. Ancora poco e non ci sarebbero più stati né padri né figli, né padroni, né schiavi, né lavoratori né lavori: quindi perché perdere tempo a protestare su queste sciocchezze? In una delle ultime pagine degli Atti, Luca lo descrive a bordo di barcone alla deriva nel Mediterraneo, proprio nei luoghi dove oggi Ong e Guardia costiera soccorrono i migranti. Il ritratto è così nitido che ci sembra impossibile che Luca non fosse a bordo con lui. Paolo non sa nulla di navigazione, ma a un certo punto decide che la nave si salverà e che l’equipaggio sarà risparmiato: e da quel momento prende il controllo. Esorta marinai e passeggeri a non mollare, a nutrirsi quando è il momento. Lui sa che ce la faranno, ha fatto un sogno. Alla fine il barcone arriva proprio Malta, isola di indigeni ospitali: Luca perlomeno li ricorda così. L’episodio è straordinariamente realistico, ma lo possiamo leggere anche come una riflessione sul ruolo dell’apostolo. Paolo non è un leader politico, non è un teorico, non spiega ai marinai il proprio mestiere né ha una rotta da consigliare. Paolo è un passeggero come gli altri che ha una sola cosa da dire: ci salveremo, tenete duro, non smettete di mangiare e ognuno resti al proprio posto. Lo schiavo faccia lo schiavo, il comandante faccia il comandante, quanto a me sono il tramite con Dio e Dio vi fa sapere che ci salverà, Gesù sta arrivando.
Qualche tempo dopo Paolo è morto, Gesù non è arrivato, e duemila anni dopo stiamo ancora usando le istruzioni sui biglietti che Paolo ci ha lasciato per la gestione provvisoria – come se uno lasciasse detto ai figli bagnatemi i fiori e ogni due giorni vuotate la cassetta del gatto, e dopo duemila anni ancora i pronipoti bagnano i fiori e vuotano la cassetta per timore che gli antenati si arrabbino, il gatto non c’è ovviamente più ma nel sacro biglietto c’era scritto così, il cristianesimo è un piano per un emergenza che non scatta mai.
Le frecce di Sodoma
22-01-2019, 17:30arti figurative, Il Post, omofobie, santiPermalink"So-do-ma!", "So-do-ma!", "So-do-ma!"
Questa storia ce la siamo già raccontata: comunque siamo a Firenze intorno al 1515, è un bel pomeriggio di giugno. Ma chi è che urla così? Sono i festeggiamenti per il palio di San Barnaba: i ragazzini stanno chiamando a gran voce il vincitore – che non è il fantino, ma il cavallo – anzi no, il proprietario del cavallo: Giovanni Antonio Bazzi, nato a Vercelli e residente perlopiù a Siena, soprannominato il Sodoma. Lui stesso ha detto alla folla festante di chiamarlo così!
 |
| Un San Sebastiano del Mantegna (1456), con un buffo nodo al perizoma. |
Che sfacciato, però. E infatti appena "certi vecchi da bene" se ne accorgono ("Che porca cosa, che ribalderia è questa, che si gridi per la nostra città così vituperoso nome?") anche i "fanciulli" cambiano atteggiamento. Da festosi diventano violenti e intolleranti. Basta un attimo. Di maniera, che mancò poco, levandosi il rumore, che non fu dai fanciulli e dalla plebe lapidato il povero Soddoma, et il cavallo e la bertuccia che avea in groppa con esso lui.
Forse la Storia ci piace perché ci fa sentire meno soli. In qualsiasi secolo ci capiti di dare un'occhiata, troviamo sempre persone che amano, odiano, combattono, si stancano, si ammalano: proprio come noi. Tutto quello che succede a noi, è già successo infinite volte e questo a volte ci dà la vertigine, ma più spesso ci è di conforto. Ci è tanto di conforto che conviene diffidare: non è vero, tutte queste persone non erano necessariamente così simili a noi. Leggiamo un aneddoto di Gian Battista Vasari su un collega che gli stava antipatico, e ci sembra di aver trovato un episodio di omofobia tale quale potremmo leggerlo domani sul giornale ("artista gay inseguito e malmenato"). Non solo, ma ci sembra anche di aver messo a fuoco il prototipo di artista queer del Cinquecento: il Sodoma è una pazza.
 |
| San Sebastiano in boxer attillati (Antonello Da Messina) |
Il Sebastiano del Sodoma guarda in alto, verso un angelo che sta per deporre la sua testa l'agognata corona del martirio. È un errore curioso che molti critici e storici dell'arte non notano, appunto perché sono critici e storici dell'arte e non sono obbligati a sapere che Sebastiano non fu martirizzato con le frecce. Ovvero, la versione ufficiale (che nel Cinquecento era ancora quella di Iacopo da Varazze) stabilisce che Sebastiano fu attaccato a una colonna e sagittato "come un porcospino": è senz'altro l'episodio più famoso della sua vita... ma non è il martirio. La corona deve ancora aspettare.
Alle frecce, infatti, Sebastiano sopravvive grazie alle cure di Santa Irene di Roma e della sua domestica, Lucina. Queste due pie donne, venute a seppellirlo, si accorgono che respira ancora: nottetempo lo trasportano nella ricca casa di Irene (patrizia romana) e gli estraggono le frecce a una a una: lunga fatica clandestina che a noi lettori moderni sembra già accanimento terapeutico. Perché prolungare la vita a chi si è votato al martirio? E infatti appena guarito, Sebastiano corre a riconsegnarsi all'imperatore che lo ri-condanna, stavolta a morire flagellato: ed è la volta buona. Ad altri santi servono quattro o cinque supplizi prima di ottenere corona e paradiso.
 |
| Luigi Miradori (XVII sec.): Sebastiano curato dalla vedova Irene. |
 |
| Ancora il Mantegna: una freccia è orientata diversamente dalle altre, ed è quella che più lo fa sanguinare. |
 |
| Il Savonarola di Fra Bartolomeo. Il suo San Sebastiano invece è talmente peccaminoso che hanno tolto anche le foto da Internet, giuro, non riesco a trovarne. Consolatevi col profilo di fra Girolamo. |
I pittori del Rinascimento sono anche anatomisti: la figura di Sebastiano consente loro di indagare su aspetti che altri soggetti non consentivano. È l'unico santo di cui è consentito abbozzare sulla tela il pene, anche se coperto (e a volte la copertura ha una consistenza fallica: vedi quel maliziosetto del Perugino). Un pene lo abbozza persino l'austero Piero della Francesca, nel polittico della Madonna della Consolazione; per notarlo dobbiamo confrontarlo con il Cristo dello stesso polittico, a cui il pittore non osa aggiungerlo. In più di un caso i pittori, non potendo aggiungerlo, vi alludono puntando una freccia proprio in quella direzione (ed è la ferita che produce più sangue). Il messaggio è ambiguo: la freccia è il peccato, o la punizione che Dio ci riserva per esso, o la sofferenza di amore che il soggetto (passivo) deve sopportare, oppure va' a sapere, spesso i pittori non sanno perché decidono di dipingere una cosa invece di un'altra. E dobbiamo presumere che anche i committenti non fossero tutti bacchettoni ipocriti come i frati o i benedettini: che ci fosse anche chi desiderava Sebastiani bellissimi e non troppo trafitti; non si spiega altrimenti la sopravvivenza del modello anche dopo la Controriforma, quando gli alti prelati già avevano messo nero su bianco che Sebastiano andava dipinto come nel medioevo, barbuto e magari vestito. Lo stesso Michelangelo nel Giudizio Universale non rinuncia a raffigurare un ragazzone aitante, che brandisce le frecce e sembra dire ai dannati sottostanti: io il Paradiso me lo sono sudato. Anche l'iconografia di Sant'Irene che cura il soldato ferito continua ad avere successo, e anche in questo caso Irene non è sempre una vedova in età avanzata.
All'Irene della Leggenda Aurea capita poi di scoprire in sogno che il cadavere di Sebastiano è stato gettato nella Cloaca Massima. Lo seppellisce lì nei pressi, in quelle che poi saranno chiamate Catacombe di Sebastiano.
San Vincenzo, il martire banale
21-01-2019, 19:22citazione, deliri, Il Post, repliche, santiPermalinkSan Vincenzo era diacono, come Santo Stefano, presso Saragozza (come San Braulione). Sotto Diocleziano imperatore fu arrestato, come San Sebastano, e interrogato come il suo vescovo, San Valerio. Trovato colpevole di cristianesimo, fu torturato sul cavalletto, come Santa Caterina. Siccome invece di pentirsi ringraziava i suoi torturatori, come Sant’Ignazio, il magistrato decise di arrostirlo, come San Giovanni. Dopo un po’ che era sui ferri ardenti pare che abbia detto anche lui al carnefice “Voltami, son cotto”, come San Lorenzo. Ma a quel punto il magistrato si stancò, e così Vincenzo rimase cotto a metà, il destino di ogni imitazione di un’originale. Le copie più riuscite molto spesso sono le più superficiali.
 |
| Ancora una graticola, che banalità. |
 |
| Noi non investiamo nel futuro, noi siamo la minoranza dei bei gesti che durano un attimo, e al sette in condotta ci penseremo poi. |
Il fatto di vivere in un mondo saturo di discorsi, dove ogni parola che ci viene in mente è una citazione, forse non dovrebbe tormentarci. Peraltro non è una novità, ci sono stati altri periodi così. Forse tutti i periodi sono così, anche se a posteriori non è sempre facile accorgersene. Alcuni di voi avranno certamente letto da ragazzini il capolavoro del Federico Moccia del secolo XVIII, tal Wolfgang Goethe – in seguito seppe riciclarsi egregiamente come autore di testi per adulti seri, ma nel nostro cuore è sempre stato l’autore di quell’agile romanzetto che lanciò la moda della giacca blu col panciotto giallo – e anche quella dei suicidi tra i lettori più sensibili – i Dolori del Giovane eccetera. Se l’avete letto nel periodo giusto forse ricordate ancora la notte di lampi e tuoni in cui il Giovane Imbucato a una festa di nobili conosce Lotte e s’innamora di lei. L’espressione “colpo di fulmine” forse prima non esisteva, ma il momento in cui il Giovane si infiamma davvero non coincide con un tuono o con un lampo. Il grosso della tempesta è già passato, quando Lotte pensosa alla finestra pronuncia la parola che lo infiammerà, condannandolo a un amore impossibile e alla lunga mortale.
Questa parola è “Klopstock”.
Ciò mi ha sempre fatto ridere.
 |
| Nessuno potrà più dire “Klopstock” senza commuoversi. Provateci. Klopstock. Klopstock. Vedete? |
Werther invece si innamora, perché ha colto il riferimento. Conosce Klopstock, ha indovinato l'”ode sublime” che Lotte ha in mente. Questo era il significato di “Klopstock” sulle labbra di Lotte, ma nelle orecchie di Werther ha già assunto un significato diverso. Significa: “ode sublime che io so che tu sai”. Significa già “Affinità elettive”. C’è qualcosa tra di noi che la rigida compartimentazione sociale della società tedesca prenapoleonica non potrà toglierci, nemmeno quando per darmi un tono mi farò prestare [SPOILER] le pistole da tuo marito e mi ci bucherò le cervella [/SPOILER]. Nel giro di pochi secondi la parola ha assunto un significato così personale che Werther vorrebbe ritirarla dalla lingua tedesca. “Nobile poeta, se tu avessi potuto vedere in quello sguardo la tua apoteosi! e se io potessi ora non sentir più pronunciare il tuo nome così spesso profanato”.
Chissà se poi Klopstock era così contento di essere diventato una specie di catenaccio di Ponte Milvio del preromanticismo, il McGuffin di un romanzetto per giovani tormentati. Sì, perché alla fine non è così importante di che poesia si tratti. Era davvero così bella? Lotte e Werther avevano davvero il gusto per apprezzarla, o non stavano pescando nel banale come Fiorello quando cantava la Nebbia agli irti colli piovigginando sale? Che importa. Con le citazioni non si sbaglia mai: dici “gatto di Shroedinger” e il tuo interlocutore penserà che tu ne sappia davvero qualcosa di meccanica quantistica. Di fronte allo spettacolo del temporale che si ritira Lotte avrebbe potuto provare a tirar fuori qualcosa di suo, ma se fosse suonata ridicola? La citazione ti risolve. Klopstock.
Ma chi siamo noi per giudicare. L’abbiamo avuta tutti una fase Klopstock, specie se ci è capitato di maturare sentimentalmente negli anni Novanta. A rileggere i libri del tempo, viene la vertigine: tutti i protagonisti passano il tempo a citare altri libri, o fumetti o film o poesie (persino Fiorello). Cosa avevamo in testa tutti? Perché non cercavamo la nostra singola voce invece di ritagliare frasi a caso dai discorsi degli altri? Eravamo solo giovani e stupidi, o c’era qualcosa di più?
Forse c’era qualcosa di meno. I Novanta non sono poi così lontani, ma sembrano ormai un universo parallelo, dove tutto più o meno è uguale a qui salvo che non c’è internet. C’era comunque molta cultura dappertutto, ma non era così immediatamente accessibile: andava comprata, noleggiata, riprodotta, fotocopiata: tutti passaggi che la consumavano e ce la rendevano più nostra. Citarsi addosso era un modo per riconoscerci: da qualche parte in città qualcuno quella sera stava dando una festa in cui a un certo punto una ragazza avrebbe detto “Klopstock”, o “Per un bel pezzo sono andata a letto presto”, o “Preferisco di no”, “Dove vanno le anatre”, o qualche altra frase che tutto il mondo avrebbe trovato ridicola tranne te. Dovevi trovarla. Dovevi allenarti a distillare le citazioni e riconoscerle nei discorsi altrui. Memorizzarle il più possibile e mescolarle con sapienza. Trasformare te stesso in una pratica citazione da snocciolare al momento giusto.
La barra di google ha messo fine a quell’era di abiezione. Non abbiamo smesso di citare, ma lo facciamo in modo più automatico, senza più il timore e il tremore di essere o non essere capiti. Diciamo “Pijamose Roma”, diciamo “Avete scommesso sulla rovina di questo Paese e avete vinto”, ma non è per selezionare i nostri uditori all’ingresso. Ci spuntano ancora sulle labbra per pigrizia, noi non sapremmo mai farne di altrettanto efficaci. Nel frattempo abbiamo anche smesso di immagazzinare contenuti, sia nelle librerie che nel disco rigido che nel nostro stesso cervello. Tanto nella nuvola c’è tutto; l’importante è sapere come cercarlo, cosa cercare, nell’evenienza che ancora da qualche parte arrivi una bufera e noi ci si ritrovi in quella situazione in cui…
“Klopstock”.
“Che hai detto?”
“No, niente”.
“No, ti ho sentito, hai detto qualcosa di una ciabatta”.
“No, non è una ciabatta, è un lirico tedesco”.
“Sicuro? Perché sembrava proprio una ciabatta”.
“È un lirico tedesco”.
“Sei sicuro? Guarda che lo sto già cercando”.
“Si scrive con la kappa”.
San Vincenzo voleva soltanto morire dicendo qualcosa di memorabile, come si conviene a un martire: che colpa aveva di vivere alla fine dell’epoca dei martiri, in un mondo ormai saturo di supplizi e frasi celebri? Tutte le torture e tutte le parole erano già state prese da santi non necessariamente più ispirati. Lui non aveva niente di meno di Santo Stefano o San Valerio o Santa Caterina, ma era arrivato dopo, in quel momento in cui qualsiasi cosa tu dica o faccia fa già parte di un discorso già finito. Qualcosa di simile sarà forse capitato anche a noi. Avevamo solo le parole degli altri, ce le siamo fatti bastare. Per quel che avevamo da dirci, alla fine [2015].
Metti sull'Uno c'è un maestro che urla
18-01-2019, 18:215Stelle, Beppe Grillo, cinema, Il Post, santi, scuola, tvPermalinkIl primo successo del 2019 per la Rai è Alessio Boni che urla ai ragazzini. Certo, La Compagnia del Cigno è molto altro: c’è musica in abbondanza, classica e moderna, e poi ogni ragazzo ha il suo arco narrativo, l’ingresso nell’età adulta eccetera – sì sì però se lunedì sera mettete sull’Uno all’improvviso, in tre casi su tre si materializzerà Alessio Boni che a stento controlla l’impulso di rompervi la bacchetta in testa.
La Compagnia ha battuto il Titanic restaurato, ha battuto la Coppa Italia; il maestro che urla è il primo grande spettacolo italiano del 2019. Quasi un italiano su dieci ha assistito alle sfuriate del maestro Boni senza cambiare canale. Anzi dev’essersi in qualche modo affezionato, e non so se questa è una buona notizia per il mondo della scuola. In gran parte si tratta degli stessi italiani che non esiterebbero a denunciare un maestro del genere se invece che in tv sbraitasse in quel modo davanti ai propri figli, in un’aula scolastica – andiamo, persino io lo avrei mandato a quel paese a un certo punto: e faccio il suo mestiere. Che ci è successo?
Che fine ha fatto il modello di insegnante che andava di moda quando studiavo, quello super-empatico che non castigava mai nessuno, anzi riusciva a entrare in sintonia con tutti senza alzare la voce? Il Robin Williams dell’Attimo fuggente: molti di noi insegnanti vorrebbero ancora assomigliargli, anche se alla fine ci scappa la pazienza e gli studenti piangono e poi i genitori protestano. Genitori che, diciamolo, non hanno sempre tutti i torti, forse dovremmo essere ancora più pazienti – sì, però gli stessi genitori quando tornano a casa si bevono due ore di fiction con Alessio Boni che urla e strepita, c’è qualcosa di paradossale in tutto questo.
D’altro canto è pur sempre televisione. Quello specchio piuttosto distorto che non mostra quasi mai il mondo intorno a noi; il più delle volte ci mette davanti il mondo dentro di noi. Nessuno vorrebbe un maestro severo per i suoi figli, ma tutti segretamente lo vorremmo per i figli degli altri, e forse una fiction assolve questa funzione (“Guarda questo professore asfaltare sette adolescenti!”)

Come ogni modello che funziona i critici si sono subito affrettati a farci notare il prestito evidente nei confronti di un prodotto d’importazione. Lo ha prontamente ammesso anche lo sceneggiatore Ivan Cotroneo: il maestro interpretato da Alessio Boni deve molto a quello impersonato da J. K. Simmons in Whiplash, il primo film di Damien Chazelle. È il ruolo che finalmente ha fruttato un Oscar a Simmons, il classico caratterista che tutti abbiamo la sensazione di conoscere come un familiare, tante volte lo abbiamo visto in tv. E però in Whiplash il maestro urlatore è il cattivo del film, non l’eroe che aiuta a sbloccare le potenzialità del protagonista. A parte la sua ossessione per la musica (ossessione omicida) non conosciamo quasi nulla di lui. Non c’è tempo per spiegare cosa lo ha trasformato nella belva che è; non ci sono flashback che ci facciano scoprire i suoi dolori, i suoi lutti, non ci sono siparietti ricattatori che ci facciano piangere insieme a lui. Non è insomma come il maestro di Boni, che tra una scenata e l’altra lascia intravedere un animo sensibile, empatico, in grado di entrare in sintonia con il delicato mondo interiore dei ragazzi; se anche il personaggio di Simmons sembrava trapelare qualcosa del genere, era soltanto per rivelarsi fino alla fine un subdolo manipolatore.
Whiplash fu criticato, anche in Italia, per la visione del mondo che tradiva: una giungla dove conta soltanto la lotta per la sopravvivenza, l’autoaffermazione e il successo. Il film si presta in realtà a un’interpretazione più problematica: il protagonista è più vittima che eroe. Il maestro della Compagnia del Cigno, all’apparenza più sfaccettato, alla fine è soltanto il classico burbero dal cuore d’oro. Ma Whiplash è un grande film anche perché mette in guardia da quel modello di maestro carismatico, denunciandone la tossicità.

Sia Whiplash che La Compagnia, poi, traggono spunto da un discorso così universalmente condiviso ormai che rischiamo di non vederlo intorno a noi, come l’aria che respiriamo. In un certo senso è l’aria che respiriamo. È il talent-show. Whiplash è strutturato come una caricatura di talent-show: un maestro severo, un allievo che deve seguirlo ma anche sconfiggerlo. La Compagnia è un succedaneo di talent-show – quasi un placebo per i telespettatori in crisi d’astinenza, tra la fine di X Factor e l’inizio di Sanremo. Lo stesso Sanremo assomiglia anch’esso sempre più a un talent-show, al punto di essersi dotato di un maestro talentuoso, magari non sbraitante ma più severo di quanto ci saremmo aspettati: Claudio Baglioni.
Il 2019 è l’ultimo anno degli anni Dieci. Forse non è più troppo presto per un bilancio: è stato il decennio dei Talent. È vero, esistevano anche prima (più negli USA che in Italia). Ma fino a X Factor non eravamo abituati a chiamarli così, e soprattutto non li consideravamo molto di più che una forma di intrattenimento, una sottospecie dei Reality. Poi è successo qualcosa, fuori e dentro la tv. Non è ancora chiaro cosa – forse ha a che vedere con la caduta delle élite di cui in questi giorni stanno parlando sui giornali di carta. Insomma altri punti di riferimento sembrano essere crollati: i politici hanno smesso di essere attendibili (non che lo fossero dieci anni fa), medici e insegnanti hanno perso ogni autorevolezza. L’unico punto fermo, l’ultimo baluardo della meritocrazia, è il Talent.
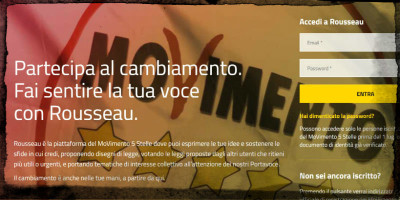
A questo punto naturalmente occorre obiettare che una meritocrazia del genere non può funzionare: tanto per cominciare gli strumenti sono farraginosi (Rousseau non funziona), ma anche se fossero efficienti, ci sarebbe il problema che il popolo è un pessimo giudice, non ha le competenze ecc. ecc.. Tutto probabilmente vero. Ma non è così strano che la società dello spettacolo si affidi al codice del Talent. Scuole e università non è chiaro se funzionino o no; perlomeno le ultime classi dirigenti che hanno formato lasciavano molto a desiderare. I Talent non è detto che creino più competenza, ma sicuramente fanno spettacolo, e quella è una cosa che sappiamo apprezzare.

Nei Talent scorre ancora, neanche tanto sotterranea, quella vena di sadismo e crudeltà che abbiamo bandito dalle scuole (e che forse inconsciamente rimpiangiamo). Solo nei Talent è ancora concesso umiliare l’incapace, e mettere apertamente l’uno contro l’altro gli apprendisti. Che parlino di cucina o di musica, il motivo per cui li guardiamo è il motivo per cui ci lasciamo ipnotizzare dalle sfuriate di Alessio Boni: i maestri sadici sono sexy. Vederli tormentare le loro vittime è uno spettacolo per cui paghiamo abbonamenti e biglietti al cinema. Forse ci piacciono proprio perché non assomigliano affatto ai nostri ex professori, empatici e condiscendenti, sempre pronti ad applaudire ogni nostro minimo sforzo. Se non siamo diventati quegli uomini e donne di successo che loro vedevano in noi, magari è colpa loro: troppo buoni, troppo permissivi. Se ci avessero preso a ceffoni, invece, chissà… vabbe’, è troppo tardi per recriminare. Ma si fa ancora in tempo ad accendere la tv. Sull’Uno c’è un prof che strepita, su Sky quattro cuochi infieriscono su dilettanti allo sbaraglio, l’Attimo fuggente almeno stasera non c’è (anche perché a modo suo va in scena in tutte le scuole d’Italia, da lunedì a sabato, da settembre a giugno: e dopo un po’ viene a noia, non ditelo a me).
Il papa che successe a sé stesso
16-01-2019, 00:53cristianesimo, Il Post, pontefici, religioni, repliche, santiPermalink |
| Nulla, non c'entra assolutamente nulla. |
Dell'imperatore Diocleziano, delle sue sanguinose persecuzioni, su questo blog ci siamo spesso presi gioco. Il fatto è che già a poco più di un secolo di distanza (quando il cristianesimo era diventato religione di Stato), Diocleziano aveva già assunto le dimensioni dell'orco sbrana-cristiani, a capo di un esercito di torturatori efferati e un po' frustrati: a Santa Cecilia cercano di tagliare il collo e la lama rimbalza, Santa Lucia cercano di portarla nel bordello ma è troppo pesante, a Sant'Agata tagliano i seni e le ricrescono, eccetera. E però tutto questo grand-guignol di leggende inventate dai monaci per distrarsi un po' nell'ora di refettorio non deve farci dimenticare che un Diocleziano ci fu davvero, e che di cristiani ne fece uccidere più di qualsiasi altro imperatore: quanti? Difficile dire. Migliaia, forse più – Gibbon semplicemente non ci credeva, ma era un uomo del Settecento, quando anche le battaglie campali sembravano figure di minuetto. Gli storici del penultimo secolo, familiari coi concetti di pogrom e di purga, non escludono che un imperatore deciso a fondare un culto della personalità non possa aver messo in cantiere uno sterminio, anche se il body count rimane piuttosto prudente (tremila o un po' di più in tutto l'impero). Pochi, tutto sommato, per una religione che nelle città era ormai un fenomeno di massa.
Evidentemente molti cristiani cercarono di sfangarla venendo a patti con l'autorità costituita: alcuni bruciando incenso agli Dei (turificati), altri sacrificando animali agli stessi Dei (sacrificati), altri, non volendo scannare nessun animale, corrompendo qualche autorità per procurarsi un certificato che attestasse che lo avevano sacrificato (libellatici). Infine c'erano i peggiori di tutti, i traditores, che all'inizio significava semplicemente "consegnatori": erano i sacerdoti che avevano consegnato i libri sacri ai magistrati - e magari anche qualche registro di battesimo coi nomi degli affiliati, gli infami. Tutto questo poteva salvarti la vita terrena, ma quella eterna? I sacrificati, i turificati, i libellatici e i traditores non erano più ammessi in chiesa. Erano i cosiddetti lapsi, "scivolati", quelli che avevano avuto un'occasione buona per diventare protagonisti di una sanguinosa leggenda di martiri e se l'erano giocata. Il dibattito sulla riammissione dei lapsi era già scoppiato ai tempi dell'imperatore Decio, e riprese subito vigore. In certe comunità venivano riammessi soltanto dopo una pubblica cerimonia di pentimento: insomma dopo aver ritrattato il cristianesimo davanti ai magistrati dovevano ritrattare la ritrattazione davanti ai sacerdoti, e farsi consegnare una ricevuta, un libellus che dimostrasse che erano di nuovo cristiani a tutti gli effetti. Ovviamente se i magistrati imperiali mettevano la mano sul libellus potevano ri-imprigionarli, e così via.
Si dice che il cristianesimo crebbe annaffiato dal sangue dei martiri. È una mezza verità: le piante hanno bisogno di liquidi ma anche di letame. Senz'altro i martiri ci misero il sangue, ma se il cristianesimo sopravvisse a Diocleziano fu grazie ai lapsi. Questo però non si può dire - tranne che sul Post - perché molti lapsi furono probabilmente traditores, nel senso moderno del termine: molti di loro probabilmente si conquistarono la libertà vuotando il sacco davanti al magistrato, spifferando nomina e cognomina di tutti i cristiani del quartiere. Poi alla fine se ne tornavano alla catacomba e chiedevano pure di essere riammessi al culto, che facce toste. Il cristianesimo che sopravvive alla persecuzione dioclezianea deve affrontare quel senso di colpa collettivo che attanaglia i superstiti di qualsiasi disastro: perché gli altri sono morti e io no? Aggiungi che in certi casi la risposta è insostenibile: sono morti gli altri perché tu li hai traditi. Gli altri sono santi, e ne leggiamo le leggende: tu sei il peccatore, tu dovrai espiare. La realtà probabilmente era molto più sfumata, vedi il caso di San Marcellino Papa.
Da non confondere con San Marcello Papa, che è il santo che si festeggia oggi, e di cui dovrebbe essere il predecessore. Il nome può sembrarvi buffo, ma è uno di quei tipici nomi tardoromani: si chiama Marcellino anche uno degli scrittori più interessanti del quarto secolo, un ex soldato dalla prosa cupa e marziale che non ti aspetteresti in un'antologia, alla voce Ammiano Marcellino. "Marcellino" è la terza derivazione del nome Marco, che a sua volta deriva dal dio Marte: all'inizio Marco significa "di Marte". Marcello, invece, significa "di Marco": può sancire un'adozione o forse un passaggio di proprietà di schiavi che poi una volta liberati mantengono il nome. "Marcellino", a sua volta, potrebbe essere un figlio di Marcello, o uno schiavo venduto e poi liberato. I nomi dei primi secoli erano brevi: Lucio, Mario, Claudio. Verso il terzo secolo abbiamo Marcellino, Claudiano, Valentiniano (←Valentino ←Valente), Costantino (←Costanzo ←Costante) eccetera. L'impero continua a essere retto da uomini duri e violenti, ma hanno nomi derivativi, sempre meno originali, sempre più involontariamente pucci, fino a quel Romolo Augustolo che chiude miracolosamente il cerchio. Non fossero arrivati i barbari, oggi ci chiameremmo Marcelliniancelliniano? In un certo senso i barbari dovevano arrivare, era un'esigenza sentita a tutti i livelli, persino nell'onomastica.
 |
| La chiesa di San Marcello al Corso (da wikipedia) sorge nell'antico sito della stalla (far lavorare un papa, che barbarie). |
A dire il vero il suo nome nel Cronografo c'è: ma è associato al diciottesimo giorno alla Calenda di Febbraio, cioè oggi, 16 gennaio, e non al 26 aprile. E tuttavia deve trattarsi di una svista: il 16 gennaio non è la festa di Marcellino, bensì di Marcello, il suo successore: un papa integerrimo che si oppose al facile recupero dei lapsi, e insistette sulla necessità che facessero penitenza e mostrassero contrizione per i loro tradimenti. Tanta intransigenza lo portò in rotta col successore di Diocleziano, Massenzio, che lo condannò a lavorare nelle stalle imperiali (ma questa forse è una storia messa in giro dal proprietario di una stalla che credeva nelle opportunità del turismo religioso e sperava di attirare i pellegrini con una storiella). Il lavoro in stalla era molto pesante e Marcello ne sarebbe morto, martire, il 16 gennaio, perlappunto. Ora, non è così strano che un papa Marcello subentri a un Marcellino (non era ancora invalsa l'abitudine a cambiar nome una volta varcato il soglio): ma che cadano entrambi martiri lo stesso giorno, è una cosa che lascia perplessi. Al punto che Mommsen riteneva che il secondo non fosse un vero papa: piuttosto un vicario, un facente funzione. In effetti la situazione poteva essere molto delicata: magari Marcellino aveva perso la carica di pontefice nel momento in cui aveva temporaneamente abiurato la fede in Cristo. Poi ci aveva ripensato, ma a quel punto era da considerarsi ancora pontefice a tutti gli effetti? Chi poteva deciderlo, se non lui stesso? Un falso storico del sesto secolo ci mostra proprio un concilio-processo in cui i vescovi lo interrogano, ne ottengono una confessione, ma non lo condannano, perché "la prima sede non può essere giudicata da nessuno".
Un'altra possibilità è che Marcellino se ne sia tornato bel bello a fare il pontefice, dopo l'abiura, senza chiedere scusa a nessuno. Qualche secolo dopo un cronista avrebbe potuto trovare la cosa imbarazzante, e dividerlo in due: un pontefice un po' tremebondo che viene perseguitato, abiura ma poi si pente e muore martire nel 305, e un altro tutto d'un pezzo che ostenta tolleranza zero per i lapsi e i traditori, e muore anch'esso martire in una stalla il 16 gennaio 309. La scelta di chiamare il doppione di Marcellino "Marcello" potrebbe essere stata dettata da scarsa fantasia o (più verosimilmente) dalla necessità di non alterare troppo i documenti originali. Dei due, quello probabilmente inventato è il più eroico e intransigente. Non sorprende.
Parlo di teologia, io?
09-01-2019, 20:49cristianesimo, Il Post, razzismi, repliche, santiPermalink[2016].
Anche oggi c'è gente che, come quei famosi ateniesi, non trova di meglio da fare che discutere di argomenti inediti od originali. Braccia rubate al mercato o al cantiere che si improvvisano maestri di teologia: avanzi di schiavitù da prendere a mazzate, che d'un tratto ci filosofeggiano con solennità di cose incomprensibili.
Lo sapete di chi stiamo parlando: la città ne è piena. Le strade, i crocicchi, i fori, i parchi... venditori di tappeti, cambiavalute, friggitori ambulanti. Tu chiedi di scambiare una moneta, ti rispondono disquisendo sulla natura del Generato e dell'Ingenerato; vuoi sapere quanto costa una pagnotta, “Il Padre è il maggiore”, ti dicono, “e il figlio gli è soggetto”: domandi se ai bagni l'acqua è calda, e ti informano che il Figlio ha origine dal nulla...
 |
| Padri cappadoci, Nissa è (forse) quello con la barba lunga. |
Certe citazioni ormai galleggiano nel vuoto, non siamo nemmeno sicuri del libro da cui sarebbero ritagliate. Hanno maturato significati diversi da quelli previsti in partenza; diventano meme, parole di un linguaggio nuovo, incomprensibile ai non iniziati. Tra i miei amici di facebook non è infrequente rimproverarsi di parlare di astrofisica. Citiamo ovviamente la battuta di un regista frustrato, protagonista di un film di Nanni Moretti - no, non l'ultimo - neanche il terzultimo - forse il terzo? Lamentandosi della mania che hanno tutti di parlare di cinema senza mai aver studiato l'argomento, gridava: parlo di astrofisica io?
Molti anni prima dell'invenzione del cinema, e della stessa astrofisica, il problema era già avvertito dagli intellettuali. Non potendo citare Moretti, ripiegavano su San Gregorio vescovo di Nissa, che nel IV secolo scrisse in mezzo a un migliaio di pagine fitte di patristica l'esilarante bozzetto che ho tradotto sopra un po' liberamente. È un brano famoso in senso molto relativo: ci ho messo anni a rintracciarlo. Poi mi sono reso conto che lo cercavo nel volume di patristica sbagliato, perché tutti questi professori che si lamentano dell'incompetenza popolare... sbagliano quasi sempre a segnalare la fonte della citazione, attribuendola a un amico di famiglia di Gregorio di Nissa, Gregorio di Nazianzo. Anche lui vescovo in Cappadocia e padre della Chiesa, per cui non è così difficile confondersi.
È un errore illustre, condiviso dallo stesso Hegel; lui del resto non aveva perso tempo a sfogliare i padri cappadoci, ma si era fidato di Gibbon che nel suo best seller Declino e caduta dell'Impero Romano aveva a sua volta citato il Gregorio sbagliato, mutuando l'errore da un teologo dei suoi tempi, tale John Jortin che nelle note del suo volume aveva fatto confusione tra i due Gregori ed era morto prima di correggere le bozze. Che storia affascinante. Morale: non si è mai abbastanza competenti.
Va bene, ma di che stava parlando Gregorio esattamente? In quel frammento dell'orazione Sulla divinità del Figlio e dello Spirito Santo, 46esimo volume della Patrologia greca, il vescovo di Nissa si distrae per un attimo dal problema trinitario, e si volta a dare un'occhiata a quel che succede nella grande città: Costantinopoli. Quando mi imbattei per la prima volta nei due Gregori, a metà anni Novanta, in società si parlava più che altro di calcio e politica. Tutti ne erano esperti, tutti ritenevano di avere pareri interessanti, giuro, non è una frenesia nata con facebook: Zuckerberg ci ha fornito soltanto un impietosissimo specchio. A volte mi mancava l'aria e così frequentavo lezioni strane, ad esempio Storia del Cristianesimo Antico.
Scoprivo che secoli prima, gli abitanti di una lontana metropoli, dovendo pur trovare qualcosa su cui litigare in attesa dell'invenzione del calcio, si scannavano intorno alla teologia. Il dibattito sulla Trinità, e sulla generazione del Figlio, era uscito dai capitoli e dai sinodi e circolava sulle bocche di tutti, pizzaioli e rigattieri. Venivano alle mani spesso, e a volte ci scappava il morto. L'altro Gregorio - non quello di Nissa - fu quasi linciato nella sua stessa cappella privata, perché era stato ordinato vescovo niceno di Costantinopoli, in un periodo in cui in città andavano per la maggiore gli ariani. Questi ultimi credevano che il Padre avesse creato il Figlio in un secondo momento; i niceni invece credevano in un Figlio generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. I niceni avevano già vinto un Concilio nel 325, e col tempo avrebbero prevalso, massacrato gli ariani e distrutto i loro libri. Ma in quel periodo erano un po' in crisi: gli imperatori, dopo averli favoriti, se ne erano stancati e a volte sponsorizzavano apertamente gli avversari. Il bello di studiare queste cose, quando sei giovane, è che ti chiedono la stessa sospensione dell'incredulità di una saga fantasy - pensateci, si accapigliavano per stabilire se il Figlio fosse stato "creato" o "generato" dal padre. Un dibattito che oggi non interessa più nemmeno i cristiani. Già. Oggi parliamo d'altro. Ma, ecco, di che parliamo?
A quel tempo ero una specie di marxista, a mio modo ovviamente – in sostanza credevo che gli uomini si potessero dividere soltanto in classi sociali. Questa era l’unica classificazione che avesse un senso economico, e quindi l’unica che avesse un vero senso. Tutti gli altri insiemi – i cosiddetti “popoli”, le cosiddette “religioni” – erano fenomeni sovrastrutturali. Non è che non esistessero, ma venivano elaborati dagli uomini a mo’ di paravento, sovrastruttura, per occultare la ripartizione fondamentale, quella tra profittatori, aspiranti profittatori e lavoratori. Tutte queste cose non so se Marx le abbia mai scritte davvero, avrei più difficoltà a spulciare il Kapital che la Patrologia, però ci credevo e forse ci credo un po’ persino adesso. Dunque diffidavo della versione di San Gregorio, perché davvero, che può interessare a un cambiavalute della Generazione del Figlio? Però da altri accenni si capiva che gli ariani erano la fazione più popolare (lo stesso Ario, racconta Filostorgio, una volta cacciato dalle chiese ufficiali, si era messo a comporre i suoi sermoni sulla musica delle canzonacce dei marinai e dei mulattieri). I niceni invece avevano già quella sfumatura benpensante che li identificava come organici della borghesia – e i Costantini giocavano a metterli gli uni contro gli altri, appoggiando ora questa ora quella fazione, per strategia o per capriccio.
Due secoli più tardi sarebbe successa la stessa cosa coi tifosi delle due più importanti scuderie delle corse di bighe, gli Azzurri e i Verdi. I primi erano i popolari (ma appoggiati dall’imperatore Giustiniano), i secondi aristocratici e monofisiti. Entrambi giravano coi coltellacci legati alla gamba, e si pettinavano all’Unna, lasciandosi crescere le creste per spaventare gli avversari. Vedi come lo stesso fenomeno (una guerra tra bande di delinquenti per le strade di una metropoli) si può leggere in tre modi: (1) guerra di tifosi: è il modo più superficiale, come se qualcuno fosse davvero disposto a morire per i colori di una squadra; (2) guerra di religione, monofisiti contro ortodossi; (3) lotta di classe. A me ovviamente interessava solo il terzo piano, quello di cui nessuno vuole mai parlare. Fanno tutti una gran confusione, parlano di bighe o quadrighe o di natura divina e umana del Figlio, perché non vogliono parlare di salari e di libertà degli schiavi… Però alla fine Azzurri e Verdi si stancarono di ammazzarsi per il sollazzo del Cesare, gli assediarono il palazzo contiguo al Circolo e chiesero le dimissioni del prefetto del pretorio, ritenuto responsabile dell’iniqua tassazione. (Le ottennero, ma in seguito Giustiniano, consigliato dalla moglie Teodora, riuscì a dividerli e li sterminò).
(Milletrecento anni più tardi, in una difficile città di mare dall’altra parte dell’Europa, ci si rimise ad ammazzare tra “verdi” e “azzurri”. I primi tifavano il Celtic Glasgow, erano immigrati irlandesi e cristiani cattolici. I secondi sostenevano i Rangers, ostentavano lealtà alle maestà britanniche e fedeltà alla chiesa protestante. Risse da ubriachi, guerre di religione, indipendentismo e identità celtica: dipende anche da storia vuol leggere la gente il mattino dopo).
 |
| Seduta di autocritica maoista in Bobocandia ("O Marx O Lenin O Mao Mao"). |
Nello stesso periodo in cui studiavo i padri cappadoci, avevo messo le mani su certi vecchi fumetti di un francese geniale e irregolare, Gérard Lauzier. La sua prima storia era ambientata in un’ex colonia francese di fantasia tra jungla e savana. Gli abitanti della savana erano diventati il Fronte Bobocalandese di Liberazione – trotskisti – mentre la tribù della giungla si era convertita al marxismo-leninismo di marca cinese, fondando il Fronte di Liberazione Bobocalandese. Dopo il tramonto conducevano lunghe sessioni di autocoscienza politica davanti al fuoco, cantando O Lenin O Mao O Mao al suono dei tamburi. Negli anni Settanta Lauzier passava per un autore di destra, e in effetti disegnava ancora gli africani coi labbroni e i dentoni. Si rifiutava a vedere il progresso nella decolonizzazione: era tutta una farsa, una tribù resta una tribù anche se coi fucili le vendi il libretto rosso. Il libro è fuori commercio in Italia, trovarlo è stato più difficile che rintracciare la citazione giusta nella patrologia.
Mi capita spesso di ripensare alla vignetta della tribù marxista, ultimamente, e ai venditori di tappeti di Gregorio di Nazianzo, pardon, Nissa. Sono contento che è finito Natale, quest’anno più del solito. Al mercato, in piazza, in sala insegnanti, per un mese non s’è parlato che di identità cristiana, e soprattutto di presepe. Chiedevi il prezzo del pane, ti rispondevano presepe. Domandavi che fine aveva fatto la programmazione monodisciplinare, ti mettevano al corrente del grosso rischio che stavamo passando di non poter più sentire le zampogne a causa degli immigrati musulmani. L’Amaca di Michele Serra appesa dappertutto. Il punto di riferimento del ceto medio riflessivo progressista che verso la fine del 2015, fidandosi di qualche notizia distorta, si è convinto che i musulmani ci stessero togliendo il presepe. Il presepe. Tra due secoli qualcuno ritroverà un fondo di Michele Serra nel fondo di una valigia, leggerà e si domanderà nella sua lingua sconosciuta: ma sul serio? Parlavano di questo all’inizio del millennio? Di presepe? Non del riscaldamento globale, dell’instabilità economica europea o delle migrazioni nel mediterraneo; parlavano del presepe? Era così tanto importante per loro? O c’era dietro qualcos’altro che non volevano dirci. Cioè: cosa intendeva davvero questo Serra per “presepe”?
Poi i sauditi hanno ammazzato un imam – i sauditi ammazzano chi vogliono più o meno come l’Isis, e più o meno per gli stessi motivi, ma sono nostri alleati, quindi è ok – salvo che per una settimana è stato tutto un fiorire di esperti di teologia islamica. Ci hanno spiegato che tutte le tensioni del Medio Oriente – tutte – si possono spiegare con la religione, l'eterna rivalità tra sunniti e sciiti. Perché, credevate che fosse il petrolio? I sauditi che lottano per imporre una supremazia regionale, che l’Iran gli contende? La Russia che reagisce all’accerchiamento Nato? Le irrisolte questioni curde e palestinesi? No. «Braccia rubate al mercato o al cantiere», avrebbe detto il nostro Gregorio, ci hanno avvertito che tutto dipende da uno scisma di mille anni fa. E infine si è scoperto che a Colonia a capodanno c’erano un sacco di maschi molesti, e i redattori hanno subito deciso che si trattava di stranieri, anzi immigrati, probabilmente clandestini, magari islamici e Bruno Vespa ha twittato:
Le nostre donne. Forse siamo sempre stati così, forse la novità è che Internet ha moltiplicato gli specchi per guardarci. Io una volta pensavo che Bruno Vespa fosse organico a una determinata classe sociale che imponeva la sua visione dei fatti a tarda sera su Rai 1. Ultimamente lo vedo più come uno stregone che balla al ritmo del tamtam, cantando parole che non conosce, “religione”, “valori”, “cultura”. Ma quel che vuole dire è quello che i capotribù hanno sempre detto in questi casi: straniero vuole venire e rubarci le donne.
Forse i posteri saranno più indulgenti. Spulciando un enorme archivio troveranno l’amaca di Serra o i tweet di Vespa, e capiranno che “presepe”, “religione”, “valori”, “bande di immigrati”, in realtà volevano dire una sola cosa: abbiamo paura. Il mondo cambia troppo alla svelta, un sacco di gente arriva qua e mette in discussione tutto quello in cui abbiamo sempre creduto – comprese quelle cose in cui non credevamo di credere davvero (il presepe?) ma erano insomma parte di un paesaggio. Difendo il mio presepe dai musulmani, quarant’anni fa difendevo la mia famiglia dai cosacchi. La mia quarta sponda dagli inglesi. La mia Patria dallo Straniero. Il mio Dio dall’infedele. La mia bandiera, qualsiasi colore abbia, perché è proprio questo il punto: non importa il colore. Non importa il Dio, non importa la Patria, né la famiglia né il presepe. Sono valori arbitrari che fissiamo di volta in volta. L’importante è l’aggettivo: mio. Tracciamo una linea qualsiasi e guai a chi la oltrepassa. Sul serio non moriremmo per il colore di una squadra? Non è l’unica cosa per cui moriamo, alla fine dei conti?
Gregorio nacque in Cappadocia, che oggi è lo zoccolo duro della Turchia rurale e islamica, ma nel suo secolo produceva santi cristiani e padri della Chiesa a un ritmo impressionante. Gregorio può vantare in calendario una nonna, Santa Macrina l’Anziana; due fratelli (San Basilio Magno e San Pietro di Sebaste) e una sorella (Macrina la Giovane). Lui si venera il 10 gennaio.
Il Santo Prepuzio (di cui è proibito parlare)
01-01-2019, 02:45anniversari, Cristo, ebraismo, Il Post, santiPermalink[Questo pezzo è uscito ieri sul Post]. È il caso di iniziare con un disclaimer: in questo pezzo si parlerà di una reliquia nota come il Sacro Prepuzio di Gesù. Prima o poi era inevitabile. Ne parleremo nel modo meno offensivo possibile; ma comunque ne parleremo, e questo a quanto pare sarebbe più che sufficiente per incorrere in una scomunica, prevista dalla Chiesa cattolica ai sensi del "Decreto n. 37 del 3 febbraio 1900".
Scrivo "a quanto pare" perché non sono riuscito a verificare la cosa. La trovo scritta in decine di pagine web, su Buzzfeed e persino nelle note a pie' di pagina di alcuni libri, ma tutti riportano la stessa formula stereotipata. Ho la sensazione che si citino tutti tra loro, e che nessuno sia davvero andato a cercare dove sia questo famoso decreto n. 37, e se ci sia davvero. Ma insomma il senso è che a un certo punto di prepuzio non si è potuto più parlare – certo, l'oggetto in sé esisteva ancora, custodito da trecento anni presso la parrocchia di Calcata (VT). Finché un bel giorno non è scomparso anch'esso (ma era già il 1983!) a causa di un clamoroso furto di cui probabilmente non avete sentito parlare. Proprio così, immaginatevi: scompare l'unico brandello del Corpo di Cristo non resuscitato e asceso al cielo, e i giornali non ne parlano. Anche perché nel frattempo Pio XII aveva ribadito, anzi rafforzato la scomunica per chiunque toccasse l'argomento; e il Concilio Vaticano II aveva eliminato la festa dal calendario. Insomma il prepuzio di Gesù è diventato un tabù, qualcosa di cui non è possibile parlare: e lo è diventato recentissimamente, proprio nel momento storico all'apparenza meno adatto al rispetto dei tabù.
 |
| "Presto sentì con la più soave dolcezza sulla sua lingua un pezzetto di pelle simile alla pelle in un uovo, che essa ingoiò; e dopo che l'ebbe ingoiato sentì di nuovo sulla sua lingua la stessa pellicina con la stessa dolcezza che ne aveva provato, e di nuovo la ingoiò. E questo accadde migliaia di volte. E quando l'ebbe provata così tanto, fu tentata di toccarla con le sue dita, E quando desiderò di farlo, quella pellicina le scese da sola nella gola. E le fu detto che il prepuzio sarebbe stato resuscitato col Signore nel Giorno della Resurrezione" (Agnes Blannbekin, nel tredicesimo secolo, parlava di sé stessa alla terza persona ed era considerata un po' "strana", anche per la media delle mistiche medievali). |
Mentre nei secoli cosiddetti bui il prepuzio di Gesù non costituiva nessun imbarazzo. Se ne discuteva (esiste o no? E se esiste, è ancora sulla terra?), ci si azzuffava, ci si giocava perfino. Una mistica austriaca sognò di averlo assaggiato (un chirurgo dell'Ottocento, si guadagnò il soprannome di "croque-prépuce", mangia-prepuzio, per avere effettivamente sottoposto una presunta reliquia alla prova gustativa). Caterina da Siena si limitava a immaginarselo legato al dito come fede nuziale. Anche chi negava che il prepuzio potesse essere rimasto sulla Terra, non sapeva bene dove collocarlo, al punto che quando furono scoperti gli anelli di Saturno un erudito del Seicento avrebbe creduto di avere trovato la soluzione al problema: il prepuzio era asceso al cielo solo fino a un certo punto, magari si era incastrato nel cielo del pianeta che Aristotele collocava appena sotto la sfera delle Stelle Fisse, ed era rimasto orbitante lì. Una teoria un po' troppo buffa per non essere inventata – e in effetti wikipedia ammette che questo famoso trattato sul prepuzio orbitante non si riesce a rintracciare.
Ma naturalmente l'idea che fosse rimasto sulla terra era più interessante per i ricercatori e i collezionisti di reliquie. Non era soltanto un business: ritrovare il brandellino di pelle, esporlo, ammirarlo, significava ribadire che Cristo oltre a un Dio era stato un uomo: il prepuzio poteva essere brandito contro gli eretici che negavano la natura umana di Gesù o la relegavano in un secondo piano: monofisiti, monoteliti e in generale i difensori di una religiosità più astratta, meno corporale. Questi ultimi erano in realtà già sconfitti da secoli, quando a Roma apparve il primo prepuzio di Gesù di cui abbiamo notizia, dono di Carlo Magno a quel papa Leone III che ebbe la pazza idea di incoronarlo imperatore. (A Carlo Magno l'avrebbe regalato l'imperatrice bizantina Irene, o un angelo). Con le crociate, e la relativa reliquie-mania, i prepuzi divini si moltiplicano: memorabile quello di Anversa, dono del re Baldovino di Gerusalemme, che fu visto da un vescovo stillare almeno tre gocce di Sangue. D'altro canto, spiega il nostro collega Iacopo di Varazze, il poco sangue scorso quel giorno non era che un anticipo di quello che Cristo avrebbe versato per noi. A un certo punto in giro per l'Europa ce n'è almeno una dozzina, ormai degradati al rango di amuleti. In quanto residui di un pene, diventano prima o poi un rimedio ai problemi virili; un re inglese (Enrico V) riesce ad adoperarne uno come cura per l'infertilità della moglie (Caterina di Valois), e a procurarsi finalmente un erede (Enrico VI). Sul finire del medioevo ormai tutta l'Europa ha stabilito che l'anno solare si conta secondo lo stile detto "della circoncisione", ovvero dal primo gennaio: se si accetta infatti come data della nascita di Gesù quella tradizionale del 25 dicembre, il primo gennaio è il giorno in cui secondo la legge mosaica (e secondo il Vangelo di Luca) il neonato sarebbe stato circonciso. Insomma intorno al prepuzio ruota l'anno intero.
La reazione all'inflazione di prepuzi e altre reliquie è la riforma protestante, che fa piazza pulita dei gadget sacri nell'Europa centrale e settentrionale, ma anche del più prestigioso prepuzio romano, scomparso durante il Sacco di Roma inflitto dai lanzichenecchi (1527). Trent'anni dopo lo stesso prepuzio ricompare a Calcata, provincia di Viterbo, nascosto nella parete di una cella dove era stato rinchiuso un lanzichenecco. La reliquia, in teoria la più ambita, non torna però a Roma: a Calcata si conquista un santuario tutto suo, e un discreto successo di pubblico (il pellegrinaggio valeva un indulgenza di dieci anni), ma i papi della Controriforma stanno già cominciando a prendere le distanze. Ducecentocinquant'anni dopo un'altra ondata iconoclasta, la rivoluzione francese, fa sparire più o meno tutti i prepuzi residui.
Ma proprio quando la reliquia di Calcata sembra essere rimasta senza rivali, nel 1856 un colpo di scena mette in imbarazzo il Vaticano: nell'abbazia di Charroux, nel Poitou, mentre abbatte una parete un muratore ritrova un altro prepuzio. In effetti secondo la tradizione locale sono i monaci di Charroux, e non Leone III, i destinatari del dono di Carlo Magno. Non è certo la prima volta che una reliquia si rivela un doppione; ma ormai siamo nell'Ottocento, e due prepuzi di Gesù creano più problemi di quanti ne creasse una dozzina nel Duecento. L'Europa non è più una selva fiorita di castelli e chiese, separati e autonomi tra loro: ormai è un reticolo di ferrovie, uno spazio misurabile. Un oggetto, ancorché miracoloso, non può esistere in due luoghi contemporaneamente: la cosa non è più plausibile, non è più immaginabile, nemmeno da un'anima semplice o pia. Nel frattempo il Vaticano ha reclamato l'infallibilità papale, e quindi tra Charroux e Calcata un Papa non può più rifiutarsi di scegliere: e sceglie di tacere, anzi di zittire chiunque.
Dal 1900 in poi del prepuzio non si parla più. Solo a Calcata la venerazione rimane tollerata, fino al misterioso furto del 1983. Misterioso anche per la sua semplicità: alla vigilia delle celebrazioni del primo gennaio, il parroco Dario Magnoni avvisa i fedeli di Calcata che la reliquia non si trova più: qualche ladro sacrilego è penetrato nella sua casa, l'ha trovata nella scatola di scarpe in cui la nascondeva, e l'ha portata via. Non è nemmeno chiaro se don Magnoni abbia sporto denuncia. L'oggetto in sé appare poco commerciabile: l'ipotesi è che al ladro interessassero soprattutto le pietre preziose del reliquiario che lo conteneva. Ma se davvero Magnoni temeva i ladri, al punto di portarsi il prepuzio in casa, perché non ha pensato a custodire reliquiario e reliquia almeno in due scatole diverse? Qualche compaesano nota che il giorno prima il parroco si era recato a Roma. Qualche anno prima, un vecchio vescovo aveva annunciato: quando me ne andrò io, se ne andrà anche il prepuzio. E poi basta, anche il giornalista americano che ci scrisse un libro non è che trovò molto altro da dire. L'ultimo prepuzio è scomparso, proprio quando ormai si cominciava a parlare di analisi del DNA e di clonazione. 1500 anni fa la priorità della Chiesa era difendere l'idea che Dio si fosse fatto corpo: le reliquie erano prove, evidenze tangibili, perfino assaggiabili, della permanenza del Sacro nella carne. Oggi la battaglia è sul fronte opposto: salvare il Sacro da una carne sempre più misurabile, osservabile, persino replicabile. Alcune reliquie hanno ancora un senso; altre sono appena tollerate; altre ormai sono imbarazzanti, e infatti spariscono. È il caso della Veronica, una macchia triangolare che nel medioevo poteva apparire davvero come una immagine miracolosa Gesù, ma che oggi non riusciremmo affatto ad associare a un volto; probabilmente è anche il caso del Santo Prepuzio, di cui non si dovrebbe parlare: e chiedo scusa per averlo fatto.
I compiti a casa sono il male (necessario?)
21-12-2018, 19:22Il Post, non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo, santi, scuolaPermalinkIl giorno in cui esce finalmente la tanto strombazzata circolare natalizia del ministro Bussetti sui compiti delle vacanze è anche il giorno in cui si festeggia San Pietro Canisio, aka Pieter Kanijs, un gesuita tedesco che scrisse un catechismo talmente facile e utile che lo si usava ancora nelle scuole qualche decennio fa (ogni tanto penso che dovremmo rivalutare i vecchi catechismi, quelli strutturati con le domande semplici e le risposte secche da imparare a memoria. Col tempo magari li metti in discussione, ma nel frattempo ti danno sicurezza; probabilmente tra un po' ci accorgeremo che ci mancano, li riscopriremo come qualcosa di solido da afferrare nel mare caotico delle mappa concettuali, quei maelstrom caotici di freccette che vanno da tutte le parti e non si capisce mai da che parte cominciare e da che parte finire).
Il giorno in cui si festeggia un insegnante che ha scritto rispostine facili da imparare a memoria per milioni e milioni di studenti è anche il giorno in cui finalmente il ministro, dopo aver annunciato in lungo e in largo che ci avrebbe chiesto di tagliare i compiti delle vacanze, ci ha mandato davvero la circolare – alleluja! È una banalissima circolare che davvero, senza tutto questo tour di presentazione nessuno avrebbe notato. Da nessuna parte ci troverete scritto: tagliate i compiti. C'è invece un olimpico invito agli insegnanti a "riflettere, anche anche collegialmente, sul carico di compiti che saranno assegnati durante le vacanze". Dove "collegialmente" non è un avverbio a caso pescato dal burocratese delle circolari, ma un termine abbastanza pesante: significa che non si tratta di discuterne amichevolmente in sala insegnanti, ma di deliberare attraverso l'organo preposto, il Collegio Docenti. Significa, in altre parole, che il 21 dicembre 2018 il ministro Bussetti ci sta prendendo in giro: non c'è proprio verso che si possano convocare collegi docenti prima dell'inizio delle vacanze di Natale, che quasi ovunque è domani. A quest'ora i compiti sono già stati assegnati, sui diari e sui registri (elettronici). Se ne riparla a Pasqua? Senz'altro se ne riparlerà. Nel frattempo, qualsiasi genitore o alunno convinto di essere stato caricato di un'eccessiva mole di lavoro può prendersela con noi: il ministro non ci copre, il senso della circolare alla fine è questo. Il ministro ci usa come il poliziotto buono adopera il poliziotto cattivo. Va bene, ministro, è stato un piacere, buon Natale anche a lei.
È difficile discutere del problema dei compiti a casa. È uno di quei casi in cui dalla parte del torto siedono molte brave persone e professionisti seri, mentre dalla parte della ragione incontri certi ceffi senza scrupoli che ti fanno domandare se avere ragione sia davvero così importante. Ovvero: chi crede nella scuola pubblica, nella scuola come strumento di uguaglianza sociale, non può che condividere l'idea che i compiti a casa siano ingiusti. Magari necessari, ma concettualmente iniqui. Proprio la scuola democratica, che dovrebbe offrire al bambino benestante e al bambino disagiato la medesima educazione: proprio la scuola pubblica rimanda a casa il benestante e il disagiato con gli stessi compiti. Chi dei due avrà maggiori possibilità di farli davvero, di farli bene, magari con l'assistenza di altro personale pagato dalle famiglie?
Più compiti si danno a casa, più classista è la scuola; e si dà il caso, (lo dice l'OCSE) che in Italia se ne diano troppi. Dovremmo darne meno; forse non dovremmo darli e basta. Sarebbe una linea da difendere a oltranza, se solo in trincea non ci si ritrovasse con politici populisti in cerca di popolarità, genitori lassisti, studenti pigri. E poi diciamolo, imparare a lavorare a casa serve. Allenarsi a ignorare le notifiche, tenersi lontani dalle lusinghe del frigo e a non perdersi su Internet appena ti imbatti in un termine da googlare. Lavoreremo sempre di più in casa, tanto vale addestrarsi sin da piccoli. Certo, in un mondo ideale la scuola dovrebbe fornirti tutta l'educazione e l'istruzione di cui hai bisogno senza chiedere assistenza al pomeriggio a genitori o altri tutori. Ma non viviamo in un mondo ideale: viviamo in Italia, anche se a volte chi parla di istruzione sembra non rendersene conto. Si abbozzano sempre confronti con le scuole di altri Paesi e sono sempre Paesi più a nord – la Francia e la Germania, ovvio, ma anche la Danimarca o la Finlandia. Laggiù di compiti ne danno di meno, è vero. Magari a Natale non ne danno nemmeno, e del resto che compiti vuoi che facciano i ragazzi in quelle due settimane scarse in cui spesso sono ostaggio dei parenti, costretti a sequele interminabili di cenoni, veglioni e cerimonie.
Negli altri Paesi però le vacanze di Natale non sono la prima seria interruzione dell'anno scolastico: quasi sempre c'è una seria pausa in novembre (Ognissanti), e poi ce ne sarà un'altra in primavera, o a volte già a Carnevale. In compenso, in questi Paesi le vacanze estive sono molto più brevi: a giugno e a settembre si va già a scuola. Non è che vacanze più brevi e più diluite rendano inutili i compiti, ma consentono a gli insegnanti di assegnarli in dosi ragionevoli, in dosi umane. Non c'è bisogno di assegnare centinaia di esercizi a giugno nella speranza che gli studenti si ricordino ancora come risolverli a settembre.
 Quando si parla di questi argomenti mi vengono sempre in mente le formiche di un vecchio racconto di Clifford Simak – uno scrittore di fantascienza dell'età dell'oro, gli anni Quaranta. In questo racconto uno scienziato sociopatico trova un sistema per impedire a una colonia di formiche di andare in letargo. Il risultato è un improvviso balzo evolutivo: le formiche cominciano a costruire minuscoli utensili e in breve arrivano alla rivoluzione industriale. Il tutto perché hanno smesso di dormire per una lunga stagione, e non devono più ripartire da zero ogni anno: hanno cominciato a immagazzinare, oltre al cibo, anche le nozioni. È un'idea molto ingenua, ma non mi si è mai levata dalla testa: forse perché lavorando nella scuola italiana ho spesso la sensazione di trovarmi nel formicaio di Simak, anzi in un formicaio pre-Simak in cui le formiche a settembre non ricordano più quello che avevano scoperto a giugno. Un posto dove ogni anno si ricomincia sempre da capo, rispiegando le stesse cose agli stessi studenti. Persino le classi più brave, quelle che fino all'inizio di giugno ti hanno seguito in qualsiasi argomento, lavorando assieme e acquisendo fior di competenze: anche loro, tre mesi dopo ti guardano catatonici: e non importa quanti compiti hanno fatto, non si ricordano niente. Le tabelline, la rivoluzione francese, l'Inno alla Gioia col flauto: niente. Ma li capisco, anch'io a metà settembre fatico a ricordarmi come si fa lezione. Poi riparto, ma appunto: ho la sensazione di ripartire sempre da capo, di reimparare sempre le stesse cose. Come le formiche. E la gente si preoccupa dei compiti. Ma i compiti sono un falso problema, il modo in cui noi insegnanti cerchiamo di mettere una pezza al problema vero.
Quando si parla di questi argomenti mi vengono sempre in mente le formiche di un vecchio racconto di Clifford Simak – uno scrittore di fantascienza dell'età dell'oro, gli anni Quaranta. In questo racconto uno scienziato sociopatico trova un sistema per impedire a una colonia di formiche di andare in letargo. Il risultato è un improvviso balzo evolutivo: le formiche cominciano a costruire minuscoli utensili e in breve arrivano alla rivoluzione industriale. Il tutto perché hanno smesso di dormire per una lunga stagione, e non devono più ripartire da zero ogni anno: hanno cominciato a immagazzinare, oltre al cibo, anche le nozioni. È un'idea molto ingenua, ma non mi si è mai levata dalla testa: forse perché lavorando nella scuola italiana ho spesso la sensazione di trovarmi nel formicaio di Simak, anzi in un formicaio pre-Simak in cui le formiche a settembre non ricordano più quello che avevano scoperto a giugno. Un posto dove ogni anno si ricomincia sempre da capo, rispiegando le stesse cose agli stessi studenti. Persino le classi più brave, quelle che fino all'inizio di giugno ti hanno seguito in qualsiasi argomento, lavorando assieme e acquisendo fior di competenze: anche loro, tre mesi dopo ti guardano catatonici: e non importa quanti compiti hanno fatto, non si ricordano niente. Le tabelline, la rivoluzione francese, l'Inno alla Gioia col flauto: niente. Ma li capisco, anch'io a metà settembre fatico a ricordarmi come si fa lezione. Poi riparto, ma appunto: ho la sensazione di ripartire sempre da capo, di reimparare sempre le stesse cose. Come le formiche. E la gente si preoccupa dei compiti. Ma i compiti sono un falso problema, il modo in cui noi insegnanti cerchiamo di mettere una pezza al problema vero.Il problema vero... (continua sul Post!) è l’estate, che in Italia non finisce mai (tre mesi e mezzo senza scuola!), e ci riconsegna all’autunno lobotomizzati. Non solo, ma un’estate così lunga ci impedisce di avere delle pause serie nel resto dell’anno. Due settimane a Natale sono appena sufficienti a farci passare l’ansia prenatalizia; cinque giorni a Pasqua sono ridicoli, non fai in tempo a svuotare lo zaino che è già ora di tornare a scuola; quanto ai ponti, sono più dannosi che utili, soste brevissime e forzate che ci spezzano il ritmo proprio quando le scadenze cominciano a farsi vicine. Il nostro calendario è il vero problema: è tutto sbagliato. Quindi per avere una scuola funzionale basterebbe cambiarlo? Eh, ma forse non si può.
Leone contro tutti
10-11-2018, 18:51Il Post, pontefici, Roma, santiPermalinkIl nome, dicono, è un destino: spero non sia il mio caso, ma fu quello per esempio di Leone Magno, che combatté per tutto il suo pontificato e qualche volta vinse. Contro i discepoli di Priscilliano, un santone che mescolava profeti e oroscopo e stava allontanando le chiese spagnole dal controllo di Roma: ma Leone lottò finché non convinse l'imperatore Graziano che Priscilliano era un eretico e uno stregone, e lo fece giustiziare. Contro i manichei, che credevano che l'universo fosse il risultato di una lotta tra Luce e Tenebre e avevano fatto breccia non solo tra i poveracci impressionabili, ma anche su intellettuali promettenti come il giovane Agostino d'Ippona; per cui a Leone non bastava confutarli dottamente: li denunciava all'autorità imperiale, che avrebbe proceduto a torturarli. Contro i monofisiti, che in Oriente predicavano la natura solo divina di Cristo e stavano portando dalla loro parte tutta la chiesa di Costantinopoli e di oriente: ma Leone s'impuntò, chiese e ottenne un nuovo concilio che mise fuorilegge pure i monofisiti. Contro i vescovi delle Gallie che credevano di potersi nominare tra loro (come in effetti avevano spesso fatto) invece di riconoscere l'autorità del vescovo di Roma, non un vescovo tra tanti ma il successore dell'apostolo Pietro. Contro la stessa lingua latina che si stava un po' rammollendo nelle cancellerie: a causa delle migrazioni certi accenti forse non si sentivano più, certe sfumature si erano perse. Servivano nuove regole per scrivere in prosa e Leone Magno se le inventò, forse improvvisando, e poi gliele copiarono per secoli, lo chiamarono cursus leonino.
L'Occidente intanto franava, gli Unni premevano sui Goti che premevano sui Vandali che in un qualche modo si erano trovati in fondo alla catena e schizzarono sui territori dell'Impero in modo impressionante, dalla Spagna al Marocco alla Tunisia, e dalla Tunisia (via nave) di nuovo a Roma. Leone, che pochi anni prima forse era riuscito davvero a convincere Attila a non scendere a Roma, nel 455 poté solo negoziare col re dei Vandali (Genserico) i termini del saccheggio. Leone insomma combatté per tutta la sua carriera, forse per tutta la vita: a volte vinse, a volte venne a patti. Un patriarca riottoso si poteva far deporre; un vescovo ribelle si poteva ridurre a più miti consigli; contro i ribelli, in generale, non è difficile prevalere: basta metterci la tigna, alzarsi ogni mattina qualche ora prima di loro e passarla a concepire nuovi sistemi per confutarli, per perseguitarli, per accerchiarli e far terra bruciata intorno a loro. I ribelli non sono il vero problema. Magari. In fondo sono persino simpatici, ci aiutano a tenere la barra, ci danno un motivo per alzarci prima la mattina, per dimostrare che hanno torto e noi ragione, i ribelli ci servono (quegli stronzi). I veri nemici invincibili non sono certamente loro, a un certo punto Leone dovette rendersene conto. E chi sono allora? (Continua sul Post).
Le abitudini.
Contro le abitudini anche Leone lottò invano. Il Papa che aveva fermato Attila e rovesciato un intero concilio, non riusciva nemmeno a evitare che i suoi fedeli si voltassero un attimo indietro a fare un inchino a un vecchio dio pagano, il Sole, quando entravano nella sua chiesa (la vecchia San Pietro, poi demolita per costruire la nuova).
“…alcuni cristiani prima di entrare nella basilica di San Pietro apostolo, dedicata all’unico Dio, vivo e vero, dopo aver salito la scalinata che porta all’atrio superiore, si volgono verso il sole e piegando la testa si inchinano in onore dell’astro fulgente. Siamo angosciati e e ci addoloriamo molto per questo fatto che viene ripetuto in parte per ignoranza e in parte per mentalità pagana”.
Leone sapeva bene che quegli inchini non erano neanche più un sussulto di paganesimo, ma qualcosa di ancora più labile e residuale: un’abitudine; ma non la tollerava. Non poteva. Se cominci ad accettare che i vecchi si voltino indietro, finirà che i giovani impareranno dai vecchi, e l’abitudine non finirà mai. “Anche se alcuni intendono venerare il Creatore della luce leggiadra, e non la luce stessa che è una creatura, devono astenersi da ogni apparenza di ossequio, perché chi ha lasciato il culto degli dei, qualora trovasse tra noi simile usanza, potrebbe praticare, come incensurabile, questo elemento delle vecchie credenze perché lo vedrebbe comune ai cristiani e agli infedeli”.
Alla fine però la spuntò, direte voi. Oggi i cristiani non si inchinano più al Sole nascente, vero? Sì, ma non fu l’ostinazione di Leone a superare il problema. Alla fine la Chiesa procedette nel solito modo: visto che la gente continuava a inchinarsi a oriente, da Leone in poi si mise a costruire le chiese con l’altare orientato verso il sole del mattino. Così l’inchino pagano sarebbe passato inosservato, e dopo un po’ nessuno si sarebbe accorto che era un residuo pagano. Ne costruirono per altri mille anni, quindi potrebbe essere capitato pure a voi, di inchinarvi senza accorgervene al dio Sole. Contro i priscilliani e le loro scemenze new age si può trionfare. Sopra i manichei e il loro mondo in bianco e nero, si può stendere una passata di grigio in mille sfumature. Ma lottare contro le piccole abitudini quotidiane, quella è il combattimento che Leone stava perdendo, e forse lo perderemo anche noi. Quando crediamo che il vero nemico sia un antivaccinista o uno sciachimista, e non la persona qualunque che non riesce a differenziare i rifiuti, o a lasciare la macchina nel box lunedì mattina, che non riesce a modificare le sue abitudini. Il destino dell’uomo è nel suo nome, dicevano gli antichi, il che senz’altro fu vero per Leone Magno e sarebbe un grosso problema per me, se nel frattempo non avessi formulato un’ipotesi ancora peggiore: che il destino dell’uomo sia nelle sue abitudini.
Storia di un finto povero
16-07-2018, 13:59come diventare leghisti, Il Post, migranti, santiPermalinkLo trovarono secco nel sottoscala, il mendicante, nella casa del patrizio che diciassette anni prima gli aveva dato riparo. "Anche mio figlio, come te, è in giro per il mondo", gli aveva detto: "ovunque sia, prego che un altro padre gli dia un tetto e un giaciglio per dormire". Quando l'ospite morì, e furono per raccogliere dal pavimento le sue ossa irrigidite, si accorsero che la mano stringeva un cartiglio, e che c'era scritto qualcosa; ma non si riusciva a leggere, il morto non mollava la pergamena.
 Ci provarono i medici ad aprirgli la mano, i pompieri e i pretoriani, ormai era diventata una specie di sfida. Alla fine chiamarono gli imperatori Arcadio e Onorio, tutti e due, perché l'autore della leggenda probabilmente non era sicuro su quale imperasse a Roma e quale a Costantinopoli; e in effetti probabilmente all'inizio la storia era ambientata nella nuova Roma sul Bosforo, ma poi un copista si confuse, probabilmente un locale, sai come la pensano: di Roma ce n'è una sola, hai voglia a spiegare che ce ne sono almeno tre. In una versione successiva interviene il Papa direttamente, così è chiaro in quale Roma siamo. Dunque ecco arriva il Papa in questo palazzo sull'Aventino, ah ma quindi è in questa casa che dormiva quel sant'uomo del mendicante? Gli volevano tutti tanto bene. Cos'avete detto che ha nella mano? Un cartiglio? Ecco qui (la mano morta si apre senza fatica). C'è scritto... c'è scritto che si chiama Alessio e che ringrazia suo padre per l'ospitalità.
Ci provarono i medici ad aprirgli la mano, i pompieri e i pretoriani, ormai era diventata una specie di sfida. Alla fine chiamarono gli imperatori Arcadio e Onorio, tutti e due, perché l'autore della leggenda probabilmente non era sicuro su quale imperasse a Roma e quale a Costantinopoli; e in effetti probabilmente all'inizio la storia era ambientata nella nuova Roma sul Bosforo, ma poi un copista si confuse, probabilmente un locale, sai come la pensano: di Roma ce n'è una sola, hai voglia a spiegare che ce ne sono almeno tre. In una versione successiva interviene il Papa direttamente, così è chiaro in quale Roma siamo. Dunque ecco arriva il Papa in questo palazzo sull'Aventino, ah ma quindi è in questa casa che dormiva quel sant'uomo del mendicante? Gli volevano tutti tanto bene. Cos'avete detto che ha nella mano? Un cartiglio? Ecco qui (la mano morta si apre senza fatica). C'è scritto... c'è scritto che si chiama Alessio e che ringrazia suo padre per l'ospitalità.Al padrone di casa si ferma il cuore.
Il papa all'improvviso si rammenta. "Ma tu avevi un figlio che si chiamava Alessio, no? Quello che mollò la fidanzata davanti all'altare, quando fu? Trent'anni fa? Ma non se n'era andato per il mondo?"
"Alessio, figlio mio".
"Vuoi dire che per tutto questo tempo non l'hai riconosciuto?"
"Figlio mio!"
"Anche lui però poteva dirti qualcosa, eh".
Di tutti i santi del calendario, Alessio è forse quello che capisco meno. Tutti i suoi atti di eroica santità, ai miei occhi di abitante del 21esimo secolo, mi sembrano un mix indigeribile di ingenuità e stronzaggine. Mollare la sposa all'ultimo momento perché Dio è più importante, ok, può succedere a tutti di cambiare idea all'ultimo momento, per fortuna lei ti capisce, condivide la tua scelta di castità e si fa monaca, a questo punto perché non dovresti farti monaco anche tu? No, tu te ne scappi via, posso capire anche questo. Decidi di dare tutto quello che possiedi ai poveri, molto giusto, salvo che sei andato via senza un soldo e quindi sei povero anche tu: se fossi rimasto a casa dei tuoi almeno avresti avuto a disposizione un budget da destinare in imprese benefiche, microcredito eccetera, e invece niente: vuoi combattere la povertà con la povertà, una di quelle cose omeopatiche. Ti è mai venuto in mente che invece potevi metterti a lavorare? In fondo sei un giovane sano, puoi benissimo trovarti un mestiere e poi elargire elemosine a tutti i poveri che incontri, il Vangelo si rispetta anche così – eh, no, dopotutto sei un patrizio romano, o campi nel lusso o fai l'elemosina, ma lavorare è fuori discussione.
 |
| Anonimo, Ritrovamento del corpo di sant'Alessio, XVIII secolo |
E va bene, chi sono io per giudicare, son tre giorni che non telefono ai miei. Però alla fine prima di morire glielo scrivi sul cartiglio, così fa ancora in tempo a guastarsi la vecchiaia dal rimorso che non ti ha riconosciuto – eh no vabbe' ma allora vaffanculo, Sant'Alessio, sei la leggenda di santi più stronza che conosco. Talmente stronzo che sembri vero. Cioè qui non parliamo di draghi che rapiscono fanciulle o dormienti in una grotta o martiri che accarezzano i leoni; qui c'è un hippy di buona famiglia che sembra stato ritratto l'altro ieri. Figurati se non ce n'è stato almeno uno a Roma o Costantinopoli od ovunque, figurati se in mille anni non è mai successo che un giovinastro mollasse la famiglia per fare il barbone, in teoria in giro per il mondo ma ben presto a pochi metri dalla casa dei genitori. I quali magari a un certo punto si erano impietositi e lo ospitavano pure nella mansarda a uso foresteria, magari fingendo di non riconoscerlo perché il ragazzo ha un suo distorto senso della dignità, che non gli impedisce di chiedere scusa a mamma e papà ma non di chiedere moneta sotto il loro portico di casa. Magari ce n'è stato uno sia a Edessa che a Bisanzio che a Roma, che si svegliavano presto senza mettere a posto la cameretta e uscivano in strada a mendicare, e alla fine che gli vuoi dire? Dopo un po' sei parte del paesaggio urbano, il giorno che non ti vedono sulla panchina si preoccupano.
 |
| Nausicaa s'imbatte sulla spiaggia in un migrante economico. |
Il selfie di Gesù
11-07-2018, 18:44arti figurative, cristianesimo, Cristo, fotografia, Il Post, santiPermalink |
| Grazie Gesù (e chi ti smacchia più) (Mattia Preti). |
Una fotografia, diremmo noi.
 |
| La Veronica di Hans Memling (1475, notate le due punte della barba). |
È forse la prima volta nella storia della fantasia occidentale che la fotografia viene non inventata, ma almeno immaginata: e per essere una fantasia è già sorprendentemente nitida. C'è già l'idea del ritratto, e soprattutto dell'istantanea, dello scatto, ovvero la cosa che più distingue la pittura dall'arte fotografica molto al di là da venire (anche dopo l'invenzione della camera oscura e del dagherrotipo, ci vorrà ancora parecchio tempo prima di ottenere immagini istantanee). È un'idea straordinaria, che nasce nelle terre dell'Impero d'Oriente, in una situazione storica molto particolare, ma alla Chiesa d'occidente non è andata sempre a genio: e così nella Via Crucis approvata da Roma, Veronica dovette limitarsi a raccogliere sangue e acqua, senza ricavarne nessun'immagine miracolosa. I predicatori confondevano volentieri Berenica/Veronica con un'altra comparsa femminile dei vangeli, l'emorroissa guarita da Gesù. La leggenda però non era sparita del tutto e ogni tanto qualcuno riportava dalle terre d'oriente una santa veronica. Il telo era meno richiesto della scheggia della Vera Croce o della Vera Lancia, ma comunque anche per gli asciugamani col volto di Cristo c'era un mercato. Non si doveva nemmeno dimostrare che fosse la veronica originale: i fedeli si sarebbero accontentati di una copia il più possibile conforme.
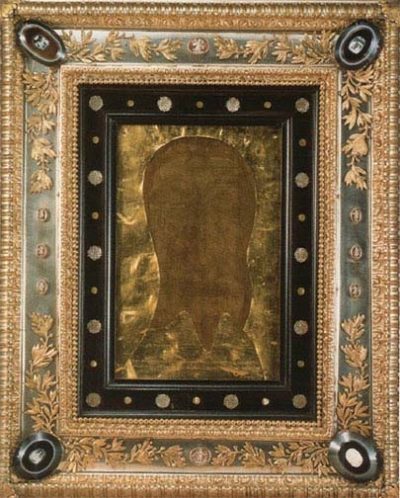 |
| Il Volto di Vienna. |
 |
| La Veronica di Roma |
Le cinque vite di Veronica
09-07-2018, 13:56autoreferenziali, Il Post, santiPermalinkUn giorno il demonio entrò nella cella di Veronica; entrò in forma di Maestra delle Novizie, ma appena la vide nella penombra Veronica intuì che qualcosa non andava. La falsa Maestra si mise subito a parlare, Veronica riusciva a malapena a sentirla. C'è qualcuno che mormora, dicono che hai fatto perdere la testa al confessore, è un'accusa molto grave. Ma sta' tranquilla, quel sacerdote non metterà più piede in questo convento.
 |
| Il monastero delle cappuccine in Città di Castello. |
– Sono tutte calunnie, risponde Veronica: e non sia mai che il confessore abbia da soffrire per causa mia. Sono pronta ad andare dal vescovo a difendere la mia e la sua innocenza.
– Ma che vescovo e vescovo, risponde il demonio, io sono la tua Maestra e ti ordino di stare zitta, la questione è chiusa.
Appena possibile, Veronica ne parla col confessore, che ne rimane molto turbato.
– Chi sono le malelingue che mettono in giro simili infamie? Fatti dare una lista dalla tua Maestra.
– Padre, non posso: ho promesso che non ne avrei parlato a nessuno.
Il confessore abbozza e se ne va. Qualche tempo dopo arriva la maestra a spiegare a Veronica cos'era successo, ovvero nulla. Non c'era mai stato nessun pettegolezzo.
– Ma sorella, era stata proprio lei a entrare in questa cella e dirmi...
– Non ero io: non sono mai entrato nella tua cella. Quello che hai visto era un demonio.
– Un demonio?
– Sai quante volte capita. Magari è lo stesso che prende le tue forme e s'ingozza in cucina davanti alle tue consorelle mentre tu sei nell'oratorio a digiunare. Un demonio mutaforma.
– Questo in effetti spiegherebbe tante cose.
– Tutto. Il demonio spiega tutto.
– Dovrei parlarne col mio padre confessore?
– Ah, ecco, quello sarà davvero trasferito, te ne procureremo un altro.
– Ma non è stato trasferito per i pettegolezzi, vero?
– Quali pettegolezzi? Non c'è mai stato nessun pettegolezzo. È stato il demonio, ti ho detto. Il demonio.
La cosa migliore di scrivere sui Santi è che tornano tutti gli anni, nell'ordine prestabilito. Sai sempre quando arriveranno, il che non significa che riuscirai a essere puntuale all'appuntamento, anzi. Ci sono santi che manchi regolarmente dal 2011. Ma non importa, tanto loro tornano anche l'anno prossimo: sempre in fila, come i solchi di un disco. Io invece da un anno all'altro divento una persona diversa, e il santo che nel 2013 mi stava simpatico nel 2016 mi accorgo di non riuscirlo più a sopportare. Poi ci sono quei santi che rimando ogni volta, perché ancora non ho capito quel che vogliono dirmi, se possono dirmi qualcosa.
Di solito questo è il momento dell'anno in cui comincio a pensare che mi piacerebbe scrivere un pezzo su Santa Veronica Giuliani; sulla sua matta infanzia, sulla sua drammatica anoressia, sulla sua torrenziale autobiografia. E ogni anno mi rispondo che bisognerebbe però fare le cose sul serio, insomma studiarla davvero, Santa Veronica, ma come si fa? Ha scritto ventiduemila pagine di autobiografia – un dato che probabilmente viene usato per spaventare il lettore occasionale, cioè non ha senso contare le pagine manoscritte, magari la santa aveva una calligrafia molto ampia: l'edizione integrale a stampa consta comunque di dieci volumi.
 |
| Questo è un comodo compendio in 450 PAGINE. |
Ci vorrebbe una vita per studiare la vita di Veronica Giuliani: io non ce l'ho, e mi bastano le venti fulminanti pagine di Rudolph M. Bell (1985), per trovarmi a disagio. Su molti santi è così facile scherzare, quello che ci resta è una leggenda di una paginetta, una sagoma di cartone che si presta anche alla farsa. Ma di Veronica sappiamo troppo. Che la madre non la allattava al venerdì; che sin dall'inizio interpretava i suoi disturbi alimentari come prove di santità; che crebbe in una famiglia dove si leggevano soltanto storie di santi, la minore di tre sorelle che aspiravano tutte al chiostro, a cui rubava il flagello per frustarsi un po' nell'intimità; che alla morte della madre, il padre si trovò rapidamente una compagna e cedette abbastanza presto alla richiesta di Veronica di farsi suora. Una vita da reclusa per la quale, lo si capisce da fin troppi elementi, la ragazzina non era portata, e alla quale reagì smettendo di mangiare e vivendo esperienze allucinate che attirarono su di lei i sospetti dell'Inquisizione. Disturbo dell'attenzione, complesso di Edipo, repressione sessuale, impulsi sadomasochistici, confessori sadici, anoressia e bulimia, nella sua vita c'è di tutto e ce n'è in abbondanza. Eppure quello che anno dopo anno mi attira sempre di più a Veronica è un altro aspetto della sua esistenza lunga e complicata: il fatto che la passò a raccontarla. A molti personaggi più e meno importanti capita di scrivere un'autobiografia: è già molto più raro il caso di qualcuno che ne scriva due (il primo che mi viene in mente è Leonard Nimoy). Veronica Giuliani ne scrisse cinque.
 |
| La prima autobiografia (1975) si chiamava "I Am Not Spock", la seconda, vent'anni dopo, "I Am Spock". |
 |
| Calco di cera del volto morente di Veronica. |
Col linguaggio di oggi diremmo che Veronica guarì – anche se continuò ad avere esperienze mistiche e a medicarsi le stimmate. Non sappiamo esattamente cosa la fece guarire: siamo abbastanza sicuri che non furono i confessori. Bell è convinto che la scrittura possa averla aiutata, e io sono fin troppo felice di dargli ragione. La sua quintupla biografia è un trattato di mistica che contiene una ricerca del tempo perduto, che contiene il romanzo di una donna murata viva, che contiene chissà quanti altri strati, una specie di cipolla. Eppure Veronica insiste che scrivere non le piaceva; era solo un’altra forma di penitenza, forse meno grave di pulire i pavimenti con la lingua: ma non doveva essere semplice tornare ogni volta sulla propria infanzia capricciosa, sui pruriti infidi della preadolescenza, sulle frustrazioni della sua giovinezza di reclusa.
Costretta a riscriversi all’infinito, Veronica difficilmente aveva la possibilità di rileggersi: ogni resoconto finiva nel cassetto di un confessore diverso, e a lei toccava ricominciare da capo. Il risultato è che di certi episodi della sua infanzia abbiamo quattro o cinque versioni diverse. L’episodio rimane più o meno lo stesso, ad esempio quella volta che a tre anni volle cimentarsi con la santità toccando davanti a tutti un carbone ardente. Ma la Veronica di trent’anni lo racconta in un modo diverso di quella di quarant’anni, mentre quella di sessanta ormai ammette di non ricordarselo quasi più. L’episodio assume ogni volta un significato diverso e ci domandiamo quale Veronica lo stia ricordando meglio, quando in realtà stiamo soltanto cercando la versione che ci piace di più, quella che si concilia meglio col nostro racconto. Come se il passato esistesse davvero e non assomigliasse più alle memorie di Veronica, che all’inizio si ricordava qualcosa e verso la fine ricordava soltanto sé stessa ricordarsi.

Ogni epoca pretende qualcosa di diverso da Veronica: i suoi contemporanei ragionavano in termini di angeli e di demoni, Bell parla di malattia e di guarigione, chissà cosa ci troveranno nelle stesse pagine di Veronica tra cento, duecento anni. Una volte ho letto da qualche parte che il nostro corpo si rinnova completamente più o meno ogni sette anni. O forse l’ho sentito su Quark, e non ho mai avuto voglia di ricontrollare: è una nozione troppo bella per metterla in discussione. Persino le molecole del midollo delle mie ossa, persino loro nel giro di sette anni si rigenerano e muoiono, non so come facciano, ma insomma tra me e il me stesso che cominciò a scrivere di santi ormai sette anni fa non c’è quasi più una cellula in comune. Siamo due persone diverse che condividono però gli stessi ricordi. Ecco, appunto, questo è l’aspetto più curioso: come faccio a condividere gli stessi ricordi con quel cadavere, se il mio cervello nel frattempo si è rigenerato completamente? Probabilmente c’è una parte della mia memoria fissa che passa il tempo a fare back-up, a raccontare le vecchie storie alle cellule nuove. Proprio come Veronica Giuliani, anche quando credo di ricordare la mia infanzia io in realtà sto ricordando me stesso già adulto che ricorda sé stesso ragazzino che se la ricorda. Questo significa tante cose: la più rassicurante è che non dovrei preoccuparmi più di tanto di morire, visto che succederà auspicabilmente a un tizio più vecchio di me: io in realtà muoio un po’ tutti i giorni ma rinasco anche; una parte non piccola della polvere che si deposita nel dyson sono le mie cellule morte, ricordi inclusi. Ma ciò significa anche che il mio passato è un’invenzione: che posso averlo modificato a piacere e anzi sono sicuro di averlo fatto, diverse volte, cambiando dei dettagli che non piacevano, e smettendo di raccontarmi delle cose che erano troppo difficili da sopportare.

Come faccio a sapere tutto questo? Perché oltre a ricordarmi, io ho questo difetto che scrivo, come Veronica Giuliani: e a differenza di Veronica nessun inquisitore mi impedisce di rileggermi, e scoprire che tutto quello che mi ricordo è sbagliato. L’autore della mia prima autobiografia di vent’anni è una persona che mi è quasi estranea, come può essere estraneo un figlio che si abbandona da piccolo in un convento. Mi dà anche un po’ fastidio sentirlo parlare, non lo frequento volentieri, un giorno o l’altro lo rinchiuderò di nuovo nel cassetto di qualche armadio in soffitta, finché nessuno si ricorderà più di lui. Eppure il passato ogni tanto sembra tornare così vicino, come le stagioni e le feste dei santi sui calendari: ma è un’illusione. Il solco del disco non torna su sé stesso, ma si avvita a spirale. Le cinque vite di Veronica mi danno l’idea che le persone crescano come cipolle, strato su strato: oppure crescere è come perdere uno strato alla volta, finché non rimane solo il cuore, ma anche il cuore non è che l’ultima buccia, e quando finisce non c’è più nessuno a provarne rimpianto o a soffrire per i ricordi perduti; non c’è più dolore, non c’è più niente.
Tommaso, apostolo ambiguo
03-07-2018, 03:20Il Post, santiPermalinkC'è un gesuita austriaco in giro per l'Amazzonia in cerca di popoli da battezzare. Quando incontra una tribù di Guaranì, la prende molto per il largo: salve, mi chiamo Martin Dobrizhoffer, vengo dall'altra parte del grande mare, sono un prete e vengo a portarvi il C...
"Sì, sì", taglia corto il capotribù, "grazie del pensiero ma non abbiamo bisogno di preti qui, tutta la storia di Cristo e della salvezza ce l'ha spiegata direttamente Tommaso".
"Tommaso?"
"L'apostolo".
Ci sarebbe di che gridare al miracolo – salvo che siamo nella seconda metà del Settecento e neanche Dobrizhoffer riesce ad accettare l'idea che San Tommaso si sia spinto a predicare il vangelo in Paraguay. La stessa risposta l'aveva ottenuta un gesuita spagnolo un secolo prima; magari i guaranì avevano semplicemente scoperto che raccontando la storiella giusta i gesuiti li lasciavano stare.
Oppure.
Oppure un Tommaso evangelizzatore è esistito davvero: non necessariamente l'apostolo, ma uno dei primissimi esploratori europei, perché no? un cane sciolto che si era perso nella jungla e che aveva insegnato il cristianesimo agli indigeni caricandosi una croce sulle spalle. Qualcosa del genere, lo vedremo, potrebbe essere successa anche dall'altra parte del mondo.
 |
| Sì però dovresti verificare la profondità di una ferita mortale, così sembra che gli stai strizzando un brufolo. |
Del resto Tommaso è un doppio: lo dice il nome. In aramaico significa "gemello", e a volte è affiancato all'equivalente termine greco, Didimo. I tre vangeli sinottici non ci dicono nient'altro di lui. È solo col vangelo di Giovanni che diventa un personaggio, uno di quelli di poche parole ma tutte importanti. Sua è una delle frasi più icastiche di tutto il libro, quando alla notizia che Gesù intende riavvicinarsi a Gerusalemme, dice ai colleghi: "Andiamo a morire con lui". Giovanni passa per l'evangelista-filosofo, ma in certi casi mi sembra anche uno straordinario narratore: in tre parole ha suggerito al lettore il momento in cui Gesù decide di mettersi davvero nei guai, e la rassegnazione con cui i seguaci più intimi lo accompagnano al macello. Inoltre ci ha preparato per l'altra scena in cui userà il suo personaggio: che idea ci facciamo di Tommaso in questo versetto? Sembra il brontolone nell'angolo, il tizio che mentre Pietro e Giovanni si esaltano al pensiero di sedere nella gloria del figlio dell'uomo, sta riflettendo sul fatto che probabilmente nessuno riporterà la pelle a casa.
Oppure?
Io perlomeno l'ho sempre visto così ("Ecco, adesso ci tocca morire anche noi"), ma rileggendo mi sono reso conto che la frase si può anche interpretare in un modo più semplice, come un'esortazione al martirio: dai, andiamo a morire con lui! Dipende insomma tutto da come ti immagini la scena, e la tua immaginazione dipende molto dalla tua esperienza di vita. Per tutto questo tempo non mi ero accorto che alla fine il mio Tommaso era uno specchio: il brontolone nell'angolo ero io.
Ma l'episodio che fa di Tommaso uno degli apostoli più conosciuti è ovviamente quello del dito nella piaga (un dito che Tommaso non ha necessariamente infilato, anche se la scena era troppo adatta a Caravaggio perché Caravaggio non la dipingesse). Dopo la morte in croce, quando Gesù comincia ad apparire qua e là, Tommaso prende di nuovo la voce a nome degli osservatori più concreti, meno disposti a farsi prendere dall'entusiasmo: sentite, so che siamo tutti molto scossi, ma questa cosa non la bevo. Non ci credo. Potrebbe essere un altro, dopotutto, no? Per crederci dovrei vederlo, anzi no, dovrei infilare il dito nelle ferite dei chiodi, la mano nel suo costato. Otto giorni dopo, Gesù riappare e sfida Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio costato». A questo punto molti credono che Tommaso abbia davvero infilato il dito (e Caravaggio è appunto tra loro), ma il vangelo non lo dice. Giovanni si limita a riferire che Tommaso cede su tutta la linea: «Mio Signore e mio Dio», dice. Gesù gli risponde: tu hai veduto e hai creduto; beati quelli che non vedranno ma crederanno. Per il quarto evangelista in effetti non c'è niente di male a chiedere a Gesù dei segni tangibili della propria divinità: la prima parte del suo resoconto è proprio un elenco circostanziato di miracoli (il cosiddetto Vangelo dei segni), avvenuti davanti a testimoni credibili. Con l'Ascensione di Gesù in cielo il tempo dei segni si conclude: non sarà più possibile chiedere dei segni, Tommaso è tra gli ultimi ad averne ottenuto uno. Da qui in poi, per credere bisogna fidarsi dei testimoni: tanto più che la fine dei tempi è vicina.
Oppure?
Oppure il Gesù risorto era un imbroglione, e Tommaso il suo compare. Come altri personaggi del quarto vangelo, sembra più un'invenzione letteraria che un testimone in carne e ossa: nell'economia del racconto la sua funzione è proprio quella del compare del ciarlatano. Se avete presente la scena: il tizio con la cura miracolosa sta imbonendo la folla. Un tizio prende la parola per dire che non ci crede. Il ciarlatano stranamente lo lascia parlare, finché non ha catalizzato tutto lo scetticismo del pubblico, e poi gli propone di provare il suo elisir. Il tizio esita, in un primo momento non vuole (forse ha paura?) ma poi si lascia convincere, e miracolo! La cura su di lui funziona. Il pubblico si pente di aver dubitato.
È un trucco da quattro soldi (continua sul Post)
Uno, nessuno, centomila Calogero
18-06-2018, 02:32Il Post, santiPermalink"San Calogero di Girgenti, miracoli non ne fa nienti;
San Calogero di Canicattì, miracoli non ne fa tri;
San Calogero di Naro, miracoli ne fa un migliaro".
 |
| Calogero di Agrigento |
Di tutte le leggende, quella della cerva avvalora l'ipotesi. Racconta che giunto intorno ai novant'anni, Calogero non riuscisse più a mandar giù nessun tipo di cibo. Il digiuno, che di solito nelle storie dei santi è una pratica autoindotta e consapevole, qui è semplicemente il segno dell'invecchiamento. Calogero dunque si nutre unicamente del latte ad altissima digeribilità prodotto da una cerva che Dio gli invia tutte le mattine. Finché un cacciatore, Siero, non gliela ferisce a morte. La cerva fa giusto in tempo a tornare nella grotta di Calogero e morirgli tra le braccia; il cacciatore che la stava braccando arriva anche lui nella grotta, vede il monaco che l'ha battezzato che chiude gli occhi alla preda che ha ucciso: minchia, pensa, l'ho fatta grossa. Ma il santo lo perdona immediatamente, e già che c'è gli mostra la grotta vaporosa e gli illustra tutte le virtù delle acque che sgorgano in quelle falde, un vero tour guidato al termine del quale Siero diventa un suo discepolo, appena in tempo perché Calogero non sopravviverà alla cerva che per quaranta giorni.
Calogero è un buon vecchio che conosce le virtù nascoste all'interno della terra; lo si venera a Sciacca, il cui monte era dedicato al dio Crono; sul monte di Termini Imerese dove avrebbe scacciato i demoni e lasciato l'impronta della mano; mentre a Vicari avrebbe lasciato quella del piede. Calogero è insomma una figura dell'inculturazione, il nome dietro al quale uno dieci o centomila chierici, forse davvero provenienti dalla Grecia bizantina, scacciarono le antiche divinità ctonie dalle grotte della Sicilia; che poi uno o dieci avessero davvero la pelle scura, non è implausibile; ma il momento in cui San Calogero diventò davvero nero fu quando cominciarono a circolare le sue statue, più spesso in bronzo o in rame. Il bronzo dei Calogeri di Agrigento e di Naro ha anche l'indubbio vantaggio di scintillare al sole, il che deve suggerire durante la processione del pomeriggio di giugno l'idea che anche il santo stia sudando; che il suo sudore sia qualcosa di fisico, che si può trattenere nelle pezzuole e poi usare per curare i malati. Il sudore di Naro pare che funzioni di più di quello di Agrigento (ma che sia anche più costoso).
La negritudine di Calogero nei secoli è stata spiegata con tante ipotesi diverse, nessuna del tutto soddisfacente... (continua sul Post)
La ballata di San Vito
15-06-2018, 09:19finché c'è salute, Il Post, santiPermalink |
| Aggiungi didascalia |
"Un giorno io chiamo Diocleziano e gli racconto che sei un cristiano".
"No papà dai, non lo farò più".
"Non farai più cosa?"
"Non lo so, cosa stavo facendo?"
Vito faceva il distratto, alzi il piede chi non l'ha mai fatto. Perché in verità era cristiano sul serio: l'aveva convertito il suo maestro, che poi era San Modesto. E non aveva ancora finito di asciugarsi dall'acqua del battesimo che si era già messo a fare miracoli a destra e a manca; ora si capisce che un santo i miracoli ogni tanto li deve fare, ma Vito proprio non se li teneva, gli scappavano da tutte le parti. Ti guariva la psoriasi anche solo a guardarlo da lontano, anche solo a pensarci. San Modesto gli diceva: ti vuoi calmare? Hai tolto la rabbia all'intero canile, vuoi mandare sul lastrico i veterinari? Non c'è più un caso di encefalite da Praga a Mazara del Vallo: e i dottori che cosa faranno? Anche Cristo si è fermato a Eboli: tu dov'è che pensi di andare? E Vito, sempre: scusa Modesto! perché alla fine era un bambino onesto: ma niente da fare, come si voltava ricominciava a mollare miracoli dappertutto.
"Guarda che arriva Diocleziano, guarda che scopre che sei cristiano".
Difatti un bel giorno arrivò, lo processò e lo condannò. Ma Vito era un po' iperattivo, chi non lo è stato controlli se è vivo. Vuoi stare un po' fermo (gli diceva Diocleziano mentre lo immergevano nella pece bollente)? Non vedi che sporchi dappertutto.
"Guarda qui che macello, ci sono macchie di pece fino in Basilicata".
"Scusa Cesare".
"Augusto, io mi chiamo Augusto, Cesare è il mio vice. Ma a scuola non la studiate più la tetrarchia?"
"Non lo so, ho perso il diario".
"La solita scusa, anche mio figlio non fa in tempo a scriversi i compiti che..."
"Tuo figlio in realtà è indemoniato".
"Ti dirò che la cosa non mi sorprende affatto".
"Comunque l'ho guarito".
"Meno male, adesso se non ti dispiace potresti smettere di accarezzare quel leone?"
"Ma perché? È così carino".
"Non è carino, è una belva feroce, è anche paurosamente magro, non mangia da una settimana, l'abbiamo liberato in questa arena affinché ti morsichi a morte e tu gli stai facendo i grattini dietro alle orecchie".
"Senti che fusa, senti".
"Va bene, ho capito, portate via il leone, proviamo col supplizio del cavalletto. Io non li sopporto questi cristiani. Han così tanta voglia di morire e poi alla prova dei fatti non muoiono mai. Li immergi nella pece e non si scottano, liberi i leoni e fanno le fusa. Abbassi la scure e la scure rimbalza. Li lanci dalla finestra e s'involano con gli angeli, ma che razza di religione è. Se proprio ci tieni a morire, non puoi star fermo un attimo e aspettare che ti ammazzino? E adesso cosa c'è? Cosa dice il boia?"
"Cesare, si dimena troppo, non riusciamo ad appenderlo".
"AUGUSTO! MI CHIAMO AUGUSTO! È da vent'anni che ho implementato questa cazzo di tetrarchia e ancora i sottoposti non sanno come chiamarmi ma dico io, le leggete le circolari?"
"Ma Maestà..."
"Non si dice Maestà, non siamo in una fiaba medievale, questo è l'impero romano e io devo essere chiamato Au-gu-sto, Au-gu-sto, Gaio Aurelio Valerio Diocleziano per i biografi. E il cristiano nel frattempo che fine ha fatto?"
"Credo che si sia involato con gli angeli".
“No vabbe’. Io esco. Vado a Spalato a coltivare i cavoli, con vent’anni di contributi da imperatore credo di potermi permettere una villetta in campagna”.
L’angelo aveva portato San Vito alla foce del fiume Sele, dove fece giusto in tempo a morire a causa delle torture, e salito in paradiso cominciò a tormentare anche i santi. Ma vuoi stare un po’ fermo? gli diceva San Simeone Stilita. T’ha morsicato un serpente? gli chiedeva San Patrizio. Qua bisogna dargli qualcosa da fare, propose Sant’Isidro contadino. Buona idea, pensò San Pietro: “Vito, ti va di proteggere i farmacisti? Non hanno ancora un patronato, potresti pensarci t–”
“Fatto”.
“Come fatto”.
“Li ho protetti, capo”.
“Ma ti ho detto di farlo due secondi fa”.
“Controlla”.
“Sì vabbe’ ma scusa non si fa così, non te l’ha spiegato San Modesto? Bisogna avere anche un po’ di rispetto per i santi che ci mettono più tempo”.
“Scusa hai ragione, prova a darmi un altro patronato”.
“Eh vabbe’, così, su due piedi… Gli albergatori”.
“Ok”
“Ok cosa vuol dire? Li hai già protetti?”
“No, no, ci sto lavorando”.
“Non fare il furbo con me”.
“Ti giuro capo, non ho già finito, ci sto mettendo più tempo, guarda”.
“Ci hai messo tre secondi in più, Vito, dai, non è una cosa seria”.
“Ma che ci posso fare? Sono nato così”.
“Non c’è nessuna gloria nell’essere nati, io per dire ero nato pescatore. Bisogna sforzarsi un po’, inventarsi qualcosa. Sennò sembriamo palline scagliate dalla racchetta di Dio. Almeno un po’ di effetto, un po’ di libero arbitrio; Dio t’ha fatto tondo? Prova a metter fuori gli angoli. Se Dio ti ha creato veloce tu almeno prova a rallentare”.
“Ma se Dio mi ha creato in un modo…”
“Di sicuro non era per vederti finire nello stesso modo. Dio ama le sorprese”.
“Ma se è onnisciente”.
“Esatto, ama l’unica cosa che non può avere davvero. È per quello che ci somiglia tanto. Ma cosa puoi capirne tu, sei solo un bambino. E probabilmente lo resterai. Ma fa una cosa: proteggimi i birrai, tu che non bevi mai”.
“Protetti”.
“E i bottai”.
“Fatto”.
“I muti e i sordi, tu che non taci mai”.
“Protetti”.
“Gli abitanti di Sapri e di Rijeka già Fiume, in Croazia. Gli idrofobi e i letargici – proprio tu che non dormi mai”.
“Ok”.
“Sei uno spasso, Vito, non invecchiare”.
“Capo, non credo di poterlo fare”.
Vito era un bambino complesso, chi non lo è stato può alzarsi adesso. Batti quel piede, batti la mano, danza con Pietro e con Diocleziano. Tu che se vuoi riesci a stare seduto (e per questo ai maestri sei sempre piaciuto); che se ti dicono “fermo” tu stai; ma io dico “balla”, e tu ballerai. Tutta la notte finché, sfinito, non ti verrà a salvare San Vito. Lui fa in un attimo, stende la mano: su te, su Pietro e su Diocleziano. Così saprai come ci si sente, a non poter star mai fermi per niente: a sentirsi bruciare le ossa, mentre i nervi ti danno la scossa. E avrai pietà anche di quel cristiano: e pietà per Pietro, e per Diocleziano.
Popcorn, vaccini e ghigliottine (100 anni di orgogliose sconfitte)
11-05-2018, 16:47elezioni 2018, giornalisti, Il Post, Renzi, rifiutatiPermalink |
| E comunque qualsiasi accostamento tra Renzi e il cibo in qualche modo funziona. |
Nei prossimi mesi, se il governo Di Maio-Salvini va in porto, due partiti populisti che si presentavano alle elezioni come diretti concorrenti troveranno un terreno comune e occuperanno i palazzi del potere. Gestiranno le forze dell’ordine. Avranno la possibilità di influenzare l’opinione pubblica attraverso la Rai, che tende sempre a riposizionarsi secondo la maggioranza, mentre difficilmente il conflitto di interessi della Mediaset sarà ritoccato. Con o senza il “benevolo” Berlusconi, Lega e M5S avranno tempo e agio per modificare la legge elettorale a loro piacimento: in fondo lo fanno tutti i partiti che vincono le elezioni in Italia. Tutti questi rischi, una buona parte del Pd ha deciso di correrli; ha pensato che ne valesse la pena. Questa idea che l’avversario politico si combatta non ostacolando la sua ascesa al potere, da dove viene? Purtroppo non è un’innovazione dei renziani, anzi: è uno dei tratti che più li accosta alla tradizione della sinistra italiana.

Berlusconi ai tempi del Berlusconi II (2001).
La strategia del popcorn ha nobili precedenti. Il più immediato è il vaccino di Montanelli. Fu proprio il giornalista, ormai diventato un vate dell’antiberlusconismo, a sintetizzarlo in una delle ultime interviste che rilasciò a Repubblica. Era la primavera del 2001: Berlusconi si apprestava a vincere le elezioni per la seconda volta; polizia e carabinieri si stavano già preparando a quella spaventosa dimostrazione di forza che fu la repressione dei manifestanti al G8 di Genova. Dopo aver dichiarato che avrebbe votato per il centrosinistra, Montanelli confessò a Laura Laurenzi che in realtà sperava in una vittoria di Berlusconi, “faccio fioretti alla Madonna perché lui vinca, in modo che gli italiani vedano chi è questo signore. Berlusconi è una malattia che si cura soltanto con il vaccino, con una bella iniezione di Berlusconi a Palazzo Chigi, Berlusconi anche al Quirinale, Berlusconi dove vuole, Berlusconi al Vaticano. Soltanto dopo saremo immuni. L’immunità che si ottiene col vaccino”.
Berlusconi in effetti vinse, con un buon margine che gli consentì di governare praticamente indisturbato per cinque anni. I disastri non mancarono: il già citato G8, e poi una lunga battaglia sull’abolizione dell’articolo 18 che su concluse con una ritirata strategica (dieci anni dopo Renzi completò l’opera). Gli interventi in Afganistan e in Iraq. L’ennesima riforma della scuola che nascondeva i tagli più drastici. La finanza creativa di Tremonti. Perdemmo molto tempo prezioso in quei cinque anni in cui avremmo potuto modernizzarci e invece ci berlusconizzammo definitivamente. Ma almeno come vaccino funzionò? Non risulta. Dopo cinque anni Berlusconi si ripresentò nel 2006 contro l’Ulivo di Prodi ottenendo un sostanziale pareggio; e nel 2008 stravinse di nuovo. Eppure quando Montanelli nel 2001 aveva suggerito di inocularci un po’ di berlusconismo benigno, molti avevano trovato l’immagine felice e calzante. Gli inglesi lo chiamano wishful thinking, gli psicologi razionalizzazione: visto che Berlusconi appariva ormai inevitabile, ci siamo convinti che ci sarebbe servito, che si sarebbe rivelata un’esperienza formativa. Marx aggiungerebbe che la Storia si ripete sempre in farsa e che Montanelli, inconsciamente, non stava che “evocando con angoscia gli spiriti del [suo] passato per prenderli al servizio”: se alla sua generazione erano serviti vent’anni e una guerra mondiale per immunizzarsi dal fascismo, non era poi così peregrino pensare che qualche anno di Berlusconi al governo ci avrebbe guarito dal male.

“Né Mussolini né Vittorio Emanuele hanno virtù di padroni“, scrive Gobetti, “ma gli Italiani hanno bene animo di schiavi. È doloroso dover pensare con nostalgia all’illuminismo libertario e alle congiure. Eppure, siamo sinceri fino in fondo, c’è chi ha atteso ansiosamente che venissero le persecuzioni personali perché dalle sofferenze rinascesse uno spirito, perché nel sacrificio dei suoi sacerdoti questo popolo riconoscesse se stesso. C’è stato in noi, nel nostro opporsi fermo, qualcosa di donchisciottesco. Ma ci si sentiva pure una disperata religiosità. Non possiamo illuderci di aver salvato la lotta politica: ne abbiamo custodito il simbolo e bisogna sperare (ahimè, con quanto scetticismo) che i tiranni siano tiranni, che la reazione sia reazione, che ci sia chi avrà il coraggio di levare la ghigliottina, che si mantengano le posizioni sino in fondo. Si può valorizzare il regime; si può cercare di ottenerne tutti i frutti: chiediamo le frustate perché qualcuno si svegli, chiediamo il boia perché si possa veder chiaro”.
Il giornalista e militante che chiede le frustate – e le otterrà, fino a morirne – ha appena ventun anni: non arriverà a compierne ventisei. Il fascismo al potere gli sarebbe sopravvissuto di altri quindici. Tra il suo Elogio e l’odierno dibattito sui popcorn c’è ormai un secolo, in cui la Storia ha avuto il tempo di ripetersi in forme sempre più farsesche. Però in un qualche modo inconscio e distorto sembriamo ancora vittime dello stesso pattern: Gobetti chiedeva che i tiranni fossero tiranni perché gli italiani si pentissero di averli lasciati marciare indisturbati fino ai palazzi del governo; Montanelli pregava che gli italiani votassero Berlusconi affinché capissero che votare Berlusconi era sbagliato; Renzi, se pure aveva un minimo margine per impedire che due partiti populisti diretti concorrenti trovassero un accordo, ha preferito andarsi a sedere sulla riva del fiume. Se dice che non si è portato un sacchetto di popcorn, è giusto credergli. Allo steso tempo, come si fa a non immaginarlo mentre sgranocchia.
La violenza a scuola e l'effetto bulldog
22-04-2018, 10:17giornalisti, Il Post, scuolaPermalinkEra ministro dell'istruzione nel 2007.
Tutte le notizie che ho linkato fin qui risalgono alla primavera del 2007. I "telefonini", quelli con i tasti di plastica, producevano già foto e video di qualità discutibile, ma sufficiente a compromettere il quadrimestre di uno studente e la reputazione di un insegnante. Instagram non esisteva; Facebook in Italia era praticamente sconosciuto; Youtube funzionava da due anni e quella ondata primaverile di allarmismo scolastico ci dimostra che stava già diventando mainstream. I siti dei più importanti quotidiani italiani andavano già in cerca di video amatoriali a base di professori sbeffeggiati: avevano già l'abitudine di ripubblicarli, sovrapponendo il loro logo editoriale, aggiungendo un po' di pubblicità e qualche corsivo moralista: Dove Andremo A Finire?
Oggi lo sappiamo: da nessuna parte in particolare. Siamo ancora qui.
Qualche insegnante è andato in pensione, qualcuno un po' più giovane lo ha rimpiazzato, e ogni tanto i giornalisti si rimettono a frugare su Youtube e scoprono che c'è un'emergenza, la solita. Si è rotto il patto educativo! proclama venerdì il Corriere. Un prof picchiato ogni quattro giorni, echeggia Repubblica. "Ventisei episodi diventati pubblici in centonove giorni".
Peccato che tra questi episodi sia ancora una volta inclusa la storia della "professoressa legata alla sedia con lo scotch" di Alessandria, che non è stata né picchiata né tantomeno legata a una sedia (con lo scotch? quanti rotolini servirebbero a immobilizzare un adulto? Come si fa a mandare in giro roba del genere?) Peccato che nel bollettino di guerra pubblicato da Repubblica giovedì siano stati cucinati nello stesso calderone fatti di cronaca successi in mesi diversi, alcuni nemmeno a scuola, in cui i prof spesso non sono né vittima di percosse né di molestie: a volte sono quelli che le denunciano. Peccato che il video che rimbalzava venerdì sulle homepage dei quotidiani, dove l'ennesimo stronzetto minaccia un professore di scioglierlo "nell'acido" (paura!) sia dell'anno scorso. Ma avrebbe potuto essere anche di due, tre, undici anni fa. Ormai viviamo in un eterno presente. Colpa dei social, del deficit di attenzione, oppure semplicemente su Youtube le date sono scritte in piccolo e qualche giornalista trova comodo non farci caso.
È l'effetto bulldog: a volte basta un niente, una notizia che per qualche motivo riesce ad attirare l'attenzione (in un parco un bulldog morde un bambino). In redazione si accorgono che funziona e decidono di insistere sul genere, si mettono a cercare: ci sono stati altri incidenti simili, altri bulldog mordaci? Va bene anche se non sono bulldog, va bene anche se non hanno morsicato bambini. Nei giorni successivi le aggressioni canine non aumenteranno, ma invece di scivolare indisturbate in fondo alla cronaca locale finiranno tutte in prima pagina e il lettore si convincerà che esiste un'emergenza bulldog. Bisogna anche ammettere che è primavera, la politica è in stallo, l'emergenza immigrazione è improvvisamente sparita dal radar (per una curiosa coincidenza, tutti i giornalisti che la propagavano sui canali Mediaset sono stati ridimensionati) la guerra mondiale in Siria non ingrana, magari anche i bulldog nei parchi sono un po' lenti di riflessi e così, in mancanza di bimbi morsicati e bombardamenti seri, la maleducazione scolastica sta avendo il suo momento di gloria.
Il bullismo tira – pazienza se in realtà "bullismo" vuol dire un'altra cosa, ormai per i giornalisti italiani lo spettro del "bullismo" si estende dalla semplice maleducazione all'omicidio a sfondo razziale. Il bullismo ci smuove qualcosa dentro: siamo tutti convinti di esserne stati vittima, siamo tutti convinti di poterla far pagare a qualcuno. Quel ragazzino petulante, non ti viene voglia di prenderlo a schiaffoni? Quel prof immobile, non lo licenzieresti? Su Youtube trovi tutti i video che vuoi (ci sono canali dedicati), non devi neanche pagarci i diritti. In cinque minuti puoi sbattere in home uno spettacolo che attira lettori dalle idee radicalmente opposte: chi difende gli insegnanti e chi gode a vederli svillaneggiati (oppure fantastica di trovarsi al loro posto, ma dotato di arcani poteri che gli consentirebbero di sospendere alunni per direttissima, bocciarli ad aprile anche se gli scrutini sono in giugno). Gli insegnanti stessi spesso sono i più voraci lettori e propagatori di notizie e video del genere, convinti che una pubblica umiliazione possa servire a denunciare la triste condizione della classe docente eccetera. E non dimentichiamo il target più difficile per i giornali: gli studenti stessi, a cui questa roba indubbiamente piace. Magari se trovano su Repubblica e il Corriere le stesse scemenze che sono virali su Youtube, staranno un po' più su Rep e sul Corriere e un po' meno su Youtube... e pazienza se si scatena l'effetto emulazione.
Già, l'emulazione.
 |
| 'Ma mi dia retta, s'inginocchi, vedrà che svoltiamo'. |
 |
| ‘Se non si vuole inginocchiare, potrebbe almeno darmi in ceffone. Finiamo sul canale dei ceffoni, c’è una compilation di ceffoni scolastici che ha 3 milioni di visualizzazioni… oh prof ma mi ascolta? Le sto parlando del nostro futuro’. |
Chi è davvero convinto che le scuole del passato fossero ambienti più tranquilli e rispettosi tende a considerare la propria individuale esperienza scolastica un campione statistico rilevante: spesso è gente che ha fatto un buon liceo, dove di mosche magari ne volavano poche e gli echi dei tafferugli nel più vicino istituto professionale arrivavano di molto attutite. Però, ecco, quel buon liceo avrebbe dovuto anche insegnarci a mettere in discussione i luoghi comuni. Do un’occhiata alla mensola alle mie spalle: al primo colpo trovo uno dei primi libri di Sciascia, Le parrocchie di Regalpietra (1956), lo apro a una pagina a caso. Trovo “trenta ragazzi sporchi arruffati” che anche in presenza di un ispettore scolastico “continuano a mormorare e a litigare tra loro”. Nemmeno del parroco che insegna religione hanno rispetto. “Qualche bestemmia ronza nell’aula, ma il prete non finge come me di non sentire. Promette il fuoco eterno. Ridono. Diventa scarlatto di collera. Son costretto a gridare anch’io il mio inutile rimprovero”.
È davvero il primo libro che mi è venuto in mano. E siccome descrive un territorio che non riesce a liberarsi dal retaggio del Ventennio, mi torna in mente il solito Benito Mussolini che già si portava il coltello alle elementari, e adolescente in un collegio di Faenza rischiò l’espulsione perché lo aveva usato contro un compagno. (Nota: la rischiò soltanto! Non c’è proprio più rispetto. Dove andremo a finire?) Ma il tempo gli riservava un’orribile vendetta: un giorno sarebbe diventato maestro anche lui – con esiti altalenanti. A Tolmezzo si ritrova “una seconda elementare, che contava quaranta ragazzetti vivaci, taluni dei quali incorreggibili e pericolosi monelli. Inutile dire che lo stipendio era modestissimo […] Feci tutti gli sforzi possibili per tirare innanzi la scuola, ma con scarso risultato, poiché non ero stato capace di risolvere sin da principio il problema disciplinare”. Imporre a quaranta milioni di italiani una dittatura si sarebbe rivelato un compito più alla sua portata.
 |
| Che s’ha da fare pur di non tornare dietro quella cattedra. |
Le scuole italiane hanno un sacco di problemi, alcuni strutturali. Tra questi, la maleducazione degli studenti non costituisce una particolare emergenza. È solo la notizia che per qualche motivo ha forato l’attenzione in questo momento. Gli studenti maleducati ci sono da sempre, e non erano molto meno maleducati anche quando si potevano picchiare (è uno dei motivi per cui abbiamo smesso: non funzionava). L’unica sensibile novità è che oggi la maleducazione scolastica è davanti agli occhi di tutti: in attesa delle videocamere appese alle pareti delle aule (arriveranno) la scuola va in onda a tutte le ore su Youtube, su Whatsapp, al punto che viene quasi voglia di prendersela non con il “bullismo”, ma con chi lo propaga, lo rende virale, magari convinto di contrastarlo mentre ci sta soltanto speculando un po’ sopra. Quei video che gli insegnanti condividono nell’illusione di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle difficoltà della loro professione; che i loro studenti ormai organizzano nella speranza di guadagnarsi quei cinque minuti di viralità che dovrebbero valere il prezzo di una bocciatura; quei video alla fine si rivelano una fregatura per entrambe le categorie: uno spettacolino di costo irrisorio montato in homepage per un pubblico annoiato che spesso finisce per invocare quello che la scuola pubblica non può dare (ma la privata sì): il frustino.
Muoia Sansone e... chi sono i Filistei?
14-03-2018, 05:59Bibbia, elezioni 2018, Il Post, RenziPermalink |
| Se cerchi “Sansone” nell’archivio del Post trovi Hedy Lamarr, ok, non ho obiezioni. |
Se è veramente troppo presto per capire come andrà a finire, possiamo nel frattempo registrare una notevole mutazione in atto: il PD, il partito che fino a qualche giorno fa era considerato il partito della responsabilità, del Principio di Realtà, dopo il pessimo risultato sta cambiando completamente pelle – sembra aver indossato la pelliccia leonesca di Sansone. Non perché Renzi si sia dimesso (peraltro, anche dimesso, continua a dettare la linea), ma perché nel giro di poche ore si è trasformato nel partito della ripicca, della recriminazione, della fantasia di rivalsa. Gli stessi dirigenti che per mesi ci hanno preparato emotivamente a una scelta dolorosa ma responsabile (pensavano che avrebbe vinto Berlusconi, e che si sarebbero messi d’accordo con lui), quando hanno vinto Salvini e Di Maio hanno improvvisamente mandato all’aria la responsabilità, il bene del Paese e tutto quanto. Governino gli altri, e vediamo di cosa saranno capaci. “Aspetto con ansia ius soli, stepchild adoption per le coppie gay e lesbiche e legge contro l’omotransfobia”, annuncia Ivan Scalfarotto, e il suo sarcasmo lascia un po’ perplessi: non solo immigrati e gay non avranno nulla di ciò (è colpa loro se il Pd ha perso?), ma è abbastanza facile immaginare che un governo Salvini revochi quei pochi, soffertissimi passi avanti che erano stati fatti fin qui: quante speranze ha di resistere il Ddl Cirinnà?

L’altro ieri c’è stata una direzione del Pd e Matteo Renzi, segretario dimissionario, non c’è andato. In compenso ha concesso a Cazzullo, sul Corriere, un’intervista che lascia perplessi, in cui conferma le sue dimissioni e… nel frattempo detta la linea, poi ribadita in direzione dal reggente Martina: no a qualsiasi alleanza, staremo all’opposizione. Ma è un altro il punto dell’intervista dove Renzi svela la sua prospettiva: non quando racconta a Cazzullo che nei prossimi anni ha intenzione di fare il senatore (“non ci crede nessuno”, reagisce Cazzullo, e noi con lui), ma quando afferma, un po’ a sorpresa, che nessuno dei due schieramenti vincitori ha intenzione di tornare subito al voto perché “prenderebbero la metà dei parlamentari che hanno adesso”.
Un’affermazione piuttosto azzardata (continua sul Post). Perché Renzi è convinto di una cosa del genere? Ha dei sondaggi? Che calcoli fa? Prendiamo il M5S: l’opinione unanime degli osservatori è che abbia vinto (al Centro e al Sud, ma non solo) perché è riuscito a individuare un tema concreto e sentito: il reddito di cittadinanza. Anche ieri, mentre Salvini e il Pd finivano sui giornali per lo più per le alleanze che rifiutavano, il blog del M5S pubblicava un intervento molto articolato, e apparentemente ragionevole, del ministro ombra grillino dell’economia. Come a dire: gli altri si preoccupano delle poltrone (anche solo per rifiutarle), noi dei veri problemi. È un messaggio che sta passando. Se tra qualche mese tornassimo alle elezioni, perché chi ha sostenuto il M5S in marzo dovrebbe bocciarlo in giugno o settembre? Il reddito di cittadinanza ormai era a portata di mano, sul Blog delle Stelle sembrava di toccarlo: non è certo colpa di Di Maio e compagnia se gli avversari politici hanno preferito tornare alle urne.

Ma perché?
Temo che il ragionamento di Renzi sia questo: se tra un mese o due o tre non ci sarà un governo, l’Italia sarà nel caos. Quando gli italiani saranno nel caos, capiranno che errore hanno commesso a non votare sì alle mie riforme costituzionali. Finalmente riconosceranno che avevo ragione un anno fa, e verranno a cercarmi (nella mia cameretta), mi diranno: Renzi torna! E io magari all’inizio dirò no, perché non mi meritano, ma poi… Ecco. Il “tanto peggio tanto meglio” che tante volte ho riconosciuto dietro le riflessioni di chi a sinistra votava per i partiti anti-sistema da Rifondazione in poi, oggi lo ritrovo nelle parole del segretario dimissionario del Pd. Crolli pure tutto, così i Filistei imparano a incatenarci. I Filistei magari imparano, ma Sansone muore. Renzi forse non ci ha riflettuto: è comprensibile che i rovesci di fortuna degli ultimi anni lo abbiano accecato. Ma il Pd? Può davvero condividere i sogni di rivalsa di chi ancora non si dà pace per la sconfitta al referendum del 2016? Tra un po’ sarà il 2019 e non sarebbe male arrivarci con un governo stabile.
Nota bene: non c’è bisogno di cullarsi in fantasie di vendetta per rifiutare una coalizione con il M5S (o con Salvini); ci sono motivi molto più sensati che suggeriscono, per ora, di non compromettersi. La fedeltà ai propri principi, la coerenza, la stessa opportunità. Però le cose cambiano, a volte anche molto rapidamente: i mercati potrebbero innervosirsi, gli elettori potrebbero mandare dei segnali, Trump potrebbe fare davvero qualsiasi cosa, eccetera. Non sta certo a me spiegare al Pd cosa deve fare in un momento tanto difficile (tra l’altro non l’ho nemmeno votato). Il mio non è nemmeno un appello alla responsabilità, ma a quell’istinto che un partito dovrebbe condividere con associazioni e forme di vita assai più basilari: l’autoconservazione. Se il Pd pensa di poter stare per qualche mese o anno tranquillo sulla riva del fiume, mentre qualcun altro manda il Paese alla malora, forse il Pd sta sottovalutando la portata del fiume, e la situazione critica di quelle dighe, a monte, che sta ancora amministrando. Poi magari i Filistei vengono travolti, il che sarebbe fonte di gran soddisfazione per i lettori, se fossimo su una pagina della Bibbia; ma siamo nella realtà, quel libro più lungo e complesso in cui capita a tutti, prima o poi, di essere i Filistei di qualcun altro.
L'ultimo sanguinario, tempestoso Dylan
31-12-2017, 19:21Bob Dylan, Il Post, invecchiare, musicaPermalinkFischia come per spazzarmi via.
Mi fermo un po' a Carbondale, poi riparto,
il Duquesne mi riprenderà con sé.
Mi dai del giocatore, del ruffiano,
Ma non sono né l'uno né l'altro.
Senti come fischia il vecchio Duquesne?
Come fosse l'ultima partenza.
 È stato un lungo viaggio. Anche per chi come noi lo ha fatto tutto in un anno solo, concentrato, una stazione alla settimana. Per più di un anno abbiamo accettato l'idea che un insieme arbitrario di canzoni incise sullo stesso supporto ("disco") possano avere un senso, una qualità superiore (o inferiore, talvolta) alla somma delle parti. Alcune stazioni erano famosissime, altre in disuso; altre sconosciute, artificiali, monumentali, postume. Spesso abbiamo avuto la sensazione di ritornare indietro; talvolta ci siamo messi a fantasticare di ideali scorciatoie, o di stazioni immaginarie che avrebbero avuto più senso di quelle che invece esistono davvero (e che non hanno sempre senso). Tre o quattro volte siamo arrivati in una stazione che sembrava essere concepita come l'ultima - già Blonde on Blonde in qualche modo suggeriva questa sensazione. E poi i dischi con Lanois; alcuni confanetti; e tutti i dischi dal 2000 in poi: hanno tutti quell'aria di capolinea che non ci ha mai impedito di ripartire. Tempest, uscito nel 2012, allude all'ipotesi già dal titolo, che ogni buon ex studente anglofono collega, ancor prima che a un evento atmosferico, all'ultima opera di William Shakespeare. Quella però si chiama The Tempest, con l'articolo: fu Dylan stesso a ricordarlo ai giornalisti, almeno una volta. Segno che si era posto il problema; che non trovava poi così immodesto paragonarsi al più grande bardo inglese, dopo essersi paragonato più di una volta a Picasso - e proprio di Shakespeare avrebbe parlato nel primo biglietto di ringraziamento spedito all'Accademia di Svezia dopo l'annuncio del Nobel: uno Shakespeare impresario di sé stesso, che oltre a scrivere tot righe all'anno deve anche preoccuparsi di fundraising e oggetti di scena (“Dove posso procurarmi un cranio umano?”). Chissà se poi le cose andassero davvero così, se Dylan si sia realmente documentato sulle incombenze dei drammaturghi elisabettiani. Fatto sta che a un certo punto Dylan ha voluto chiamare una stazione "Tempest"; ha voluto che pensassimo che poteva essere l'ultima; quando gliel'hanno chiesto, ha negato; e in effetti ci sono state altre stazioni, ma ora che ci siamo lasciati parecchie miglia alle spalle ci rendiamo conto che forse è andata proprio così: Tempest era l'ultima.
È stato un lungo viaggio. Anche per chi come noi lo ha fatto tutto in un anno solo, concentrato, una stazione alla settimana. Per più di un anno abbiamo accettato l'idea che un insieme arbitrario di canzoni incise sullo stesso supporto ("disco") possano avere un senso, una qualità superiore (o inferiore, talvolta) alla somma delle parti. Alcune stazioni erano famosissime, altre in disuso; altre sconosciute, artificiali, monumentali, postume. Spesso abbiamo avuto la sensazione di ritornare indietro; talvolta ci siamo messi a fantasticare di ideali scorciatoie, o di stazioni immaginarie che avrebbero avuto più senso di quelle che invece esistono davvero (e che non hanno sempre senso). Tre o quattro volte siamo arrivati in una stazione che sembrava essere concepita come l'ultima - già Blonde on Blonde in qualche modo suggeriva questa sensazione. E poi i dischi con Lanois; alcuni confanetti; e tutti i dischi dal 2000 in poi: hanno tutti quell'aria di capolinea che non ci ha mai impedito di ripartire. Tempest, uscito nel 2012, allude all'ipotesi già dal titolo, che ogni buon ex studente anglofono collega, ancor prima che a un evento atmosferico, all'ultima opera di William Shakespeare. Quella però si chiama The Tempest, con l'articolo: fu Dylan stesso a ricordarlo ai giornalisti, almeno una volta. Segno che si era posto il problema; che non trovava poi così immodesto paragonarsi al più grande bardo inglese, dopo essersi paragonato più di una volta a Picasso - e proprio di Shakespeare avrebbe parlato nel primo biglietto di ringraziamento spedito all'Accademia di Svezia dopo l'annuncio del Nobel: uno Shakespeare impresario di sé stesso, che oltre a scrivere tot righe all'anno deve anche preoccuparsi di fundraising e oggetti di scena (“Dove posso procurarmi un cranio umano?”). Chissà se poi le cose andassero davvero così, se Dylan si sia realmente documentato sulle incombenze dei drammaturghi elisabettiani. Fatto sta che a un certo punto Dylan ha voluto chiamare una stazione "Tempest"; ha voluto che pensassimo che poteva essere l'ultima; quando gliel'hanno chiesto, ha negato; e in effetti ci sono state altre stazioni, ma ora che ci siamo lasciati parecchie miglia alle spalle ci rendiamo conto che forse è andata proprio così: Tempest era l'ultima.Certo, il treno è andato avanti. E potremmo andare avanti anche noi, almeno per un po'. Ma in un certo senso Dylan è sceso. Il Dylan compositore, perlomeno: ovvero quello che ci interessa di più. Seguono altre tre stazioni di cover di lusso, una interminabile playlist di pezzi confidenziali che potrebbe essere quel tipo di musica che suonano nell'ascensore mentre uno va in paradiso, ecco, forse da Tempest in poi ci troveremo in un limbo del genere, e sai quanto ci divertiremo! Abbiamo tre stazioni per decidere se Dylan abbia preso più da Sinatra o più da Louis Armstrong o per caso niente da entrambi. Ma prima di tutto questo dobbiamo affrontare Tempest con la consapevolezza che è davvero, che ha proprio tutta l'aria di essere l'ultimo disco di inediti che Dylan ha voluto pubblicare. E com'è questo Ultimo Disco di Dylan, com'è? Beh:

Ha una della copertine più brutte mai autorizzate da Dylan ("Qualcuno è stato davvero pagato per questa cosa?" "Sembrano i primi passi su photoshop di uno studente del primo anno"). Ma dal punto di vista musicale, l'unico che c'interessi davvero, com'è?
È... straordinario (per un settantenne, almeno).
Senti come fischia il vecchio Duquesne?
Fischia come non ha fischiato mai.
Il blu lampeggia, il rosso avvampa
come sulla porta della mia camera.
E tu sorridi ancora dal cancello
come mi sorridevi un dì?
Senti come fischia il vecchio Duquesne:
come se non dovesse fischiare più.
La straordinaria opera di un settantenne. Temo che a questo punto del viaggio l'età del conducente non possa più essere considerata una curiosità. Per quanto ancora possano essere suggestive le stazioni, è il viaggio che sta diventando un'opera in sé; nessun treno dello stesso genere ha percorso un tratto così lungo e complicato. Forse non abbiamo neanche gli strumenti per descriverlo, il disco rock di un settantenne; ci mancano i punti di riferimento - persino i Rolling Stones (comunque partiti dopo) sono rimasti indietro, su una pista tutta loro che torna sempre alle stesse stazioni. La grandezza del Dylan di Tempest rischia di essere la grandezza di certi atleti che vanno alle olimpiadi senior per la quarta volta e finalmente vincono la medaglia perché i loro avversari storici nel frattempo sono morti. Allo stesso tempo, come si fa a ignorare che Dylan continui a suonare ottanta concerti all'anno all'età in cui voi vi immaginate davanti a un brodino caldo all'ospizio? Che stia ancora scrivendo canzoni mezzo secolo dopo aver pubblicato Blowin' in the Wind?

Stavolta a soffiare è una vecchia locomotiva a vapore, la "Duquesne", metafora semplice e immediata della vita e della morte. È un soffio che gli ricorda chi è stato e chi non potrà mai non essere; è un fischio che annuncia il destino, come quello di When the Ship Comes In; se è della morte che si sta parlando, non è questa gran novità: ne parlava più ossessivamente il Dylan del suo primo disco di 50 anni prima. La novità è magari il modo sornione con cui ne parla: Duquesne è il brano più allegro, più sereno del disco, l'unico vero swing (e l'unica collaborazione con Robert Hunter, a mio avviso la più riuscita). Dylan attraversa la canzone come un vecchio giocatore con qualche brutta avventura alle spalle e un pensiero fisso che gli fa compagnia come una vecchia amante. Il riff della chitarra è un capolavoro di sintesi tipico del suo ultimo stile chitarristico (lui nel frattempo nei concerti era passato alla tastiera, segno che forse le articolazioni gli danno qualche difficoltà). Due note; di nuovo due note ma con una velocità diversa; di nuovo il primo intervallo di due note; e infine un intervallo un po' più esteso. Come la biella della locomotiva, che ha solo due direzioni e manda avanti un treno intero. Qui e in The Long and Narrow Way (che gira intorno a una versione semplificata del riff di Hoochie Coochie Man) il minimalismo chitarristico di Dylan potrebbe essere un modo per adeguare la musica ad articolazioni meno reattive: ma ricorda anche quel certo tipo di sbrigatività con cui affrontava i suoi cavalli di battaglia acustici già dopo qualche anno, accelerandoli e semplificandoli. Il vecchio Dylan contiene sempre il giovane Dylan.
Senti come fischia il vecchio Duquesne?
Come se facesse a pezzi il cielo.
Sei l'unica cosa viva che mi manda avanti,
sei una bomba a orologeria nel mio cuore.
Riesco a sentire una voce che mi chiama...
Dev'essere la madre di nostro Signore.
Senti come fischia il vecchio Duquesne?
Come se il mio amore fosse a bordo.
Poteva essere molto peggio, questo ultimo disco di Dylan. (Per esempio: poteva essere Together through Life). Come uscita di scena di un grande autore, è comunque notevole: contiene almeno due brani (Duquesne, Tin Angel) che salgono immediatamente nell'empireo delle trenta canzoni migliori di tutti i Dylan: il che non si può dire di dischi più robusti come Modern Times o Time Out of Mind. Allo stesso tempo contiene anche brani che possono lasciare perplessi (Long and Wasted Years, Tempest, Roll On John), come non succedeva ormai da parecchi anni; perché Dylan in Tempest si prende dei rischi che non si prendeva da tantissimo tempo, da quanto? Forse dal 1990 di Under the Red Sky. Ricordate che a un certo punto il viaggio si è fatto molto più tranquillo, senza più scossoni improvvisi, con tappe più lunghe e rifornimenti confortevoli, ma come dire, un po' ripetitivi? Ecco, Tempest non è così e sarebbe il suo più grande pregio - se non contenesse Duquesne e Tin Angel, che sono pregi più grandi. Proprio quando ci aspettavamo l'Ennesimo Disco Alla Jack Frost, metà blues metà ballate confidenziali, il settantenne Dylan si rimette a pasticciare con altre cose; e i risultati non è che siano sempre limpidi, però...

Però a questo punto meglio così, davvero. Meglio cose torbide come Pay in Blood e persino filastrocche interminabili e inascoltabili come Tempest: meglio tutto questo all'ennesima collezione di rockabilly e blues, perdio, lo so che sono la quintessenza del folklore americano e una componente ineludibile della dylanità, ma sono su questo scompartimento da un anno e non so se sarei riuscito ad ascoltarne tre in più. In Tempest ce n'è il minimo sindacale (sul serio, probabilmente se non ne infila almeno un paio ad album Robert Johnson sale dall'inferno a complicargli i sogni): entrambe variazioni di Hoochie Coochie Man: la già citata Long and Narrow Way ed Early Roman Kings. Hoochie Coochie era un inno all'arroganza del maschio alpha; le nuove Hoochie Coochie di Dylan sono canzoni più trucide che arroganti, ma è un aspetto che condividono con quasi tutto il disco - è un disco che trabocca di sangue. Quel che più sorprende è che non sia sangue di Dylan. Lui stesso ce lo spiega per cinque lunghi minuti: “pagherò col sangue, ma non col mio”... (continua sul Post).
Dylan sarà a casa per Natale
23-12-2017, 00:56Bob Dylan, Il Post, musica, non ho voglia di tuffarmi in un gomitoloPermalinkUn disco no, ormai c'è Spotify. Un dvd no, abbiamo Netflix. Un profumo te l'ho preso per il compleanno. Questo Natale mi sa che tocca a un libro. Così entro in libreria, nell'unica seria rimasta, e incontro proprio te. Ci salutiamo imbarazzati come se non ci conoscessimo da mezza vita; tu stavi giusto uscendo con due o tre sacchetti che vistosamente ignoro. Ora che non ci sei più e posso scegliere con libertà, do un'occhiata alle ultime uscite e in cinque secondi trovo:
1. Il libro che un po' desidero e che sicuramente mi hai appena comprato.
2. Il libro che desideri tu. Ma lo desideri nel senso che te lo devo comprare, o non hai resistito e te lo sei comprata da sola? Perché magari lo desideri troppo per fidarti di me, magari pensavi che ti avrei preso una sciarpa.
Mi sta mancando l'aria. Intorno a me tutti comprano cose come se fosse il gesto più naturale del mondo: è Natale. A volte fingo di dimenticarmi che soffro il Natale. Finché sei adolescente è ok, poi diventa una posa noiosa. Ma temo che non sia una posa, è proprio il momento sbagliato dell'anno per me, arriva troppo presto. Avrei centinaia di cose da fare ma sbam! Natale. Devo anche recensire Christmas in the Heart, il più assurdo dei dischi di Bob Dylan, o no?
I've done my window shopping
There's not a store I've missed
But what's the use of stopping
When there's no one on your list
You'll know the way I'm feeling
When you love and you lose
I guess I've got the Christmas blues
"Più divertente dei chipmunks, riconosciamoglielo" (Robert Christgau).
Ognuno ha le sue liturgie che non sa più giustificare; tu per esempio ovunque sei nel mondo a Natale cerchi di andare a messa. Non ci sarebbe niente di strano, senonché tu odi le messe natalizie e detesti i preti che si sentono finalmente sotto i riflettori e decidono che davanti a una folla rassegnata a restare in piedi per un'ora pronunceranno l'omelia della vita. Così ti ritrovi in giro nel pomeriggio del 25 - uno dei momenti più bui dell'anno, malgrado tutte le luci. Dai comignoli essuda ancora il vapore del brodo di cottura dello zampone - finalmente trovi una chiesa ancora aperta. Ti butti dentro, è tutto buio e vuoto e la prima cosa che senti è un tizio che cerca di cantare Adeste fideles. Non ha voce e non sa il latino, ma in un qualche modo strano funziona. È un vecchio parrocchiano che ha deciso di venire a digerire il Natale qui, cantando la messa più sfigata di tutte. Come un Babbo Natale ubriaco.
"Adesti fide-e-leis, leity thriooomphanteis
Venitew veni-i-tew ad Bethle-e-ehm..."
(La pronuncia di zio Bob non è meno corretta di quella di qualsiasi studente di liceo. È solo diversa dalla nostra, ma forse quella degli antichi era più simile alla sua. Anche loro avrebbero pronunciato qualcosa di più simile a "reghem anghelor'm", piuttosto del nostro "regem angelorum". D'altro canto non ce l'avevano, il Re degli Angeli, quindi di cosa stiamo parlando?)
"Cosa stiamo ascoltando?"
"Il disco di Natale di Bob Dylan".
"Sì, ma perché?"
"Beh. perché... è Natale".
"È stonato".
"No, tecnicamente non è stonato. È solo un po'..."
"È fastidioso".
"Dici? io lo trovo commovente".
"Mi fa male alle orecchie. Perché lo stiamo ascoltando?"
"È per beneficenza".
Who wears boots and a suit of red?
Santa wears boots and a suit of red.
Who wears a long cap on his head?
Santa wears a long cap on his head!
Il più bel video in cui canta Bob Dylan è Must Be Santa. Indossa svariati cappelli buffi e una parrucca assurda e non si è mai calato così bene in una parte. È un vecchio zio che senza troppo dare nell'occhio sta tenendo accesa una festa. Quando c'è bisogno di far partire le danze, lui canta. Quando tutti ballano, se ne sta in poltrona col sigaro. Nel momento esatto in cui hai bisogno di un bicchiere, lui tira fuori due bottiglie pronte. È una festa di famiglia, e quindi è intergenerazionale, incasinata, e devi stare attento perché prima o poi voleranno bottiglie. Nel finale arriva il Babbo vero, che scambia con Babbo Dylan un'occhiata di profonda comprensione. Bah, che mondo. Ormai fanno entrambi lo stesso mestiere.
"Mestiere un po' di merda eh?"
"È quel che so fare".
"Ma senti c'è una cosa che mi sono sempre chiesto. Come hai cominciato?"
"Guarda, ho ricordi molto vaghi. Ero un vescovo che si preoccupava per la dote di alcune ragazze... oppure ero il dio Odino che galoppava su un cavallo a otto zampe... è passato del tempo, capisci. E tu?"
"Anch'io ne so poco. Ero un un poeta beat, forse, oppure un profeta hippie..."
"Tu? Hippie? Ma sei sicuro?"
"No appunto. Ma a un certo punto ero senz'altro un ragazzino senza un soldo che cantava nei caffè. Sai cosa ricordo bene?"
"Il freddo".
"Puoi dirlo".
 |
| Ding Ding Ding |
"...Un freddo atroce, dio, l'inverno è una cosa orribile. Soprattutto quando arrivi a fine dicembre e pensi, beh, quanto inverno ci resta da soffrire? E invece è appena iniziato".
"È per questo che il nostro lavoro è importante, Bob".
A un certo punto, credo durante la lavorazione di Shot of Love, Dylan arrivò in uno studio e decise che avrebbe inciso White Christmas di Bing Crosby, solamente perché aveva sentito dire che Bing Crosby aveva lavorato lì. Fu il solito buco nell'acqua e a tutt'oggi non si sono ancora trovate le registrazioni, ma è la prima manifestazione di un interesse di Bob Dylan per il Natale.
(La canzone più triste è I'll Be Home for Christmas, un pezzo strappaventricoli di Bing Crosby che nel 1943 speculava sulla malinconia dei soldati che non avrebbero fatto in tempo ad arrivare a casa a Natale: ci sarò, canta Dylan, conta su di me, prepara il vischio e i regali sotto l'albero perché sarà a casa per Natale... almeno nei miei sogni. In 40 minuti del disco è l'unico momento in cui serpeggia il sospetto che sia tutto finto, che il Natale di Dylan sia l'invenzione di un vecchio signore rimasto solo con le sue vecchie canzoni, che nessuno inviterà a una festa).
Dylan in effetti non è mai stato natalizio, neanche nel suo periodo gospel. Il suo inverno è un mondo orribile dove si muore sul marciapiede, e gli ultimi spiccioli ti servono per comprare una pallottola per ogni membro della famiglia. Sai chi è sempre stato natalizio? I Beatles, loro sì. Anche se non hanno mai scritto una vera canzone di Natale - i loro dischi natalizi poco più che curiosità - i Beatles hanno quel quid. Sanno di zenzero, di cannella. Tutti vogliono bene ai Beatles, anche se li odiano. Il tempo passa e loro restano lì, per sempre uguali a sé stessi. Scaldano il cuore, rallegrano i bambini. Tutte cose che Bob Dylan per tantissimo tempo non si è posto il problema di fare. Là fuori il mercato dei dischi crollava, e artisti che fino a qualche anno prima, se gli avessi chiesto: "che ne pensi di un album natalizio?" ti avrebbero riso in faccia - non siamo mica negli anni Cinquanta, nonno! - ma a un certo punto il mercato si è piegato che nemmeno il Titanic, ed eccoli all'improvviso tutti in vetrina col cappuccio e l'albero e il vischio, i pattini, le renne, vi prego comprate il nostro disco di Natale! Ma il caso di Dylan è un po' diverso - se non altro non aveva bisogno di soldi, anzi. Ha dato tutto in beneficenza, al World Food Programme. Molto nobile da parte sua.
D'altro canto, chi è che regala davvero gli album natalizi? Vi hanno mai regalato un album natalizio? (Continua sul Post)
Insieme attraverso i brutti dischi
16-12-2017, 17:57Bob Dylan, Il Post, invecchiare, musica, nostalgiaPermalinkImmagino che se invecchi abbastanza riesci ad arrivare a un momento in cui rimpiangi qualsiasi cosa. Io perlomeno credo che potrei arrivarci, per dire ultimamente a volte penso a un autogrill. Non provo nostalgia di una ragazza che andavo a trovare - cioè la provavo, ma ormai è una nostalgia che ha perso il suo sapore, come un bubblegum molto rimasticato - non provo più nostalgia per la città in cui abitava. Anche quel tratto di autostrada ormai per me è un tratto qualsiasi. Ma a volte mi fermavo in autogrill e quello ancora un po' mi manca. L'hanno buttato giù per farne uno più grande che invece non mi ricorda nessuno. Stavamo dicendo?
"Che se invecchi abbastanza riesci ad arrivare in quel momento in cui rimpiangi qualsiasi cosa".
Ah già. Bob Dylan per esempio, a un certo punto ha smesso di avere nostalgia per The Freewheelin'. Ma anche per Blonde on Blonde e Blood on the Tracks. Dylan a un certo punto deve aver cominciato ad aver nostalgia per quando registrava certi suoi dischi inutili, bruttini, senza capo né coda. È la famosa legge dei vent'anni: negli anni Quaranta era tornato di moda lo swing degli anni Venti (ma Mussolini aveva piuttosto nostalgia di quando i fascisti marciavano sulle capitali). Negli anni Sessanta si credevano tutti partigiani. Negli anni Settanta improvvisamente si ricordano di quanto era smagliante e cromato il rock'n'roll. Negli anni Ottanta avevano tutti nostalgia di quando negli anni Sessanta si credevano tutti partigiani. Nel 2008, Dylan è maturo per provare nostalgia per i dischi più deprimenti che ha fatto; roba come Knocked Out Loaded, o Down in the Groove, roba che mette tristezza solo a pensarci - ma se la lasci decantare per vent'anni, quella tristezza a un certo punto deve assumere un sapore interessante. Ve lo ricordavate di com'era difficile essere dylaniti negli anni Ottanta, quando il nostro registrava quaranta tracce con quaranta musicisti diversi in cinque studi in sei mesi e un attimo prima di buttar via tutto pubblicava i cocci? E noi glieli compravamo, e glieli ascoltavamo, e glieli stroncavamo... Che nostalgia.
 |
| Quelle belle giacche di una volta non torneranno più |
MOTIVI PER CUI TOGETHER THROUGH LIFE, USCITO NEL 2008, FU IL SUO DISCO PIÙ BRUTTO IN 20 ANNI.
1. Ve ne viene in mente un altro? Come passa il tempo, sono già 20 anni che è uscito Oh Mercy. In seguito abbiamo avuto Under the Red Sky (che secondo me è piuttosto bruttino, ma vedo in giro che piace), i due acustici, Time Out of Mind, “Love and Theft” e Modern Times. Appena sette dischi in vent'anni! In compenso la qualità ha smesso di oscillare sull'ottovolante come le succedeva negli orribili anni Ottanta e nei complicati Settanta. Together non è un disco brutto come Self Portrait o Knocked Out, ma rispetto ai tre dischi precedenti ha qualcosa di dissonante, di irrisolto, di affrettato - qualcosa che in fondo ci mancava. Ben tornato, cattivo Bob, cos'hai combinato stavolta? Hai licenziato i tuoi fedeli musicisti? Non risulta, eppure si capisce da subito che c'è qualcosa che non va. Appena parte Beyond There Lies Nothing, con quella tromba un po' stonata (chi la sta suonando?) e poi... la fisarmonica?
2. La fisarmonica. Ogni tanto succede che uno strumento insolito dia un colore particolare a un disco di Dylan - l'organo di Kooper in Blonde on Blonde, il violino di Scarlet Rivera in Desire, il sax di Street-Legal, e quella fantastica batteria elettrica in Empire Burlesque, ve la ricordate? che nostalgia. Ecco. Together Through Life è il disco di Dylan con la fisarmonica in tutti i brani. La suona David Hidalgo, chitarrista-pluristrumentista dei Los Lobos. Non la suona male. Ma la suona in tutti pezzi, ed è una maledetta fisarmonica. Se voglio sentire le fisarmoniche ascolto Raul Casadei. Ok, forse è un problema mio. Probabilmente uno choc infantile. Odio le fisarmoniche.
3. Il mandolino. Non così onnipresente - si sdilinquisce all'inizio di Life is Hard, ma di solito è molto più discreto, però allora dillo che lo fai apposta. Fisarmonica e mandolino, come ai tempi di Joey: non dirmi che rimpiangi anche quelli. This Dream of You, 35 anni dopo Joey, è il secondo tentativo di scrivere una ballata all'italiana, con quell'idea tutta particolare di italianità che possono farsi a Manhattan quando vanno a mangiare le fettuccine Alfredo. Certo che ce ne vuole di nostalgia del disastro, per tornare sulle orme di un delitto come Joey. Di quali altri delitti senti la mancanza, Bob? Qual è la cosa peggiore che rifaresti? Non so, un altro tour coi Grateful Dead? Troppo tardi, Garcia non c'è più. In compenso puoi sempre rimetterti a collaborare con...
4. Robert Hunter. "Hunter è un vecchio amico, potremmo probabilmente scrivere un centinaio di canzoni assieme se pensassimo che ne valesse la pena"... è un'affermazione che suona vagamente minacciosa. Hunter era un membro atipico dei Dead: benché scrivesse per loro, non li seguiva dal vivo. Il suo rapporto con Dylan ha qualcosa di inspiegabile. Robert Hunter è l'autore di una delle canzoni che Dylan ha cantato più dal vivo, Silvio. La leggenda ci dice che aveva trovato la pagina col testo nello studio dei Dead. Cosa ci abbia trovato proprio in quella paginetta nessuno lo sa. È un rock senza infamia e senza lode: Hunter ne ha scritti a dozzine, Dylan ne ha scritti centinaia. Nel 2008 si ritrovano insieme e decidono di scriverne un altro po', casomai ce ne fosse venuta la mancanza (non c'era venuta). Hunter è un grande autore? Ha scritto tantissima roba, ma niente che abbia mai veramente superato il suo ambito di competenza (per dire: mi sapreste dire un grande successo dei Grateful Dead?) Io i Dead non li ho mai capiti e non saprei neanche esattamente dire cos'hanno di diverso i testi di Together - forse sono più brevi del solito, ecco, magari Dylan portava la penna e Hunter le forbici. In questo caso bravo Hunter, perché uno dei pregi di Together è che dura un quarto d'ora meno del solito (ma mezz'ora più del necessario).
5. I just want to make love to you. Metà dei brani, che ve lo dico a fare? sono blues o derivati. Blues in 8 misure, blues in 12 misure, rockabilly, rock and roll, non è che non conosca certe differenze, ma sapete una cosa? Mi rifiuto, è come quando un birraio pretende di farti degustare delle lager, ma andiamo. E il retrogusto, e i profumi, e neanche fosse cognac, sant'iddio, è birra, servila fredda e non rompere i coglioni. Che Dylan sia uno dei più grandi bluesman della storia è ormai fuori discussione; se ne poteva discutere al massimo nei primi mesi del '64, quando con Subterranean Homesick Dylan aveva stravolto il genere come un calzino, dimostrando che il blues per lui non era antiquariato, ma qualcosa di vivo e pulsante. Ma ormai sono trent'anni che per Dylan suonare il blues è giocare in difesa. Come quando gli chiedono: perché suoni cento concerti all'anno? E lui risponde che B.B. King ne suona trecento, che discorso è? C'è che nessuno se la prende se B.B suona gli stessi blues da una vita, e nessuno dovrebbe prendersela se Dylan fa la stessa cosa. Negli ultimi vent'anni ne ha buttati fuori talmente tanti che potrebbe persino aver messo lo stesso blues in due dischi diversi, con due titoli diversi, e nessuno se ne sarebbe accorto - nessuno. I blues si somigliano tutti; alcuni si somigliano più di altri; in Together a un certo punto Dylan sembra volerci cantare I Just Want to Make Love to You (ma si chiama My Wife's Home Town). Jolene è un vecchio rudere r'n'r che cerca di commuoverti al bancone così gli paghi da bere anche stasera. In Forgetful Heart fa capolino un riff che sembra il tema di Peter Gunn (e il rullante della batteria sembra un po' svitato); Shake Shake Mama è la cosa più divertente del disco, ma è come quando hai voglia di birra e te ne servono una fredda, va bene? Vuoi farmela pagare il doppio perché è artigianale? Non siamo tutti un po' vecchi per queste stronzate? (continua sul Post)
Dylan e il capolavoro involontario
10-12-2017, 01:14arti figurative, Bob Dylan, Il Post, musica, PasoliniPermalinkIo comunque su Pasolini ho una teoria: secondo me, mentre girava il Decameron lui...
"Ma che c'entra Pasolini adesso".
Ma niente, mi viene sempre in mente sotto l'Immacolata, perché sai.
"Ti confondi col ponte dei morti".
Ah già.
"Ma senti è un po' che non passo a leggerti, li hai poi finiti i dischi di Dylan?"
No, effettivamente ne ho ancora un po'.
"Ancora? Ma quando hai cominciato? Sembrano anni".
In effetti è esattamente un anno.
"Ma ne ha fatti così tanti?"
Più di una cinquantina, sì. E parecchi persino belli.
"Beh io a un certo punto ho smesso di leggerli, però..."
Non devi mica scusarti.
"...quando li raccoglierai in volume di sicuro io... perché pensi di raccoglierli in volume, vero?"
Eh, dipendesse da me.
"Ma hai mai scritto a un editore?"
Sì, e mi hanno anche risposto, ma...
"Cioè è chiaro che bisogna lavorarci un po' su, togliere le cose che in un libro non funzionano, però..."
Ma alla fine non resta niente.
"In che senso".
È come coi Santi. Uno dice: sto facendo una rubrica dei Santi che ha un suo seguito, insomma funziona, che ne dite? E loro all'inizio wow, in effetti è interessante, però... bisogna lavorarci.
"Ma ti fa così schifo lavorarci?"
Ma no io ci lavorerei anche, però... senti, non mi sto lamentando, ok? È un problema mio. Si vede che non funziono sulla carta.
"Ma cosa dici".
Di solito va così: mi dicono, metti tutto in un pdf e mandacelo. E io: guardate che è tanta roba.
"Tagliane un po'".
Ma certo che ne taglio.
"E alla fine ti restano..."
Quelle due, trecento cartelle.
"Così tanto?"
In un blog non sembra tanto, ma su carta è come se si gonfiasse. Poi ti dicono: bello eh, ma bisogna togliere tutti gli interventi in prima persona, i siparietti autobiografici... in un libro non hanno senso. E sai una cosa?
"Hanno ragione".
Hanno assolutamente ragione, e allora io li tolgo. E tutte le battute stagionali, le trovate estemporanee, le cose che hanno senso soltanto nel giorno in cui le scrivi, tolgo tutto. E a quel punto...
"Non sono più interessati?"
Non sono più interessante.
"Però su Dylan..."
Ma certo, figurati se fuori non c'è la fila di gente che mi vuole pubblicare quattrocento cartelle su Dylan.
"Ma saranno meno, dai".
Specie dopo aver tolto tutte le digressioni personali, le battutine, le cose da blog, tutto quello che lo renderebbe diverso dall'ennesimo libro su Dylan.
"E allora cosa farai?"
E allora cosa farò? Mi inventerò altre cose da scrivere e andrò avanti così.
"Ma non ci pensi che un giorno qui sparirà tutto?"
"Ci penso sempre, ma alla fine non è quasi mai successo".
"Tra un po' finisce la net neutrality e ciao".
"Troverò un sistema".
 "Un server si pianterà e puf, non resterà nulla. Solo tanti link che puntano nel vuoto".
"Un server si pianterà e puf, non resterà nulla. Solo tanti link che puntano nel vuoto".Ogni tanto faccio un backup.
Got nothing for you, I had nothing before
Don't even have anything for myself anymore
Sky full of fire, pain pourin' down
Nothing you can sell me, I'll see you around
Resto convinto che Pasolini, mentre girava il Decameron, se la deve esser vista brutta. Ma veniamo a Dylan, sennò pensate che io voglia cincischiare; che il disco di questa settimana non l'abbia neanche ascoltato, e in effetti parliamo di un disco triplo dal prezzo scandaloso (ma su Spotify ci sono solo i primi due, quelli che venivano venduti a una cifra ragionevole). Invece non solo l'ho ascoltato, ma lo riascolterei volentieri anche adesso, toh. Sono sinceramente convinto che sia uno dei dischi migliori di Bob Dylan - sì, tra i cinquanta e più dischi che ho ascoltato quest'anno, Tell Tale Signs sta nei primi quindici, forse anche tra i primi dieci. Credo addirittura che sia il disco migliore della sua ultima fase, ed è un'affermazione abbastanza forte, visto che Tell Tale Signs è perlopiù una collezione di scarti dalla lavorazione di Oh Mercy (1989), World Gone Wrong (1993), Time Out of Mind (1997), Modern Times (2006): com'è possibile che gli scarti siano migliori del prodotto? Con Dylan è possibile, anzi.
I was thinking of a series of dreams
Where nothing comes up to the top
Everything stays down where it's wounded
And comes to a permanent stop

È quasi inevitabile. Avete sentito che l'ultimo Leonardo Da Vinci disponibile sul mercato è finito in Arabia Saudita? Secondo me era una sòla, però io non me ne intendo e anzi ho in materia idee molto estreme, ad esempio nutro qualche dubbio sulla Gioconda del Louvre: e se non fosse l'autentica? Perché non ha le sopracciglia e mancano due colonne che ci sono in alcune copie molto vecchia - ma è comunque una Gioconda fantastica, se dubito di lei figurati quanto posso fidarmi di un Salvatore col volto ieratico (ma asimmetrico!) con dei ricciolini da Botticelli, ritratto di fronte... cioè hai Da Vinci a disposizione e gli chiedi un ritratto di fronte? È come chiedere alla Ferrari se ti fanno un motorino 50 cc, dai, non esiste... (continua sul Post)
Avanti, a passi sempre un po' più corti
02-12-2017, 08:24Bob Dylan, Il Post, invecchiare, musicaPermalinkQuando compi un anno di vita, tutta la vita è in quell'anno; ma poi ne compi un altro e ti sembra un periodo lunghissimo, addirittura la metà della tua vita. E già pensi che ti aspetta un altro anno, ma quando arriva è soltanto un terzo della tua vita (che per carità, è ancora parecchio). Ma insomma, ogni anno che passa, passa più alla svelta: e per quanti anni metti assieme, la somma di tutti gli anni dopo il primo non durerà mai quanto il primo. La funzione insomma è y=x/1+x/2+x/3+x/4+x/5 eccetera, c'è senz'altro un modo più elegante ed esauriente di scriverla ma non ho fatto lo scientifico. La cosa interessante è che quando arrivi a x/65 - l'età di Dylan quando incise Modern Times, in realtà devi ancora arrivare al quinto anno di età percepita. Roba da matti.

Infatti secondo me ho fatto un errore. Eppure il ragionamento spiegherebbe perfettamente il perché a un certo punto oltrepassi una specie di soglia dopo la quale gli anni passano talmente alla svelta che non li riconosci più. C'entra anche il modo in cui ti tratta la vita: fino a vent'anni puoi provare a cambiare spesso i partner, o la città, o la professione, ma a un certo punto fatalmente rimani incastrato in una famiglia e/o una città e/o un ufficio, e da lì in poi certe cose come, che so, fare la spesa, assumono una ritualità ipnotica: se all'Esselunga ogni tanto non cambiano il posto ai prodotti degli scaffali, tu sul serio certe volte non ti ricordi più se quei cetriolini li hai comprati la settimana scorsa o dieci anni fa. Oppure entri in un bar e il cameriere ti serve senza chiederti niente, ma come si permette, poi fai due calcoli e sono già cinque anni che entri e chiedi la stessa cosa, cinque rapidissimi anni, ma in realtà per te ne sono passati appena (1/35+1/36+1/37+1/38+1/39)=0,13, cioè quando dici che ti sembra ieri che inauguravano il locale, dal tuo punto di vista hai ragione (è che il tuo punto di vista sta accelerando man mano che muori).
Il peggio è che lo avevo sempre saputo che sarebbe finita così, ma per qualche motivo ero convinto che l'avrei gestita meglio degli altri. Per esempio: scriverò una pagina tutti i giorni per tutta la mia vita. Quando mi chiederanno, dove hai messo il tuo tempo? Eccolo qua. E non si sgarra, vedrete che ogni anno sarà più o meno di trecento pagine. Che ingenuo, vero? Beh, l'ho fatto sul serio. Meno male che hanno inventato i blog, sennò ormai mi ritroverei in soggiorno una pila di manoscritti che mi accuserebbero: "dove hai messo il tuo tempo?" E, indovinate? Ogni pagina è come se fosse un po' meno importante della precedente. Per esempio: cosa facevo nel febbraio del 2006, mentre Bob Dylan incideva Modern Times (sembra ieri e infatti è successo 11 anni fa)? Voi non vi ricordate di cosa stavate discutendo nel febbraio del 2006. Io sì, io ho l'archivio on line. Io infatti stavo discutendo... delle vignette satiriche di Charlie Hebdo su Maometto.
No, aspetta
Sono passati già undici anni?
Dio mio.
Ma parliamo di Dylan. Ha appena ottenuto una nomination ai Grammy - beh, ne ha già vinti dodici, di cui uno alla carriera. Ultimamente lo candidano nella categoria "Miglior album pop tradizionale", che come ci spiega l'eminente Madeddu non è un campo qualsiasi, ma il teatro di una logorante guerra di posizione tra Tony Bennett e Michael Bublé. Che ci fa Dylan tra questi crooner, questi interpreti confidenziali? Diciamo che la cosa non ci sorprende più. Forse ci avrebbe ancora sorpreso l'altro ieri - ovvero nel 2006, quando uscì Modern Times.

Una cosa dovete riconoscere al signor Dylan: non ha mai voluto incidere lo stesso disco due volte. Diciamo *quasi* mai. Persino quando aveva a disposizione solo una chitarra e un'armonica, ogni disco era il segnale che il tempo stava cambiando. The Freewheelin' non assomigliava a The Times They Are A-changin' che non assomigliava ad Another Side. Solo verso gli anni Ottanta le sue difficoltà in studio lo hanno portato un po' a ripetersi: ma persino Saved non assomigliava a Slow Train Coming; persino Knocked Out Loaded, che è pure fatto con gli avanzi di Empire Burlesque, in qualche miracoloso modo è già un disco diverso. Per quanto la gente continuasse a pensare a lui principalmente come al menestrello delle foto in bianco e nero, o il rocker d'avanguardia in occhiali scuri - tutti ricordi risalenti ai suoi pochi, primi, lunghissimi anni - Dylan ha combattuto l'accelerazione del tempo con tutte le sue forze, continuando a cambiare pelle a ogni disco. Questo forse per lui era più importante che la qualità - posso capirlo. Immagino che trovare un seguito a The Freewheelin' debba essere dura, ma quando invece hai fatto trenta dischi, è così importante se il trentunesimo è un capolavoro o è inascoltabile? Smetterai di essere il grande Bob Dylan, se capita che sia un brutto disco? E se invece è buono, qualcuno oserà metterlo sullo stesso piano di Blonde On Blonde e di quei dischi che hai inciso in fretta e quasi per caso da giovane, quando gli anni non finivano mai e succedeva qualcosa di diverso tutti i giorni?

Modern Times è il 32esimo disco di studio di Bob Dylan, e com'è? È buono. Buono come "Love and Theft"? Più o meno. Buono come Highway 61? In teoria si potrebbero mettere sullo stesso piano - se potessimo avere un punto di vista fuori dal tempo, e magari tra uno o due secoli un ascoltatore ce l'avrà. Per adesso è come paragonare una stella di media grandezza al big bang. La cosa più notevole è che almeno per una buona metà Modern Times suona quasi identico al precedente, di cui ricalca la struttura (un brano rockabilly, uno swing, di nuovo un rockabilly, ecc.): il che non è poi sorprendente per un tizio che ha già stampato trentadue dischi (i Rolling Stones hanno cominciato a cristallizzarsi trent'anni prima) ma lo è per Dylan. Soprattutto se pensiamo che tra i due dischi ci sono cinque anni: un'eternità.

È lo stesso tempo che separa il suo disco d'esordio da John Wesley Harding. Quante pelli Dylan aveva già cambiato tra 1962 e 1967? Tra 2002 e 2007, Dylan sembra congelato. E invece si stava dando parecchio da fare: nel 2004 pubblica il primo e per ora unico volume della suona biografia, Chronicles I. Nello stesso periodo assiste (per la verità in modo abbastanza distante) alla lavorazione del documentario di Scorsese, No Direction Home; nel frattempo i negozi di dischi vengono riforniti regolarmente di nuove uscite della sua Bootleg Series. Sono insomma anni in cui Dylan sta lavorando molto sul suo passato: lo corregge, in certi casi lo stravolge, inserisce dettagli che mai ci saremmo aspettati... ad esempio scopriamo con Chronicles che a lui i grandi standard jazz sono sempre piaciuti, e che quando nel 1970 tutti lo aspettavano sulle barricate, lui andava con Sara a sentire un concerto di Sinatra Jr. Ma non è sempre stato così con lui? Quando passò al rock, non si premurò di informarci che aveva sempre sognato di suonare il rock? E il country? Non era la musica che aveva sempre sognato di fare prima di riuscirci con Nashville Skyline? Dylan è sempre fedele al suo passato, che però può modificare quando e come vuole.

Accanto a questa incessante opera di revisionismo storico, c'è una vita quotidiana fatta soprattutto di concerti: più o meno ottanta all'anno, in Europa, Asia e soprattutto America. Forse Dylan ha avuto un'idea migliore della mia: quando ha capito che fare un disco all'anno non avrebbe fermato il tempo, ha deciso di svegliarsi ogni mattina in un albergo diverso. Magari il Tour Infinito è il suo modo di fermare l'istante. Che dire: beato lui. In albergo, tra una data e l'altra, trova anche il tempo di registrare il suo "Theme Time Radio Hour", un programma radiofonico che comincerà nel 2006 e andrà avanti fino al 2009. Un'ora di trasmissione, una dozzina di vecchie canzoni collegate dallo stesso argomento, e tra un pezzo e l'altro la voce di Dylan che si atteggia a vecchio dj notturno - quel caldo timbro sussurrato delle vecchie FM (continua sul Post)
Dylan ama, Dylan ruba
26-11-2017, 04:00Bob Dylan, Il Post, musicaPermalinkQuesti cosiddetti esperti della musica di Bob Dylan... Non credo che ne sappiano nulla, che abbiano la minima idea di chi sono e cosa rappresento. Lo so che credono di avercela, il che è ridicolo, esilarante e triste. Il fatto che gente del genere abbia passato così tanto tempo pensando... a chi? A me? Fatevi una vita, per favore. Nessuno dovrebbe pensare così tanto a qualcun altro. Non state onorando la vostra vita. La state buttando via (Dylan nel 2001 al Times, a proposito di me).
Il nuovo secolo avrebbe dovuto portarci i telefonini coi tasti più piccoli, Berlusconi di nuovo a palazzo Chigi, e un brutto disco di Dylan. I segni nell'aria c'erano tutti: la gente aveva davvero bisogno di più tasti sui telefoni. Tutti non facevano che messaggiarsi, passavano il tempo a premere anche tre volte un tasto per trovare la lettera giusta (nessuno si fidava del t9, ammesso ci fosse già). Quando non venivano investiti agli incroci erano loro stessi a investire qualcuno, era un'emergenza sociale, i giornalisti erano preoccupatissimi. Quanto a Berlusconi, beh, il suo principale contendente era Rutelli. La vittoria del Polo della Libertà era data per inevitabile, e anche Dylan probabilmente stava per uscire con un brutto disco. Anche solo per una questione di statistica. Berlusconi vince un'elezione su due, Dylan ha mai fatto tre dischi belli di fila? Il dylanita alla soglia del 21esimo secolo ormai lo sapeva: ogni capolavoro ha un suo prezzo. Se il prezzo di Oh Mercy era stato Under the Red Sky, cosa potevamo aspettarci dopo Time Out of Mind? I segni dell'imminente catastrofe c'erano tutti. Aggiungi questa circostanza inquietante: non si trovava più nessuno in giro disposto a parlare male di Bob Dylan. Time Out, col suo Grammy per il Miglior Disco, aveva segnato il discrimine da "solito stronzo" a "venerato maestro". Improvvisamente stava simpatico a tutti. Quando Curtis Hanson, il regista di LA Confidential, gli chiede una canzone per il suo nuovo film, Dylan non si fa pregare e offre un brano pregevole, Things Have Changed, in cui gioca col suo personaggio con una disinvoltura inedita per lui (se il ritornello è davvero un disincantato riferimento a The Times They Are-A Changin'):
La gente è matta, i tempi son strani,
io sto fuori dal giro, ho legate le mani:
una volta mi sarei preoccupato,
ma è tutto cambiato.
Con Things Have Changed Bob Dylan vince l'Oscar per la miglior canzone. Se lo meritava? In lizza c'era anche Björk, era l'anno di Dancer in the Dark. Può anche darsi che il 2000 non avesse niente di meglio da offrire, ma fa un certo effetto pensare che i giurati dell'Academy trent'anni prima non avessero notato Knockin' on Heaven's Door - non dico una statuetta, ma almeno una nomination. È che nel 2000 Dylan, senza sforzo apparente, è diventato molto più premiabile. Ormai è un'icona al di sopra delle polemiche: sfoggiarlo in salotto fa fine e non impegna. A questo punto servirebbe proprio un disco brutto - anzi no, qualcosa di peggio. Qualcosa che, nelle mani di Dylan, fosse una garanzia di disastro: un film.
E infatti ecco il film - anche a questo il dylanita è ormai rassegnato: quando le cose cominciano ad andare troppo bene, di solito Dylan fa un passo più lungo della gamba che spesso si traduce in un film (o un aborto di). Ai tempi di Blonde on Blonde stava cercando di montare Eat the Document (non c'è mai riuscito); la Rolling Thunder Revue terminò col botto di Renaldo and Clara; il primo millennio di Dylan termina con Masked And Anonymous, un film scritto da Dylan in collaborazione con Larry Charles, al suo debutto dietro la macchina da presa. Charles era uno degli autori di Seinfeld: in seguito avrebbe firmato i film di Sacha Baron Cohen. Masked non è purtroppo il film divertente che avremmo potuto aspettarci da lui. Si capisce che Dylan ci ha lavorato davvero - ogni personaggio, più che dialogare, sembra intonare un monologo, attaccare una strofa. Qualsiasi tentativo di alleggerire i contenuti è demandato ai membri dell'incredibile cast: Jeff Bridges (Dylan lo minaccia spaccando una bottiglia di Jack Daniels), Penelope Cruz, John Goodman (sempre il migliore), Jessica Lange, Luke Wilson, Val Kilmer (a un certo punto si dimentica la parte ma Charles continua a girare), Chris Penn, Mickey Rourke, Christian Slater, e ne ho senz'altro dimenticati. Tutta gente che recita al minimo sindacale o quasi, per la gloria di stare sul set col grande Bob Dylan. Quindici anni prima sarebbe stato impensabile. Quel che ricordo meglio di Masked è l'ambientazione caotica, un set che sembra ricavato all'ultimo momento nella periferia di una guerra civile. Se non siamo nel Terzo Mondo, stiamo per entrarci. Bob Dylan è Jack Fate, un burbero cantautore che un tempo era un mito (sì, lo stesso personaggio di Hearts of Fire) che si ritrova senza sapere bene perché sul palco di un equivoco concerto di beneficenza ("Se vuoi far venire un cantante, gli devi dare una Causa o un Premio", dice l'impresaria Jessica Lange). La storia è un pretesto per contemplare un mondo devastato e dispensare qualche massima di saggezza; c'è anche il tempo per cantare un paio di canzoni con la sua band, ma la maggior parte della colonna sonora è composta da cover dei suoi brani anche in lingue straniere, tra cui una memorabile My Back Pages in giapponese, mentre il contingente dylanita italiano è rappresentato da ben due brani. Uno è di De Gregori, e non sorprende, l'altro è Come una pietra scalciata degli Articolo 31, e sorprende eccome.
Il Dylan dei primi Duemila, tra Things Have Changed e Masked And Anonymous, sembra ormai vivere in una bolla autoreferenziale: tutti gli vogliono bene purché lui continui a interpretare sé stesso, e per una volta lui sembra non volerli deludere. Con Masked si cristallizza anche l'immagine del "vecchio Dylan", che sul set del video di Things si aggirava ancora un po' smarrito mentre ora sembra disegnato a tavolino da un team di stylist molto attenti a valorizzare il brand: il cappello Stanton e i baffetti sottili devono diventare rapidamente dettagli iconici, come la bombetta e il baffo di Chaplin. È lo stesso Dylan che ci guarda intenso dalla copertina del nuovo disco (ancora un bianco e nero vintage) che compare finalmente nei negozi nel giorno meno adatto al mondo, l'undici settembre 2001. Immaginatevi i crocchi di gente nei multistore che guardano le Twin Towers crollare in diretta sui primi maxischermi piatti. I dylaniti aggirano la folla, sovrappensiero: devono comprare il nuovo cd, e chissà che ciofeca sarà. Stavolta non c'è scampo - ormai son più di dieci anni che non fa un disco davvero brutto, stavolta dev'essere la volta. Per dire, chi è il produttore? Jack Frost? Jack chi?
Jack Frost, nel folklore anglosassone, è una specie di folletto della brina, l'entità invernale che disegna cristalli alle finestre. Dylan ha già cominciato a usare questo pseudonimo negli anni Ottanta, ogni qualvolta si è assunto l'onere di produttore - mai da solo però. Bob Dylan, si sa, non è capace di prodursi da solo. A malapena riesce a riascoltarsi. Bob Dylan, meno tempo passa in sala di registrazione, meglio è. Bob Dylan ha bisogno di qualcuno che lo segua passo passo. Bob Dylan è il peggior critico di sé stesso: un disco prodotto da Dylan/Frost non può che essere una catastrofe. E ora che lo sappiamo, coraggio, ascoltiamo "Love and Theft".
E scopriamo che è uno dei più bei dischi di Bob Dylan.
(Non sto scherzando stavolta).
Tweedle-dee Dum and Tweedle-dee Dee,
they’re throwing knives into the tree.
Two big bags of dead man’s bones,
got their noses to the grindstones...
(Continua sul Post)
Dylan senza Penelope
18-11-2017, 22:01Bob Dylan, Il Post, musicaPermalink***
"Certe cose nella vita è troppo tardi per impararle" (Highlands).
***
 Così entro in un ristorante, e indovina chi mi trovo davanti: la donna della mia vita. Cioè, di una. Delle mie donne. Delle mie vite.
Così entro in un ristorante, e indovina chi mi trovo davanti: la donna della mia vita. Cioè, di una. Delle mie donne. Delle mie vite.***
Caro lettore, se mi hai seguito fin qui (e complimenti), sai più o meno cosa ci aspetta. Dopo un lunghissimo viaggio in un arcipelago di mostri e batterie elettroniche, il nostro Eroe è finalmente pronto per tornare a casa. In realtà è già lì da due o tre dischi, prudentemente travestito da anziano bluesman. Solo i cani e la nutrice l'hanno riconosciuto: lui si aggira tra le colonne e i jukebox che un tempo erano suoi, a stento tollerato dagli altri ospiti del palazzo, che non sanno di mangiare e bere a sue spese. Ma ora è tempo che si riveli. Il servo Lanois è già stato istruito; le porte del palazzo sono state sprangate, le armi nascoste; ora il nostro Eroe con una scusa si farà consegnare una chitarra, e non ce ne sarà più per nessuno. Bob Dylan, il vero Bob Dylan è tornato. Ci ha messo parecchio ad arrivare - a proposito, quanto? se consideriamo il 1975 di Blood on the Tracks e Desire, beh, ha già superato il record di 20 anni di Ulisse; a volte sembrava quasi arrivato, ma poi una tempesta o un Dio lo risospingevano lontano. Stavolta è qui davvero, e non fa prigionieri.
Anche ai Grammy, una strage. Disco dell'anno. Migliore performance vocale. Migliore album di folk contemporaneo. Non era mai successo - ma nel '97 è quasi un atto dovuto, è un onore più per i Grammy che per Bob Dylan. I critici sono prostrati a terra, supplicano pietà, chiedono perdono per aver dubitato anche solo per un istante del ritorno. Qualcuno nell'ombra singhiozza commosso o disperato, qualcun altro grida senza tradire incertezza: "è il disco migliore che Egli abbia mai composto!" Seh, vabbe', il solito esagerato, chi sarà? Ah, però, Elvis Costello.
This kind of love I’m so sick of it
Caro lettore, non so perché ti ho preso in giro così a lungo. Riflettendoci, in effetti, a me Dylan neanche piace. Forse avrei dovuto accorgermene prima, che ne dici? Da molti mesi lo inseguo in lungo e in largo per vent'anni di dischi, incontrando soltanto gente che mi raccontava quanto fosse fuori forma, quanto si stesse buttando via - tutta un'odissea di rimpianto per le belle cose che avrebbe potuto darci dal '75 in poi, invece di registrare in fretta e a caso. La prova di tutto questo è che quando Dylan si è fermato, quando ha deciso di imparare davvero come si registra un disco, improvvisamente si è rimesso a sfornarne di straordinari. Su poche cose i critici sono d'accordo come sul fatto che Times Out of Mind sia l'inizio di una serie positiva quasi miracolosa, per un tizio che in teoria aveva già fatto tre o quattro Grandi Ritorni ma non era mai ritornato davvero. Stavolta sì. Lo capisci anche solo dai primi versi di Love Sick. Stavolta sa cosa sta facendo. Stavolta non ha bisogno di nessuna scusa, nessun Gesù, nessuna apocalisse, nessun matrimonio da salvare, nessuna campagna politica, nessun fatto di cronaca; stavolta è solo davanti al grande vuoto che si trova davanti, il posto dove sta per ritrovarsi. Stavolta è davvero Bob Dylan. Il grande Bob Dylan, e quindi?
E quindi, beh... è un po' noioso.
Sì, lo so, scusami.
I’m sick of love; I wish I’d never met you
I’m sick of love; I’m trying to forget you

No, no, hai ragione, non c'è nessuna scusa possibile, però... ti ricordi quei dischi strampalati degli anni Ottanta, che ne so, Empire Burlesque? Ogni canzone era un esperimento, un mostro nato male e arrangiato peggio, però... almeno erano tutte diverse tra loro, come le avventure di Ulisse nel mare sconosciuto. Invece adesso beh, è tutto molto più consapevole, molto più definito, nei minimi dettagli. È tutto molto compatto - addirittura ogni canzone gira intorno allo stesso argomento. È decisamente un disco di atmosfera: lo metti su e dopo un po' non sai nemmeno più che canzone stai ascoltando - con qualche studiata eccezione, tendono deliberatamente ad assomigliarsi. Dylan per molti anni non si è minimamente preoccupato dell'atmosfera; quando ogni tanto ne azzeccava una (Lay Lady Lay) era per puro caso. Ma a questo punto della vita, se ti rimetti a lavorare con Daniel Lanois non lo fai per caso.
Dylan gli aveva fatto sentire i demo in una stanza d'albergo a New York (stavolta Dylan aveva perfino fatto i demo!) Lanois ovviamente li aveva trovati disperati e fantastici; Lanois racconterà al pubblico dei Grammy di aver esclamato "Questo è il disco che voglio fare", ma non è che avesse molta scelta - nel 1997 la sua stella stava declinando più in fretta di quella di Dylan. Persino gli U2 lo avevano temporaneamente accantonato, ora lavoravano con Howie B. Dall'Europa stava arrivando una valanga di musica sempre più campionata e sintetica, in America ormai l'hip-hop regnava egemone, in una situazione del genere se Bob Dylan ti fa sentire un demo non è che ti metti fare il difficile. Lo stesso Lanois sentiva lo spirito dei tempi, manovrava ormai le manopole come un dj techno; pretendeva di registrare un disco folk come se fosse dub, mixando 64 e più piste, tre sezioni ritmiche, due slide guitar, cercando il modo più artefatto per ottenere un sound apparentemente caldo e umano. Ovviamente litigarono sui musicisti, sulle sale di registrazione, sugli arrangiamenti; ovviamente ogni tanto Dylan scappava in motocicletta e Lanois forse spaccò qualche altra chitarra. Ma entrambi lo sapevano già prima di iniziare.
 Il risultato è un'opera di indubbio fascino verso la quale nutro sentimenti contrastanti - come quando restaurano un affresco medievale con colori così vivi che non sembra più medievale. È come osservare un laboratorio in cui padron Dylan grida: voglio essere spontaneo! più spontaneità perdio! mentre il professor Lanois armeggia intorno alle provette, perché si dà il caso che la spontaneità sia una formula molto complicata. Qua e là ovviamente la manopola gli prende la mano, e Love Sick da questo punto di vista non è il biglietto da visita migliore: l'idea di passare nel compressore la voce, di distorcerla come uno strumento... è un'idea coraggiosa, se non proprio avventata, che pone un ultimatum all'ascoltatore: questo è il nuovo Dylan, prendere o lasciare. In realtà altri brani di Time sono registrati molto più alla buona, come al solito, ma la prima impressione è importante, ed è quella che lasciano la voce compressa e l'organo tremolante di Love Sick. Nel laboratorio Lanois ha scoperto la formula del viaggio nel tempo, e se ci sembra falso è perché l'illusione è troppo palpabile per essere reale - il passato non è mai suonato così bene. Gli anni Cinquanta pre-elvisiani non sono più una semplice terra della nostalgia: ormai sono un'età dell'oro, un mito olimpico che forse vive ancora al di sopra delle nuvole. Mentre promuoveva Time Out of Mind, a Dylan più volte è capitato di parlare di Buddy Holly come un devoto parla di un santo; diceva che in quel periodo s'imbatteva dappertutto nelle sue canzoni - in taxi, in ascensore, e che questo era senz'altro un segno, una benedizione. Fino a pochi anni prima sarebbe stato impossibile pensare di santificare un personaggio come Buddy Holly. Poco tempo prima, dopo avere rischiato la vita per un'istoplasmosi, Dylan aveva dichiarato: "Stavolta pensavo che avrei davvero visto Elvis". Qualche anno prima avrebbe detto Gesù, ora il paradiso è un luogo interessante perché c'è Elvis.
Il risultato è un'opera di indubbio fascino verso la quale nutro sentimenti contrastanti - come quando restaurano un affresco medievale con colori così vivi che non sembra più medievale. È come osservare un laboratorio in cui padron Dylan grida: voglio essere spontaneo! più spontaneità perdio! mentre il professor Lanois armeggia intorno alle provette, perché si dà il caso che la spontaneità sia una formula molto complicata. Qua e là ovviamente la manopola gli prende la mano, e Love Sick da questo punto di vista non è il biglietto da visita migliore: l'idea di passare nel compressore la voce, di distorcerla come uno strumento... è un'idea coraggiosa, se non proprio avventata, che pone un ultimatum all'ascoltatore: questo è il nuovo Dylan, prendere o lasciare. In realtà altri brani di Time sono registrati molto più alla buona, come al solito, ma la prima impressione è importante, ed è quella che lasciano la voce compressa e l'organo tremolante di Love Sick. Nel laboratorio Lanois ha scoperto la formula del viaggio nel tempo, e se ci sembra falso è perché l'illusione è troppo palpabile per essere reale - il passato non è mai suonato così bene. Gli anni Cinquanta pre-elvisiani non sono più una semplice terra della nostalgia: ormai sono un'età dell'oro, un mito olimpico che forse vive ancora al di sopra delle nuvole. Mentre promuoveva Time Out of Mind, a Dylan più volte è capitato di parlare di Buddy Holly come un devoto parla di un santo; diceva che in quel periodo s'imbatteva dappertutto nelle sue canzoni - in taxi, in ascensore, e che questo era senz'altro un segno, una benedizione. Fino a pochi anni prima sarebbe stato impossibile pensare di santificare un personaggio come Buddy Holly. Poco tempo prima, dopo avere rischiato la vita per un'istoplasmosi, Dylan aveva dichiarato: "Stavolta pensavo che avrei davvero visto Elvis". Qualche anno prima avrebbe detto Gesù, ora il paradiso è un luogo interessante perché c'è Elvis.Gon’ walk on down that dirt road ’til I’m right beside the sun
Gon’ walk on down until I’m right beside the sun
I’m gonna have to put up a barrier to keep myself away from everyone
Il secondo brano, Dirt Road Blues, è il collaudo della Macchina del Tempo di Lanois: cosa gli manca per sembrare un vero blues del Delta, recuperato in un vecchio disco in soffitta? Forse avrebbe dovuto aggiungere al mix il crepitìo del vinile, come i Massive Attack in Teardrop l'anno dopo. Per alcuni critici era il brano più debole (il secondo in scaletta molto spesso lo è): nel 1997 non potevano sapere che Dirt Road Blues di tutti i pezzi era quello che guardava più lontano, non solo nel passato ma anche nel futuro - che poi per Dylan sono ormai la stessa cosa: il passo successivo a Time Out of Mind sarebbe stata un'immersione ancora più profonda nel blues ancestrale.
 I’m strumming on my gay guitar, smoking a cheap cigar
I’m strumming on my gay guitar, smoking a cheap cigarThe ghost of our old love has not gone away
Don’t look like it will anytime soon...
Standing in the Doorway mette a fuoco il tema ossessivo del disco: la solitudine e il rimpianto per una donna che, per quanto possa suonare assurdo a chi conosce la biografia di Dylan, è "the one", l'Unica. Nemmeno ai tempi del Marito Coccolone, Dylan aveva mai scritto un intero disco dedicato a una donna sola - persino in Nashville Skyline Sara era una presenza meno asfissiante. E in nessun disco di Dylan questa donna è così lontana, "a mille miglia"; nessun disco come Time dà la sensazione che le recriminazioni amorose di Dylan stiano cadendo in un vuoto siderale; puoi vendere tutti i dischi che vuoi (un milione solo negli USA), e convincere tutti i negozianti che sei tornato in forma e degno di stare al centro della vetrina. Dentro di te rimani sempre quel pezzente che suona una chitarra da pochi soldi ("Gay guitar", da noi sarebbe una Eko), fumando un toscano puzzolente. Dylan è tornato a casa, ma Penelope se n'è andata da un pezzo.
I’m drifting in and out of dreamless sleep
Throwing all my memories in a ditch so deep
Did so many things I never did intend to do
Well, I’m tryin’ to get closer but I’m still a million miles from you
Million Miles è un blues come ne ha scritti a dozzine, anche nei periodi meno ispirati, salvo che stavolta il professor Lanois ha azzeccato la formula giusta. Adesso è più facile anche tornare indietro, ai periodi più confusi, e capire cosa stava cercando Dylan quando si era intestardito a recuperare per esempio il rockabilly in Down in the Groove. Ci si può anche incazzare, pensando a quanti anni ha perso Dylan perché non riusciva a spiegare il tipo di suono che voleva. Ma non era solo colpa sua: paradossalmente, quel tipo di suono "antico" fino a qualche anno prima sarebbe stato molto più complesso da isolare e registrare. Come certi anziani registi che con l'avvento della tecnologia digitale hanno avuto una seconda fioritura artistica, Dylan, quando verso la fine dei Novanta si è rassegnato a tornare in una sala d'incisione, ha scoperto che era diventato un luogo meno complicato per lui. Il che non significa che non ci furono litigi e fughe, ma qualcosa effettivamente stava tornando a essere più facile. Addirittura, quando si passò al missaggio, Dylan continuò a frequentare lo studio. Reincise varie tracce, guardava i tecnici lavorare, si faceva spiegare le cose. Nessuno poteva immaginarlo, ma stava prendendo forma Jack Frost, l'alter-ego produttore che dal 1998 prenderà il controllo assoluto di ogni registrazione di BD. Un Dylan davvero produttore di sé stesso, che si riascolta in cuffia finché non è contento, fino a pochi anni prima sarebbe stato impensabile. Certo, aveva anche smesso di bere.
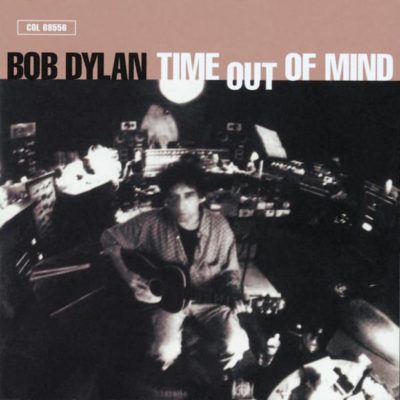
When I was in Missouri, they would not let me be
I had to leave there in a hurry, I only saw what they let me see
You broke a heart that loved you
Now you can seal up the book and not write anymore
I’ve been walking that lonesome valley
Trying to get to heaven before they close the door
Si fece persino fotografare da Lanois - la copertina di Time Out of Mind è l'unica in cui Dylan è ritratto in una sala di registrazione (la cantina della versione 1974 di The Basement Tapes è più fiaba che realtà). Il testo di Tryin' to Get to Heaven è forse la miglior sintesi del disco: l'autoritratto di un uomo solo, perennemente in viaggio (Dylan continuava a macinare i suoi cento concerti all'anno), ovunque inseguito da ricordi e rimpianti. Subito dopo arriva 'Till I Fell in Love with You, l'ennesimo blues sotterraneo, arrangiato benissimo ma... era così necessario? Il miglior disco di Bob Dylan, Mr Costello, ma siamo sicuri? (continua sul Post)
Dylan stacca la spina?
11-11-2017, 02:53Bob Dylan, concerti, Il Post, musica, tvPermalink | |
| I grafici degli anni '90, sul serio, parliamone. |
Magari negli anni Novanta non c'eravate. Troppo piccoli. Ci spero (qui se non comincio a farmi leggere dai millenials tra un po' è finita). Nel vostro caso, immagino che sia facile affrontare MTV Unplugged con un forte pregiudizio negativo - l'ennesimo tentativo del Dylansauro di adattarsi ai tempi che cambiano, ai nuovi mercati, a un pubblico giovane che pretendeva di ascoltare la musica in televisione, epperò alla resa dei conti pretendeva anche le solite lagne che lo stesso BD si era stancato di suonare 20 anni prima: sul serio, chi aveva davvero bisogno di una nuova versione di All Along the Watchtower? C'era in Before the Flood, c'era in Budokan, nel disco coi Dead, ed eccola anche qui. Già. Unplugged è uno dei dischi che soffre di più del metodo che abbiamo deciso di adottare: non è un cattivo live, ma se lo ascolti durante una full immersion cronologica, ti può ispirare una certa nausea - ancora Like a Rolling Stone, sul serio? E poi che copertina brutta, che camicia assurda, che titolo poco invitante - se negli anni Novanta eravate troppo piccoli, è probabile che la sigla "MTV" vi faccia pensare, più che alla musica, ai manga e a telefilm per bimbominchia. In effetti. Ma non è stato sempre così, lo sapete? Che all'inizio la "M" di MTV stava per "musica"? E che dopo aver conquistato il cuore e l'immaginazione dei ragazzini degli anni Ottanta, nel decennio successivo MTV aveva trasceso le generazioni e i target, diventando semplicemente il luogo dove tutta la musica succedeva? Che senza MTV Britney Spears magari avrebbe avuto una dignitosa carriera post-Disney, ma i Nirvana difficilmente sarebbero usciti da Seattle? E che uno degli strumenti con cui MTV aveva costruito la sua egemonia era proprio una trasmissione in cui i divi di due generazioni si alternavano a suonare i loro successi davanti a un pubblico ristretto, con una strumentazione ridotta? Una situazione ideale per la seconda serata televisiva, un modo per trasformare anche il rock più chiassoso in qualcosa di più intimo, rassicurante. Si chiamava "Unplugged", in italiano si potrebbe tradurre "A spina staccata", e Dylan non avrebbe potuto non inciderne uno. Sarebbe stato impossibile.
 Sarebbe stato anche molto ingiusto - in fondo, cos'è "unplugged" se non un set acustico? E chi ha inventato i set acustici? Chi è stato il primo a portare al pubblico perplesso non soltanto versioni elettriche dei suoi successi folk, ma anche l'opposto: riletture acustiche dei brani che aveva inciso con una band? Già ai tempi del tour del '66, quando saliva sul palco da solo per suonare Visions of Johanna e Just Like a Woman, stava suonando quello che negli anni '90 ci eravamo tutti messi a definire un "unplugged". Insomma non era Dylan ad accostarsi a MTV: era MTV che stava cominciando a capire Dylan. E poi c'era il precedente di Eric Clapton.
Sarebbe stato anche molto ingiusto - in fondo, cos'è "unplugged" se non un set acustico? E chi ha inventato i set acustici? Chi è stato il primo a portare al pubblico perplesso non soltanto versioni elettriche dei suoi successi folk, ma anche l'opposto: riletture acustiche dei brani che aveva inciso con una band? Già ai tempi del tour del '66, quando saliva sul palco da solo per suonare Visions of Johanna e Just Like a Woman, stava suonando quello che negli anni '90 ci eravamo tutti messi a definire un "unplugged". Insomma non era Dylan ad accostarsi a MTV: era MTV che stava cominciando a capire Dylan. E poi c'era il precedente di Eric Clapton."Tutti mi parlavano di come Eric Clapton aveva rifatto Layla in stile acustico per Unplugged. Questo mi ha influenzato a fare la stessa cosa con Like a Rolling Stone, ma non sarebbe mai stata suonata così normalmente".
Due anni prima, Clapton aveva partecipato a MTV Unplugged con un set di un'ora - tra i pezzi suonati, l'ancora inedita Tears in Heaven e una Layla addomesticata: l'urlo d'amore primordiale trasformato in uno swing elegante per ascoltatori di mezza età. Una volta messo su CD, il concerto aveva ottenuto qualche tiepida recensione e venduto VENTISEI MILIONI DI COPIE. È tuttora il live più venduto di tutti i tempi - a questo punto possiamo serenamente concludere che sarà il disco live più venduto della storia dell'uomo. Questo credo che sia sufficiente a spiegare perché quelle due sere di novembre, a New York, la Columbia non permise a Dylan di suonare quel che voleva, un set magari davvero acustico di cover di vecchi brani folk: il risultato sarebbe stato il terzo volume di una trilogia inaugurata con Good As I Been to You e proseguita con World Gone Wrong, con ogni probabilità un disco più interessante, ma nel '95 sarebbe stato un errore quasi criminale.
 Unplugged era la trasmissione musicale più seguita al mondo e Dylan non poteva rinunciare all'opportunità che gli offriva. Quella sera gli bastava suonare a volume non troppo alto i suoi migliori successi, sorridere ogni tanto al pubblico selezionato dalla Sony/BMG/Columbia, e vendere anche solo la metà di Clapton, per ottenere il suo più grande successo commerciale. Il suo Unplugged alla fine incassò molto meno, ma comunque più qualsiasi disco inciso dopo i Traveling Wilburys. Però, siamo onesti: non ci mise l'anima. Forse proprio perché il concetto della trasmissione si adattava molto di più a lui che a Clapton o ai Nirvana: per loro si trattava di rimettere in discussione strumentazioni e arrangiamenti, per Dylan era solo un set come tanti. È difficile capire, per esempio, cosa volesse ottenere con questa Like a Rolling Stone, e in che modo pensava che potesse rappresentare quel che era stata per Clapton la Layla swing del '93. Non c'è niente di swing nel modo in cui Dylan rilegge per l'ennesima volta il suo cavallo di battaglia: quel che si può dire è che è molto più rilassato del solito (forse la versione incisa a cui somiglia di più è quella all'isola di Wight), e che proprio in virtù di questa rilassatezza, il brano non finisce mai. Nove interminabili minuti. Persino Desolation Row scorre più velocemente. Poi davvero, magari a questo punto della storia sono stanco io - anche Tombstone Blues mi sembra di averla sentita cento volte, e invece è la prima versione live ufficiale. Sarà autosuggestione, ma le cose nettamente migliori di Unplugged mi sembrano gli inediti: soprattutto John Brown, che abbiamo ascoltato già al Gaslight e nei Witmark Demos, ma nel 1995 era un brano noto solo ai dylaniti più estremi. Dylan la canta con una foga e una convinzione che non mi sembra di trovare nei pezzi più famosi. Ci potrebbe essere una spiegazione vagamente politica: durante la prima guerra del Golfo (1991) Dylan aveva ripreso in concerto con una nuova convinzione alcuni dei suoi inni pacifisti: soprattutto Masters of War, di cui aveva dato una versione sguaiatissima, più-che-punk, proprio la sera di quel febbraio '91 in cui lo premiavano con il Grammy alla carriera: lo stesso brano che al concerto del trentesimo anniversario era stato rabbiosamente rivendicato dai Pearl Jam (continua sul Post).
Unplugged era la trasmissione musicale più seguita al mondo e Dylan non poteva rinunciare all'opportunità che gli offriva. Quella sera gli bastava suonare a volume non troppo alto i suoi migliori successi, sorridere ogni tanto al pubblico selezionato dalla Sony/BMG/Columbia, e vendere anche solo la metà di Clapton, per ottenere il suo più grande successo commerciale. Il suo Unplugged alla fine incassò molto meno, ma comunque più qualsiasi disco inciso dopo i Traveling Wilburys. Però, siamo onesti: non ci mise l'anima. Forse proprio perché il concetto della trasmissione si adattava molto di più a lui che a Clapton o ai Nirvana: per loro si trattava di rimettere in discussione strumentazioni e arrangiamenti, per Dylan era solo un set come tanti. È difficile capire, per esempio, cosa volesse ottenere con questa Like a Rolling Stone, e in che modo pensava che potesse rappresentare quel che era stata per Clapton la Layla swing del '93. Non c'è niente di swing nel modo in cui Dylan rilegge per l'ennesima volta il suo cavallo di battaglia: quel che si può dire è che è molto più rilassato del solito (forse la versione incisa a cui somiglia di più è quella all'isola di Wight), e che proprio in virtù di questa rilassatezza, il brano non finisce mai. Nove interminabili minuti. Persino Desolation Row scorre più velocemente. Poi davvero, magari a questo punto della storia sono stanco io - anche Tombstone Blues mi sembra di averla sentita cento volte, e invece è la prima versione live ufficiale. Sarà autosuggestione, ma le cose nettamente migliori di Unplugged mi sembrano gli inediti: soprattutto John Brown, che abbiamo ascoltato già al Gaslight e nei Witmark Demos, ma nel 1995 era un brano noto solo ai dylaniti più estremi. Dylan la canta con una foga e una convinzione che non mi sembra di trovare nei pezzi più famosi. Ci potrebbe essere una spiegazione vagamente politica: durante la prima guerra del Golfo (1991) Dylan aveva ripreso in concerto con una nuova convinzione alcuni dei suoi inni pacifisti: soprattutto Masters of War, di cui aveva dato una versione sguaiatissima, più-che-punk, proprio la sera di quel febbraio '91 in cui lo premiavano con il Grammy alla carriera: lo stesso brano che al concerto del trentesimo anniversario era stato rabbiosamente rivendicato dai Pearl Jam (continua sul Post).Nessuno canta il blues come Bob D.
05-11-2017, 12:24Bob Dylan, Il Post, musicaPermalinkSuccedono cose strane, mai successe prima:
la mia donna mi ha detto che me ne dovrò andare.
Non posso più essere buono con te,
buono come ero prima,
non posso più essere buono, amore,
tutto perché il mondo è andato a puttane.
Ci sono canzoni che cantiamo e canzoni da cui siamo cantati. Dylan ha scritto tante belle canzoni, e molte è anche riuscito a inciderle in modo soddisfacente. E poi ci sono quelle che non ha scritto lui; quelle che ha inciso alla svelta, quasi per liberarsene (Dylan non ha mai suonato World Gone Wrong dal vivo). All'orecchio inesperto sembrano brani come gli altri, magari un po' più legnosi, vecchi blues oscuri, curiosità da folklorista. Finché un giorno non ti trovi a canticchiare sconsolato: "All the friends I ever had are gone". E ti rendi conto che era dentro di te da prima che l'ascoltassi, e che non se ne andrà mai: forse dovresti fare come Dylan, trovare un nastro libero e inciderla. Magari a quel punto ti lascerà in pace. Strane cose succedono.
Ti ho detto amore, davanti a Dio,
se non ti lascio, dovrò ammazzarti io
Non posso più essere buono...
A voi non è successo? tanto meglio per voi. C'è chi dice che un bianco non può capire il blues; non è mica una cosa che s'impara sui libri. In effetti. E meglio così, sul serio: non vi auguro di ritrovarvi un giorno in qualche corridoio chiuso dove decidono il vostro destino senza chiedervi un parere, o in ginocchio davanti a qualche macchinario che state rimontando nella certezza che comunque non funzionerà mai più: non vi auguro di ritrovarvi tra le labbra quelle parole spontanee, stonate: I can't be good no more. Su quel treno c'è una persona che fa finta di non vedervi. Once like I did before. Suona il telefono, c'è una persona che non potete fingere di non conoscere. I can't be good baby. Non doveva andare così, ma è un fatto: è andato tutto a puttane. Questo è il blues. Perlomeno, quello che ho capito io. Non subito.
 All'inizio pensavo che fosse quella cosa che succede se suoni un riff, lo ripeti sulla corda più bassa e poi su quella alta. Una cosa spontanea, ovvia, come l'abc o il do-re-mi. Che avesse a che fare con la tristezza era una cosa che avevo letto in giro, e ovviamente mi fidavo (al tempo credevamo a tutto quel poco che riuscivamo a leggere in giro), ma non è che lo capissi realmente. Anche perché, alla fine, chi è che cantava il blues ai miei tempi? I Blues Brothers? Non erano tristi. E quando alla fine misi le mani sulle registrazioni complete di Robert Johnson - perché ero uno che voleva fare le cose per bene, persino un po' scolastico, no? In quel negozio c'era una montagna di Nevermind dei Nirvana, diciamo pure una piramide di Nevermind dei Nirvana, era quasi impossibile uscire da lì senza avere in tasca un Nevermind dei Nirvana, ma io dovevo farmi una cultura, e quindi uscii con le registrazioni complete di Robert Johnson - e scoprii che in effetti Sweet Home Chicago non era il pezzo allegrone dei Blues Brothers: ma riuscii a capire perché mentre lo cantava Johnson era più triste della morte? Non credo proprio, no. Sapevo gli accordi del blues e sapevo cos'era la tristezza, ma le due cose non le avevo ancora collegate e sarebbe stato meglio così, dopotutto: non ti danno mica una medaglia quando capisci il blues (più probabile che ti stiano per dare cinque anni senza condizionale).
All'inizio pensavo che fosse quella cosa che succede se suoni un riff, lo ripeti sulla corda più bassa e poi su quella alta. Una cosa spontanea, ovvia, come l'abc o il do-re-mi. Che avesse a che fare con la tristezza era una cosa che avevo letto in giro, e ovviamente mi fidavo (al tempo credevamo a tutto quel poco che riuscivamo a leggere in giro), ma non è che lo capissi realmente. Anche perché, alla fine, chi è che cantava il blues ai miei tempi? I Blues Brothers? Non erano tristi. E quando alla fine misi le mani sulle registrazioni complete di Robert Johnson - perché ero uno che voleva fare le cose per bene, persino un po' scolastico, no? In quel negozio c'era una montagna di Nevermind dei Nirvana, diciamo pure una piramide di Nevermind dei Nirvana, era quasi impossibile uscire da lì senza avere in tasca un Nevermind dei Nirvana, ma io dovevo farmi una cultura, e quindi uscii con le registrazioni complete di Robert Johnson - e scoprii che in effetti Sweet Home Chicago non era il pezzo allegrone dei Blues Brothers: ma riuscii a capire perché mentre lo cantava Johnson era più triste della morte? Non credo proprio, no. Sapevo gli accordi del blues e sapevo cos'era la tristezza, ma le due cose non le avevo ancora collegate e sarebbe stato meglio così, dopotutto: non ti danno mica una medaglia quando capisci il blues (più probabile che ti stiano per dare cinque anni senza condizionale). Quello che sto cercando di dire è che quando ti ritrovi nelle ossa World Gone Wrong, non è mai un buon momento. Come minimo hai appena picchiato una persona cara, o qualcosa di ugualmente triste e... squallido. Quello che non ti dicono in nessun libro, è che c'è qualcosa di profondamente squallido nel blues. È il rantolo concesso a chi non ha più santi a cui pregare - ha rubato a tutti gli altari, profanato tutte le vergini e gli resta solo un po' di miseria tra qui e l'inferno. Quello che sto cercando di dire è che forse non è necessario essere di origine africana per capire il blues (oddio, siamo tutti di origine africana se fai qualche passo indietro) ma sicuramente bisogna essere disperati, e con la coscienza cattiva; e anche in quel caso ti serve un maestro: e dove potevi trovarlo, negli anni Novanta, un maestro disperato con la coscienza cattiva? (Continua sul Post).
Quello che sto cercando di dire è che quando ti ritrovi nelle ossa World Gone Wrong, non è mai un buon momento. Come minimo hai appena picchiato una persona cara, o qualcosa di ugualmente triste e... squallido. Quello che non ti dicono in nessun libro, è che c'è qualcosa di profondamente squallido nel blues. È il rantolo concesso a chi non ha più santi a cui pregare - ha rubato a tutti gli altari, profanato tutte le vergini e gli resta solo un po' di miseria tra qui e l'inferno. Quello che sto cercando di dire è che forse non è necessario essere di origine africana per capire il blues (oddio, siamo tutti di origine africana se fai qualche passo indietro) ma sicuramente bisogna essere disperati, e con la coscienza cattiva; e anche in quel caso ti serve un maestro: e dove potevi trovarlo, negli anni Novanta, un maestro disperato con la coscienza cattiva? (Continua sul Post).
Sii buono come Dylan lo è con te
28-10-2017, 20:14Americana, Bob Dylan, Il Post, musicaPermalink(Il disco precedente: The Bootleg Series Vol. 1-3 (Rare and Unreleased)
Il disco successivo: World Gone Wrong).
la terra sua è nel Texas, il suo nome Diamond Joe.
I suoi soldi li tiene in un vaso tempestato di diamanti,
le procedure della legge non gli hanno mai dato problemi.
1. TI PORTERÒ A CHICAGO
un cofanetto di scarti che non ha venduto come Biograph, ma alla fine farà anch'esso il suo mezzo milione di copie. Insomma gli affari vanno abbastanza bene, senza bisogno di comporre strofe e ritornelli di cui nessuno sente veramente il bisogno. Sennonché...
...la Columbia vuole il suo disco di inediti.
Anche nel 1992.
C'è scritto sul contratto.
E va bene, dice Dylan, facciamo 'sta sceneggiata. Verso l'inizio dell'estate chiama un vecchio amico pluristrumentista, David Bromberg, la cui carriera di cantautore dopo gli anni '70 si è rapidamente arenata, al punto che ha aperto uno studio da liutaio; prenotami uno studio a Chicago, voglio fare un disco di cover. Povero Bromberg. Devono tremarti le gambe, quando Dylan ti dice che vuole fare un disco di cover. Pensa ai precedenti. Esperimenti abortiti come Self Portrait. Pasticci come Knocked Out Loaded. Oggetti deprimenti come Down in the Groove. La cosa più saggia, quando Dylan ti chiede di fare un disco di cover, è scappare. Invece Bromberg prenota l'Acme Recording Studio. Chiama un violinista, un mandolinista e tutta la compagnia pizzicante. Registreranno il primo vero disco di cover di Bob Dylan - non il solito pasticcio rovinato dai ripensamenti. Un disco serio, rigoroso. Un bel disco, probabilmente.
Non lo sappiamo.
Deve ancora uscire.
Povero David Bromberg.
Ho preso cavalli da Diamond Joe, ho firmato il suo contratto.
Mi diede una mandria di ronzini così vecchi che non stavano in piedi.
E sono quasi morto di fame, mi ha trattato così male.
Non ho mai tenuto un dollaro dalla paga di Diamond Joe.
(No, in realtà l'ha pagato. Ma la canzone dice così, e in un qualche modo oscuro le canzoni non mentono).
2. IL RITORNO DEL GEMELLO CATTIVO (o era il buono?)
Quando torna a casa sua in California, Dylan ha una sorpresa: qualcuno gli ha forzato la serratura del garage - più che garage è una piccola sala d'incisione, quella dove i Traveling Wilburys appena nati incisero Handle with Care. Non hanno rubato niente, forse un paio di armoniche (o forse le ha perse Dylan: ha sempre fatto casino con le armoniche). In compenso qualcuno ha lasciato qualcosa. Dei nastri. Dylan non ha nemmeno bisogno di ascoltarli per capire chi è stato: il suo gemello è passato di lì. Quello che non è mai diventato famoso, quello che non è mai passato al rock, quello che continua a strimpellare sui marciapiedi del mondo - in teoria ha la sua stessa età, eppure Dylan è felice che non sia morto di qualche forma di vecchiaia anticipata. Si sa che la vita per strada ti consuma. Vabbe', sentiamo questo nastro - mio dio, è quasi un'ora di roba. Un'ora di voce e chitarra, ma come si fa. Nemmeno nel '64 riuscivi a mantenere l'attenzione per così tanto tempo. E poi senti che voce, mamma mia - non sputa più le sue cattiverie come ai tempi di Blood on the Tracks. Adesso gracchia. La sua glottide è una spina, una puntina di giradischi - ma questa canzone la conosco...
Frankie pulled out a pistol, pulled out a forty-four.
Gun went off a rootie-toot-toot and Albert fell on the floor.
He was her man but he done her wrong.
Frankie and Albert, storia di una tizia che uccise il suo uomo fedifrago a fine Ottocento, al tempo in cui la cronaca nera si diffondeva con le ballate - che roba. Così sei tornato alla fase folkloristica, eh, vecchio Ismaele? beh, almeno adesso hai la voce giusta. Ma a chi credi che possano interessare questi brandelli di antichi giornali? Anche la mano è un po' incerta, una volta sapevi suonare meglio. Si vede che hai avuto problemi alle articolazioni, anche tu...
Frankie got down upon her knees, took Albert into her lap.
Started to hug and kiss him, but there was no bringin' him back.
He was her man but he done her wrong.
Va bene, non è malaccio in fondo, sembra... sembra vera. Suonata da un vecchio cantastorie a un crocicchio. Potrei anche piazzarla da qualche parte nel nuovo disco, per spezzare un po' il ritmo. E poi che c'è? Jim Jones che va a marcire nella colonia penale australiana? Inizio Ottocento ormai. Ismael, stai diventando un museo ambulante.
3. STORIA DELLA CULTURA OCCIDENTALE COME SE FOSSE LA DISCOGRAFIA DI BOB DYLAN
Era un giochino che avevamo iniziato da qualche parte - dunque, i primi dischi acustici sarebbero la fase arcaica. Miti, leggende, echi di guerre civili di duemila anni fa. Con Bringing It All Back Home, e la scoperta del rock, entriamo nell'età classica, che ci regala le maggiori soddisfazioni ma dura pochissimo, chi la vive a momenti manco se ne accorge. Col trauma dell'incidente in moto comincia la fase tardoantica, in cui la barbarie progressivamente penetra entro i confini dell'impero - dapprincipio attraverso le registrazioni nelle catacombe di Big Pink, poi con i riti misterici di JWH - ma è con Nashville Skyline che comincia l'Alto Medioevo: dove c'erano testi filosofici e sapienziali ora si fanno feste danzanti in campagna. I secoli bui si protraggono per tutto il 1970 (Self Portrait, Dylan, se volete New Morning può essere l'alba del Basso Medioevo). Rifioriscono i commerci, si ritorna in tour. Blood on the Tracks non può che essere il Rinascimento quattrocentesco (e allora vedi che in Tangled Up in Blue Dylan non aveva sbagliato secolo?), mente Desire è quello maturo e inquieto di inizio Cinquecento, con le sue tensioni mistiche e simbologie egizie. Street Legal è già manierismo, ma nel frattempo sotto le ceneri cova ben altro; con Slow Train Coming ha inizio la rivoluzione puritana. Cadono teste, i bigotti prendono il parlamento, ma Cromwell comincia a diffidare di loro e dopo la sua morte la repubblica ha breve durata. Già da Shot of Love comincia una lenta transizione da un pomposo barocco a un lezioso rococò, con occasionali tentativi neoclassici (ricordiamo che la classicità per Dylan è il rock and roll). Oh Mercy arriva come un fulmine a ciel sereno: è lo Sturm und Drang? il primo romanticismo? Quindi Good As I Been cosa dovrebbe essere? Forse i fratelli Grimm, la seconda generazione dei romantici che comincia a fare ricerche sul campo. Dylan già si era messo sulle loro tracce con le fiabe e le filastrocche di Under the Red Sky. Ora però fa sul serio - o forse è il suo gemello cattivo, meno incline ai compromessi: le canzoni non si scrivono più, è il popolo che le scrive. Il cantante è solo un medium, un tramite. Attraverso le canzoni possiamo sentire il popolo pensare. Captare le sue emozioni, capire cosa lo appassiona e cosa lo indigna. A volte in realtà non captiamo un bel niente: non ci resta che riflettere davanti a un mistero. Dylan per trent'anni ha riempito il mondo di parole: è ora di tacere e lasciarsi riempire dalle parole del popolo (continua sul Post...)
Was in the summer, one early fall, just tryin' to find my little all and all.
Now she's gone, an' I don't worry: Lord, I'm sittin' on top of the world.
Una serie di sogni (rari e irrealizzati)
20-10-2017, 21:54Bob Dylan, Il Post, musicaPermalinkDisco Uno
1. Hard Times in New York Town. Registrato il 22 dicembre del 1961 da Tommy Glover, Hard Times descrive con qualche guizzo in meno la stessa situazione di Talkin' New York, e non è dunque la registrazione più antica di Rare and Unreleased. Ma anche stavolta è il punto esatto da cui Dylan vuole cominciare la sua storia: un vagabondo senza un soldo che prende forma sui marciapiedi di New York, in un inverno in cui chi non si adatta muore. There’s a-mighty many people all millin’ all around / They’ll kick you when you’re up and knock you when you’re down.
2. Il brano più antico invece è He Was a Friend of Mine. Non solo perché è stato registrato un mese prima, durante le sessioni del primo album, ma perché la canzone a quel punto circolava già da decenni: era stata registrata per la prima volta nel 1939. È il più generico lamento per un amico caduto (i Byrds lo useranno per piangere J. F. Kennedy). Quando lo incide (1961), Dylan non ne aveva ancora perso uno. Quando lo pubblica, trent'anni dopo, la lista dei compagni caduti lungo la strada è impressionante. Chi non si adatta muore, appunto: Dylan sa adattarsi. Nel '91 cominciamo a renderci conto che è questo che lo rende unico: il più grande superstite della storia della musica popolare.
3. "Canterò una canzone non molto lunga, su un uomo che di male non fece mai nulla. Di cosa sia morto nessuno lo sa: lo trovarono morto un mattino in città". A differenza che nei Witmark Demos, stavolta Dylan si ricorda tutte le parole. Man on the Street è uno schizzo hillybilly che non avrebbe affatto sfigurato in Bob Dylan - ma appunto a quei tempi non voleva sembrare troppo hillybilly ("we want folksingers here!" I tre brani scartati dal disco d'esordio parlano di morte - Bob Dylan avrebbe potuto essere un disco perfino più lugubre di quanto non sia.
4. No More Auction Block. (Registrato nell'ottobre 1962 al Gaslight cafe). Quando uscì, nel 1991, il primo triplo volume della Bootleg Series, Dylan era convinto che non avrebbe mai più inciso un disco inedito. Non avrebbe più pubblicato una canzone. Ne aveva scritte fin troppe. Avrebbe continuato a suonare concerti in giro per il mondo, ma la sua carriera di compositore era conclusa. Adesso poteva finalmente ammettere che era nata da un equivoco, una mezza truffa: la sua canzone più fortunata, quella che aveva attirato i riflettori su di lui al momento giusto, non era farina del suo sacco. Dylan aveva preso la melodia di Blowin' in the Wind da un vecchio canto di schiavi (l'"auction block" era il masso su cui venivano esposti gli schiavi durante le vendite). Riproposta trent'anni dopo, sembra una vendetta postuma nei confronti di quel giovane folksinger che sembrava non sbagliare un colpo: credete che sia così migliore di me, chiede il vecchio zio? Guardate che non era quel genio che sembrava, anzi, copiava senza ritegno. Rubava melodie agli schiavi.
5. House Carpenter. Un uomo misterioso torna da un lungo viaggio per proporsi a una ragazza che nel frattempo ha sposato un carpentiere ("house carpenter"). L'Uomo insiste, la donna lascia i tre figli e salpa con lui, ma la nave è diretta all'inferno, l'Uomo è il demonio. The Demon Lover è una ballata scozzese che risale almeno al Seicento - forse in principio il Demone era l'ex primo marito, marinaio. Ho letto che in tedesco "house carpenter" suona "Zimmerman". Nel 1991 Dylan era appena tornato sull'argomento, con The Man in the Long Black Coat. Nel 1993 inciderà un intero disco di antiche ballate. Ci stava prendendo gusto.
6. Talkin' Bear Mountain Picnic Massacre Blues. Registrata il 25/4/1962 durante le sessioni di The Freewhelin'. Dylan le preferì un altro talkin' blues, Third World War. Questo è il primo talkin' che ha composto, ed è già sardonico al punto giusto. Da quanto tempo non ascoltavamo un talkin'? O in generale, una canzone di Dylan che facesse un po' ridere? C'è stato un momento terribile in cui Dylan ha smesso del tutto di fare il buffone - tra Blonde On Blonde e l'incidente, direi. In seguito, anche quando ci ha provato (con Self Portrait?), mancava sempre qualcosa; come se avesse perso i tempi comici.
7. Let Me Die in My Footsteps è una delle prime canzoni composte da Dylan, scartata da The Freewheelin' quando il disco era già in stampa: forse per renderlo un po' meno politico dopo che gli avvocati avevano chiesto la rimozione di John Birch. Secondo me è una delle canzoni più importanti del primo Dylan, all'intersezione dei suoi due grandi argomenti sociali: la bomba atomica e i contadini del Midwest. Qui appunto c'è un contadino del Midwest che non vuole entrare in un rifugio antiatomico - un eroe di poche parole che vuole morire sui suoi piedi. I don’t know if I’m smart but I think I can see / When someone is pullin’ the wool over me. And if this war comes and death’s all around... let me die on this land ’fore I die underground (mi fa piangere). (Se nei 40 anni successivi il Midwest avesse avuto un Bob Dylan in più e un telepredicatore in meno, oggi Trump sarebbe un palazzinaro qualsiasi).
8. Rambling, Gambling Willie è un altro dei pezzi scartati all'ultimo momento da The Freewheelin' (si sente anche nei Witmark Demos). Ma mentre Let Me Die nel 1991 sembrava la preistoria di Dylan, Rambling Gambling offre uno sguardo sul suo futuro: un tizio che gira il mondo a bluffare, suscitando incredulità e ammirazione, macinando soldi per i bambini e le ex che a casa hanno smesso di aspettarlo. Un giorno qualcuno lo farà secco al tavolo, ma nel frattempo dimmi se non è una bella vita. And it’s ride, Willie, ride, roll, Willie, roll; wherever you are a-gamblin’ now, nobody really knows.
9. Talkin' Hava Negeilah Blues. Risale forse al periodo pre-Oswald in cui aveva amici che andavano a Cuba di nascosto e la cosa gli sembrava ancora divertente. L'invocazione blasfema "Havana" si trasforma nell'inno ebraico Hava Nagila, orrendamente storpiato da un hipster che dice di averlo "imparato in Utah". Forse sta prendendo in giro i sionisti, forse gli hipster, forse è ubriaco, forse tutte e tre le cose, ma nel frattempo su wiki ho imparato che Hava Negila è stato composto su un'antica melodia ucraina. Anche la famiglia Zimmerman, non veniva da quelle parti? Dylan ha cancellato la vecchia melodia e l'ha rimpiazzata col talkin' blues. Incredibile che si possa raccontare la storia della propria vita anche quando si canticchiano sillabe a caso.
10. Quit Your Low Down Ways. Già sentita nei Witmark Demos. Roba forte, delta blues senza vergogna. Dylan scende all'inferno e s'informa sul prezzo dell'anima di Robert Johnson. Troppo cara.
11. Worried Blues. Brano tradizionale (non è un vero blues) inciso durante le sessioni di The Freewheelin' (9/7/1962). The Bootleg Series 1-3 è la prima antologia di Dylan a rispettare l'ordine cronologico - così bellamente ignorato in Biograph. Quando uscì, sembrava davvero la conclusione di un percorso. Fine della storia, inizio dell'archeologia.
12. Kingsport Town. Un altro brano di riscaldamento dalle sessioni di The Freewheelin', le pene d'amore di un cowboy braccato dalla legge. Sono canzoni semplici, suonate con cura e attenzione: non ci posso fare niente, le trovo più ascoltabili di qualsiasi cosa Dylan abbia tentato negli anni Ottanta. Anche lui forse riascoltandosi potrebbe essere giunto alla medesima conclusione: ma se mi rimettessi a registrare canzoni altrui con chitarra e armonica?
13. Walkin' Down the Line. Demo per i trascrittori della Witmark - mi piacerebbe poterli vedere, mentre cercano di trascrivere "My money comes and goes and rolls and flows and rolls and flows through the holes in the pockets in my clothes".
14. Walls of Red Wing. La descrizione iperbolica di un riformatorio giovanile, su una melodia clonata dal folklore scozzese. Registrata nell'aprile del 1963, scartata da The Freewheelin', rispuntò fuori durante le session di The Times They Are A-Changin'. Ma a quel punto Dylan non aveva più bisogno di esagerare.
15. Paths of Victory. Le note dicono che è già una prova per The Times..., ma è accompagnata col pianoforte (e l'armonica), sembra più materiale da Witmark. In questo caso stava cercando un inno che si potesse cantare durante una lunga marcia - senza trovarlo, forse.
16. "Questa si chiama Talkin' John Birch Blues. E non c'è niente che non va in questa canzone". È la versione del concerto di ottobre al Carnegie Hall - la più divertente, quella in cui se la prende col postino.
17. Who Killed Davey Moore? Tratta dallo stesso concerto al Carnegie Hall (l'abbiamo ascoltata in una versione più tarda, al Philharmonic Hall). Continua a sembrarmi un pezzo straordinario, che mostra quanto fosse lucido il Dylan impegnato del 1963, prima di decidere di cambiare completamente strada. Pezzi come Hattie Carroll e Davey Moore sono dispositivi impeccabili - Dylan aveva capito come fare retorica senza mostrarne troppa.
18. Only a Hobo. Un altro barbone che non canterà più. Scartato anche dalla scaletta di The Times They Are A-Changin'.
20. Moonshiner. Una delle cose più oscure e toccanti del Dylan acustico, la confessione spietata di un alcolista ("Moonshine" è il liquore fatto in casa). Il brano - non originale - lo avevamo già ascoltato tra i nastri del Gaslight. A quanto pare era ancora in lizza per entrare nel terzo disco, dove sarebbe sembrata troppo pessimistica.
20. When the Ship Comes In. La non fondamentale versione al pianoforte, registrata per la Witmark. È il brano che Dylan ha suonato alla marcia su Washington e, più di vent'anni dopo, al Live Aid. In entrambi i casi non si capisce bene cos'avesse in mente. Forse è una di quelle profezie che capisci solo quando si avverano.
21. The Times They Are A-Changin'. Versione al pianoforte per i trascrittori della Witmark (in effetti tirare giù gli accordi di chitarra di Dylan doveva essere uno sbattimento).
22. Last Thoughts on Woody Guthrie. Quando si gioca a "chi ha inventato il rap", qualcuno tira mai fuori questa cosa? Sette minuti di versi a mitraglia, senza interruzioni - non si capisce onestamente come faccia a respirare. Il testo di un inno a Woody Guthrie che Dylan non sarebbe riuscito a cantare (né a imparare a memoria), letto al pubblico del New York City's Town Hall il 12 aprile 1963. La dimostrazione di un talento che sembrava incontenibile: servivano nuovi strumenti, nuovi modi per cantare che sarebbero arrivati molti anni più tardi. Dylan cercò di inserirlo nel disco live che la Columbia voleva pubblicare - poi non ne fece niente e i Last Thoughts diventarono una curiosità per collezionisti. E il rap lo inventò qualcun altro (Continua sul Post...)
Dylan sfruttatore di sé stesso
14-10-2017, 19:25Bob Dylan, Il Post, musicaPermalinkSguscia sguscia, come una regina zingara
sguscia sguscia, tutta vestita di verde,
sguscia sguscia, finché la luna è azzurra
sguscia finché la luna ti vede
Lo senti quel battito, tutti gli strumenti all'unisono? È tornato il vecchio-zio-Dylan, dalla sua strana vacanza in Louisiana. È tornato in California e si è già rimesso la giacca di pelle di Down in the Groove. Temeva che Lanois ci stesse addormentando ed è tornato a farci ballare coi suoi rock and roll fuori tempo, fuori senso, fuori tutto. Porta in regalo una valigia di filastrocche meno ispirate di quelle che aveva quand'è partito. Ha una voce più gracchiante e chioccia del solito - vecchio zio Dylan, ci sei mancato. Temevamo quasi che fossero finiti gli anni Ottanta. Temevamo quasi che ti fossi rimesso a fare dei bei dischi - giusto per la tigna di fregare un'altra volta i critici che ti davano spacciato nel 1980, nel 1970, nel 1966. E invece eccoti qui, stonato e scazzato al punto giusto. Caro vecchio zio Dylan, se non ci fossi tu.
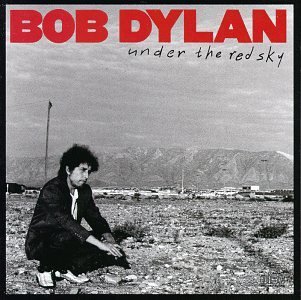
Insomma avevo fatto quel disco con Lanois nel 1988. A quel punto stavo già facendo un centinaio di show all'anno. Avevo deciso di rimettermi a fare concerti, una cosa che non avevo più pensato davvero di fare dal 1966. Alcuni artisti fanno un sacco di sacrifici per registrare un disco - bruciano una gran quantità di tempo ed energia. Io lo avevo fatto con Lanois, e aveva funzionato abbastanza bene. Ma più o meno nello stesso periodo stavo facendo un disco coi Traveling Wilburys, e poi avevo cominciato quest'altro disco con Don Was, Under the Red Sky. Tutto questo stava succedendo nello stesso periodo. A ripensarci adesso sembra inimmaginabile. Mi capitava di mollare i Wilburys e scendere al Sunset Sound a registrare Under the Red Sky, il tutto allo stesso tempo perché il tal giorno avrei dovuto essere a Praga o da qualche altra parte. Ed entrambi i dischi, li lasciavo lì sospesi e poi più tardi sarei tornato a vedere com'erano venuti.
Elton John. David Crosby. George Harrison. Steve Ray Vaughan. Bruce Hornsby. Slash, quello dei Guns'n'Roses. Se vi dicessi che c'è un album del 1990 in cui hanno tutti collaborato, prodotto dal grande Don Was, cosa mi rispondereste? Scommettiamo che è uno di quegli inutili dischi di zio Bob in cui suonano tutti una particina che qualsiasi turnista rimediato nei sottoscala della Columbia avrebbe inciso senza che si notasse la differenza? Sei davvero così prevedibile, zio Bob, è il motivo per cui ti si vuole bene. Che altro avevi? Problemi con le partner? Un divorzio in arrivo? Problemi con l'alcool? La voce un po' fiacca? Ma non ci dire. Quando Clinton Heylin licenziò le bozze di Jokerman, il disco era così fresco che aveva preferito non parlarne - più che un nuovo album era un ulteriore sintomo di una situazione preoccupante. Non dava più interviste, non faceva soundcheck, si presentava sul palco col volto quasi del tutto coperto. Anche in sala di registrazione si presentò spesso con "quel cappuccio del cazzo e gli occhiali scuri", come disse Slash, che racconta di averne visto solo il naso. Insomma stava un po' peggio del solito. Però doveva fare un disco lo stesso. Ma perché?
Not one more night, not one more kiss
Not this time baby, no more of this
Takes too much skill, takes too much will
It’s revealing
Non è il Tempo e non è l'Amore. Non è la guerra e non è il passato. La Musa più assidua di Dylan, quella cui dobbiamo il maggior numero di dischi e canzoni, la sua più grande ispiratrice, è sempre lei: la Scadenza Contrattuale. Come non pensare a lei mentre ascoltiamo i nonsense di Under the Red Sky, le filastrocche buttate lì in mezz'ora sugli stessi giri blues che suonava già nel 1964, gli sgorbi di canzoni che avrebbe dovuto finire ma l'amica Scadenza urlava: non c'è tempo! e allora vabbe', è andata così anche stavolta, arrivederci alla prossima. Scadenza Contrattuale, quanti crimini in tuo nome. Quanti dischi non per forza brutti, ma poco convinti, tirati via, mandati fuori per disperazione quando sarebbe bastato aspettare qualche mese, qualche anno. Ma chi è poi che ti ha mandato, Scadenza Contrattuale? Perché tanto infierisci sul povero Bob Dylan? Da quale altro grande vecchio del rock si pretendeva ancora un disco all'anno nel 1990? Che senso aveva spremerlo così? Era la Columbia ad averlo messo alla catena, o non era lui a insistere con una tabella di marcia che avrebbe sfibrato una rockstar con metà dei suoi anni? Al Toad's Place di New Haven una sera suonò per cinque ore. A un tizio che gli chiedeva una canzone a un certo punto disse, ehi, me ne hai chieste già cinque e te le ho suonate. Il Grande Bob Dylan. Il Mito Distante e Scostante. Si stava tirando il collo da solo, e per cosa, per chi? I figli, d'accordo (secondo Carolyn Dennis, ne ha "otto o nove"). Un sacco di avvocati, le pedine di una ventennale battaglia col suo vecchio manager Grossman. Tutto questo basta a spiegare perché nel 1990 Dylan, sulla soglia della cinquantina, registrava due dischi mentre stava ancora promuovendo il precedente?

Era il 1990. Un artista di una major, nel 1990 pubblicava in media un disco ogni 18 mesi. Meno di così non avrebbe avuto senso - se il disco funzionava si estraevano tre, quattro singoli, e ognuno doveva godere della giusta esposizione radiofonica e su MTV. I più famosi diradavano ancora di più le uscite. Tra Nothing Like the Sun e The Soul Cages Sting fece passare quattro anni. Dopo Tunnel of Love (1987) Springsteen attese un anno in più - e poi ne fece uscire due, ma nel frattempo Dylan ne aveva incisi tre in studio e uno dal vivo. Nello stesso periodo si stava deteriorando il rapporto tra Prince e la sua casa madre, la Warner, che non solo lo aveva svezzato sin da piccolo (come la Columbia con Dylan), ma si era impadronito del suo nome registrandolo come un marchio. Prince continuava a registrare come un matto: avrebbe voluto e potuto uscire con uno o più dischi all'anno, mentre la Warner preferiva rallentare per non inflazionare il mercato.
È un dandy alla mano, circondato da polemiche. Ha fatto il giro del mondo, e rieccolo qua. Qualcosa nel plenilunio ancora lo tormenta - Dandy-Alla-Mano, zucchero e canditi. Se ogni osso del suo corpo fosse rotto, non lo ammetterebbe.
L'urgenza di registrare di Prince, però, era imputabile a un'ispirazione debordante - una necessità di liberarsi della troppa musica che aveva in testa, che aveva nelle mani. Dylan, tutte queste idee, queste canzoni, non le aveva. E però in un qualche modo il suo disco all'anno, fino al '90, doveva farlo uscire. Dopo aver cucinato gli avanzi in Knocked Out Loaded, per Down in the Groove si era ridotto a servire agli invitati pietanze altrui, acquistate in fretta in qualche equivoca rosticceria sotto casa. Per Oh Mercy si era presentato in Louisiana quasi a mani vuote; e se in un qualche modo il duro lavoro con Lanois aveva dato qualche frutto, resta il mistero: perché affannarsi così? Sei un mito vivente, hai ancora gente che ti adora e ti compra i biglietti ovunque tu suoni: perché devi affliggerli con tutti questi dischi inutili? Quando capirai che di tutti i suicidi artistici, il tuo è il più lento e doloroso?
Tutte queste cose succedevano nello stesso periodo di tempo, e fu allora che capii che davvero ne avevo abbastanza. La mia parte razionale non sapeva più cosa farci. Avrei mantenuto il mio proponimento e non avrei più fatto dischi. Non sentivo il bisogno di annunciarlo, ma avevo comunque raggiunto questa conclusione. Non m'interessava più incidere. Preferivo suonare on the road. Registrare era una cosa troppo cerebrale. Inoltre, sentivo che non stavo scrivendo le canzoni che avrei voluto scrivere. Non ricevevo l'aiuto che mi serviva per registrare bene, non mi piaceva il suono dei dischi... non mi ricordo bene. Era solo... una cosa conduce all'altra, capisci? Mi resi conto che non ne potevo più.
Il risultato più notevole del combo Dylan/Kooper/Was è Handy Dandy, che nasce in coda a un'improvvisazione di Like a Rolling Stone. Lo racconta lo stesso Was: a un certo punto stava suonando il basso con gli altri due e quelli si mettono a suonare Like a Rolling Stone: che emozione. Finché la progressione del ritornello non si trasforma in qualcosa di più simile a Louie Louie, Dylan si mette a improvvisare versi su un musicista balordo, ed è più o meno buona la prima.
Handy Dandy, ha un mazzo di fiori e un sacco pieno di dolori. Finisce il suo drink, si alza e dice: "Ok, ragazzi, ci si vede domani".
Forse a un certo punto Dylan aveva pensato semplicemente di fare un disco tranquillo, un po' estemporaneo, tra amici, insomma un disco alla Wilburys. Unbelievable è un rock allegro che inizia con lo stesso fraseggio di chitarra che usava George Harrison in Honey Don't - e magari la sta suonando davvero Harrison, quindi che male c'è? Certi brani alla fine sono talmente nella media che ti domandi se non potrebbero stare in qualsiasi altro disco di Dylan. Cat's in the Well alla fine è Outlaw Blues, rifatta venticinque anni dopo con strumentazioni migliori e un testo più scemo. Però dal vivo l'ha suonata trecento volte, Outlaw Blues una volta sola. Una cosa sconcertante di Under the Red Sky è che contiene alcuni brani a cui non daresti il minimo credito, e che invece sono diventati cavalli di battaglia delle sue successive esecuzioni dal vivo. Il brano omonimo è una canzoncina macabra come potrebbe inventarsela un bambino di sei anni dopo che gli hai raccontato Hansel e Gretel.
And they lived in an alley under the red sky...
[E adesso cosa canto? Bah, ripeto i primi due versi un po' più accelerati:]
There was a little boy and there was a little girl, and they lived in an alley under the red skyyyy...
Sembra uno scherzo scemo, il modo di perpetuare due tradizioni: (1) inserire il brano più debole al secondo posto della scaletta; (2) usare il titolo del brano più debole come titolo dell'intero album (come in John Wesley Harding. Alla Columbia si erano lamentati perché Oh Mercy non aveva una title track, beh, eccovi accontentati). Poi uno va a vedere se per caso abbia mai cantato Under the Red Sky dal vivo e misericordia! 148 esecuzioni in poco più di vent'anni. Magari nel frattempo è migliorata, è diventata una canzone interessante. Lo spero per Dylan e per i suoi ascoltatori. TV Talkin' Song non è purtroppo il talkin' blues che sembra promettere dal titolo (per quanto la melodia sia ridotta al minimo), ma è l'unico brano in cui Dylan non si accontenta di dispensare filastrocche o fesserie da anziano al parco. Anzi, sembra il brano in cui Dylan per la prima volta si pone il problema: come posso fare a lamentarmi della modernità senza sembrare un anziano al parco? L'espediente è immaginare che tutte le cose brutte che vorrebbe dire sulla TV, Dylan non le stia affermando in prima persona. Sta solo riferendo quello che ha sentito dire da un predicatore a Hyde Park (pare sia successo davvero, Dave Stewart testimone).
"The news of the day is on all the time
All the latest gossip, all the latest rhyme
Your mind is your temple, keep it beautiful and free
Don’t let an egg get laid in it by something you can’t see”
“Pray for peace!” he said. You could feel it in the crowd
My thoughts began to wander. His voice was ringing loud
"It will destroy your family, your happy home is gone
No one can protect you from it once you turn it on”
Ok, sembrano proprio le fesserie di un anziano al parco. Fate la prova: rileggetele a qualcuno che non conosce il titolo della canzone; chiedetegli di cosa sta parlando. Di Facebook? Internet? La radio? La stampa periodica? Ogni generazione ha il suo satana mediatico. "Un giorno dovrete fare come Elvis e sparare a quella cosa". A questo punto però la folla comincia a premere sullo speaker, c'è baccano, Dylan nota una troupe televisiva e se la batte. Quella sera stessa, rivede la scena in tv. Canzoni che finiscono con Dylan che spegne il televisore: Black Diamond Bay, Tweeter and the Monkey Man, TV Talkin' Song (Continua sul Post)
Pietà per Dylan
08-10-2017, 03:22Bob Dylan, Il Post, invecchiare, musicaPermalinkBroken lines, broken strings. Broken threads, broken springs.
Broken idols, broken heads. People sleeping in broken beds.
Ain’t no use jiving, ain’t no use joking:
Everything is broken.
Scusate, sono un po' in ritardo coi dischi di Dylan, però non avete idea di cosa mi è successo questa settimana. Tanto per cominciare c'è puzza - dovrei telefonare l'amministratrice ma a proposito mi si è rotto il telefono - il modem di casa mi sta morendo, niente linea fissa. È da tre mesi che lo voglio cambiare ma Telecom Italia (sì dico proprio a te amica TIM) non riesce a farmi un contratto. Chiamarli al telefono è inutile, dovrei uscire ma si è rotto il ventilatore dell'auto, o va al massimo o non va, e mi è anche venuta un po' di bronchite. L'elettrauto doveva cambiarmi la resistenza, ma non riescono a collegarsi con la casa madre, non gli funziona la rete. Forse volevano passare a TIM anche loro. Anche a scuola c'è puzza, per un cantiere dicono, che però è bloccato perché hanno rotto qualcosa. Non riesco a configurare in rete la fotocopiatrice del plesso. In seconda un nativo digitale si è appeso al cavo di alimentazione di una LIM (le LIM si rompono continuamente). I genitori che fanno le collette per le LIM, anche loro si rompono spesso. Mentre penso a tutto questo mi chiama una signora dall'Albania e mi chiede se per caso non vorrei passare a TIM. Mi lasci perdere signorina, le dico, tra me e TIM ormai c'è una storia troppo complicata, ne stia fuori, le conviene: ma lei insiste, occupando l'unica linea telefonica che mi funziona (così i colleghi che hanno rotto qualcosa non mi possono chiamare). Per comprare un modem nuovo potrei usare il Bonus Docente, ma anche lì si dev'essere rotto qualcosa, non mi riconosce la password. Neanche il codice di emergenza. Rotto anche quello. Il Bonus Docente poi devo stare attento a usarlo, mi serve anche per la Nuova Piattaforma Formativa del Ministero, che è appena nata e si è già, ovviamente, rotta. La signorina insiste che lei risolverà qualsiasi problema tra me e TIM, dall'Albania, lei non è come tutte le altre che ci hanno provato da giugno in poi. Entra un ragazzo e chiede se lo stereo funziona, ne ha bisogno la collega d'inglese. Lo stereo sì, ma il cavo di alimentazione l'altro giorno ha fatto saltare una valvola in mezzo corridoio. Sotto il corridoio c'è una stanza, io lo so che c'è, piena di cose che si sono rotte o sono state dichiarate tali. Bisognerebbe caricarle su un furgone e portarle in discarica, ma suppongo sia rotto anche il furgone. Oppure prendersi un paio di ragazzi e cercare di capire cosa è rotto davvero e cosa potremmo ancora recuperare - sarebbe molto bello ma anche i ragazzi rischiano di rompersi, bisogna far firmare un'autorizzazione ai genitori, con cosa la stampo? La stampante è rotta. Dovrei configurare la fotocopiatrice. Oh, pietà.
Broken cutters, broken saws. Broken buckles, broken laws
Broken bodies, broken bones. Broken voices on broken phones.
Take a deep breath, feel like you’re chokin':
Everything is broken
Si è rotto anche il cuore di Tom Petty, troppo presto a mio parere. Forse non sembrerebbe così assurdo se Dylan non fosse ancora in circolazione - pubblica dischi, ritira premi - la vera notizia non è un rocker sessantenne che muore, ma Dylan che continua a sopravvivere. Lista di rockstar vive nate prima del 1942: Bob Dylan, Charlie Watts, Ringo Starr, David Crosby, altri in mente non mi vengono. Dylan ha iniziato a seppellire colleghi quando aveva vent'anni, e non ha mai smesso. Ha debiti infiniti con gente che non verrà più a riscuoterli, e Chronicles a volte dà l'impressione di essere proprio questo: il libro dei debiti morti e coi vivi. Tom Petty era uno dei due artisti più giovani a comparire in bilancio: a metà anni Ottanta i suoi Heartbreakers lo avevano raccolto con il cucchiaino e rimesso in sesto. "Tom stava dando il meglio di sé e io stavo dando il peggio". Con gli Heartbreakers ritrovò la voglia di suonare dal vivo, ed è curioso che non esista un disco live che documenti l'evoluzione dei loro concerti tra il 1986 e il 1987 - un'ottantina di date. Per dire, coi Grateful Dead ne suonò soltanto sei, e di quel tour abbiamo il disco (purtroppo). Magari è solo un problema di diritti. In realtà anche Petty, quando incrociò Dylan, era un po' appannato e bisognoso di visibilità. E le cose cominciarono a girare per entrambi soltanto quando presero un po' il largo: anche grazie a Dylan, Petty incontrò Jeff Lynne, mentre Dylan un giorno si ritrovò nello studio di Daniel Lanois.
What good am I then to others and me
If I had every chance and yet still fail to see
If my hands are tied must I not wonder within
Who tied them and why and where must I have been
 Quando ero giovane mi si rompeva tutto perché mi piacevano le cose usate (è un modo elegante di dire che ero taccagno). Il mio primo giradischi, mi ricordo, era amplificato con due vecchie casse per automobili - io vivevo sopra un'auto-officina e avevamo un cortile pieno di quelle cose un po' rotte un po' no. Queste casse a volte vibrando finivano per cascare sul giradischi segnando orribilmente i vinili. A un certo punto mi ruppi e comprai un impianto stereo, col lettore CD. Era già il 1989 e io non avevo davvero l'intenzione di mettermi a comprare CD (costavano il doppio delle cassette, maledette major, gli mp3 ve li siete cercati) ma intendevo copiare tutti quelli dei miei amici. In questo modo comunque cominciarono a entrare nella mia camera molti CD, e cominciai ad ascoltare la musica in un modo diverso. Prima alzavo il volume e amen, sperando che verso l'alto il canale sinistro e quello destro avrebbero trovato un loro equilibrio, e che i bassi non facessero cascare qualche libro da una mensola. Ma verso la fine degli anni Ottanta, magari fu una coincidenza, cominciai ad ascoltarli a un volume molto basso, mentre studiavo o leggevo o pensavo o facevo finta di. Il cd all'inizio aveva qualcosa di magico: potevi abbassare il volume finché non si sentiva nulla: col vinile la puntina continuava a gracchiare qualcosa, col nastro c'era qualche altro rumore (le testine?), il cd invece scompariva del tutto - solo se accostavi l'orecchio udivi qualcosa di simile a un piccolo sputacchio. A quel punto gli eroi del rock, quelli che mi avevano urlato nelle orecchie per gli ultimi cinque anni, potevano improvvisamente esprimersi sottovoce, come amici venuti a trovarmi. Sarà stata una coincidenza, ma proprio in quell'anno due vecchi fracassoni uscirono con dischi confidenziali: Lou Reed pubblicò New York, Bob Dylan Oh Mercy. Non avevano mai cantato così piano. Ma forse prima non avevo la rotellina del volume. Sul serio, fino al 1989 non osavo toccare troppo certe rotelline, mi si rompeva tutto, oh, per carità.
Quando ero giovane mi si rompeva tutto perché mi piacevano le cose usate (è un modo elegante di dire che ero taccagno). Il mio primo giradischi, mi ricordo, era amplificato con due vecchie casse per automobili - io vivevo sopra un'auto-officina e avevamo un cortile pieno di quelle cose un po' rotte un po' no. Queste casse a volte vibrando finivano per cascare sul giradischi segnando orribilmente i vinili. A un certo punto mi ruppi e comprai un impianto stereo, col lettore CD. Era già il 1989 e io non avevo davvero l'intenzione di mettermi a comprare CD (costavano il doppio delle cassette, maledette major, gli mp3 ve li siete cercati) ma intendevo copiare tutti quelli dei miei amici. In questo modo comunque cominciarono a entrare nella mia camera molti CD, e cominciai ad ascoltare la musica in un modo diverso. Prima alzavo il volume e amen, sperando che verso l'alto il canale sinistro e quello destro avrebbero trovato un loro equilibrio, e che i bassi non facessero cascare qualche libro da una mensola. Ma verso la fine degli anni Ottanta, magari fu una coincidenza, cominciai ad ascoltarli a un volume molto basso, mentre studiavo o leggevo o pensavo o facevo finta di. Il cd all'inizio aveva qualcosa di magico: potevi abbassare il volume finché non si sentiva nulla: col vinile la puntina continuava a gracchiare qualcosa, col nastro c'era qualche altro rumore (le testine?), il cd invece scompariva del tutto - solo se accostavi l'orecchio udivi qualcosa di simile a un piccolo sputacchio. A quel punto gli eroi del rock, quelli che mi avevano urlato nelle orecchie per gli ultimi cinque anni, potevano improvvisamente esprimersi sottovoce, come amici venuti a trovarmi. Sarà stata una coincidenza, ma proprio in quell'anno due vecchi fracassoni uscirono con dischi confidenziali: Lou Reed pubblicò New York, Bob Dylan Oh Mercy. Non avevano mai cantato così piano. Ma forse prima non avevo la rotellina del volume. Sul serio, fino al 1989 non osavo toccare troppo certe rotelline, mi si rompeva tutto, oh, per carità.Most of the time I’m clear focused all around;
Most of the time I can keep both feet on the ground.
I can follow the path, I can read the signs
Stay right with it when the road unwinds
I can handle whatever I stumble upon
I don’t even notice she’s gone
Most of the time
Un altro posto dove tutto sembrerebbe rotto è la biblioteca di Babele, quella di Borges. Dentro ci sono tutti i libri che si possono scrivere - il che significa che per un volume con un briciolo di senso ce ne sono miliardi composti di stringhe di lettere senza significato. Gli abitanti della biblioteca si aggirano per il loro universo ripetendosi, come noi, che è tutto rotto, ogni libro è rotto, e non c'è rimedio. In uno degli scaffali c'è un libro che contiene un racconto molto singolare. Comincia esattamente come il quarto capitolo di Chronicles I: c'è Dylan preoccupato perché si è rotto una mano, non sa se ne recupererà la sensibilità, e questa disgrazia domestica gli è successa proprio nel momento in cui ha solo voglia di suonare. Non vuole più scrivere canzoni - dice che ne ha scritte già abbastanza e nel 1988 sembrava un argomento sensato. Gli si è rotta l'ispirazione. Non vuole nemmeno più incidere, ormai le sale d'incisione sono diventate luoghi dove si trova a disagio e non riesce a combinare niente di buono. Gli si è rotta la concentrazione. Vuole soltanto cantare e suonare dal vivo, ma gli servono le mani e si è rotto anche quelle. Oh merda.
Far away where the soft winds blow, far away from it all
There is a place you go where teardrops fall.

È il momento in cui in una leggenda appare un santo o una madonna; in questo caso entra Bono con una cassa di Guinness. Dylan lo frequenta da qualche tempo: ci ha cantato assieme in Sun City, hanno duettato in Rattle and Hum, c'è stima reciproca - forse perché Bono è l'unico artista al mondo che sostiene di amare Shot of Love. A questo punto della storia Bono è la Voce del Rock, e non solo. Ha combattuto l'apartheid, ha pianto con le madri di Plaza de Mayo e coi minatori inglesi in sciopero. Ma che importanza ha visitare i carcerati e sfamare gli affamati, se Bob Dylan nel frattempo continua a fare dischi di merda? Così, dopo aver ben chiuso le 99 pecorelle nel recinto, Bono parte per Malibu con una missione: salvare Bob Dylan, condurlo da Daniel Lanois. Il produttore che lo salverà. Oh, grazia.
Seen a shooting star tonight and I thought of you
You were trying to break into another world
A world I never knew
I always kind of wondered if you ever made it through
Seen a shooting star tonight and I thought of you

Daniel Lanois è canadese (sua sorella suonava nei Martha and the Muffins), ma da un po' di tempo lavora nelle paludi della Louisiana: il che significa che Dylan, imbeccato da Bono, tornerà a Sud per l'ennesima volta. Dieci anni dopo aver lavorato con Jerry Wexler; venti esatti dopo Nashville Skyline: è come se ogni dieci anni Dylan sentisse il richiamo delle paludi. Ma quello che cerca davvero a sud non sono le atmosfere decadenti o la retorica del sottosviluppo: a Sud di solito Dylan ci va per trovare dei musicisti professionali (ricordiamo anche Leon Russel ai tempi di Watching the River Flow) e dei produttori al passo coi tempi. In effetti il racconto che sto leggendo non è così credibile; nell'88 Lanois non era un nome sconosciuto che Bono ti passa dopo una bevuta: tra gli ultimi dischi a cui aveva lavorato c'era So di Peter Gabriel e The Joshua Tree. Tutt'un'altra idea di anni Ottanta, rispetto per esempio ad Arthur Baker: il ritorno degli strumenti acustici, dei suoni caldi - ma riprodotti con una tecnologia all'avanguardia e quindi insolitamente vicini all'orecchio dell'ascoltatore: cos'ha in comune il Peter Gabriel di Don't Give Up e il Bono di With or Without You? Sembra che siano usciti dallo stereo e stiano cantando direttamente in camera tua. Non sono uno spettacolo lontano e artefatto, sono tuoi compagni di stanza e sono disperati, vogliono strapparti il cuore. È come se in mezzo a tutte le strumentazioni escogitate dagli ingegneri del suono negli anni Ottanta, tutti gli artifici e i bip e i clang, Gabriel e Lanois avessero finalmente trovato il tasto EMOZIONE, e avessero deciso di spingere solo quello (Lanois aveva anche un debole per il tasto TREMOLIO). Oh, pietà.
Ring them bells, ye heathen from the city that dreams
Ring them bells from the sanctuaries
’Cross the valleys and streams
For they’re deep and they’re wide
And the world’s on its side
And time is running backwards
And so is the bride
Lanois aveva reso la voce di Bono l'assoluta protagonista di Joshua Tree. Era abbastanza inevitabile che lui e Dylan si incontrassero, presto o tardi. Forse successe troppo presto, ma per Dylan aveva tutta l'aria dell'ultimo tentativo. Arrivò in Lousiana con qualche testo scritto, nemmeno una musica. Per quel che ne sappiamo, Dylan aveva scritto testi senza musica solo ai tempi di John Wesley Harding. Ora però, forse a causa della mano convalescente, si ritrovava nella situazione di chi ha parole e non ha note. Il risultato è una maggiore attenzione al ritmo e al suono delle sillabe; certi testi di Oh Mercy sembrano nati come filastrocche, scioglilingua. Non è la prima volta che Dylan si affida agli aspetti più formali del linguaggio: gli era già capitato ad esempio con All I Want to Do (e già allora l'espediente serviva a smarcarsi: tutti volevano che lui scrivesse inni generazionali, lui si metteva a scrivere filastrocche). Il suo gioco preferito, l'anafora, ritorna prepotente in Everything is Broken, ma a ben vedere è la trama di tutto il disco. I titoli di Oh Mercy sono le arie su cui Dylan costruisce variazioni nelle sue strofe, giocando con le rime e sapendo che alla fine deve tornare a scandire "Man in the long black coat", "Disease of conceit", "What good am I?" o "Most of the Time". Certe parole le ripete così tanto che finiscono per perdere il significato. È il caso di "disease of conceit", che Dylan ha deciso di ripetere al termine di ogni verso della canzone omonima.
There’s a whole lot of people suffering tonight
from the disease of conceit.
Whole lot of people struggling tonight
from the disease of conceit...
All'inizio sei propenso a considerarla un "disagio dell'orgoglio", di cui siamo sicuramente tutti afflitti, una delle malattie della contemporaneità bla bla. Ma lui ci insiste così tanto, e così meccanicamente, che ti viene il sospetto che stia raccontando una storia su una specie di pandemia misteriosa.
There’s a whole lot of hearts breaking tonight
From the disease of conceit
Whole lot of hearts shaking tonight
From the disease of conceit
Steps into your room, eats your soul
over your senses, you have no control.
Ain’t nothing too discreet - about the disease of conceit.
Pare che si tratti di una cosa per cui non c'è cura - i dottori hanno fatto un sacco di ricerche, ma per ora niente da fare. Dice proprio così. Ci sta prendendo in giro? È difficile capire, la musica è molto austera, senza sbavature. Lou Reed era entusiasta, e si capisce: ha lo stesso minimalismo cocciuto di certe canzoni di Songs for Drella. Anche la "politica" di Political World sembra non essere proprio "politica" in senso stretto - a meno di non considerare Dylan nel 1989 quel tipo di vecchietto che si mette a borbottare sulla panchina "la politica è una cosa sporca", e in effetti un po' già ci assomiglia. In ogni caso si tratta di testi che hanno perso tutta la magniloquenza con cui Dylan era entrato negli anni '80: sono secchi, umili, apparentemente intimi, eppure Dylan non riesce a specchiarcisi. "Io non c'ero", dice di Political World. Non l'ha scritta per esprimersi. Neanche perché gli premesse dire qualcosa. L'ha scritta - di getto - perché, finalmente, una sera ne è stato capace: oh, grazia. Sono incastri di parole, puzzle nemmeno troppo difficili. Sono tutto quello che portava in valigia a Daniel Lanois un convalescente sulla soglia della cinquantina, esaurito e disilluso. Daniel Lanois invece voleva lavorare col grande Bob Dylan. Non l'aveva capito che si era rotto tutto, e da un bel pezzo? Non aveva un po' di pietà?
Di tanto in tanto, mentre registravamo Series of Dream, mi diceva: "Abbiamo bisogno di canzoni come Masters of War, Girl from the North Country o With God on Our Side". Cominciò a tormentarmi, un giorno sì e uno no, che avevamo bisogno di cose di quel tipo. Io annuivo. Lo sapevo anch'io, ma mi veniva voglia di ringhiare. Non avevo niente di paragonabile a quelle canzoni.
Nel lungo percorso che stiamo percorrendo, Oh Mercy è senz'altro una pietra miliare. Pochi dischi segnano la strada di Dylan in modo così netto, dividendola in un prima e in un dopo. Prima di Oh Mercy c'era una traiettoria discendente il cui esito sembrava chiaro e vicino. Era un'impressione condivisa da ascoltatori, critici e dallo stesso Bob Dylan. Dopo Oh Mercy, e una lunga fase di incubazione che prende quasi tutto il decennio successivo, c'è quel miracolo che riscatta tutta la storia - ovvero a un certo punto Dylan, invece di lasciarsi spegnere, come stava succedendo negli anni Ottanta e come in fondo era naturale che succedesse, si è bloccato. Ha smesso di consumarsi. Come se avesse trovato una nuova fonte di energia. E l'ha trovata davvero. Si è rimesso a suonare dal vivo, e non ha mai suonato così tanto. Si è rimesso a fare dischi e ha scoperto, a sessant'anni, che è persino capace di produrli - lui che in studio ormai nemmeno riusciva a entrare. Si è rimesso a scrivere canzoni e ne ha scritte di ottime. Ha scelto la vita, per la seconda volta. La prima volta, nel 1966 aveva rifiutato di sfracellarsi su una moto (com'era naturale che succedesse). Tra Ottanta e Novanta dev'essere successo qualche altro strano non-incidente, ma è difficile capire esattamente dove, quando, cosa. Lui stesso non ne è sicuro, anche se il quarto capitolo di Chronicles sembra scritto da una persona che vorrebbe capire, vorrebbe ricordarsi. È vero, ci sono stati episodi che sembrano miracoli - quella passeggiata notturna a San Rafael, quel concerto in Svizzera, ma quel che è accaduto in seguito non sembra per nulla miracoloso. Dylan va in Lousiana, decide che Lanois gli va a genio e comincia a lavorare con lui, con poche idee e un'insolita arrendevolezza. A questo punto la versione ufficiale è che Lanois riesca a riparare il grande Bob Dylan e a cavargli di gola un capolavoro - per molti dylaniti Oh Mercy lo è. Oh, finalmente! (continua sul Post)
La tavernetta degli specchi
29-09-2017, 23:07Bob Dylan, Il Post, musica, nostalgia, OttantaPermalinkMa Orbison andava al di là di tutti i generi, folk, country, rock and roll o qualunque altra cosa. Mescolava tutti gli stili, compresi quelli che non erano ancora stati inventati. In un verso cantava veramente da cattivo, in quello dopo se ne usciva con un falsetto alla Frankie Valli. Con Roy non si sapeva mai se stavi ascoltando del mariachi o un'opera lirica. Teneva sulle spine. La sua era un'offerta di grasso e di sangue. Sembrava che cantasse dalla cima del monte Olimpo ed era meglio starlo a sentire perché diceva sul serio. [...] Adesso cantava con un'estensione di tre o quattro ottave, roba da farti spingere la macchina giù per la scarpata e non pensarci più. Cantava come un professionista del crimine.
La storia è nota, ma si racconta lo stesso volentieri. Nella primavera del 1988, George Harrison è improvvisamente tornato alla ribalta. Il suo nuovo disco, Cloud Nine, prodotto da Jeff Lynne (chi?), è andato al numero uno negli USA, soprattutto grazie alla cover di Got My Mind Set On You, un pezzo che cura la nostalgia per i Beatles mediante robuste iniezioni di cose persino precedenti ai Beatles. Nel primo videoclip, Harrison e Lynne suonano tra gli ingranaggi di un videojukebox a manovella: i loro anni Cinquanta ormai sono un'idea depurata di ogni nostalgia, un giocattolo per bambini che non sanno chi è Elvis ma a quel ritmo muoveranno i piedi comunque. Numero 1 negli USA. La Warner è entusiasta e vuole estrarre un altro 12 pollici, ma serve un riempitivo per il lato B. Harrison è in California e sa che anche Lynne è nei paraggi, così lo chiama: dobbiamo incidere un pezzo al volo, tu adesso cosa stai facendo? Lynne ormai è tutto preso dal rock'n'roll, sta producendo il nuovo disco di Roy Orbison, eccentrica leggenda vivente anche se non vende un disco da anni. Roy Orbison! Wow! invita anche lui. Potremmo registrare a Malibu da Bob Dylan, lui ha quello studio in garage che di sicuro non sta usando nessuno. Il problema è che non ho chitarre con me, l'ho lasciata a casa di Tom Petty l'altra sera, beh, ma invito pure lui. Due giorni dopo i Traveling Wilburys sono appena nati e hanno appena registrato il loro più grande successo, Handle With Care, che oggi è una curiosità ma lanciò il 33 giri oltre i tre dischi di platino. Dylan tre dischi di platino non li vedeva dal 1971.
You can sit around and wait for the phone to ring (End of the Line)
Waiting for someone to tell you everything (End of the Line)
Sit around and wonder what tomorrow will bring (End of the Line)
Maybe a diamond ring?
Questo però lo avremmo scoperto in seguito. All'inizio c'era soltanto un video, in cui George Harrison intonava una di quelle canzoni alla George Harrison: semplici, meditate, disarmanti. La stessa vena serena e irresistibile di Here Comes the Sun, While My Guitar, Sweet Lord. Va avanti per otto versi, e se tutta la canzone fosse soltanto la ripetizione di quegli otto versi, avrebbe già un suo senso. Ma subito dopo entra Roy Orbison, che nel 1988 senz'altro non conoscevo. Il video mi forniva degli indizi: un profugo dagli anni Cinquanta, un sosia di Elvis sopravvissuto al suo personaggio? Gli basta aprire la bocca per trasformare una melodia tardobeatlesiana in qualcosa di completamente diverso, ha una voce cromata come una Triumph, si sente nell'aria un vago sentore di giacca di pelle, hamburger e frullato alla fragola. Sono passati trenta secondi ed è già una canzone molto strana, un patchwork come ne incidevano i Beatles verso la fine, giusto vent'anni prima - ma ecco che entrano Dylan e Petty, insieme. Petty segue la sua guida, il suo mentore, e Dylan... cosa vuoi che faccia Dylan? Dylan stecca.
Everybody's
got somebody
to leeeeeeeeeeeean on
Unghie sulla lavagna, la specialità della casa. Sono tra amici, si divertono, che può fare Dylan in queste situazioni se non trovare l'unica nota dissonante? Petty invece no: lo segue eppure non stecca, come fa? Anni di allenamento, probabilmente.
All'inizio pensavo di non farlo, un pezzo sui Traveling Wilburys. In fondo fu un'avventura estemporanea, una festicciola protratta per dieci giorni (ma quanti buoni dischi Dylan li ha registrati anche in meno tempo?) Magari avrei aggiunto da qualche parte un postcriptum: ah, nel 1988 ha anche inciso qualche canzone tra amici e ci ha guadagnato più che in cinque anni di dischi e concerti. Poi mi sono ricordato che c'era un sacco di cose da raccontare. Di certi album non sai veramente cosa dire, ma non è il caso di quelli dei Traveling Wilburys. Sono dischi interessanti. Avanzi di canzoni montati assieme in fretta, per la gioia del musicologo dilettante. Handle With Care è l'esempio migliore: gran parte del divertimento consiste nella facilità in cui puoi scomporre il prodotto in fattori primi. Qui c'è l'eccipiente Beatles, qui c'è la base rockabilly, qui c'è la guarnizione: Dylan che stecca. È come smontare un lego. È facile. Ma ti fa sentire un ingegnere.
Di solito cominciava su un registro basso, appena udibile. Per un po' ci rimaneva, poi cominciava con i suoi stupefacenti istrionismi. La sua voce avrebbe dato la scossa a un cadavere. Si finiva con il mormorare a se stessi: "Non ci posso credere". Le sue erano canzoni dentro canzoni. Passavano dalla tonalità maggiore alla minore senza nessuna logica. Orbison era terribilmente serio, non c'era niente di adolescenziale in quello che faceva. Alla radio non c'era nessuno come lui. Io ascoltavo e aspettavo un'altra canzone, ma a paragone di Roy il resto dei programmi veniva dritto dalle terre della noia, roba flaccida, senza spina dorsale, fatta per chi non aveva un cervello.
Tra i tributi più sorprendenti che Dylan offre in Chronicles, c'è senz'altro quello a Roy Orbison. Sul serio, chi l'avrebbe detto che il giovane Dylan lo apprezzasse così tanto? Non potrebbe essere uno di quei ricordi che si aggiustano a posteriori? Apparentemente in Orbison c'era tutto quello che Dylan non aveva e non aveva mai dato l'impressione di voler cercare: tanto per cominciare la voce impostata ed estesa su quattro ottave. Un'attitudine melodrammatica che negli anni Cinquanta aveva contagiato i rockers, ma proprio il successo di Beatles (e di Dylan) avrebbe estromesso dalle classifiche. E una vena barocca nella costruzione delle canzoni, piccole sinfonie in cui strofe e ritornelli si intrecciavano in strutture molto più complesse del necessario. Tutto questo aveva reso Orbison un personaggio unico ai suoi tempi, ma anche un ingrediente ideale per il metodo di lavoro dei Wilburys: improvvisare dei riff e montarli assieme. Si potrebbe dire dei brani più collettivi dei Willburys quel che Dylan dice delle canzoni di Orbison: canzoni dentro canzoni, dalla tonalità maggiore alla minore senza nessuna logica - oppure una logica c'è, come in Handle With Care, ma Dylan non la capisce e la smonta senza neanche accorgersene (Dylan, ricordiamo, è il compositore che incise sei dischi prima di scoprire il middle-eight, e che in John Wesley Harding aveva abolito i ritornelli). Malgrado l'ammirazione (reciproca?), Dylan e Orbison non duettano mai. Sembrano veramente inconciliabili, l'acqua e l'olio. Nei brani in cui canta Orbison, Dylan quasi scompare. Nel brano più dylaniano del mazzo, Tweeter and the Monkey Man, Orbison scompare davvero, abbastanza misteriosamente (magari era in bagno mentre registravano, va' a sapere). Sono loro i due veri monumenti da maneggiare con cura: Harrison - che ha venduto più di entrambi messi insieme - è più duttile, la sua voce è iconica, ma non è un fossile vivente. Quella di Orbison lo era, e anche quella di Dylan, nel 1988, sembrava a un passo dal diventarlo.
Ama il tuo corpo sexy, la tua mente sporcacciona.
Ama quando lo stringi e lo afferri dal didietro.
Uuuuuh, baby, che bella cosa sei!
Voglio proprio presentarti a questa gang di amici miei...
Traveling Wilburys Vol. 1 è una serata con gli amici. Ci sono canzoni che hanno un senso soltanto mentre le canti in coro e dev'essere un coro maschile - un pezzo autocommiserante come Congratulations, se Dylan l'avesse inciso in Down in the Groove o Knock Out Loaded, magari con moglie e suocera in sottofondo, non si sarebbe potuto sopportare. Ma qui siamo al banco del bar, Dylan può lagnarsi quanto vuole, i fratelli W ascoltano, cantano il ritornello e versano da bere. Se invece è in vena di scherzare, finalmente ha dei compari che lo capiscono - se è vero che Dirty World nacque da una sua idea di "fare una cosa alla Prince". Ovviamente non saltò fuori una canzone di Prince, ma quelle poche strofe sguaiate sono assolutamente dylaniane: la disinvoltura inspiegabile con cui passa dalla terza alla prima persona singolare, e quella litote ("non c'è assolutamente niente di te che non gli piaccia") che è proprio il modo con cui si esprime con sé stesso - molti anni dopo, a un giornalista che gli chiedeva di Alicia Keys, avrebbe usato praticamente le stesse parole.
Maybe somewhere down the road aways (end of the line)
You'll think of me, wonder where I am these days (end of the line)
Maybe somewhere down the road when somebody plays (end of the line)
Purple haze?
 |
| "Wilburys" deriverebbe da un'espressione spesso usata da Harrison e Lynne durante le sessioni: We'll bury it in the mix, "questo lo seppelliremo nel missaggio". |
Well it's all right, even if you're old and gray
Well it's all right, you still got something to say
Well it's all right, remember to live and let live
Well it's all right, the best you can do is forgive
I Wilburys, ripetiamo, sono Bob Dylan (Lucky Wilbury), George Harrison (Nelson Wilbury), Roy Orbison (Lefty Wilbury), Tom Petty (Charlie T. Wilbury) e Jeff Lynne (Otis). I primi due li conoscono tutti; Orbison è quello di Pretty Woman; di Tom Petty qualche canzone in radio passa ancora, ma Jeff Lynne insomma chi è? Non vale googlare (continua sul Post...)












.jpg)